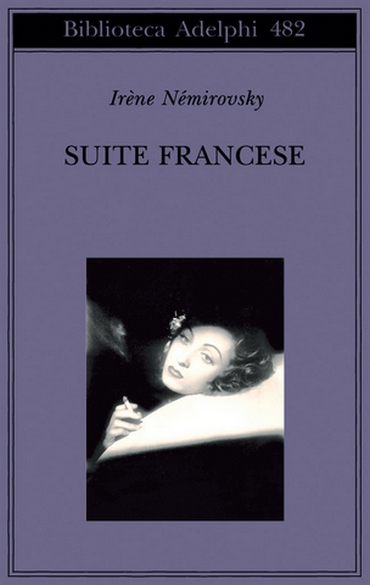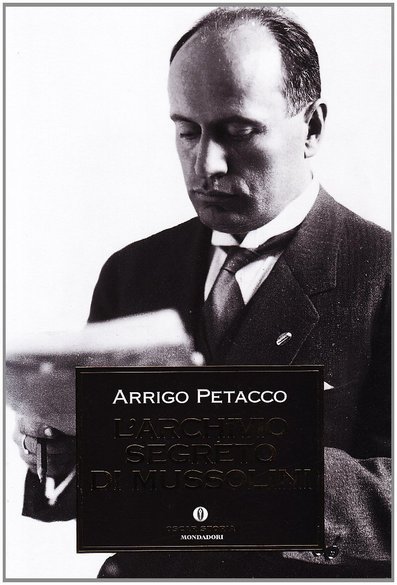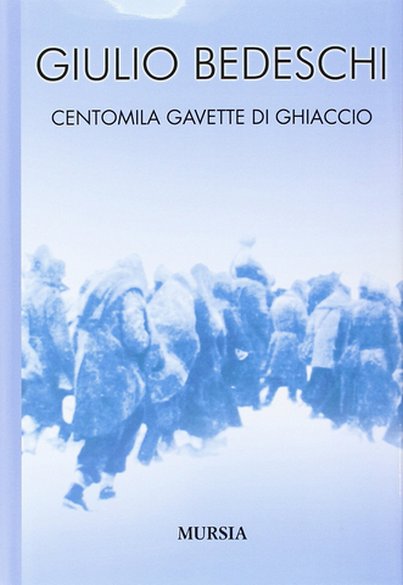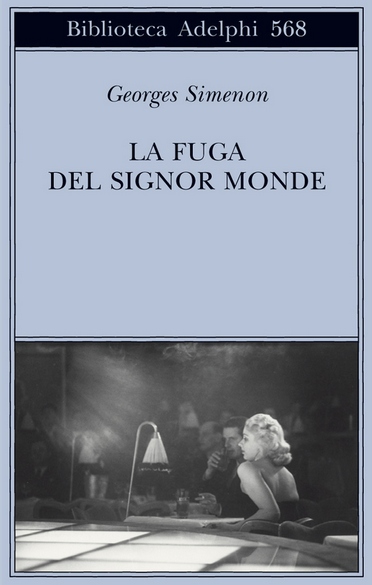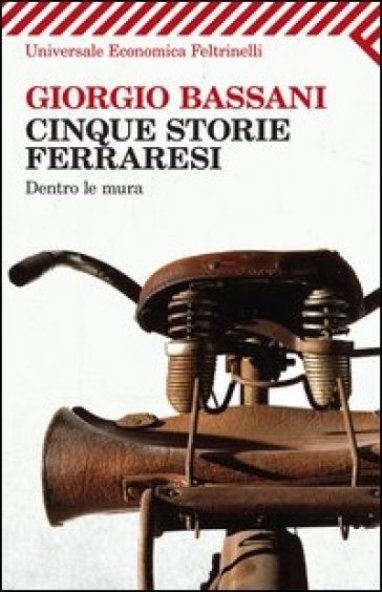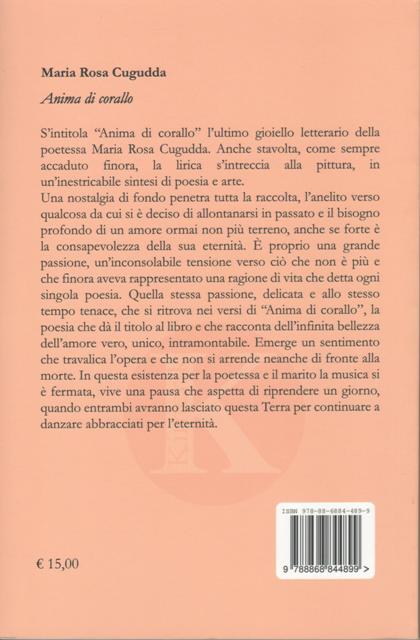Recensioni
2016
![]()
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Commenti Poesie consigliate La Giostra della satira Concorsi La Sorgente delle poesie
|
Questa pagina raccoglie le recensioni di romanzi, libri di racconti, volumi di poesia e di altro genere letterario (libri di saggi, viaggi, teatro, ecc.), film. |
Recensioni 2012
Recensioni 2013
Recensioni 2014 (Gennaio-Settembre)
Recensioni 2014 (Ottobre-Dicembre)
Recensioni 2015
|
18 Dicembre
Suite francese Traduzione di Laura Fausin Guarino Edizioni Adelphi Narrativa Collana Biblioteca Adelphi
Il super capolavoro Suite francese é un progetto letterario ambizioso con cui Irene Nemirovsky voleva parlare della seconda guerra mondiale, vivendola giorno per giorno, strutturato in cinque parti (Tempesta in giugno, Dolce, Prigionia, Battaglie, La pace), di cui solo le prime due completate, poichè nel luglio del 1942 fu arrestata, in quanto ebrea, e deportata ad Auschwitz, dove morì di febbre tifoide il 17 agosto dello stesso anno. Restano quindi solo di questo poema sinfonico Tempesta in giugno e Dolce, pubblicati postumi in Francia nel 1954, sufficienti però per dare un’idea di ciò che l’autrice voleva rappresentare. Sono entrambi riportati in questa edizione di Adelphi, in cui è possibile cogliere quella continuità che è propria appunto di una Suite. Tempesta in giugno è una serie di quadri con cui si rappresenta il caos magmatico che segue all’invasione della Francia da parte dei tedeschi, mentre Dolce ha più la struttura di un romanzo, con una delicata storia d’amore fra un ufficiale germanico e una signora francese, il cui marito è stato fatto prigioniero. In entrambi i casi, sia pur con motivazioni diverse, ci troviamo di fronte a qualche cosa che trascende il cosiddetto capolavoro, tanto che non riesco a trovarne una definizione, se non quella di super capolavoro. In particola in Tempesta in giugno i vari quadri sono raccordati con una puntualità e una perfezione che oserei definire incredibile; se ci sono dei personaggi emblematici che danno corpo alla narrazione e sullo sfondo troviamo un’umanità impazzita nella fuga, la cura del dettaglio è impressionante, senza che tuttavia venga a costituire un appesantimento che possa nuocere alla lettura. Tutto scorre veloce o lento, a seconda delle circostanze, con descrizioni mirate, con una capacità di ricreare l’atmosfera del momento che consentono a chi legge di vedere le scene, come in un film. A ciò giova indubbiamente uno stile snello e fresco, una frequente nota poetica che smussa, attenua la tensione quel tanto che basta per scorgere gli eventi come una sequenza di fotogrammi. Raramente mi é accaduto di imbattermi in una scrittura così inappuntabile, così concisa e al tempo stesso completa, in una sapiente concatenazione di ritmi senza che vi sia una nota stonata; la sua non è una scrittura, ma La Scrittura, cioè il massimo che ci si possa attendere da un’opera letteraria e se stupiscono e avvincono le trame dei singoli quadri, non si può non porre in rilievo appunto la bellezza di questo stile che da solo attira l’attenzione. Sono non pochi i personaggi principali, la cui psicologia é analizzata approfonditamente e sono, per certi versi, simboli di classi sociali, verso le quali la narratrice dimostra ben poca simpatia, fatta eccezione per il grado più basso della borghesia. Non è infatti un caso se rilucono i coniugi Michaud, modesti impiegati di banca, legati da un tenero e incrollabile amore che li porta a essere totalmente solidali nei momenti dolorosi e nelle piccole e non frequenti gioie della vita; sono minuscole realtà che, tuttavia, nel reggere se stessi finiscono con il reggere l’intera umanità. É quindi solo l’amore - quell’amore che si traduce in un sentimento di totale affetto e condivisione, che è superiore a ogni ricchezza e bramosia di potere - a salvare il mondo, concetto che è sorprendente ove si consideri che Irene Nemirovsky era figlia di uno dei più grandi banchieri dell’epoca, un uomo dalla ricchezza smisurata. La seconda parte, Dolce, è in un certo senso più convenzionale, con questo lento innamoramento che mai arriverà a un amore reciproco palesemente manifestato, perché troppo grandi sono certe differenze, fra il vincitore e la sconfitta, fra chi, prima di essere uomo, è soldato e colei che, insoddisfatta del marito che si trova in prigionia, non può tradire il suo paese e desidera avere un uomo vero. L’autrice cesella le parole, riesce a rendere perfettamente questi insanabili contrasti che in altre penne sortirebbero ridondanti di retorica, ma che qui invece sono di grande semplicità e naturalezza in quanto propri dell’esistenza. A qualcuno, come per esempio al sottoscritto, potrà risultare più gradito Tempesta in giugno, ma comunque pure Dolce è un romanzo di assoluto rilievo, una di quelle storie d’amore così realistiche da non sembrare assolutamente frutto di creatività. Resta da chiedersi come avrebbero potuto essere le altre tre parti, ma qui entriamo nel campo delle congetture. Pertanto, l’analisi e il giudizio è forzatamente limitato a queste due prime e mi pare di aver evidenziato abbastanza compiutamente la loro importanza, derivante da valori che non sono solo letterari, ma che si espandono alla storia, alla filosofia e perfino alla sociologia; di ciò che non ha potuto scrivere, si può dire solo che di sicuro sarebbe stato di estremo interesse. Dire che il libro sia meritevole di lettura finisce con l’essere un po’ riduttivo; più che consigliarla, credo invece sia mia dovere raccomandarla, lasciandosi trasportare dal ritmo adottato dalla narratrice; per le riflessioni c’è tempo, lasciatele a una indispensabile e ancor più gratificante rilettura.
Irène Némirovsky
(Kiev, 11 febbraio 1903; Auschwitz, 17 agosto 1942).
14 Dicembre
L’archivio segreto di Mussolini di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori S.p.A. Storia
Vizi privati e pubbliche virtù Ogni dittatore, nessuno escluso, diffida, oltre che dei nemici, anche e soprattutto degli amici, di chi sta intorno a vario titolo e che potrebbe rivelarsi all’improvviso per uno che desidera soppiantarlo. Benito Mussolini lo sapeva bene e non era quindi un caso che ricorresse ai servizi dell’OVRA, la polizia segreta fascista, per documentarsi dei comportamenti degli altri gerarchi, in modo da renderli facilmente ricattabili. Il duce era anche un uomo ordinato e pignolo e, oltre a conservare i rapporti degli agenti segreti, non buttava via niente, né le lettere dei numerosi postulanti, né documenti apparentemente banali come lettere di invito a cena. Alla sua caduta nel luglio del 1943 questa immensa mole di dati sparì, per poi essere ritrovata nel settembre dello stesso anno alla Stazione di Milano. Nulla vieta di supporre che nel tragitto ne siano venuti a mancare, come è anche certo che, finita la guerra, siano stati consegnati all’archivio di stato, dove Arrigo Petacco li ha potuti visionare. Certamente mancano quelli che Mussolini portò con sé nella sua vana fuga verso il confine svizzero e che, finiti in mano ai partigiani che lo catturarono, si volatilizzarono. Si mormora anche oggi che si trattasse del carteggio intercorso fra Churchill e Mussolini, ma sembra si tratti di pure illazioni, anche se ad aggiungere mistero a mistero vi è da ricordare il lungo soggiorno dello statista britannico, dopo l’aprile del 1945, sulle rive del lago di Como. Forse si trattò solo di una meritata villeggiatura, ma è una ben strana coincidenza. Data la mole della documentazione Petacco ha dovuto fare una scelta e, a mio avviso, ha scritto di ciò che potrebbe sembrare al lettore di particolare interesse, il tutto con ampie riflessioni personali che non mancano di un pizzico di sana ironia. Non poteva mancare un dossier su Achille Starace, segretario per un lungo periodo del partito, una sorta di macchietta vituperato non solo dagli antifascisti, ma anche dai suoi camerati. Eppure, quest’uomo fascistizzò il modo di vivere degli italiani, con assurde disposizioni quali quella di sostituire al “lei” il “voi”, di italianizzare tutti i nomi di origine straniera, con risultati spesso esilaranti, come nel caso di Eden, insegna di non pochi teatri, cinema, bar e alberghi, un “paradiso” in latino che lo zelante funzionario credeva un termine in inglese, visto che così si chiamava anche il ministro degli esteri britannico. E poi il sabato fascista, le divise, insomma una sorta di baraccone carnevalesco che come come un mago Starace tirava fuori dal suo cilindro, previa autorizzazione beninteso di Mussolini. Pure interessanti sono i vizi privati, contrapposti alle pubbliche virtù, di gerarchi come Balbo e Farinacci e altri, né poteva mancare la corrispondenza amorosa fra Benito e Claretta. Sta di fatto che leggere i documenti di questo archivio, pur con i dovuti distinguo fra un’epoca dittatoriale e l’attuale democratica, ci si accorge che, fra chi tiene le leve del potere, il vizio imperante è quello della corruzione, cosicché si può parlare di una tradizione a cui non si vuol rinunciare. E se é vero che forse Mussolini scappando non portava con sé valori ingenti, è altrettanto vero che la numerosa famiglia, compresi i parenti acquisiti, batteva spesso cassa e in parte veniva soddisfatta, beninteso con i soldi dello stato. Il libro é assai piacevole e non sono rari i casi in cui si sorride o addirittura si ride, soprattutto quando si legge di gente come Farinacci, il ras di Cremona, considerato un duro, laurearsi in legge con una tesi copiata interamente da un’altra o impuntarsi, sbraitare, insomma fare dei capricci quasi come un bimbo per ottenere medaglie al valore per azioni eroiche del tutto inventate. É forse allora che si comprende come l’Italia fascista fosse uno stato di operetta, soggiogata a tantissimi pagliacci; peccato che poi si sia passati dalla farsa al dramma, ma ciò era inevitabile quando chi comanda ha una smisurata vanità e ben poco cervello.
Arrigo Petacco è
nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori: Dear
Benito, caro Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il
Prefetto di ferro, La principessa del Nord, La Signora della Vandea,
La nostra guerra. 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio
segreto di Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in fuga, La
storia ci ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
11 Dicembre
La guerra dei poveri di Nuto Revelli Edizioni Einaudi Storia Collana ET Scrittori Storia La riscoperta del semplice valore umano Benvenuto (Nuto) Revelli é all’Accademia militare di Modena quando l’Italia entra nella seconda guerra mondiale; geometra, ha infatti scelto il mestiere delle armi, decisione frutto anche della costante militarizzazione dei giovani da parte del regime fascista. Ma le notizie che arrivano dapprima dal fronte francese e poi da quello greco sembrano in contrasto con la tanto sbandierata nostra potenza militare; infatti, se i comunicati sono frutto della propaganda, il tam tam del si dice fa capire che le stiamo prendendo e Revelli vuole sapere, vuole conoscere una verità che il regime si sforza di celare, e allora chiede di partire per il fronte russo, cosa che ottiene non senza fatica e da lì inizierà un’avventura di cui tratta ampiamente in questo suo libro intitolato La guerra dei poveri. In effetti, il nostro esercito non è quell’esempio di organizzazione e di potenza della martellante campagna fascista, anzi è una struttura povera di mezzi e quei pochi che ci sono risultano soggetti a continue ruberie nelle retrovie. Con tono distaccato e poche volte incline alla commozione il memoriale di Revelli é un atto di accusa implacabile , ma è anche un ricordo di dolore, di sofferenza, sia fisica che morale, in una ritirata in cui ben pochi riescono a conservare la loro dignità di uomini. É fortunato chi riesce a tornare, ma è un essere cambiato profondamente, che non crede più in un regime menzognero e menefreghista. Non é finita, però, questa tragedia, perché ne subentra, con l’8 settembre 1943, un’altra, forse ancora più lancinante, con una guerra civile, che vede da una parte uomini che vanno maturando l’avversione verso il fascismo e dall’altra i tedeschi e i loro odiosi e subordinati alleati, gli uomini della Repubblica Sociale Italiana. Sono tante le pagine dedicate all’esperienza della resistenza, sovente rappresentate da ordini di combattimento, da relazioni sulla consistenza e le intenzioni delle forze nemiche e mai, dico mai, che vi siano accenni di autoesaltazione; Revelli, esperto in quanto militare, diventa il comandante della Brigata Carlo Rosselli, che verrà contrastata duramente dalle truppe nazifasciste con estenuanti rastrellamenti. Nessuno dei partigiani é un eroe alla Rambo, ma a suo modo ciascuno é un eroe, un eroe nel combattere contro forze soverchianti, nei disagi dei trasferimenti, nell’alimentazione scarsa e inadeguata, nell’armamento spesso insufficiente. Ci si sposta di valle in valle per sfuggire agli accerchiamenti, si vedono morire, come in Russia, tanti compagni, si soffre in silenzio e si va avanti. Una ferita in quelle condizioni può voler dire la morte certa e non è nemmeno possibile abbandonare un ferito alla pietà del nemico, che non conosce nemmeno il significato della parola pietà. Lo stesso Revelli, dopo che la brigata Rosselli si è trasferita in Francia a fianco degli alleati, mentre opera un collegamento in motocicletta insieme al leggendario Wolf (Walter Cundari, degnissima persona che ho avuto modo di conoscere personalmente) resta gravemente ferito al volto, tanto che ci vorranno ben otto operazioni per ricostruirlo, tutte in una Parigi da poco liberata dagli alleati, e sempre da poveri, con cibo scarso per risparmiare i soldi per la clinica. Verso la fine dell’aprile 1945 il ritorno in Italia, fra mille peripezie, giusto in tempo per partecipare alla liberazione di Cuneo. Ma i sogni di un paese nuovo vengono subito fugati dall’incontro con un nutrito gruppo di militi repubblichini, passati all’ultima ora fra i partigiani, tanto che il menefreghismo del passato regime finisce con l’apparire come un male endemico del nostro popolo e i fatti successivi, di cui il libro non parla, perché si ferma appunto alla liberazione di Cuneo, ne forniranno ampia prova. Non è un romanzo, si avvicina di più al saggio storico, ma la presa di coscienza dell’ex fascista Nuto Revelli è descritta talmente bene che alla fine non si può che nutrire rispetto e ammirazione per quest’uomo. Hanno scritto bene di La guerra dei poveri Alessandro Galante Garrone (“E’ la guerra vista dal basso, la guerra sofferta...E’, prima di tutto, la tragedia dei poveri cristi gettati allo sbaraglio, beffati, traditi, e che pure, nello sfacelo immane, di un esercito e poi di uno Stato, riscoprono in sé le ragioni profonde della dignità del vivere, del semplice valore umano.”) e Giorgio Bocca (“Il libro è proprio questo: uno scrittore nato che trova, mentre si cammina e si combatte, un linguaggio per cose vere e tragiche quasi sconosciuto alla nostra letteratura….E’ il libro che avrei voluto scrivere.”). Imperdibile.
Nuto Revelli (Cuneo,
1919-2004), ufficiale degli alpini in Russia e protagonista della
Resistenza nel cuneese, si è battuto per anni per dare voce ai
dimenticati di sempre: i soldati, i reduci, i contadini delle
campagne piú povere. Tra i suoi libri, tutti editi da Einaudi, La
guerra dei poveri (1962), La strada del davai (1966 e
2010), Mai tardi (1967 e 2008) , L'ultimo fronte (1971
e 2009) , Il mondo dei vinti(1977), L'anello forte (1985) Il
disperso di Marburg (1994 e 2008), Il prete giusto (1998 e
2008), Le due guerre (2003 e 2005).
8 Dicembre
Otel Bruni di Valerio Massimo Manfredi Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa romanzo Parte bene, poi s’inceppa L’idea, non nuova, è interessante: parlare della nostra storia nella prima metà del XX secolo attraverso le vicende di una famiglia contadina, i Bruni. Congiuntamente a questa intenzione, l’autore si proponeva, probabilmente, anche di dar vita a una saga familiare, evidenziando un mondo rurale ormai scomparso, una civiltà, insomma, quella contadina che con gli anni del boom economico è venuta meno. Dico subito che all’inizio l’opera mi ha avvinto non poco, nonostante che presenti non poche lacune; del resto queste storie mi hanno sempre interessato, forse memore dei racconti dei nonni le cui origini erano contadine. Dagli inizi del del secolo scorso fino all’incirca alla sua metà si può così leggere delle vicende dei Bruni, in origine coltivatori a mezzadria di un appezzamento di terreno, una bella famiglia patriarcale con padre, madre e, circostanza frequente all’epoca, un bel po’ di figli. Se l’ambiente è reso bene, tuttavia si può notare già dalle prime pagine come sia approssimativa la caratterizzazione dei personaggi, circostanza che si accentua mano mano che passano gli anni con il naturale aumento dei protagonisti, poiché i figli e le figlie si sposano, e a loro volta hanno altri figli; questo, proprio per la carenza di caratterizzazione, fa sì che si possa ingenerare un po’ di confusione. Inoltre, l’autore sembra tendere a privilegiare più le vicende che gli indispensabili contorni ed è così che si sofferma a lungo sull’esperienza della prima guerra mondiale, peraltro resa bene, anche se, per uno storico come lui, è sorprendente il madornale errore che ha commesso quando scrive che alla morte dell’imperatore Francesco Giuseppe gli succede il figlio Carlo, ma quest’ultimo è tutt’altro, è un pronipote, e neanche in linea retta, ma collaterale visto che lo scomparso monarca era un suo prozio. Comunque, fino agli anni della guerra d’Etiopia il libro scorre bene e la lettura è anche piacevole, benchè Manfredi non vada a fondo negli eventi che contano, come il sorgere del fascismo. Da circa il 1936 la macchina narrativa comincia a perdere colpi, a incepparsi e si arriva in un attimo alla seconda guerra mondiale, di cui si parla poco, tranne quando, dopo l’8 settembre del 1943, inizia la Resistenza, anche questa trattata abbastanza superficialmente, peraltro con un tono da leggenda. Inoltre, é netta l’impressione che l’autore sia stanco e abbia fretta di finire il suo lavoro, o che comunque abbia perso il filo conduttore, visto che certi personaggi, a cui si era dato risalto, scompaiono senza che si sappia più nulla di moro, mentre ne entrano altri come se questi ci fossro noti e invece ci sono perfettamente sconosciuti, perché Manfredi non ne ha mai parlato prima. Anche il declino della civiltà contadina é appena abbozzato, tanto che viene da chiedersi perché sia poi finita, il tutto in presenza di una costante approssimazione che è lecito trovarsi nel caso di un autore alle prime armi, ma che non mi sarei mai aspettato da un narratore di lungo corso. Per farla breve, ho iniziato il romanzo colmo di entusiasmo, entusiasmo che è andato scemando per essere sostituito da una perniciosa noia, tanto più che, mano a mano che mi avvicinavo alle ultime pagine, cresceva in me l’impressione di trovarmi di fronte a una telenovela. Le intenzioni dell’autore erano senz’altro buone, ma la realizzazione, purtroppo, è risultata inadeguata. Il libro si può leggere, ma solo se si sorvola sulle molte lacune.
Valerio Massimo Manfredi (Modena, 1943), scrittore, archeologo, topografo del mondo antico,
ha condotto spedizioni archeologiche in molte località del
Mediterraneo.
6 Dicembre
Celestina di Adalgisa Zanotto Fara Editore Narrativa racconti Collana Narrabilando La riscoperta dei sentimenti Ci sono dei libri, che senza essere dei capolavori, hanno il pregio di lasciare traccia nel lettore, testi che vanno oltre il semplice scopo dello svago, ma che, pur consentendo di trascorrere piacevolmente qualche ora, portano a uno stato d’animo di pacata e corroborante serenità. Non sono molte queste opere, anzi sono poche, tutte contraddistinte da una scrittura semplice, da una capacità di saper toccare quei sentimenti che sono propri di ogni essere umano e che spesso giacciono assopiti dentro di noi. E questo il caso di Celestina, una raccolta di racconti di cui uno dà il titolo all’intero libro. Sono storie non fuori dall’ordinario, né ci sono protagonisti dalla forte e coinvolgente personalità, ma sono capaci di coinvolgere, nonostante alcuni marcati toni di tragedia, grazie a una vena malinconica che smussa, attenua e, anziché imporre, chiede che siano accolte. E soprattutto insegnano ad amare la vita, nonostante tutto, una lezione che fa leva sull’ancora di salvezza di ogni uomo: la pietà, per gli altri, ma soprattutto per noi stessi. Anche nelle situazioni più difficili, così come nei piccoli-grandi drammi domestici, la riscoperta dei sentimenti dirada le tenebre e fa trionfare la luce. Giocare sugli stati emotivi può essere rischioso, può far cadere facilmente nel déja vu, ma l’abilità dell’autore è nel proporli con un disarmante candore, senza la sensazione di un qualcosa di artefatto, con una spontaneità tale da sembrare che quelle parole escano direttamente dal cuore. É piacevole commuoversi di fronte a certe storie, come quella della bimba nata cieca e che ha la forza di vedere nel puro e reciproco sentimento dell’amore, o di Celestina, che lascia il suo piccolo mondo per andare a vivere in un ospizio e che trova una ragione per continuare a esistere in Anita, sua compagna di stanza. Sono storie minimali, forse, ma hanno tutta la parvenza di essere vere e soprattutto attuali, scritte con delicatezza, con rispetto, oserei dire in punta di penna, e che con umiltà e timidezza bussano alla porta del nostro cuore. Adalgisa Zanotto vive a Marostica. È coniugata e madre di tre figli; lavora presso un Ente Pubblico. Collabora con gruppi di scrittura creativa e laboratori di poesia. È attiva in associazioni impegnate nel volontariato sociale. La passione per la scrittura l’accompagna da sempre, “scompagina la sua vita, accresce la sua libertà, allunga i passi del cuore”. Suoi racconti e poesie sono inseriti in diverse antologie. Ha ricevuto vari riconoscimenti e segnalazioni: ultimamente ha vinto la sez. Racconto del concorso per opere brevi Rapida.mente 2015 con pubblicazione premio nella omonima antologia; il suo racconto La fessura è stato selezionato dal concorso Come farfalle diventeremo immensità e pubblicato nella antologia La mia sfida al male (Fara 2016). Il suo testo Scremature è inserito nel libroUno scarto di valore a Bardolino(Fara 2016).
Foto di copertina di Valter Binotto www.valterbinotto.it
3 Dicembre
Favole di Fedro Saggio introduttivo di Paola Corradini Nuova traduzione e note di Lorenzo Montanari Testo latino a fronte Rusconi Editore
Narrativa favole Divertenti ed educative Per quanto, analogamente a Esopo e a La Fontaine, Fedro venga giustamente considerato uno dei maggiori favolisti è ancora oggi ben poco conosciuto, non tanto la sua produzione quanto invece la sua vita, elemento per certi aspetti indispensabile per inquadrarlo con esattezza nel panorama letterario. Del resto se molti hanno letto, tanto per fare un esempio, Il lupo e la gru e Il lupo e l’agnello e sanno che sono state scritte da Fedro, quando ci si chiede chi sia stato questo autore si entra nel campo del totalmente vago. Incerte sono le sue origini, forse elleniche, certo invece è il fatto che fosse uno schiavo liberato, cioè un liberto. E in tale condizione, cioè di uomo solo in parte affrancato, le scrisse, probabilmente per conquistare, se non il successo economico, quella fama che non solo gli consentiva di essere almeno pari agli uomini liberi, ma di risultarne addirittura superiore. É probabile che almeno in parte abbia raggiunto tale ambito traguardo, più in epoche successive alla sua esistenza che in quella in cui operò, anche perché a Roma il genere favolistico era considerato “minore”, pur possedendo un carattere tipicamente pedagogico e una finalità educativa. A noi sono pervenuti, incompleti, cinque suoi libri in versi senari (dunque si tratta di poesie) e, come scrive lui stesso nel prologo al primo libro, lo scopo é di far ridere e di fornire dei saggi consigli sul modo di vivere. Così animali e piante parlano in una consecuzione di metafore che celano comportamenti umani e che sono propri della favola, quindi da non confondere con la fiaba, popolata quest’ultima da folletti e orchi, cioè da creature di pura invenzione. Qualcuno potrà obiettare che questi testi potrebbero celare intenti satirici e in effetti i comportamenti umani narrati potrebbero lasciarlo intendere, ma il genere satirico, altro genere minore nell’antica Roma, non rientrava nelle intenzioni di Fedro, e comunque più che un riferimento a singoli personaggi si tratta sempre di una descrizioni di vizi, o difetti, tipici di non pochi uomini. Il rischio tuttavia che qualche potente potesse identificarsi in qualche animale o pianta c’era sempre e infatti Seiano, il potente ministro dell’imperatore Tiberio, lo fece processare, ipotizzando delle allusioni non gradite a chi allora contava; Fedro fu fortunato, poiché ne uscì senza danni, probabilmente per l’improvvisa scomparsa del suo accusatore, tanto che continuò a scrivere indisturbato i suoi amati senari. Se mi può sembrare superfluo, oltre che dispersivo, parlare di tutte queste favole, che nel libro in questione sono riportate nella bella traduzione di Lorenzo Montanari con il testo latino a fronte, mi corre invece l’obbligo di evidenziare che i fruitori della lettura non devono essere considerati solo i bambini, ma anche e soprattutto gli adulti, in tempi come gli attuali dove è possibile trovare gli stessi difetti di allora, spesso più tipici dei potenti che degli umili, come era Fedro, il che starebbe a giustificare il ripetersi, immutabile, della storia. Comprensibili, grazie anche alle note, e pure divertenti , le Favole di Fedro non hanno perso nulla del loro antico smalto e la fantasia dell’autore è accattivante, invoglia a leggere, a scoprire, a verificare, cogliendo così quello scopo educativo originario e tributando all’autore quella fama ormai imperitura di cui ai suoi tempi non poté essere gratificato. Gaio Giulio Fedro (20/15 a.C. circa - 51 d.C. circa) é stato uno scrittore romano, autore di celebri favole. Paola Corradini, laureata in “Filologia, letteratura e tradizione classica” presso l’Università degli Studi di Bologna , è docente di Lettere e studiosa di lingua e cultura latina. Si é occupata di problemi di didattica, collaborando alla realizzazione di testi scolastici.
Lorenzo Montanari, studioso di
lingua e cultura latina, é dottore di ricerca in Filologia Classica e
insegna Lettere nei licei. Si occupa di didattica del latino ed è
autore di testi scolatici.
30 Novembre
La principessa del Nord. La misteriosa vita della dama del Risorgimento: Cristina di Belgioioso di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia biografia
Nata troppo presto Cristina Trivulzio di Belgioioso nacque Milano il 28 giugno 1808 e lì morì il 5 luglio 1871. Benché nobile per nascita (i Trivulzio erano una nota famiglia aristocratica milanese) divenne principessa a seguito del matrimonio con il giovane e avvenente principe Emilio Barbiano di Belgioioso, uno scapestrato, che dilapidò una bella fetta del patrimonio della moglie e che le trasmise anche la sifilide. Questa donna, che fu una delle più importanti figure del nostro Risorgimento, é quasi sempre dimenticata negli insegnamenti scolastici o, al più, se ne da un breve cenno, come se fosse stata, in quel grande teatro della rinascita nazionale, poco più di una comparsa. Forse questa trascuratezza é dovuta al sesso, ma se si guarda bene la sua vita, di cui Arrigo Petacco ha scritto ampiamente, si potrà notare che vi sono altri motivi, ben più rilevanti. Già alla sua epoca le donne non le perdonavano la sua notevole bellezza e gli uomini la sua prodigiosa intelligenza, ma c’é ben altro in questo personaggio che oserei definire unico, nato probabilmente troppo presto (sarebbe stato meglio accolto nella seconda metà del secolo successivo). Benché nobile e ricchissima era convinta che solo con l’istruzione dei suoi cittadini uno stato avrebbe potuto dar corso alle riforme che gli erano necessarie e che potevano così essere comprese da tutti. Per quanto questo straordinario principio fosse all’epoca non solo bel lungi dall’essere messo in pratica, ma nemmeno ipotizzabile, lei diede prova che poteva essere realizzato e così nella sua proprietà di Locate creò una scuola pubblica, aperta anche alle donne. Per chi deteneva le leve del potere, e non si trattava solo della corte di Vienna, ma anche di milanesi illustri, la cosa non garbò, tanto che Alessandro Manzoni, sì il celebre scrittore, considerò questa iniziativa un evidente sintomo della follia di Cristina. In effetti, chi portava avanti idee avveniristiche, allora come oggi, era visto come un essere non in pieno possesso delle facoltà mentali, soprattutto da quelle menti ristrette e bacchettone, fra le quali possiamo annoverare anche Manzoni, che a quei tempi pretendevano di imporre il loro grigio e monotono stile di vita. Carbonara, antiaustriaca, egalitaria con idee che si potrebbero definire socialiste Cristina Trivulzio aveva tutto quanto per indispettire chi comandava e per quanto abbia dato un notevole contributo al nostro Risorgimento non ha risparmiato nei suoi scritti accuse ai politici, avulsi dalla realtà, come oggi, e tesi solo al . predominio del loro interesse. Scriveva senza remore, diceva sempre ciò che pensava – e pensava bene -, mettendo in piazza tutto quanto non era di dominio pubblico (e non erano bagatelle), insomma é facile ora comprendere perché una simile protagonista non abbia ancor oggi il rilievo che meriterebbe e una riprova ulteriore è data dal fatto che al suo funerale non presenziò nessuno dei politici di quella Italia che lei, disinteressatamente e con passione, aveva contribuito a unire. Ripeto che era nata troppo presto, ma non è troppo tardi per riconoscerle quegli onori che tanto meriterebbe. La biografia di Petacco é puntuale, ma il personaggio è vulcanico, si sposta di continuo e, pur con la cura e l’abilità dell’autore, non è difficile perdere il filo del discorso, e allora il riallacciarlo ogni tanto è l’occasione per comprendere pienamente la grandezza di questa donna.
Arrigo Petacco è nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear
Benito, caro Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il
Prefetto di ferro, La principessa del Nord, La Signora della Vandea,
La nostra guerra. 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio
segreto di Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in fuga, La
storia ci ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
27 Novembre
Il peso dello zaino di Giulio Bedeschi Gruppu Editoriale Mursia Narrativa romanzo
Il dopo
Giulio Bedeschi,
alpino, medico e scrittore, nasce ad Arzignano, in provincia di
Vicenza, il 31 gennaio 1915. Nel 1940 ottiene l’abilitazione alla
professione medica e frequenta la Scuola Allievi Ufficiali presso la
Scuola Militare di Sanità a Firenze. Ufficiale medico, andò
volontario prima sul fronte greco-albanese, poi, nel 1942, venne
trasferito sul fronte russo dove, con gli alpini della Julia, visse
la tragedia della ritirata che raccontò nel suo capolavoro Centomila
gavette di ghiaccio (Mursia, 1963). Nel 1966
pubblica Il peso dello zaino, ideale continuazione delle
Gavette, nel quale racconta le vicende dei reduci dalla
Russia dopo l’8 settembre 1943. Nel 1972 dà alle stampe due nuovi
titoli: La rivolta di Abele e La
mia erba è sul Don. Negli anni Settanta e Ottanta
cura per Mursia la serie «C’ero anch’io», monumentale raccolta di
testimonianze di coloro che combatterono sui fronti della Seconda
guerra mondiale. Nel settembre del 1990 torna in Veneto, a Verona,
dove morirà nel dicembre dello stesso anno. Nel 2003 è stata
pubblicata la raccolta di scritti Il
Natale degli alpini e nel 2004
Il segreto degli alpini. segreto degli Tutte le opere
di Giulio Bedeschi sono edite in Italia da Mursia.
24 Novembre
Un delitto in Olanda di Georges Simenon Traduzione di Ida Sassi Edizioni Adelphi
Narrativa Non è sempre oro ciò che luccica A Delfzijl, un paesino olandese, il professor Jean Duclos è incolpato dell’omicidio del capitano di lungo corso Conrad Popinga, in quanto trovato con l’arma del delitto in mano. Maigret vi viene inviato di supporto alla polizia del luogo e per l’assistenza all’incriminato, in quanto francese, ma sopratutto famoso per i suoi studi da criminologo. Questo è l’antefatto del poliziesco Un delitto in Olanda, ottavo romanzo di Simenon con protagonista il commissario Maigret. Lo scrittore belga sta ancora affinando le sue indubbie capacità descrittive dell’ambiente e dei personaggi, ma è già assai prossimo al raggiungimento degli eccellenti risultati che gli sono propri. Più che la trama emergono così i fatti e i misfatti di un piccolo mondo borghese che all’apparenza si presenta come paradisiaco, con un ordine perfetto che stupisce, ma che non incanta. Delfzijl è una dorata prigione e sfuggire alle convenzioni che lo regolano è arduo, quasi impossibile; eppure, c’è chi tenta, ma i risultati sono alquanto deludenti e, addirittura nel caso della vittima, nefasti. Il nostro Maigret quasi gigioneggia nel prendere in mano di fatto le indagini, desideroso di scoperchiare un pentolone di ipocrisie, di buone maniere che nascondono il soffocamento di istinti naturali. É quasi superfluo dire che, procedendo in una intricata ricostruzione dei fatti, finirà con l’assicurare alla giustizia il colpevole, ma senza particolare soddisfazione, se non quella di dare una scrollata decisa a un mondo rigido e formale, poi ritornerà a Parigi, pronto a intraprendere altre indagini. Un delitto in Olanda ha il pregio anche di poter essere letto velocemente e quindi di essere l’ideale passatempo di qualche ora, senza che imponga grandi sforzi intellettivi, perché la famosa analisi psicologica dei personaggi, una costante della produzione di Simenon, qui è appena abbozzata, preferendo l’autore dare maggior risalto all’ambiente e all’atmosfera.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
19 Novembre
La nostra guerra 1940 – 1945 L’avventura bellica tra bugie e verità di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia La ricerca della verità Il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annunciò all’Italia che le dichiarazioni di guerra erano state consegnate agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna; dalla folla che gremiva l’immensa piazza si levò un unanime urlo di consenso. Certo, nella moltitudine moltissimi erano i fascisti di provata fede, ma è anche vero che alla luce delle impressionanti vittorie dell’alleato tedesco si era convinti che il conflitto potesse avere brevissima durata e con esito a noi ampiamente favorevole. Lo stesso Duce aveva questa convinzione, benchè sapesse della nostra impreparazione; quindi giocò d’azzardo e, come sappiamo, perse e con lui persero tutti gli italiani, gravati da una guerra disastrosa e terrificante. Quindi Mussolini, nel mentire al popolo sulle nostra capacità belliche, mentì anche a se stesso e del resto, come ebbe a dire Churchill, in tempo di guerra la verità è così preziosa che bisogna nasconderla dietro una cortina di bugie. In tutti i conflitti, anche quelli in corso, questa massima è puntualmente rispettata, ma se ce fu uno in cui divenne pratica comune fu proprio quello del 1940 – 1945. In un regime che viveva di menzogne queste, a maggior ragione, erano continue durante la guerra, ma sarebbe un errore attribuire le colpe unicamente al Duce, che pure restano e sono gravissime, in quanto ampie responsabilità sono attribuibili alle classi politiche, militari, economiche e anche intellettuali, animate da una fiducia incondizionata in Mussolini, trasformata in occulta e anche palpabile avversione quando le cose cominciarono ad andare male. Insomma, senza voler troppo polemizzare, il ventennio e la guerra ci sono stati perché hanno trovato il terreno di coltura idoneo in un popolo ben poco socialmente unito, con ampi strati volti a coltivare illusioni, salvo poi, quando si rivelano tali, scaricare tutte le colpe su chi le ha propinate. Arrigo Petacco, con la sua scrittura semplice, ma efficace, scrive la storia di questi cinque anni di guerra con un ritmo incalzante, senza ricorsi alla retorica e cercando di far luce sulle tante menzogne dell’epoca; certo, parlare a posteriori di questo tragico evento può sembrar facile, anche per i numerosi studi effettuati nel dopo guerra; quello che è difficile é l’essere imparziale nei giudizi e mi sembra che l’autore lo sia stato, volto a togliere ogni mito, perfino quello della Resistenza, pur attribuendole un valore rilevantissimo. La realtà è ciò che vediamo, la verità è quello che spesso non riusciamo a scorgere; Petacco non ha la pretesa di portare agli occhi del lettore la verità assoluta, ma solo quella di fare un po’ più di chiarezza, perché capire ciò è effettivamente accaduto è l’unico modo, poi, per mettere in pratica tutto quanto necessario affinché non si ripeta. Il libro é appassionante, e spesso si legge come un romanzo, con un palcoscenico su cui trovano posto tutti i grandi dell’epoca, ma anche i popoli e gli eserciti, in un dramma intenso e che coinvolge emotivamente fino al suo epilogo.
Arrigo Petacco è
nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear Benito, caro
Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il Prefetto di ferro,
La principessa del Nord, La Signora della Vandea, La nostra guerra.
1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio segreto di
Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in
fuga, La storia ci
ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
14 Novembre
David Golder di Irène Némirovsky Traduzione di Margherita Belardetti Edizioni Adelphi Narrativa romanzo Collana Biblioteca Adelphi
Alta finanza David Golder é stato il primo romanzo di Irène Némirovsky ad essere pubblicato e al riguardo c’è un aneddoto che, forse, risponde a verità: l’editore, letto il manoscritto che aveva ricevuto per posta, volle conoscere personalmente l’autore, al fine di fugare l’eventualità che questo fosse il prestanome di qualche narratore famoso. In effetti l’opera stupì non poco il pubblico, trattandosi di opera prima e già comunque di notevole livello, per quanto a mio parere, inferiore a successivi romanzi. Per esempio, se già si intravvede la capacità di analisi che è propria della Némirovsky, lo stile non è così fluido come nelle produzioni che seguiranno e anche la costruzione, per quanto robusta, non è ancora così equilibrata come quella a cui ci ha abituato. Resta però il fatto che in un’epoca in cui la finanza, l’alta finanza, prosperava allegramente, anche se il 1929, con la grande crisi, è ormai prossimo, la scrittrice ucraina smonta certi falsi miti, fornendoci un quadro impietoso del mondo degli affari, fatto da rapaci senza cuore e che maturano sempre di più la convinzione che con il denaro si possa comprare tutto, anche l’amore. La figura di questo satrapo ebreo, il cui nome é un vaticinio, riluce di triste squallore, anche se tuttavia alla fine – una conclusione edificante che era forse d’obbligo, trattandosi del primo romanzo – l’uomo si riscatta, e non per interesse, ma per affetto. Forse non é un caso che il protagonista sia ebreo, visto che il padre della Némirovsky era un celebre banchiere israelita, e poi, senza voler cercare una casistica, di imprenditori ebrei nell’alta finanza ce ne sono sempre stati tanti. Comunque, ebrei o cristiani, agnostici o atei, questi capitalisti del denaro si somigliano tutti e Irène Némirovsky sembra volerci suggerire che dove questi Re Mida posano le loro mani la vita si svilisce, il denaro e solo il denaro diventa lo scopo dell’esistenza e l’inaridimento é crescente, tanto che lo splendore esterno non riesce più a camuffare il vuoto che si portano dentro. Da leggere, senz’altro.
Irène Némirovsky
(Kiev, 11 febbraio 1903; Auschwitz, 17 agosto 1942).
9 Novembre
Le due guerre Guerra fascista e guerra partigiana di Nuto Revelli Edizioni Einaudi Storia Affinché chi non sa possa sapere Questo libro ha una strana origine, in quanto nasce dai testi preparatori e dalle lezioni tenute presso l’Università di Torino comprese nel corso 1985 – 1986 di Storia contemporanea tenuto dal professor Giorgio Rochat, con il tema “L’Italia nella Seconda guerra mondiale”. In tale ambito, su invito del cattedratico, Nuto Revelli ha tenuto una serie di lezioni sulla base dell’esperienza acquisita e con lo scopo di far conoscere ai giovani studenti che cosa fosse il fascismo nel ventennio. E lo scrittore piemontese era più che qualificato per tenerle, con il suo passato di fascista, come erano tutti gli italiani senza sapere cosa fosse il fascismo. Nel discorso se ne inserisce un altro e cioè se la storia deve essere vista dall’alto, dal quadro generale, o se debba essere frutto del particolare, delle vicende di ognuno degli ignoti protagonisti. Revelli in questo è salomonico, nel senso che ritiene che di debba tener conto di entrambi i metodi, per quanto sia visceralmente portato al contatto umano, a quelle piccole storie che nel loro insieme fanno la grande storia. Seguiamo così la sua personale storia, da fascista inconsapevole e anche orgoglioso di esserlo, come può essere un giovane cresciuto a libro e moschetto, alla tragica realtà della nostra avventura in Russia nel corso della seconda guerra mondiale che aprirà (meglio tardi che mai) gli occhi a moltissimi. Si svelano in quel tragico teatro bellico le menzogne del regime: il nostro esercito é il più organizzato del mondo (e invece la disorganizzazione era la regola), la nostra aviazione é la più forte di tutte (e invece faceva pena), il nostro armamento è insuperabile ( e si combatteva con fucili progettati nel 1891 e con la preda bellica della Grande Guerra). L’autore rivive i tragici giorni della ritirata, il ritorno in Italia, lo sconforto per chi non crede più in un sistema e non ha al momento alternative. Queste verranno, dopo il 25 luglio 1943 e, soprattutto, dopo l’8 settembre dello stesso anno. La ribellione, prima ancora che un atto politico, è un atto intimo, è la presa di coscienza che è indispensabile ripensare la propria vita. Ed è dura l’esistenza alla macchia, braccati dai fascisti e dai tedeschi, con poco cibo e il domani sempre incerto. Revelli non é uno spaccone e ci parla della sua esperienza partigiana senza mai esaltarsi, citando vittorie e sconfitte, anche se la sconfitta peggiore sarà il dopo, finita la guerra, con i fascisti che rialzano la testa e vogliono ritornare protagonisti di un paese che nelle sue istituzioni non li avversa, ma spesso li aiuta. Scritto in modo semplice e immediato Le due guerre é un libro che tutti dovrebbero leggere, che dovrebbe rientrare nei programmi scolastici, perché chi per l’età non può sapere deve essere reso edotto di quale immane tragedia sia stato il fascismo.
Nuto Revelli (Cuneo,
1919-2004), ufficiale degli alpini in Russia e protagonista della
Resistenza nel cuneese, si è battuto per anni per dare voce ai
dimenticati di sempre: i soldati, i reduci, i contadini delle
campagne piú povere. Tra i suoi libri, tutti editi da Einaudi, La
guerra dei poveri (1962), La strada del davai (1966 e
2010), Mai tardi (1967 e 2008) , L'ultimo fronte (1971
e 2009) , Il mondo dei vinti (1977), L'anello forte (1985) Il
disperso di Marburg (1994 e 2008), Il prete giusto (1998 e
2008), Le due guerre (2003 e 2005), Il popolo che manca (2013),Il
testimone. Conversazioni e interviste. 1966-2003 (a cura di Mario
Cordero).
6 Novembre
Consonanze di Caterina Trombetti e Antonella Natangelo Betti Editrice Poesia e musica Pagg. 44 + CD L’armonia Che la poesia e la musica possano incontrarsi è del tutto naturale, trattandosi in entrambi i casi di arte e l’arte, perché sia veramente tale, non può prescindere dall’armonia, da quel perfetto equilibrio strutturale in cui sia che si tratti di parole, sia che ci troviamo di fronte a delle note, tutto sembra essere messo lì certamente non per caso, ma per fornire una musicalità che è gioia per gli occhi e per le orecchie. Del resto, anche nel caso di non poche pellicole cinematografiche, la colonna sonora costituisce un naturale completamento che dona forza alle immagini. Al riguardo mi viene in mente l’Alexander Nevskij di Ejzenstejn in cui l’omonima sinfonia di Prokofev permea scene, con i ritmi che si incrociano e che si espandono all’unisono. Leggere una poesia, ascoltando una composizione musicale creata apposta per la stessa, è un’esperienza esaltante che consiglio vivamente ed è questo il caso di questo libriccino in cui l’ars poetica di Caterina Trombetti si fonde perfettamente con l’arte musicale di Antonella Natangelo. L’arpa, nel caso specifico, sembra poi lo strumento migliore per ricreare atmosfere e rafforzare le sensazioni che prorompono dai versi. Già di per sé queste poche liriche sono ben riuscite, ma il tocco musicale appare come un completamento imprescindibile, anche se, occorre dire, l’ascolto della musica senza la lettura delle poesie svilisce un po’ la composizione, insomma, per dirla in breve, esiste una complementarietà da cui entrambe le arti traggono i massimi vantaggi. E il suono pacato dell’arpa ben si presta alla natura dei versi, così che è possibile assaporare sensazioni ed emozioni per certi aspetti impareggiabili. Ci si rasserena, il mondo che ci circonda appare diverso, una sospensione di suoni, di immagini, in continua evoluzione ed evanescenza, una sorta di limbo in cui è piacevole restare, perché la vita, la tanto vituperata vita, scorre diversa, soffusa di un tenue e corroborante colore rosa. Quindi, Consonanze é senz’altro da leggere e ascoltare.
Caterina Trombetti, è nata a Firenze, vive a Scandicci. Insegnante di lettere e
pedagogista, dopo la laurea ha conseguito il Diploma Perfezionamento
in Traduzione Letteraria all'Università di Firenze.
Antonella Natangelo è
nata a Firenze e vive a San Gimignano in Toscana. Studia tecnica vocale, canto barocco e composizione. Dal 2007 è iscritta a S.I.A.E. Ricercatrice di brani antichi si è specializzata nel Medioevo, intraprendendo un percorso di ricerca filologica ( XIII - XIV sec). Prossima la pubblicazione di una raccolta di brani medievali e rinascimentali di cui la musicista ha curato l'accompagnamento strumentale.
E' una " pioniera " in Italia del canto accompagnato da arpa, il
repertorio spazia dal medioevo, musica classica, celtica, barocca,
sacra vocale e strumentale a sue composizioni per arpa e voce. Si
esibisce in concerti, festivals, eventi culturali, teatrali in Italia
e all'estero.
2 Novembre
A Mosca, solo andata. La tragica avventura dei comunisti italiani in Russia di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. Storia Nell’inferno staliniano Quando imperava il fascismo, alle cui regole tutti dovevano assoggettarsi, non mancavano però gli oppositori, ai quali erano riservate, nel migliore dei casi, le bastonature e l’olio di ricino, oppure venivano condannati al confino e anche imprigionati. Molti di loro, però, fuggivano all’estero, in paesi certamente più ospitali come il Belgio e la Francia, e, nel caso dei comunisti, non certo pochi trovarono rifugio nell’Unione Sovietica, mitizzata come il Paradiso Marxista. Una volta là, però, dovettero accorgersi che non di paradiso si trattava, bensì di inferno, vittime pure loro delle epurazioni staliniane. E non si trattava di bastonature e di olio ricino, ma di vere e proprie sadiche torture, di fucilazioni, di lunghi periodi di detenzione nei famigerati gulag. Anche stare accorti nel parlare non era sufficiente e non di rado si era arrestati solo per aver scambiato due parole con un altro compagno incriminato, o addirittura per colpire altri soggetti, cercando, grazie alle sevizie, di ottenere denunce del tutto infondate. Eh sì, nel periodo in cui imperava Stalin in Russia era difficile vivere, ma in cambio era facilissimo morire. I dirigenti del PCI, il partito comunista italiano, e in primo luogo il loro segretario Ercole Ercoli, pseudonimo di Palmiro Togliatti, erano ben consapevoli dei patimenti dei compagni connazionali, ma stavano zitti e con l’abilità dei camaleonti riuscirono a uscirne indenni, ovviamente mai raccontando di quei fatti al loro ritorno in patria dopo la caduta del fascismo. Questo non deve sorprendere, perché la politica é una sporca faccenda; quello che sorprende invece è che coloro che incorsero nelle purghe staliniane e riuscirono a sopravvivere rimasero di incrollabile fede comunista, alcuni cercando giustificazione dei torti subiti in qualche inconsapevole comportamento deviazionista, altri invece solo per pura fede. Fra questi ultimi anche Paolo Robotti, cognato di Togliatti, che pur pubblicando nel 1965 un libro su quel periodo funesto rimase uno stalinista convinto, un atteggiamento che a definirlo masochista non spiega del tutto i motivi. Il culto della personalità era talmente radicato che la ferocia di Stalin veniva accettata supinamente, come il castigo di un Dio che rappresentava con poteri assoluti la loro ideologia politica. Quanto al Partito Comunista Italiano, nonostante le malefatte di Stalin svelate da Chruscev, pensò bene di non rendere edotti i suoi numerosi iscritti, nel timore, giustificabile, che non pochi avrebbero stracciato la tessera. Di questo parla il bel saggio storico di Arrigo Petacco e lo fa con elementi probatori, con un atteggiamento super partes che gli fa onore e che in fondo fornisce all’opera la necessaria credibilità. Da leggere, ovviamente.
Arrigo Petacco è nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear
Benito, caro Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il
Prefetto di ferro, La principessa del Nord, La Signora della Vandea,
La nostra guerra. 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio
segreto di Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in fuga, La
storia ci ha mentito e Ho sparato a Garibaldi.
15 Ottobre
L’orchessa e altri racconti di Irène Némirovsky Traduzione di Simona Mambrini Edizioni Adelphi Narrativa racconti Collana Biblioteca Adelphi L’arte del sublime Sono nove i racconti di questa raccolta e testimoniano una volta di più le grandi capacità letterarie di Irène Némirovsky. Benchè queste siano ben note sono rimasto sorpreso di trovare una straordinaria abilità nel raccontare trame che potrei definire convenzionali, ma la cui trasposizione beneficia, pur a fronte di uno stile che può apparire semplice, di un’elaborazione completa e complessa in cui si mantengono in perfetto equilibrio le descrizioni dell’ambiente e dell’atmosfera, nonché la capacità indiscutibile di sondare l’animo umano, il tutto accompagnato da una vena poetica tenue, ma incisiva. Così, ognuno di questi racconti diventa l’espressione dell’arte del sublime, tanto belli sono e tanto lasciano nel lettore una palpabile commozione che rasserena l’animo. I protagonisti sono per lo più donne, anche se non mancano soggetti maschili di grande interesse, ma ciò che soprattutto li accomuna è il sempre presente senso della caducità della vita, di quella morte che finisce con il dare un senso alla vita. La figura del procuratore Deprez (L’inizio e la fine) incombe nella prosa con i suoi tormenti per il male che lo divora, mentre altri dolori patisce la signora Barret, la madre di un giovane assassino, che lui dovrà processare, il tutto in un chiaroscuro quasi tenebroso, dove si affrontano amore materno e senso del dovere, pietà e dignità, rimorsi e volontà. Sono tutti belli questi racconti, compreso l’ironico L’orchessa, che esce un po’ dai canoni consueti con la figura di una donna che pretende di portare al successo la propria figlia, a quel successo che lei non ha mai avuto. Personalmente mi sono piaciute particolarmente due prose: Legami di sangue e La confidente. La prima vede i figli riuniti al capezzale dell’anziana madre gravemente malata in un crescendo di screzi e di confessioni, in cui riaffiorano antiche gelosie; parenti serpenti, si potrebbe dire, e se il tema non é proprio nuovo, tuttavia per come é svolto attrae in modo irresistibile, senza dimenticare le inevitabili ricorrenti riflessioni a cui si è indotti, soprattutto se non si è figli unici. La seconda vede l’incontro fra un musicista vedovo e un’amica della moglie defunta, in un dialogo rivelatore, di cui non intendo anticipare nulla, vista l’impostazione gialla, anche se giallo non é; sono pagine che, a dir poco, affascinano, un esercizio di rara bravura, di cui mi corre tuttavia l’obbligo di riportare il grande significato dell’arte secondo l’autore, con ciò che riesce a dare l’artista; infatti, rivolgendosi al signor Dange, famoso musicista, la signorina Cousin dice a proposito della grandezza del suo interlocutore: “….Un mondo sublime. E noi, noi non siamo niente, solo povere creature inutili. É così raro, così bello, quando un grande artista si concede, ci fa uscire dalla dalla nostra mediocrità, parla con noi. É qualche cosa di immenso, signore.”. Non aggiungo altro, se non la raccomandazione di leggere questo altro capolavoro di Irène Nèmirovsky.
Irène Némirovsky
(Kiev, 11 febbraio 1903; Auschwitz, 17 agosto 1942).
12 Ottobre
Il fidanzamento del signor Hire di Georges Simenon Traduzione di Giorgio Pinotti Edizioni Adelphi Narrativa romanzo Collana Biblioteca Adelphi Caccia al mostro Il brutto, in quanto diverso ed evitato, rappresenta da sempre il classico capro espiatorio, perchè considerato un mostro e che certi aspetti fisici colpiscano in modo negativo la gente é testimoniato anche dal fatto che lo psichiatra italiano Cesare Lombroso pretese di identificare un individuo come criminale attraverso alcuni tratti somatici. Da un bel po’ sappiamo che si sbagliava, ma la sua teoria ebbe largo seguito in passato. Alla periferia di Parigi, dietro un cespuglio viene ritrovato il corpo, fatto a pezzi, di una prostituta e dato che nei pressi abita il signor Hire, che è tutt’altro che un adone e conduce una vita solitaria e appartata, i sospetti, coram populo, si appuntano subito su di lui, che, cercando di sviare i pedinamenti della polizia, finisce con l’accrescere la convinzione che sia il colpevole. Hire é invece un uomo mite, timido, che non ha rapporti con le donne, ma che ama spiare una vicina, la quale se ne accorge e inizia a condurre una specie di gioco erotico, che attira sempre di più l’uomo. Non vado oltre, perché il romanzo é bello e lascia con il fiato sospeso e anche se si fa largo la convinzione che monsieur Hire non c’entri, resta però un dubbio salutare che appassiona ulteriormente. L’incapacità del protagonista di relazionarsi, soprattutto con l’altro sesso, é splendidamente descritta da Simenon, con quest’uomo che osserva, interessato, la vicina che si spoglia e che sa di essere guardata; si poteva cadere nel ridicolo, o peggio nel pornografico, ma la misura dell’autore è tale che viene evitato, anche perché il fine di questo tratto voyeuristico non è tanto quello di attirare morbosamente il lettore, bensì è il mezzo per arrivare a dimostrare i complessi di un uomo che è tutto fuorchè un criminale. E tale é la complessità del soggetto che resta inerte anche quando la vicina gli si offre e lui è incapace di cogliere l’occasione, di manifestarle il suo desiderio, la sua passione, il suo amore, rifugiandosi nuovamente in un’altra realtà a lui dimensionata in cui si sviluppano i sogni, come i progetti per una felice vita in comune, anche se questi tuttavia sembrano vicini a concretizzarsi. Indubbiamente l’analisi psicologica di Simenon giunge in quest’opera ai massimi livelli, riscontrabili solo in un altro suo romanzo, I fantasmi del cappellaio. Si tratta di autentico virtuosismo, della capacità di sondare, di comprendere e di far comprendere e alla fine proveremo anche noi la stessa pietà dell’autore per un uomo la cui vita è sempre stata contrassegnata dall’infelicità, per l’esistenza di un individuo i cui complessi l’hanno rinchiuso in un bozzolo che non si rivelerà poi protettivo. Appassionante, coinvolgente, teso come una corda di violino Il fidanzamento del signor Hire é un romanzo che è un capolavoro, l’ennesimo di Simenon.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato centonovantatre romanzi pubblicati sotto il suo nome e un
numero imprecisato di romanzi e racconti pubblicati sotto pseudonimi,
oltre a volumi di «dettature» e memorie. Il commissario Maigret è
protagonista di 75 romanzi e 28 racconti, tutti pubblicati fra il
1931 e il 1972. Celebre in tutto il mondo, innanzitutto per le storie
di Maigret, Simenon è anche, paradossalmente, un caso di «scrittore
per scrittori». Da Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner a
Cocteau, molti e disparati sono infatti gli autori che hanno
riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André Gide: «Considero
Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più
autentico che la letteratura francese abbia oggi»; Walter Benjamin:
«… leggo ogni nuovo romanzo di Simenon»; Louis-Ferdinand Céline: «Ci
sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
10 Ottobre
La scelta di Angelo Del Boca Neri Pozza Editore
Narrativa romanzo storico Interessante, sincero ed equilibrato Dopo l’8 settembre 1943, giorno in cui fu proclamato l’armistizio, con l’occupazione dell’Italia da parte delle truppe tedesche e poi la liberazione di Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso e la successiva nascita della Repubblica Sociale Italiana, uno stato fantoccio voluto fermamente da Hitler, gli italiani si trovarono nel dilemma se aderire al ricostituito partito fascista, se combattere gli occupanti o se cercare di tirare avanti senza assumersi delle responsabilità. Questa terna di scelte divenne un problema più pressante nel momento in cui Rodolfo Graziani, divenuto ministro della Guerra, indisse le chiamate di leva. Questa situazione fu vissuta direttamente anche da Angelo Del Boca, in un’incertezza costante e avvilente e alla fine lui - nato quando Mussolini aveva già imposto nel 1925 la sua dittatura, cresciuto a libro e moschetto, anche timoroso di eventuali e probabili ritorsioni nei confronti della sua famiglia - quasi ob torto collo, finì per arruolarsi. Entrò cosi a far parte della divisione alpina Monterosa, inviata in Germania per un duro periodo di addestramento. Là furono ben preparati e tornati in Italia, nonostante che il duce nel corso di una visita al reparto avesse assicurato che sarebbero stati impiegati sulla Linea Gotica contro gli anglo-americani, furono invece utilizzati per vaste operazioni di rastrellamento nelle retrovie. Se i più erano ancora non convinti della scelta fatta, altri, dei veri e propri fanatici, diedero prova di efferatezze e crudeltà contro l’inerme popolazione, circostanza che provocò moltissime diserzioni e fra quelli che se ne andarono, passando ai partigiani, ci fu proprio Angelo Del Boca. É di questo che parla il suo libro, delle sue titubanze, delle angosce nel prendere la sofferta decisione di arruolarsi nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana e poi nella piena consapevolezza che questa scelta era sbagliata, che non si doveva stare con i fascisti, ma era indispensabile unirsi ai partigiani. La scelta é un romanzo storico atipico, anche per come é strutturato, rappresentato come é da quadri, una sorta di racconti tuttavia concatenati da quell’unico filo logico costituito dal problema della difficile e sofferta decisione. É un libro soprattutto sincero e onesto che cerca anche di comprendere i motivi di chi aderì in buona fede alla Repubblica Sociale Italiana, ma conclude evidenziando che quegli stessi motivi di onore avrebbero dovuto ravvedere questi repubblichini di fronte alle infamie e scelleratezze commesse dalle truppe fasciste. Lo stile é semplice e scorrevole, mai ridondante, misurato direi; ne esce un testo di notevole valore, in cui equilibrio ed equità di giudizio sono sempre presenti. Con la Liberazione finì il periodo della Resistenza, ma è chiaramente evidenziato da Del Boca che l’immediata restaurazione, lo svilimento continuo di chi combatté per un’Italia libera e democratica, il revisionismo ripetuto si mostrarono subito e la conclusione è amara, perché passando dalla famosa vicenda del governo democristiano Tambroni sorretto dal Movimento Sociale Italiano a personaggi più recenti, decisamente populisti, come Berlusconi e Renzi, si evince che il popolo italiano non ha perso le sue radici fasciste, continua a essere socialmente prevaricatore e infine è sempre animato dal desiderio di affidare le sue sorti a un uomo della Provvidenza, e ciò nonostante le tragiche esperienze patite. La scelta è veramente un bel libro, la cui lettura è da me vivamente raccomandata.
Angelo Del Boca (Novara
1925), saggista e storico del colonialismo italiano, ha insegnato
storia contemporanea all'università di Torino. È stato insignito di
tre lauree honoris causa dalle università di Torino (2000), Lucerna
(2002) e Addis Abeba (2014). Tra le sue numerose e importanti opere
ricordiamo: L'altra
Spagna (1961), I
figli del sole (1965), Giornali
in crisi (1968), I
gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia (1996), Il
mio Novecento (2008), La
guerra d'Etiopia. L'ultima impresa del colonialismo (2010), Da
Mussolini a Gheddafi: quaranta incontri (2012).
Da Mondadori ha pubblicato: Gli
italiani in Africa Orientale (4
voll., 1992-1996),Gli italiani in Libia (2
voll., 1993-1994), L'Africa
nella coscienza degli italiani. Miti, memorie, errori, sconfitte (2002).
6 Ottobre
Con la faccia per terra e altre storie di Piero Chiara Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa racconti Un Chiara sorprendente Credevo di aver letto tutto, o quasi, della corposa produzione di Piero Chiara (mi manca Il vero Casanova e provvederò quanto prima) al punto che tempo fa ho scritto una parziale monografia dedicata a questo autore che giustamente può essere chiamato Il cantore della provincia. Credevo e mi sbagliavo, perché, quasi per caso, mi sono imbattuto in un suo libro, ben poco conosciuto, intitolato Con la faccia per terra e altre storie, insomma una raccolta di racconti, di cui uno piuttosto lungo (Con la faccia per terra) e gli altri generalmente brevi. La lettura non solo mi ha piacevolmente sorpreso, ma mi ha rivelato un Piero Chiara che, lasciate le consuete tematiche, ha saputo fornire un lavoro che a mio parere é il suo migliore. La narrazione è totalmente dedicata a un suo viaggio in Sicilia e alla figura paterna, rivelando un complesso di approfondimenti e una capacità di esporre con semplicità riflessioni di rilevante impegno . Ha ragione Geno Pampaloni quando nella sua ampia prefazione dice che non c’è tanto un compiaciuto abbandono al passato, bensì una riflessione morale, accompagnata da una scrittura lieve e da un riserbo di giudizio nel tratteggiare gli aspetti essenziali della vita. Va da sé, per quanto ho fino a ora detto, che si tratta di una vera e propria, se pur parziale, autobiografia, in cui riluce, non disgiunta dalla consueta ironia, un velo di accennata malinconia che è propria di chi vuole verificare il riscontro fra i ricordi di età giovanile e la realtà di un uomo ormai maturo. Quella Sicilia, la terra natia del padre, che da bambino e da ragazzino, in visita ai parenti, assumeva un aspetto favolistico, ora per nulla cambiata è un’amara realtà. Un tempo fermo accompagna il viaggio, o meglio i viaggi, perché costante é la coesistenza della memoria del trascorso e del presente. In Sicilia si agogna arrivare, ma là si cerca di scappare, troppo diverso è il modo di vivere fra l’estremo sud e il grande nord. Non é tuttavia una critica ai siciliani, verso cui mostra un affetto fraterno, ma è la constatazione che lì non a caso è nato Il Gattopardo e che nulla può mutare, pur fra gli eventi fragorosi del ventennio fascista e della seconda guerra mondiale. Ci sono pagine in cui l’autore riesce così bene a descrivere il paesaggio e le atmosfere che si ha l’impressione di essere presenti con lui, di viaggiare in lungo e in largo, di incontrare i parenti, per lo più povera gente che dalla vita nulla hanno avuto e che mai avranno, ormai senza speranza, tediati da una rassegnazione atavica. Se Con la faccia per terra occupa quasi tutto il libro, gli altri racconti, tutti brevi, sono un diretto omaggio al padre, osservato nella sua avanzata età e nello sforzo per allontanare, almeno scaramanticamente, la morte, con cui pare giocare, una presenza invisibile che tuttavia lui avverte e che accompagna le sue giornate, a volte nel preparare la sua dipartita, magari facendo incorniciare una fotografia da mettere sulla lapide, altre attendendola rassegnato nelle forze che progressivamente vengono meno. É un Chiara che francamente non mi aspettavo, tenero, delicato, che con occhi pieni di affetto annota il progressivo spegnersi di un’esistenza. E con l’ultimo, Un sogno, tributa al genitore un omaggio del tutto particolare e commovente. Non mi piace attribuire giudizi altisonanti, ma fra i tanti capolavori di Piero Chiara questo é il migliore, é quello che potrei definire un lascito a futura memoria. Piero Chiara nacque a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i più amati e popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi, quasi cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo, conterraneo e grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie che Chiara amava raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori, 1962), che segna il suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara scrisse con eccezionale prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.
E’ stato autore
particolarmente fecondo e fra le sue numerose pubblicazioni figurano Il
piatto piange (1962), La spartizione (1964), Il balordo (1967), L’uovo
al cianuro e altre storie (1969), I giovedì della signora
Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La stanza
del Vescovo (1976), Il vero Casanova (1977), Il cappotto di
Astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Vedrò
Singapore? (1981), Il capostazione di Casalino e
altri 15 racconti(1986).
1 Ottobre
Il prefetto di ferro. L’uomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia
Il prefettissimo La n’drangheta, la Sacra Corona Unita, la camorra e la mafia sono mali endemici del nostro meridione, anche se l’operatività di queste associazioni criminali si sono ormai estese a tutta l’Italia, ramificandosi perfino all’estero. La mafia è certamente la più conosciuta e si è sviluppata in Sicilia, diventando un contro stato. Mai sconfitta, magari qualche volta ferita, attraversò tuttavia un brutto periodo negli anni ‘20, allorchè Mussolini, ormai al potere, decise di combatterla, affidando l’incarico, con pieni poteri, al prefetto Cesare Mori, uomo non di regime, anzi avversato ferocemente dai fascisti romagnoli da quando era a capo della prefettura di Bologna, dove, con il solo scopo di far ispettore la legge, cercava di ostacolare le manovre eversive delle squadracce. Uomo integerrimo, di vecchio stampo liberale, era l’unico che poteva riuscire nello scopo, sia per le sue indubbie capacità, sia per l’esperienza maturata in alcuni anni di inizio secolo proprio in Sicilia. Dotato di una forte personalità e anche di una notevole ambizione i risultati non tardarono a venire, anche perché, investito di poteri assoluti, non andava tanto per il sottile e di fatto conduceva una guerra senza quartiere. Famoso fu l’assedio di Gangi, paese di 16.000 abitanti con 160 briganti; riuscì non solo a catturarli, ma anche a far passare dalla sua parte i cittadini, prima consenzienti soprattutto per paura. La sua massima, a cui sempre si ispirò, era questa: “Se la mafia fa paura, lo Stato deve farne di più.”. Da questa azione gli derivo una notorietà non solo a livello nazionale, ma anche all’estero, con soddisfazione di Mussolini che poteva così presentare un regime che risolveva anche i più difficili e spinosi problemi. Tuttavia, e Mori ne era ben consapevole, nella rete cadevano solo i pesci piccoli, al massimo qualche pezzo da 90 ormai imbolsito, ma il cervello, la cupola era inattaccabile, grazie alle connivenze con i politici locali e non solo con quelli. Certo tanti malfattori finirono in carcere o al confino, ma i grandi capi preferirono emigrare, per poi tornare con gli americani all’epoca dello sbarco in Sicilia. Altri ancora, invece, capirono l’aria che tirava e si inserirono, magari indirettamente, nel tessuto connettivo del fascismo. Qualche risultato fu comunque ottenuto, come la defenestrazione dell’onorevole Cucco, federale di Palermo e di fatto massimo esponente del fascismo in Sicilia, che non era mafioso, ma colluso con l’onorata società. Con il tempo Mori divenne un personaggio scomodo, uno che non si tirava indietro e andava fino in fondo, chiunque fosse l’indagato; anche lui si accorse che qualcosa stava cambiando e più per opportunità che per convinzione si iscrisse al partito nazionale fascista. Non bastò, e, nominato senatore per alti meriti il 22 dicembre 1928, nel giugno dell’anno successivo fu collocato a riposo con effetto dal 16 luglio stesso anno “per anzianità di servizio” (35 anni per i prefetti sulla base di nuova legge che sembrava varata ad hoc). Gli si diede anche un piccolo omaggio: la presidenza del Consorzio di 2° grado dell’Istria, in cui ben operò fino alla sua morte avvenuta il 5 luglio 1942. In quel periodo quasi di esilio gli venne la passione di scrivere, in verità con mediocri risultati, tranne che per Con la mafia ai ferri corti, un libro sulla sua esperienza siciliana, non ben accolto dal fascismo, anzi decisamente avversato, ma che riuscì a vendere bene, soprattutto all’estero. Petacco ne fa una biografia in cui unisce ammirazione a recriminazioni, ammirazione per la coerenza, la ferrea volontà, la capacità dell’individuo, recriminazioni per non aver saputo essere anche un politico, il che forse avrebbe permesso la morte della mafia, invece solo stordita, e pronta a riprendersi proprio con la caduta del fascismo. Lo stile snello, la vicenda stessa, il personaggio rendono la lettura particolarmente interessante e piacevole.
Arrigo Petacco è nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear
Benito, caro Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il
Prefetto di ferro, La principessa del Nord, La Signora della Vandea,
La nostra guerra. 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio
segreto di Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in fuga, La
storia ci ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
25 Settembre
Centomila gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi Ugo Mursia Editore Narrativa romanzo La morte vestita di bianco Non c’è pace per gli uomini della divisione alpina Julia: prima a combattere contro i Greci, poi inviati nella grande steppa russa a coprire una linea del fronte lungo il fiume Don e infine costretti a tornare indietro per l’avanzata delle truppe sovietiche, che chiudono in una sacca un’’intera armata. I loro percorsi sono sempre fatti a piedi, tranne per il trasferimento in nave dalla Grecia all’Italia, dove dovranno affrontare i rischi delle mine e dei siluri (e infatti uno di questi colpisce e affonda un bastimento carico di militari) e dalla nostra Patria ai confini russi in treno, stipati su dei carri bestiame. Ma nessuno si lamenta, anzi nei disagi e nelle difficoltà si rafforza quello spirito di corpo che è proprio degli alpini. Dovrebbero andare a combattere sul Caucaso, una regione montuosa dove un corpo ben addestrato come il loro può dare ottimi risultati, ma l’incapacità, la follia degli alti comandi li destina alla pianura, quasi si trattasse di semplice fanteria. La ritirata nella neve e con un freddo polare, pressati dalle truppe nemiche, dai partigiani, poco armati, senza cibo, vestiti in modo inadeguato si trasformerà in un incubo da cui pochi, benchè segnati nel corpo e nell’anima, riusciranno a uscire. Della nostra disfatta in Russia nella seconda guerra mondiale hanno scritto pochi narratori e tutti testimoni di un’esperienza vissuta. A memoria ricorco l’ottimo I lunghi fucili, di Cristoforo Moscioni Negri, e quel capolavoro che risponde al titolo di Il sergente nella neve, di Mario Rigoni Stern; il primo è a metà fra il romanzo (la ritirata) e il saggio storico (la disamina delle cause dello sfacelo, le colpe), il secondo é un’opera di rilevante valore letterario. Centomila gavette di ghiaccio, testimonianza di quella tragica esperienza che ha vissuto il tenente medico Giulio Bedeschi, é un allucinante percorso in un girone infernale. É difficile trovare in un libro così tanto orrore che sappiamo realmente accaduto, e non inventato, un orrore che strazia, che penetra dentro come il freddo polare che dovettero patire quei disgraziati. Sì, perché la ritirata è senz’altro la parte migliore dell’opera, un incalzare di eventi, uno sfinimento totale che stringono lo stomaco. Gli alpini si trascinano nella neve, cadono esausti e muoiono, si buttano su qualsiasi cosa che abbia la parvenza di essere mangiabile, lottano per quello che chiamarlo cibo è quasi una bestemmia, ma restano saldi nel cercare di aiutarsi, almeno fino a quando avranno un po’ di forze. Il lungo serpente di un armata in ritirata è punteggiato dai poveri corpi di chi non è più stato in grado di proseguire; é una torma di dannati che si trascina verso ovest, verso la salvezza, pronta a combattere anche solo con la forza d’urto dei propri corpi contro gli sbarramenti nemici che vogliono inchiodarli per sempre. Battaglie, scontri, miserie umane, e freddo, tanto freddo che congela gli arti, che mozza il respiro. Sembra di vederli passare davanti ai nostri occhi, viene perfino la tentazione di allungare un braccio per aiutare qualcuno con ce la fa più; in quel bianco uniforme che diventa un sudario per molti va un’umanità dolente verso la salvezza o verso un ideale orizzonte di un mondo senza più guerre. Il nemico é vicino, ma non c’è odio, perché la battaglia è fra l’uomo e quella natura tanto avversa. Sono pagine memorabili, di una bellezza unica e si guardi bene che l’autore rifugge dallai retorica, da frasi del tipo “italiani brava gente”., anche se a volte esagera un po’, almeno nei toni, nel parlare dell’eroismo dei nostri alpini. Apprezzabile é la parte in cui si parla delle contadine ucraine che vicino alla meta li soccorrono; loro non hanno debiti di riconoscenza , ma solo tanta materna pietà. Saranno pochi a rientrare in Italia, piombati nei vagoni, impossibilitati a scendere alle stazioni, perché la gente non deve vedere come è ridotta la grande armata italiana che è andata in Russia. Prosegue il gioco delle menzogne, lo stesso a cui per tanto tempo sono stati abituati gli italiani. Resta da chiarire tuttavia un mistero: nonostante l’esperienza patita e l’evidente incapacità di un regime di affrontare seriamente una tragedia come la guerra, Giulio Bedeschi, dopo l’8 settembre 1943, anziché prendere la via dei monti per unirsi ai partigiani, si iscrisse al partito fascista repubblicano, divenendo comandante della XXV Brigata Nera Capanna di Forlì. Alla fine delle ostilità si nascose per poi riapparire, senza conseguenze, nel 1949. Centomila gavette di ghiaccio è meritevole di lettura, perché é certamente un libro contro la guerra, contro l’insensatezza degli uomini che non comprendono come in un conflitto anche i vincitori finiscono con l’essere perdenti, sconfitti nella loro dignità e feriti nell’animo, una lacerazione da cui è impossibile guarire. Giulio Bedeschi,
alpino, medico e scrittore, nasce ad Arzignano, in provincia di
Vicenza, il 31 gennaio 1915. Nel 1940 ottiene l’abilitazione alla
professione medica e frequenta la Scuola Allievi Ufficiali presso la
Scuola Militare di Sanità a Firenze. Ufficiale medico, andò
volontario prima sul fronte greco-albanese, poi, nel 1942, venne
trasferito sul fronte russo dove, con gli alpini della Julia, visse
la tragedia della ritirata che raccontò nel suo capolavoro Centomila
gavette di ghiaccio (Mursia, 1963). Nel 1966
pubblicaIl peso dello zaino, ideale continuazione delle
Gavette, nel quale racconta le vicende dei reduci dalla
Russia dopo l’8 settembre 1943. Nel 1972 dà alle stampe due nuovi
titoli: La rivolta di Abele e La
mia erba è sul Don. Negli anni Settanta e Ottanta
cura per Mursia la serie «C’ero anch’io», monumentale raccolta di
testimonianze di coloro che combatterono sui fronti della Seconda
guerra mondiale. Nel settembre del 1990 torna in Veneto, a Verona,
dove morirà nel dicembre dello stesso anno. Nel 2003 è stata
pubblicata la raccolta di scritti Il
Natale degli alpini e nel 2004
Il segreto degli alpini. segreto degli Tutte le opere
di Giulio Bedeschi sono edite in Italia da Mursia.
20 Settembre
Istantanea di un delitto di Agatha Christie Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa
Il cadavere scomparso Come molti sanno, Agatha Christie ha ideato due protagonisti memorabili di quasi tutti i suoi romanzi gialli, il misogino Hercule Poirot e l’anziana Miss Marple. Le mie preferenze vanno a quest’ultima,più plausibile del primo, ma sempre legata alla ferrea logica dell’autore secondo la quale alla soluzione di qualsiasi delitto si arriva per gradi, come in puzzle che si viene a formare facendo combaciare perfettamente un pezzo dopo l’altro. E così, anche in Istantanea di un delitto, scritto nel 1957, figura l’acume di miss Marple; l’inizio è brevemente convenzionale, con la signora McGillicuddy che in prossimità del Natale, oberata da pacchi e pacchetti e, nonostante l’aiuto di un facchino, si avvia con difficoltà in stazione verso il marciapiedi da cui partirà il suo treno, diretto in Scozia, dove andrà a far visita alla sua amica Miss Marple. Partito il convoglio, la signora assisterà a un delitto su un treno che passa accanto al suo nella stessa direzione. Ovviamente, di ciò sarà resa edotta la polizia, che però non le crede, perché non si trova il cadavere. É inutile che aggiunga che le verrà in aiuto l’amica Miss Marple e che alla fine l’enigma verrà risolto e l’omicida verrà scoperto grazie a uno stratagemma. Se devo essere sincero, i gialli della Christie mi piacevano di più in giovane età, mentre ora, rileggendoli, provo un tiepido gradimento, un po’ per quel modo di scrivere compassato e formale, tipicamente british, un po’ perché, se lo svolgimento della trama è ineccepibile, mancano alcune caratteristiche che mi interessano molto e che invece posso trovare nei romanzi di Simenon. Infatti, se la descrizione dei luoghi è ben realizzata e se anche l’atmosfera è sapientemente ricreata, l’analisi psicologica dei personaggi è sovente superficiale, raramente va in fondo, così che finiscono con lo sfuggire le autentiche motivazioni di un reato e si viene a valutare con indifferenza chi l’ha commesso, quasi che lo stesso fosse un anonimo che esce dall’ombra senza che alla fine sia possibile comprendere completamente il suo comportamento. É per me una lacuna, poiché non si aggiunge altro alla semplice piacevolezza della lettura. Insomma, arrivati all’ultima pagina, resta ben poco dentro e si ha la convinzione che l’opera possa costituire solo un gradevole passatempo.
Agatha Christie
(Torquay, 15 settembre 1890 – Wallingford, 12 gennaio 1976) é stata
una famosa scrittrice di romanzi gialli, creatrice dei due
investigatori Hercule Poirot e Miss Marple.
15 Settembre
Guerra partigiana di Dante Livio Bianco Premessa di Norberto Bobbio Introduzione di Nuto Revelli Edizioni Einaudi
Storia Il partigianato
Ai più Dante Livio Bianco risulterà uno sconosciuto, ma dopo aver
letto questo suo libro e dopo avere imparato che cosa fu veramente la
Resistenza finirà con il diventare un personaggio indimenticabile.
Nelle pagine si respira un’aria di libertà, di speranza, un’aria
buona che manca da troppo tempo. Non è il solito strombazzato
retoricamente eroismo partigiano, ma è la realtà di uomini che si
trasformano, che militarmente combattono per affermare un ideale di
giustizia e di libertà, e Giustizia e Libertà si chiameranno infatti
le brigate del Partito d’Azione, di cui Bianco é membro. L’autore sa
scrivere in un bello e conciso italiano e, soprattutto, sa quel che
vuol dire; vuole mettere nero su bianco quale fu l’esperienza
partigiana nel cuneese, una delle zone a più alta densità di
“ribelli”. Il suo non è un romanzo, ma è uno studio organico, la cui
attenta lettura porta a comprendere chiaramente come vennero a
nascere le bande, come progredirono, la loro funzione, il loro
inserimento nel tessuto sociale. Sono dell’idea che arrivati
all’ultima pagina si sappia molto sul movimento partigiano, non se ne
abbia solo un’idea, ma una conoscenza approfondita. Divisa in
capitoli sistematici l’opera si presta a fornire puntuali risposte
alle tante domande. Rammento, in particolare, avendo destato in me
maggior interesse, quelli relativi al carattere popolare dei
partigiani, all’inevitabile crisi che subentra nei superstiti dopo un
rastrellamento, alla militarizzazione e politicizzazione delle
formazioni, alla tecnica militare e allo spirito politico-morale. Si
noti bene, peraltro, che Dante Livio Bianco non era un professore di
storia, ma un avvocato; evidentemente, però, ha avvertito il
desiderio e la necessità di ricordare, per primo a lui stesso e agli
uomini della sua epoca, e di far conoscere alle generazioni
successive un fenomeno, quale quello del partigianato, del tutto
nuovo per l’Italia e con ambizioni non solo di liberare il paese dal
giogo nazi-fascista, ma anche di gettare le basi per la nascita di
una nuova Italia. Tuttavia, mi è sembrato di avvertire fra le righe
delle ultime pagine un senso di sconforto, poiché, finita la guerra,
anziché veder sorgere un periodo di rivoluzione (nel senso politico e
non insurrezionale del termine) ebbe inizio subito, implacabile, la
restaurazione, di cui scontiamo tuttora gli effetti.
Dante Livio Bianco, nato nel 1909, avvocato, scomparso nel 1953 in una sciagura
alpinistica, costituì la prima pattuglia della Resistenza piemontese.
Nel 1945 successe a Duccio Galimberti nel comando delle formazioni di
«Giustizia e Libertà».
10 Settembre
La valigia del signor Budischowsky di Isabella Bossi Fedrigotti BUR Biblioteca Universale Rizzoli Narrativa romanzo La valigia dei ricordi
Può una vecchia valigia essere fonte di tanti ricordi? Certamente,
come anche qualsiasi altro oggetto, a patto che a far emergere dalla
memoria eventi del passato sia un acuto osservatore; per poi metterli
nero su bianco, occorre un narratore che abbia la straordinaria
abilità di rendere interessanti e piacevoli anche fatti
apparentemente banali. Con la sua scrittura semplice, ma non povera,
con uno stile quasi colloquiale Isabella Bossi Fedrigotti si impegna
nel tema che le è più congeniale, quello del ricordo. La vecchia
valigia di pelle fabbricata a Brno da un artigiano dal nome
pressoché impronunciabile e da tanto tempo presente nella casa di
famiglia è così il pretesto per raccontarci un po’ della sua
gioventù, con la vacanza al mare, insieme alla sorella e ai due
fratelli, accompagnati dalla tata tedesca, a quella in montagna,
dalla zia, con la famiglia questa volta al completo. Lei é bambina e
certe storielle fanno un po’ sorridere, però sono tipiche di
quell’età dell’essere umano. La valigia è sempre presente, anche
quando si va in collegio dalle suore (assai riuscita la descrizione
di queste) e infine è quasi un oggetto del contendere fra una mamma e
un papà continuamente litigiosi, con lui che minaccia di andarsene e
che allo scopo riprende la valigia dalla soffitta, la porta nella
camera d’ingresso e lentamente la riempie di indumenti, per poi
fermarsi, e lei che la nasconde, lui ancora che la ritrova, la
riporta giù e la stipa di vestiario, senza poi tuttavia andarsene.
Piccoli dispetti, atteggiamenti pateticamente infantili in due adulti
che dovrebbero dare l’esempio di una sana famiglia ai figli e questi
che assistono impotenti e anche attoniti sono forse le pagine
migliori di questo breve romanzo che si lascia leggere in breve
tempo, senza particolari pretese o messaggi di rilevante profondità,
ma che alla fine risulterà un gradevolissimo passatempo. Non solo,
però, perché stimolati dalla circostanza il nostro pensiero finirà
con il correre a qualche oggetto che è presente nelle nostre case e
che è il simbolo di una vita; potrà essere un mobile, un apparecchio
fotografico, insomma qualsiasi cosa che possa riaccendere la nostra
memoria e che, con un po’ di commozione, alimenti un flusso di
ricordi.
4 Settembre
Il superfascista. Un caso di doppia personalità Alessandro Pavolini (Firenze, 27 settembre 1904 – Dongo, 28 aprile 1945) e Benito Mussolini, quando si allontanarono da Como il 27 aprile 1945, diretti verso la Valtellina (il primo per un’ultima disperata difesa nel ridotto fra i monti appena abbozzato, il secondo, tentennante fra la morte eroica e la fuga da vigliacco, con ogni probabilità con la speranza di valicare il confine e rifugiarsi in Svizzera), erano senz’altro, all’epoca, gli uomini più odiati dagli italiani. Del Duce sono state scritte tante biografie, più o meno riuscite, mentre assai meno sono state quelle relative ad Alessandro Pavolini, uomo dalla complessa personalità, e quindi assai difficile da descrivere. Tuttavia, Arrigo Petacco con Il superfascista ci ha provato e, secondo me, con risultati eccellenti. Il saggio storico inizia con la colonna, di cui fanno parte fra gli altri Benito Mussolini e Alessandro Pavolini, bloccata dai partigiani sulla sponda occidentale del lago di Como. Si parlamenta, si discute e infine si arriva un accordo: si lasceranno passare gli uomini della FlacK, a cui come è noto si aggregò il Duce travestito da tedesco. Per gli italiani, per i fascisti che disperati alternano momenti di abulismo o di sconforto ad altri di speranza, c’è da attendere le decisioni del comando partigiano. In questo tempo che per i gerarchi e gerachetti sembra non trascorrere mai Petacco , con stile snello, scevro di accademismo, ci narra la vita di Alessandro Pavolini, intellettuale fiorentino di buona e nota famiglia (il padre era uno dei più noti filologi esistenti al mondo, accademico d’Italia), dedito con passione e capacità alle arti e alla letteratura, di per sé buon giornalista e ottimo scrittore; era persona amabile, rispettosa dell’opinione altrui fin tanto che l’argomento era quello letterario, ma rivelava un’insospettabile ferocia quando nutriva timori per la stabilità del fascismo e per l’incolumità di Mussolini, che addirittura idolatrava. In breve, da vice federale a Firenze, ne divenne il federale, distinguendosi per alacrità, per la realizzazione di opere pubbliche utili e indispensabili, come la nuova stazione della città e i numerosi alloggi popolari. Era capace e onesto e inoltre fedele, ma la sua carriera nel partito non sarebbe stata così rapida se non avesse avuto la sorte di conoscere, divenendone amico, il genero del duce, il potente Galeazzo Ciano. Alla sua corte, senza essere un lacché, si dimostrò fedele e disponibile e quindi gli si aprirono le porte per un luminoso avvenire, diventando, fra l’altro, ministro della cultura popolare, dicastero importantissimo che aveva il compito di istruire non solo fascisticamente i giovani italiani, ma anche quello, non meno rilevante, di manipolare l’informazione e con essa le coscienze. Era un traguardo prestigioso, ma l’uomo non era evidentemente soddisfatto, anche perché l’entrata in guerra dell’Italia, le cui forze armate erano del tutto impreparate, circostanza a lui ben nota, gettava un’ombra sulla sua vita. Si incupì, cominciò a temere, giustamente, che il fascismo avesse le ore contate. Un rimpasto governativo, voluto dal Duce per gettare fumo negli occhi e distogliere il popolo dalle continue disfatte, lo esonerò dall’incarico, compensato dalla ben più modesta investitura di direttore del Messaggero. Era un posto defilato, in cui Pavolini avrebbe potuto attendere relativamente sicuro la fine del conflitto, ma con la defenestrazione del 25 luglio 1943 di Mussolini deliberata dal Gran Consiglio del Fascismo sentì crescere in sé un odio irrefrenabile che lo portò a rifugiarsi in Germania, nonostante disistimasse i tedeschi, e a predisporre con loro un piano di rinascita del fascismo. É così che, dopo l’8 settembre 1943 e successivamente alla liberazione del Duce anche lui condotto in Germania, che nacque lo stato fantoccio della Repubblica sociale italiana. Pavolini diventò il segretario del partito fascista e di fatto l’uomo che decideva anche per un Mussolini ormai depresso e abulico. Fu sua l’idea di fare un esercito fascista ed è così che nacque la Guardia Nazionale Repubblicana che, con ferocia combattè i partigiani, con crimini di tale portata da far intervenire ogni tanto perfino i tedeschi per chiedere un po’ di moderazione. Nel crepuscolo del regime Pavolini finì con il sognare la “bella morte” e in tal senso era spesso in prima linea, tanto che fu anche ferito. Però il libro del destino del fascismo stava per arrivare all’ultima pagina e l’odio e la ferocia si accrebbero in Pavolini che addirittura lasciò numerosi cecchini a Firenze, prossima alla liberazione, affinché uccidessero, più che i soldati alleati, gli stessi cittadini. L’avanzata dei tedeschi nelle Ardenne risvegliò le speranze di naufraghi morituri, ma fu solo una piccola fiammata e nella primavera del 1945 si annunciò la resa dei conti. É noto come andò a finire, con Pavolini che cercò disperatamente di opporsi all’arresto, combattendo, ma che poi con altri suoi camerati venne fucilato sul lungolago di Dongo. Il suo corpo, come quello di Mussolini e degli altri giustiziati in riva al lago di Como, venne poi appeso a un distributore di benzina di Piazzale Loreto a Milano. Petacco é stato molto bravo perché non solo ha messo in giusta luce le due personalità contrastanti, ma ha saputo narrare questa biografia come se fosse un romanzo, rendendola avvincente e indimenticabile.
Arrigo Petacco è nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear
Benito, caro Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il
Prefetto di ferro, La principessa del Nord, La Signora della Vandea,
La nostra guerra. 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio
segreto di Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in fuga, La
storia ci ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
2 Settembre
La disfatta di Gasr Bu Hadi di Angelo Del Boca Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Saggistica storica Tripoli bel suol d’amore? Ho cercato di pescare fra i miei ricordi scolastici questa battaglia dall’esito a noi sfavorevole, ma il risultato è stato sconfortante. Nella memoria ho trovato altre sconfitte: quelle della prima guerra d’Indipendenza, quelle della terza guerra d’Indipendenza, fra le quali ben chiaro è stato l’episodio di Lissa, nonché la famosa e tristemente nota ritirata di Caporetto. Del resto le nostre guerre coloniali hanno pochi accenni nei programmi scolastici, come se ci dovessimo vergognare di aver voluto assoggettare altri popoli nel periodo in cui noi cercavamo di liberare dal dominio straniero degli italiani come noi. Sì, ho memoria della disfatta di Adua, ma della guerra condotta in Libia, che si concluse dopo molti anni con una pacificazione ottenuta con metodi barbari e crudeli, riesco ad avere solo un’idea confusa e quindi è ben difficile pensare che Gasr Bu Hadi, questa località desertica del Fezzan, possa avere qualche significato per me. Eppure lì patimmo una cocente sconfitta con il rischio consistente di essere ributtati in mare e di finire nel peggiore dei modi la nostra avventura coloniale nell’Africa settentrionale. Per fortuna che fornisce chiari lumi al riguardo lo storico Angelo Del Boca con questo volume che ha anche il pregio di riparare alle tante omissioni relative alla nostra colonizzazione libica. Il tutto accadde nell’imminenza della partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale, quando i bellicosi mujâhidîn arabi si ribellarono e venne inviato a sedare la rivolta un corpo di spedizione comandato da un ufficiale di comprovate capacità e di lunga esperienza coloniale quale era il colonnello Antonio Miani. Il libro evidenzia i nostri cronici difetti, che già dolorosamente si rivelarono ad Adua, e in genere in tutte le guerre a cui partecipammo: l’approssimazione e la sottovalutazione del nemico; a ciò si aggiungono, nello specifico caso, gli ordini contraddittori del comando di Tripoli e l’invidia di non pochi ufficiali verso un soldato che si era meritato promozioni e medaglie sul campo, e non in poltrona. Purtroppo, Miani contava di avere forze superiori e invece erano inferiori, dava una fiducia oltre ogni logica alle bande irregolari aggregate alla spedizione, procedeva verso lo scontro come se avesse avuto di fronte dei poveri diavoli armati solo di asce e di lance. E poi, in un ufficiale di cui si presagiva un grande avvenire, si scoprono inutili manie di grandezza, rappresentate dalla corposa e ingombrante colonna delle salmerie, con vettovagliamento e munizioni non di certo per una breve campagna, come si ipotizzava, ma per una lunga e logorante guerra. Tradito dagli irregolari, che già i giorni precedenti avevano dimostrato ben scarso affidamento, comportamento inspiegabilmente ignorato dal colonnello, rallentato dalla citata colonna dei rifornimenti, il nostro corpo di spedizione finì in bocca agli avversari e fu una strage. I superstiti, compreso il colonnello ferito ben due volte, riuscirono a riparare in un nostro fortino sulla costa, anche perché i ribelli si gettarono sull’ambita preda costituita dalle salmerie. Miani si vendicò del tradimento colpendo anche chi non c’entrava e numerose furono le pene capitali immediatamente eseguite. L’uomo, conosciuto come autoritario, ma anche come giusto e imparziale, rivelò una ferocia senza precedenti. Le colpe della disfatta però non erano solo sue, investendo anche il governatore militare e il ministro delle colonie e fu questo che salvò Miani da un processo, in cui sarebbero stati inevitabilmente chiamati in causa le predette autorità, con gravi ripercussioni sullo spirito di un paese che da lì a pochi giorni avrebbe dichiarato guerra all’Austria. Comunque per Miani la carriera militare era finita, ma lui non ci stava a essere il capro espiatorio, e se un processo ci fosse stato – ma non ci fu per i motivi sopra precisati – forse avrebbe potuto difendersi, almeno per sminuire le sue colpe; fu così che si affidò alle memorie, ad articoli, insomma a tutto quanto gli era possibile per difendere la propria onorabilità. Il libro é illuminante e piacevole da leggere al punto che mi sento di consigliarlo.
Angelo del Boca (Novara
1925), saggista e storico del colonialismo italiano, ha insegnato
storia contemporanea all'università di Torino. È stato insignito di
tre lauree honoris causa dalle università di Torino (2000), Lucerna
(2002) e Addis Abeba (2014). Tra le sue numerose e importanti opere
ricordiamo: L'altra Spagna (1961), I
figli del sole (1965), Giornali
in crisi (1968), I
gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia (1996), Il
mio Novecento (2008), La
guerra d'Etiopia. L'ultima impresa del colonialismo (2010), Da
Mussolini a Gheddafi: quaranta incontri (2012).
Da Mondadori ha pubblicato: Gli
italiani in Africa Orientale (4
voll., 1992-1996),Gli italiani in Libia (2
voll., 1993-1994), L'Africa
nella coscienza degli italiani. Miti, memorie, errori, sconfitte (2002).
28 Agosto
I giorni della semina di Nino Chiovini Prefazione di Oscar Luigi Scalfaro Tararà Edizioni Storia Un tragico rastrellamento Di questo massacro parla il libro di Chiovini, all’epoca partigiano in zona e sfuggito miracolosamente all’eccidio. La sua è una cronaca puntuale e scarna, una serie di piccoli e grandi scontri che si verificano quasi senza interruzioni nel periodo del rastrellamento ed ha quindi un valore storico, poiché da essa è possibile comprendere quali errori furono commessi per arrivare a un simile luttuoso bilancio. A priori c’è da considerare un particolare attivismo partigiano, meritorio senza dubbio, ma spesso condotto con una sfrontatezza che rasentava la guasconata, frutto di una sicurezza che poi, durante il rastrellamento, contribuirà non poco al suo tragico risultato. I comandanti delle bande operanti, poi, adottarono senza dubbio il metodo della resistenza trasversale e rigida in valle, senz’altro sconsigliabile anche per un esercito regolare, poiché una seconda linea difensiva è da considerarsi sempre imprescindibile. Purtroppo, tutti questi fattori, a cui si unirono la notevole superiorità in uomini e in mezzi dei nazifascisti , condussero a una mattanza , scrupolosamente documentata dall’autore. Tuttavia, finita l’operazione di repressione, il nemico non ottenne i risultati auspicati e in breve si ricostituirono in zona, con i superstiti e nuove leve, le formazioni partigiane, diventate più esperte dopo il disastro subito, tanto da fornire il loro prezioso contributo per la nascita della Repubblica della Val d’Ossola, avvenuta il 10 settembre 1944; questa zona libera durerà una quarantina di giorni, ma costituirà la prova che i cosiddetti ribelli avevano un alto senso dello Stato. I giorni della semina, benché porti la prefazione ampiamente positiva di Oscar Luigi Scalfaro, ex presidente della repubblica italiana, per come è impostato e per come è scritto ha più il valore di una testimonianza che di un approfondito saggio storico, ma riesce a ben rendere l’atmosfera di quegli anni e in particolare di quel tragico evento, elementi positivi che ne consigliano la lettura. Nato a Verbania nel 1923,
Nino Chiovini ha partecipato
alla guerra di Liberazione nelle file della banda Giovine Italia e
poi nella Brigata Cesare Battisti. Dal 1946 al 1978 ha lavorato come
perito chimico alla Montefibre. Ha iniziato la sua opera di studioso
nel 1966, pubblicando Verbano giugno quarantaquattro, storia del
locale movimento partigiano e del rastrellamento della Valgrande. Una
rielaborazione ampliata di quelle pagine è uscita nel 1974 e poi nel
1979 con il titolo I giorni della semina ripubblicato da
Tararà nel 2005. Nel 1980 Chiovini ha pubblicato Valgrande
partigiana e dintorni(ripubblicato da Tararà nel 2000) e Classe
III B, Cleonice Tomasetti vita e morte.
25 Agosto
Il Cristo dell’Amiata La storia di David Lazzaretti di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S,p.A. Storia biografia Il Cristo rosso Ci sono personaggi della storia che sembrano essere inventati, tanto sono avvolti da un alone di leggenda e di mistero; sono pochi in verità, ma rappresentano sovente una luce improvvisa che squarcia le tenebre, un faro a cui tanti esseri umani si affidano per avere una speranza in un mondo migliore. David Lazzaretti è uno di questi protagonisti che sembrano andare oltre il corso del tempo, che lanciano un messaggio talmente grande da essere utopistico. Era nato ad Arcidosso, sul monte Amiata, il 6 novembre 1834 in una povera famiglia di contadini e manifestò quasi subito una natura contrastante, associando misticismo e vita fuori dai comuni canoni. Sposato e con cinque figli, svolgeva l’attività di barrocciaio, trasportando terra di Siena da Arcidosso a Grosseto e Siena. Strani sogni, visioni, continuavano a popolare la sua esistenza fino a quando nel 1868 avvertì dentro di sé di essere stato scelto per una missione di carattere religioso, una rifondazione della Chiesa cristiana non solo con un ritorno alle origini di questa, ma anche una sostituzione di questa con una nuova Chiesa giurisdavidica. Fece rapidamente proseliti, più che per l’aspetto religioso, per una sua visione dell’umanità che non poteva non soddisfare la povera gente che, oppressa da tasse e da burocrazia, pativa la fame. Per lui sarebbe presto finita l’Era della Grazia e avrebbe avuto inizio l’Era del Diritto, con l’avvento finalmente di un’autentica giustizia sociale, in un mondo di uguali, con pari dignità e che si sarebbe sostenuto con il lavoro collettivo e la messa in comune delle risorse ottenute. A ben guardare sono i principi socialisti del Vangelo, ma lui socialista non era, o meglio tendeva a esserlo, senza saperlo. E poi non era finita, poiché predicava l’apparizione di un secondo Cristo, cioè lui. Forse le sue idee erano un po’ confuse, frutto del disordine delle letture con cui era cresciuto, ma di certo non era un truffatore; credeva a quel che predicava, aveva una fiducia illimitata nel suo pensiero e proprio per questo la gente lo seguiva. Certo, l’aspetto religioso e quello civile della sua dottrina, anche se dottrina è una parola un po’ grossa per un coacervo di idee che tendevano tanto all’utopia, erano una miscela altamente esplosiva. Se avesse continuato a raccogliere proseliti, che ne sarebbe stato della Chiesa di Roma? Se avesse diffuso il principio dell’eguaglianza, del lavoro collettivo per realizzare una società di uguali, che ne sarebbe stato dei ricchi?. La Chiesa lo esecrò, lo condannò come eretico, lo scomunicò, mise all’indice i suoi scritti; lo Stato lo uccise, cogliendo l’occasione di una processione da lui guidata e diretta all’Arcidosso. Processione o sommossa? Propendo per la prima ipotesi, giacché l’uomo mai si rivelò violento; sta di fatto che una pattuglia di carabinieri e un militare la fermarono, sparando sulla gente e ammazzando degli altri fedeli, oltre a David Lazzaretti. Con la sua morte il giurisdavidismo non finì, anche se si ridimensionò alquanto, fino a scomparire poco a poco. Di questo straordinario personaggio parla Arrigo Petacco, con misura, data anche la delicatezza del tema trattato. La ricerca delle fonti è stata scrupolosa e quindi il ritratto che emerge di questo predicatore appare realistico, è quello di un uomo che magari non manca di ambizione, ma che in ogni caso si è reso conto che la gente, la sua gente, ha bisogno di una speranza per sopravvivere e lui offre loro questa idea utopistica, a cui dedicherà tutti i suoi giorni e a qualunque prezzo, anche a costo della vita. E come Cristo che morì sul Golgota, David Lazzaretti finì la sua esistenza sull’Amiata, novello Cristo senza resurrezione, ma il cui nome mai verrà dimenticato. Da leggere, senza alcun dubbio.
Arrigo Petacco è
nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear Benito,
caro Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il Prefetto di
ferro, La principessa del Nord, La Signora della Vandea, La nostra
guerra. 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio segreto
di Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, Viva la muerte!,
L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O Roma o
morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo andata, Nazisti
in fuga, La storia ci ha mentito e Ho sparato a
Garibaldi.
21 Agosto
La fuga del signor Monde di Georges Simenon Traduzione di Federica di Lella e Maria Laura Vanorio Edizioni Adelphi Narrativa romanzo
Collana Biblioteca Adelphi L’ebbrezza della libertà Perché Norbert Monde, titolare della ditta di intermediazione ed esportazione Monde, sposato, padre di due figli adulti, una posizione economica invidiabile si è allontanato da casa senza lasciare traccia? Non si tratta di un personaggio di Chi l’ha visto, di un uomo depre4sso e sfiduciato che compie un gesto senza saperne il motivo, anzi lui è ben consapevole, tanto che di quando se ne va Simenon scrive “ Non ebbe incertezze, si potrebbe dire che non ebbe bisogno di decidere, anzi non ci fu niente da decidere.”. Il tema della fuga non é nuovo all’autore belga e già si è visto in qualche altra sua opera, ma in questa costituisce il nerbo, è l’argomento di cui si tratta. Per il signor Monde non è tanto una fuga, ma una ribellione a una vita ripetitiva che nel trascorrere nel tempo (non è un caso quindi se prende il volo nel giorno del suo quarantottesimo compleanno) diventa di una monotonia assordante, tanto che questo modo di esistere, stabilito da altri, dalle convenzioni finisce con il diventare insopportabile. Iniziare a percorrere una strada senza sapere dove andare, liberarsi dai laccioli di una vita costellata di responsabilità e di doveri familiari è forse un sogno che qualche volta nasce, magari solo per un momento, in ognuno di noi, ma provare l’ebbrezza della libertà resta sempre un desiderio, nascosto in una piega dell’animo, e che di tanto in tanto fa capolino, subito ricacciato sul fondo dal timore dell’ignoto, da un’innata preferenza a un certo non esaltante rispetto a un incerto oscuro. Monde cambia i suoi vestiti e se potesse cambierebbe anche il suo aspetto fisico, va alla stazione, dopo aver prelevato in banca un bel malloppo, prende un treno per il sud e via, che la vita cominci. Va in Costa Azzurra, cambia nome, conosce una donna e s’accompagna, trovano entrambi lavoro in un locale notturno che è anche un casinò. Come é bello iniziare una nuova vita, rinascere in effetti dopo aver troncato i ponti con il passato! Ma il passato ogni tanto ritorna e infatti una sera se lo ritroverà davanti in modo del tutto inatteso. Non si può sfuggire al proprio destino, la libertà assoluta è solo un’utopia, ma Monde è diventato un’altra persona e ora può permettersi di guardare gli altri negli occhi con una serenità disarmante. Non aggiungo altro, se non che ci troviamo di fronte all’ennesimo capolavoro di Simenon.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato centonovantatre romanzi pubblicati sotto il suo nome e un
numero imprecisato di romanzi e racconti pubblicati sotto pseudonimi,
oltre a volumi di «dettature» e memorie. Il commissario Maigret è
protagonista di 75 romanzi e 28 racconti, tutti pubblicati fra il
1931 e il 1972. Celebre in tutto il mondo, innanzitutto per le storie
di Maigret, Simenon è anche, paradossalmente, un caso di «scrittore
per scrittori». Da Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner a
Cocteau, molti e disparati sono infatti gli autori che hanno
riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André Gide: «Considero
Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più
autentico che la letteratura francese abbia oggi»; Walter Benjamin:
«… leggo ogni nuovo romanzo di Simenon»; Louis-Ferdinand Céline: «Ci
sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
18 Agosto
Scrittori piemontesi del novecento Una lettura <<intertestuale>> di Antonio Catalfamo Edizioni Solfanelli Saggistica letteraria
Analisi intertestuale Antonio Catalfamo, docente di Letteratura Italiana presso le Università di Cassino e di Messina, ha fondato nel 2001 l’Osservatorio permanente sugli studi pavesiani nel mondo, divenendone sin dall’inizio anche coordinatore. Appare evidente, quindi, che nutra una vera passione per Cesare Pavese, senz’altro uno degli autori più interessanti del novecento, e non solo a livello nazionale. Gli approfondimenti da lui effettuati delle opere dello scrittore di Santo Stefano Belbo lo hanno portato ad analizzare anche i lavori di altri narratori piemontesi coevi di Cesare Pavese, in un confronto comparativo e intertestuale le cui risultanze sono indubbiamente di rilevante interesse. Ne scaturisce una visione, che pur nella disparità degli stili e dei temi, porta in buona sostanza a trovare un comune denominatore negli scrittori piemontesi del secolo scorso. L’analisi, e ovviamente la comparazione, ha riguardato Italo Cavino, che, benchè nativo di Cuba, con padre ligure e madre sarda, ha avuto un rapporto stretto con Pavese, di cui era l’allievo prediletto, e che a suo modo, ne ha subito gli influssi; gli altri nomi, tutti di spicco in campo letterario, sono invece proprio piemontesi, e così troviamo Beppe Fenoglio, Davide Lajolo, Nuto Revelli, Primo Levi, Carlo Levi e Franco Ferrarotti. L’ultimo parrebbe stonare, in quanto è conosciuto come grande sociologo, ma in realtà viene rivalutato come scrittore da Catalfamo. Il metodo usato per questo ponderoso lavoro è d’impronta gramsciana, vale a dire che è orientato ad analizzare i testi non solo in base alle loro caratteristiche specifiche, ma anche in relazione al contesto nel cui ambito sono nati. La pratica é più che corretta, perché é evidente che le opere di un autore risentono inevitabilmente del territorio e dell’epoca, quest’ultima con le sue specifiche caratteristiche economico-sociali, storiche, politiche, ideologiche, culturali e letterarie. Il risultato, come ho sopra anticipato, é sicuramente interessante e consente anche, ad li là di quelle che sono le connessioni, di approfondire le caratteristiche di tutti questi scrittori; presuppone, però, di non essere a digiuno, cioè di aver letto con attenta analisi le loro opere. Questo saggio, per certi versi e anche per lo stile eccellente, ma accademico di Catalfamo, finisce con il presentarsi come un testo universitario, di indubbio valore per un laureando, ma a volte ostico per chi voglia limitarsi a una semplice erudizione. Ciò nonostante, è un piacere seguire le riflessioni, apprendere le connessioni e infine avere un’idea meno generica e più documentata di questi scrittori piemontesi, le cui opere, lette singolarmente, hanno un indubbio valore, ma che alla luce di una lettura intertestuale appaiono quasi come una corrente letteraria che ha arricchito la cultura del nostro paese.
Antonio Catalfamo è nato a
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel 1962. Opera a livello
accademico presso le cattedre di Letteratura italiana dell’Università
di Cassino e di Messina. E’ coordinatore dell’ “Osservatorio
permanente sugli studi pavesiani nel mondo”, che ha sede a Santo
Stefano Belbo (Cuneo), nella casa natale di Cesare Pavese, per il
quale ha curato sinora undici volumi di saggi internazionali di
critica pavesiana. Dirige il Centro Studi “Nino Pino Balotta”.
31 Luglio
Nella notte ci guidano le stelle. La mia storia partigiana di Angelo Del Boca a cura di Massimo Franzinelli Arnoldo Mondadori Editore S,p,A.
Storia
autobiografia Il significato di una lotta E’ indubbiamente interessante questo diario partigiano scritto una settantina di anni fa, perché rievoca senza enfasi e senza retorica un periodo della vita dell’autore (dall’autunno del 1944 fino a quasi alla Liberazione) in cui passa da cacciatore di ribelli della divisione Monte Rosa a partigiano, e non è un voltagabbana, bensì è frutto di una decisione di cui Del Boca prenderà piena consapevolezza nei mesi dolorosi in cui dovrà misurarsi con la ferocia dei nazisti. La decisione di cambiare casacca avviene all’inizio più che altro perché ci si accorge che il fascismo non solo non ha più nulla da dare, ma che tende a togliere sempre di più in un’agonia cupa e opprimente. La scelta non è facile, poiché é fra il certo e l’incerto, ma il certo fascista é talmente nauseante che si preferisce fare un passaggio di parte, con tutti i rischi del caso (la diserzione in tempo di guerra é punita con la morte); così, più che una decisione ponderata, è frutto di una fuga da un mondo che sta morendo, nella speranza che i ribelli possano dare uno stimolo per continuare a vivere e a sperare. Se non è stato facile scegliere, ancor più difficili saranno i mesi con i partigiani, stretti nella morsa di un grande rastrellamento. Combattimenti, compagni morti, la paura per la propria sorte, il freddo inclemente e la fame assillante sono descritti in modo encomiabile per senso della misura e per la capacità di trovare in questo orrore, ogni tanto, una nota di poesia, con paesaggi nella nebbia e nella neve e personaggi semplici, umili, ma indimenticabili. E proprio le privazioni e la paura finiscono per fortificare l’autore, poco a poco gli donano la consapevolezza dell’esattezza della scelta operata, perché fra questi soldati senza divisa trova un ragione per rischiare la propri vita non inutilmente, ma per un ideale di giustizia e di libertà. Le lunghe marce per sfuggire al rastrellamento, i contatti umani con le popolazioni, i terreni impervi su cui é difficile procedere, specialmente di notte quando ci si orienta solo con le stelle, a patto che il cielo non sia coperto, donano un tono epico alla narrazione, ma scevro da facili entusiasmi e da scialbe retoriche. Si va, si combatte, si muore, é una lotta per la sopravvivenza e nei rari momenti di calma, con i crampi nello stomaco per la fame, si ragiona sulla propria condizione, si cerca di dare una risposta ai tanti perché e lui trova il motivo di questo suo essere ribelle, che non ha all’origine il concetto vago di patria, ma ben altro. Scrive infatti Del Boca: "Io non combatto per la mia patria, combatto per mia madre, per rivedere il suo viso." E non è mammismo, ma è quel porto sicuro a cui cercare di approdare nei momenti più bui, quando tutto sembra perso, quando si sopravvive più per istinto che per volontà. Benchè viziato da una prolissità e ripetitività dei concetti, Nella notte ci guidano le stelle é un libro che affronta il tema della Resistenza in modo onesto e imparziale, merce rara in un argomento del genere, e che forse più di altre opere può servire a comprendere che cosa essa sia stata veramente. Insomma, la lettura, più che consigliata, é da me particolarmente caldeggiata.
Angelo del Boca (Novara
1925), saggista e storico del colonialismo italiano, ha insegnato
storia contemporanea all'università di Torino. È stato insignito di
tre lauree honoris causa dalle università di Torino (2000), Lucerna
(2002) e Addis Abeba (2014). Tra le sue numerose e importanti opere
ricordiamo: L'altra Spagna (1961), I
figli del sole (1965), Giornali
in crisi (1968), I
gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia (1996), Il
mio Novecento (2008), La
guerra d'Etiopia. L'ultima impresa del colonialismo (2010), Da
Mussolini a Gheddafi: quaranta incontri (2012).
Da Mondadori ha pubblicato: Gli
italiani in Africa Orientale (4
voll., 1992-1996),Gli italiani in Libia (2
voll., 1993-1994), L'Africa
nella coscienza degli italiani. Miti, memorie, errori, sconfitte (2002).
27 Luglio
L’armata nel deserto Il segreto di El Alamein di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia
Grazie, Ultra! In una guerra ci sono sempre battaglie che, se non possono essere definite risolutive della stessa, rivestono però una particolare importanza, poiché segnano un’inversione di tendenza. Fino all’epico scontro di El Alamein nel corso della seconda guerra mondiale la vittoria aveva sempre arriso alle armate del Terzo Reich, ma la sconfitta subita in quel piccolo villaggio, che era talmente piccolo da costituire una semplice espressione geografica, segnò una svolta al corso degli eventi, perché in seguito l’asse Roma – Berlino vide sempre una progressiva riduzione dei territori in precedenza occupati e una lenta, ma inesorabile ritirata delle sue truppe, soprattutto dopo la batosta di Stalingrado. Di questa grande battaglia nel deserto, anche se in effetti gli scontri furono tre, di cui solo l’ultimo determinante, parla questo interessante saggio storico di Arrigo Petacco. In verità l’autore, per opportuna completezza, discetta dell’intera guerra tenutasi in territorio libico, allora nostra colonia, e parte proprio dalle primissime fasi del conflitto, segnate dal tragico incidente di cui fu vittima, con l’equipaggio del suo bombardiere, Italo Balbo e che rallentò, fino a quasi paralizzare, qualsiasi nostra azione volta a contrastare l’esercito inglese e a conquistare l’Egitto. Certo ci fu l’eccessiva prudenza del nuovo comandate in capo della nostra armata in Libia, il generale Rodolfo Graziani, ma è altrettanto vero che, oltre a non essere preparati come mezzi per una guerra moderna, i piani generali erano inconsistenti ed estremamente vaghi. Fu anche per tale ragione che l’esercito inglese, inferiore ampiamente di uomini al nostro, ma superiore come qualità dell’armamento, ci inflisse a fine 1940 una sconfitta di grandi proporzioni, a cui si pose rimedio solo accettando, finalmente, l’aiuto tedesco che inviò un apposito corpo di spedizione comandato dal generale Erwin Rommel, uomo dalla forte personalità che, benchè sulla carta subordinato al comando italiano, fece sempre di testa sua, dapprima ricacciando gli inglesi, e poi marciando direttamente verso il canale di Suez. Alla luce di ciò fra gli alleati italiani e tedeschi nacquero degli attriti, tanto più che le condizioni delle nostre truppe, pure encomiabili per dedizione e coraggio, erano deplorevoli. Per combattere però in un territorio vasto, inclemente e spopolato come il deserto erano indispensabili i rifornimenti, che potevano arrivare solo via mare dall’Italia, ma questi venivano in buona parte persi per l’affondamento delle navi che li trasportavano, silurate o dagli aerei, oppure dalle motovedette, che partivano da Malta, una vera e propria spina nel fianco e che, per un motivo o per l’altro, nonostante un piano predisposto per la sua invasione, non si riusci mai a rendere inoffensiva. C’è di più però, perché se è pur vero che quasi magicamente gli inglesi sapevano tutto di questi trasporti, è altrettanto vero che avevano la possibilità di leggere i piani dell’avversario. Nessuna magia, ma la presenza di Ultra, un prezioso decodificatore delle comunicazioni tedesche; il Comando Supremo tedesco avrebbe dovuto senz’altro insospettirsi, vista la straordinaria coincidenza fra gli orari, le velocità dei convogli e le rotte seguite con gli attacchi inglesi. ma lo stillicidio delle navi perse andò avanti, sia perché gli inglesi seppero mimetizzare Ultra, sia perché l’Intelligence Service fabbricò ad arte il sospetto che le informazioni fossero fornite da qualche alto ufficiale italiano traditore. Al riguardo, poiché i tedeschi non stimavano gli italiani, abboccarono e non pensarono nemmeno per un momento che i loro preziosi codici potessero essere decifrati. Però dare il merito solo a Ultra della vittoria inglese nella terza e decisiva battaglia di El Alamein (23 ottobre – 3 novembre 1942) è troppo riduttivo; certo, concorse e non poco, ma la sconfitta venne anche per altri motivi: la scarsità del carburante, il logoramento dei mezzi e degli uomini, che si batterono tuttavia eroicamente, sia tedeschi che italiani, la malattia che colpì Rommel, una vera e propria depressione provocata dalle prime serie difficoltà dopo tanti successi - ma che non gli impedì comunque di compiere una ritirata prodigiosa, con la quale salvò quasi tutta l’armata -, le forze nemiche più numerose, meglio armate e comandate dal generale Montgomery, che se non era altrettanto bravo del comandante tedesco, sapeva però il fatto suo. Ma con questa sconfitta, benchè non tramutatasi in una rotta, se si era spezzato qualcosa nello spirito di Rommel, si spezzò ben altro nei destini della guerra, visto che, come ho sopra precisato, da allora non avvennero nuove conquiste, anzi, se pur lentamente, la Germania e l’Italia cominciarono a ripiegare e imboccarono la strada della definitiva sconfitta. Da leggere, perchè è un’opera di sicuro interesse, avvincente peraltro come un romanzo. Arrigo
Petacco è
nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear Benito, caro
Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il Prefetto di ferro,
La principessa del Nord, La Signora della Vandea, La nostra guerra.
1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio segreto di
Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in
fuga, La storia ci
ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
23 Luglio
Dietro la porta di Giorgio Bassani Feltrinelli Editore Narrativa romanzo L’origine dell’infelicità “Gli anni non sono riusciti a medicare un dolore che è rimasto là come una ferita segreta” La giovinezza non è sempre primavera di bellezza, anzi può essere un periodo di profonda tristezza interiore, di solitudine riveniente da una inconsapevole auto esclusione. Ed è di quegli anni, anni di studio al liceo, che parla questo delicatissimo romanzo di Giorgio Bassani. É il ricordo che guida la mano del narratore, che descrive con sapienza un microcosmo in cui tutti per un po’ ci siamo trovati, quello scolastico. Il periodo storico va dall’ottobre del 1929 al giugno del 1930, ma ho rilevato che quel mondo di aule, di compagni di classe, di insegnanti era assai simile a quello che ho vissuto io, solo che a dividerci c’era stata una sanguinosa guerra e una lunga ricostruzione; per il resto, gli atteggiamenti dei professori, le piccole gare per riuscire a essere il più bravo, le invidie, le ripicche sono le stesse dei miei anni ‘60 e occorrerà arrivare al famoso ‘68 perché vi sia un radicale e irreversibile cambiamento. Per l’autore è un periodo di sfide tacite, della ricerca di un compagno con cui condividere gli studi e la scelta cade su quello che, senza essere un somaro, non è nemmeno una cima, una sorta di gregario che non potrà mai diventare un pericoloso concorrente nella gara per diventare il più bravo della classe. Inizia così un rapporto in cui la continua frequentazione fa scivolare verso un’intimità sempre più accentuata, che sfiora anche la sfera sessuale nel difficile periodo del passaggio dallo stato infantile, o quasi, a quello adulto. L’io narrante è timido e tende sempre di più a chiudersi a riccio, come a proteggere quell’innocenza dell’infanzia in cui gli piace crogiolarsi. Ma c’è chi matura prima e il nuovo compagno ne è un esempio, e così l’autore apprenderà dolorosamente quanto il presunto amico sfotta quel suo essere ancora non adulto. É allora che diventerà uomo, ma la lacerazione interiore, una sofferenza sorda e muta, lo accompagneranno per tutta vita. La perdita dell’innocenza é la perdita di un mondo che gli pareva eterno e che invece si è squarciato nell’amara realtà delle miserie umane; ciò lo isolerà ulteriormente, impedendogli di aprire quella porta che lo conduca alla consapevolezza di essere parte di una realtà che inconsciamente rifiuta. Dietro la porta é un autentico gioiello, soffuso, tenue e forte al tempo stesso, frutto di un ricordo che è un grido disperato. Da leggere, senz’altro. Giorgio Bassani nacque a Bologna il 4 marzo 1916 e morì a Roma il 13 aprile 2000. Di famiglia ebraica, patì le persecuzioni razziali e durante gli anni di guerra partecipò attivamente alla resistenza. E’ solo dopo il 1945 che si dedica all’attività letteraria in via continuativa, sia come scrittore che operatore letterario (suo è il merito di aver caldeggiato all’editore Feltrinelli la pubblicazione de Il gattopardo). Poeta
raffinato, Bassani ottenne il successo di pubblico con Il giardino
dei Finzi Contini, di cui fu curata anche una trasposizione
cinematografica da parte di De Sica.
19 Luglio
Nazisti in fuga Intrighi spionistici, tesori nascosti, vendette e tradimenti all'ombra dell'Olocausto di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Saggistica storica
L’attempato signore della foto di copertina, dall’aria mite e che sembra un contabile, è invece uno dei più famigerati criminali nazisti, responsabile dei trasporti che hanno consentito la “soluzione finale”. È troppo noto perchè non abbiate potuto riconoscerlo, se non altro per l’ardita operazione che consentì ai servizi segreti israeliani di prelevarlo in Argentina, di portarlo in Israele, dove subì un processo conclusosi con la sua condanna a morte, regolarmente eseguita. Sì, è proprio lui, l’ex colonnello delle SS Adolf Eichmann. Come era riuscito alla fine della guerra a scampare alla cattura, rifugiandosi nella compiacente Argentina? E in che modo tanti altri criminali nazisti poterono fuggire, per approdare nell’America del Sud, o in Egitto, o in Siria o in Libano? Di questa fuga, per nulla disorganizzata, parla questo libro di Arrigo Petacco. Emergono così, non come illazioni, ma come verità tanti complici, alcuni dei quali del tutto insospettabili. Finita la guerra già se ne profilava un’altra, che per fortuna fu solo fredda, cioè incruenta, fra gli alleati occidentali e l’Unione Sovietica, che, nonostante gli accordi presi a suo tempo a Yalta, non vedeva l’ora di estendere il suo dominio dall’Europa orientale a quella occidentale. E poiché machiavellicamente il fine giustifica i mezzi ci fu chi intendeva avvalersi dell’esperta collaborazione degli ex nazisti, per certo anticomunisti. Così alcuni criminali furono protetti dalla CIA, altri, la maggior parte, trovarono un aiuto fattivo nella chiesa cattolica, approdando prima a Roma, dove cambiavano identità, grazie a un nuovo passaporto, per andare a Genova e imbarcarsi per l’America Meridionale. Poiché l’apparato nazista già nutriva seri dubbi fin dal 1942 su una vittoria del Reich, fu predisposto un complesso piano di fuga, furono trovati i compiacenti rifugi definitivi (in Argentina non era un mistero che il populista Peron nutrisse simpatia per il nazionalsocialismo), approntando anche i fondi necessari, non solo per l’itinerario da seguire per sfuggire alla cattura, ma per potersi ricreare una bella vita in un porto sicuro, magari da lì riprendendo il sogno pazzesco di Hitler di sottomettere il mondo. Con tanta abbondanza di mezzi, implementata anche dalle razzie nei paesi occupati, è difficile credere che l’obolo di San Pietro non ne abbia beneficiato e che magari qualche alto prelato non abbia teso la mano solo per un aiuto disinteressato. Meno probabile è che la CIA abbia approfittato di questi fondi, mentre è pressoché certo che alcuni regimi sudamericani si siano non poco ingrassati. A Petacco preme, più che approfondire il tema dei fiancheggiatori, fornire un quadro generale affinchè si sappia come fu che i più grandi criminali della storia finirono i loro giorni sereni e beati. Ricorrono nomi che fanno rabbrividire, come quello dell’angelo della morte, il famigerato Dott. Mengele, appunto di Adolf Eichmann, un grande esperto in spedizioni, o il grande cacciatore di ebrei Alois Brunner, che peraltro era un mezzo ebreo; peraltro, Petacco non fa mancare un capitolo dedicato alla storia dell’antisemitismo, pagine che sono importanti anche per comprendere come mai ancor oggi ci siano, in diversi popoli, gruppi che vedono l’ebreo come l’origine di tutti i mali, come responsabile delle loro sfortune. Se è vero che grazie a una scrittura snella e a una struttura ben equilibrata il libro si legge come un thriller, anche se invece è un saggio storico, è ancor più vero che aiuterà non poco l’attuale generazione a comprendere come l’aberrante teoria della razza superiore possa portare solo a infamie e lutti, nonché a sapere che se il crimine dell’Olocausto è il più grande di tutti, non deve essere considerato da meno di quello commesso da chi aiutò e ospitò i nazisti in fuga.
Arrigo Petacco è
nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear Benito, caro
Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il Prefetto di ferro,
La principessa del Nord, La Signora della Vandea, La nostra guerra.
1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio segreto di
Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in
fuga, La storia ci
ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
13 Luglio
La bella Rosina Amore e ragion di Stato in Casa Savoia di Roberto Gervaso Bompiani Editore
Storia biografia Una bellissima storia d’amore Se si osserva con attenzione l’immagine della copertina, una fotografia di Rosa Vercellana, meglio conosciuta in piemontese come la Bela Rosin, non si può far a meno di rilevare la floridezza del personaggio, bene in carne e nei punti giusti (fianchi e seno), con un bell’ovale in cui spiccano gli occhi scuri, dolci, ma non succubi, insomma quella tipologia femminile che tanto piaceva a Vittorio Enanuele II, impenitente donnaiolo, padre della patria e di non pochi italiani bastardi. È anche vero, però, che oltre a queste doti fisiche, la signora ne possedeva altre, tali da far innamorare in modo duraturo il re d’Italia, uomo avvezzo a ad assai frequenti incontri sessuali con qualunque femmina destasse il suo interesse – e ce ne furono moltissime -, a cui si presentava senza tanti preamboli per andare al sodo, in un’alcova che poteva essere il grande letto di un palazzo, come una brandina da campo, o anche un fienile e perfino sull’erba. Erano smanie di cui Vittorio Emanuele era preda e che servivano a temperare per un po’ la sua esuberanza, insomma si trattava di amore soltanto fisico, e non anche di affetto, di quel sentimento che porta due persone a confidarsi, a parlare, a sognare insieme, quello che invece ci fu anche e solo per la Bela Rosin. Di questo legame, durato una trentina d’anni, ci parla in questo libro Roberto Gervaso, con la sua consueta ironia, non scevra di simpatia per una donna capace, con le sue qualità, di accrescere i pregi del monarca e di attenuarne i difetti, un porto sicuro a cui rifugiarsi nei periodi bui o a cui approdare per condividere i pochi, ma sostanziosi, momenti di felicità. Il re, come noto, era sposato con Maria Adelaide d’Austria, un matrimonio combinato per cementare alleanze e dunque non ravvivato dall’amore, il che non impedì tuttavia a Vittorio Emanuele di adempiere ai suoi doveri di consorte, come testimoniano le sette gravidanze della moglie, l’ultima delle quali le fu fatale. Maria Adelaide era un tipo fine, riservato, veramente innamorata di Vittorio e che aveva capito che con quell’uomo non c’era nulla da fare, se non ignorare le sue frequenti scappatelle; lui nutriva un certo affetto per lei e in fondo era grato di avere una moglie che lo lasciava fare, come del resto analogamente si comportava la Rosina. Questa, figlia di un tambur maggiore, e quindi plebea, aveva solo quattordici anni quando Vittorio, non ancora sovrano, le mise gli occhi addosso e fu un colpo di fulmine, che durò fino alla scomparsa del re. Lei era assai bella e aggraziata, lui non era brutto, ma aveva un che di rozzo e un aspetto somatico che neula aveva in comune con i suoi ascendenti (i Savoia per parte di padre e gli Asburgo per parte di madre); anche il carattere era del tutto diverso, contrario a ogni etichetta, forse credente, ma non certo bigotto come il padre e la madre, andava più d’accordo con il popolino che con i nobili e per l’insieme di queste cose correva la voce che non fosse un Savoia, in quanto aveva preso il posto del legittimo erede, perito ancora in culla in un incendio; le stesse voci asserivano che fosse figlio di un macellaio fiorentino, ma secondo Gervaso tali notizie sarebbero da considerarsi infondate, pur restando ancora da spiegare le differenze fisiche e caratteriali. La relazione con Rosina, con cui fu prodigo di regali in denaro, gioielli e proprietà, fu in realtà un matrimonio, anche se non ufficiale, da cui nacquero tre figli, di cui uno morto subito e ai superstiti (un maschio, chiamato Emanuele, e una femmina chiamata Vittoria) il re volle particolarmente bene, preferendoli ai figli legittimi avuti da Maria Adelaide. Questo menage era ben noto a tutti e trovò la dura avversione di Cavour, che nel libro viene descritto come un individuo della peggior specie, sempre in disaccordo con il re. Ciò nonostante, Vittorio Emanuele, pur consapevole di non poter prendere in sposa la Rosa (dopo la scomparsa della moglie) e di non poter legittimare Emanuele e Vittoria, il tutto per questioni dinastiche, prima investì del titolo di Contessa di Mirafiori la Vercellana, poi arrivò all’unica soluzione possibile, una sorta di compromesso, unendosi in matrimonio con lei morganaticamente. Gli anni migliori furono forse quelli dopo il 1860, quando, senza calmarsi nelle sue passioni (donne, guerra, caccia) il re, rimasto vedovo nel 1855, poté stare più vicino alla Rosina. I due colombi già cominciavano a pensare alla vecchiaia quando improvvisamente il 9 gennaio 1878 il re moriva per una broncopolmonite; la Vercellana non era presente al trapasso perché malata e per lei fu un gran colpo e un autentico dolore. La grande storia d’amore era finita, o forse continuava nel ricordo; non trascorse molto tempo dalla dipartita del re e anche la bella Rosina il 26 dicembre 1885 chiuse per sempre gli occhi. Gervaso è uno storico e biografo che ho avuto modo apprezzare per la puntigliosità nella ricerca della verità e anche in questo libro tali caratteristiche sono presenti; forse, per la prima volta, si sbilancia, porta alla luce la sua simpatia per il personaggio, ma se veramente le cose sono state così è impossibile non sentirsi attratti da Rosa Vercellana, venuta dalla polvere e salita sull’Olimpo, una donna che tuttavia riuscì sempre ad aver ben chiare le sue origini, insomma non si montò la testa. Le notizie che fornisce l’autore sono tante che è impossibile descriverle e come suo solito all’inizio dedica un capitolo alla descrizione dell’ambiente e del periodo storico, indispensabile per proseguire la lettura avendo ben presente lo sfondo su cui si svolge questa bellissima storia d’amore che dapprima ruota intorno a Torino, capitale del Regno di Piemonte e poi, per un brevissimo periodo, d’Italia. È una città di militari e di preti, nonché di una massa di poveracci, quasi tutti analfabeti. Vittorio e Rosina sapevano leggere e scrivere, ma non erano certo dei letterati e al riguardo basta leggere i testi delle numerose lettere che Gervaso ha scelto e che, pur negli errori di grammatica frequenti, evidenziano tuttavia in modo chiaro l’intensità di un sentimento a cui pose fine solo la morte. La lettura è senza dubbio consigliata.
Roberto Gervaso è
nato a Roma il 9 luglio 1937.
10 Luglio
L’ultima crociata Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell’Europa di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia Il sogno ottomano Non solo l’ultima crociata, cioè quella che allontanò definitivamente gli ottomani dalle mura di Vienna, la loro mitica “mela d’oro” che avrebbe dovuto aprire le porte per arrivare a Roma, la “mela rossa”, ma secoli di insanabili conflitti fra il mondo cristiano e quello islamico sono oggetto di accurata trattazione in questo bel saggio di Arrigo Petacco. Il libro, però, non vuole nelle intenzioni dell’autore essere solo una cronistoria di guerre combattute per terra e per mare, ma si propone di attirare l’attenzione su un contrasto che deriva dall’osservanza del Corano che esplicitamente indica che gli infedeli, cioè noi cristiani, dobbiamo essere sottomessi e praticamente rinunciare alla nostra fede per diventare maomettani. Non è un caso quindi se l’opera inizia con un richiamo alla lectio magistralis pronunciata nel 2006 da Benedetto XVI a Ratisbona, città dell’odierna Baviera che richiama una Lega Santa della cristianità che portò alla famosa battaglia di Lepanto, allorchè la flotta ottomana fu sbaragliata e fu frenato così l’impeto di espansione verso occidente che sempre caratterizzò la politica della Sublime Porta. Nelle pagine è un susseguirsi di scontri, di battaglie, di tensioni che mai si smorzavano e che solo la grande vittoria, ottenuta da Eugenio di Savoia comandante supremo delle truppe imperiali a Zenta nel 1697,. sembrò, una volta per tutte, stroncare il crescente e temibile pericolo islamico, che ogni tanto, tuttavia, si ripresenta, come è cronaca della fine del secolo scorso e dei primi anni di questo. La materia è complessa e molto vasta, ma fra tanti dati e tanti fatti Petacco si destreggia molto bene e riesce a fornire un quadro completo ed esauriente, senza per nulla affaticare il lettore, che anzi può apprezzare lo stile scorrevole e il ritmo adeguato alle circostanze, costante, senza brusche accelerazioni e improvvisi rallentamenti. È un libro di storia, ma si legge come un romanzo particolarmente avvincente dalla prima all’ultima pagina. Le citazioni sono frequenti, ma anziché, come non di rado accade, appesantire, sono scelte con arguzia e intelligenza, così che impreziosiscono il racconto, danno l’impressione che a parlare non sia l’autore, ma siano i protagonisti di questa epica lotta. Si impara molto e, quel che più conta, con piacere, così che si riesce anche a comprendere, in modo chiaro e incontrovertibile, che solo un’Europa unita, come accadde in occasione delle crociate, può fronteggiare con successo il pericolo derivante da un concetto di religione che fa sì che uno stato, che dovrebbe essere laico, è invece uniformato a un regime teocratico, in cui l’identità fra potere temporale e potere spirituale è solo foriera di disastri per l’umanità. Da leggere, quindi, senz’altro.
Arrigo Petacco è
nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) e vive a Portovenere.
Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della «Nazione» e di
«Storia illustrata », ha sceneggiato film e realizzato programmi
televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri
della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra
gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori:Dear Benito, caro
Winston, I ragazzi del '44, La regina del Sud, Il Prefetto di ferro,
La principessa del Nord, La Signora della Vandea, La nostra guerra.
1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio segreto di
Mussolini, Regina. La vita e i segreti di Maria José, Il
Superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne
dall'America, L'amante dell'imperatore, Joe Petrosino, L'armata nel
deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo dell'Amiata, Faccetta
nera, L'uomo della Provvidenza, La Croce e la Mezzaluna, ¡Viva la
muerte!, L'ultima crociata, La strana guerra, Il Regno del Nord, O
Roma o morte, Quelli che dissero no, Eva e Claretta, A Mosca, solo
andata, Nazisti in
fuga, La storia ci
ha mentito e Ho
sparato a Garibaldi.
7 Luglio
La Montagna di Luce terzo racconto del ciclo Dèmoni di Sicilia di Donato Altomare Copertina di Alessandro Salvemini Edizioni Tabula Fati Narrativa romanzo horror Il Rosicchiatore Donato Altomare, autore eclettico che spazia in tutte le categorie del fantastico, in questo libro sfoga a piene mani la sua creatività, con un susseguirsi di invenzioni che, accompagnate da un ritmo incalzante, finiscono ben presto per coinvolgere il lettore. I due protagonisti, l’attempato, ma ancora affascinante duca di Sanseverino, e la giovane e bella Elena Ghirardi sono alla ricerca di un demone che sta progressivamente erodendo una delle colonne portanti della Sicilia. Questo essere mostruoso, proprio per quello che sta combinando, viene chiamato il Rosicchiatore, ha dimora in un rilievo montuoso e, simile a un gigantesco verme, sazia il suo appetito con carne umana, procacciata da sette avvenenti fanciulle che, all’occorrenza, si trasformano in una grossa scolopendra. Sarà una lotta titanica, non scevra di pericoli e di colpi di scena, ma, come si conviene, soprattutto in queste storie, il risultato sarà appagante, e non solo per i protagonisti, ma anche per il lettore. Come già detto, Altomare in questa prosa dimostra ancora una volta le sue grandi potenzialità creative, coinvolgendo diverse categorie del fantasticoi, perché se è vero che l’horror mi è apparso predominante, non mancano né un pizzico di gotico, né un accenno all’esoterico; il rischio di realizzare un’opera squilibrata è evidente, ma l’autore, le cui qualità letterarie sono indiscutibili, riesce bene a creare un amalgama che è di forte effetto e che ha il pregio di essere sostenuto da un ritmo e da una tensione per nulla trascurabili. Questi elementi, uniti a una capacità descrittiva che riesce con poche azzeccate frasi a materializzare all’occhio del lettore la scena, è la chiave di volta per ottenere un lavoro che è puro svago e che, data anche la lunghezza non rilevante del romanzo, invita a divorare le pagine con un ritmo ancor più veloce di quello con cui il Rosicchiatire sbriciola la colonna portante. Francamente, poiché l’horror mi attira ben poco, all’inizio della lettura temevo di cadere presto nella noia, ma non è stato così e anzi mi sono accorto che ben presto ero avvinto da questa strana trama che riservava di continuo piacevoli sorprese. Benché ritenga che la lettura possa essere più apprezzata da chi è appassionato di questo genere di letteratura credo che a tutti possa risultare gradita e che in fondo lasciarsi permeare dalla fantasia dell’autore possa costituire l’opportunità per astrarsi dalla frenesia di tutti i giorni e ritrovare quel piacere dell’avventura che cela anche il desiderio di scoprire un’altra realtà, quella non consueta, ma che è quell’immensa zona oscura, frutto dei nostri inconsci timori. Senz’altro meritevole di lettura.
Donato Altomare nasce
a Molfetta nel 1951 e vi risiede. È laureato in Ingegneria Civile
presso l’Università di Bari ed esercita la libera professione.
3 Luglio
I fratelli Rico di Georges Simenon Traduzione di Marina Di Leo Adelphi Edizioni Narrativa romanzo Collana Biblioteca Adelphi Le regole devono essere rispettate Eddie Rico vive in Florida, abita in un quartiere lussuoso, è felicemente sposato e ha una figlia che adora, è proprietario di un’attività di commercio all’ingrosso di frutta anche esotica che procede con regolarità, insomma è quel che si dice un uomo arrivato, contento del suo stato, ma non tutto è ciò che sembra. La bella casa, l’agiatezza nascondo una verità: Eddie è un uomo dell’organizzazione, una consorteria criminale che da noi viene chiamata mafia e negli Stati Uniti Cosa Nostra. Ha anche due fratelli, il solitario Gino che fa il Killer e il più giovane Tony, abile meccanico e che guida le auto che servono per missioni per così dire “speciali”. Insomma una bella famigliola di origine italiana invischiata nella malavita, che ha delle regole ben precise e che, come dice Eddie, sono fatte per essere rispettate. Tony è sparito, pare si sia sposato e pare sempre che possa spiattellare qualche notizia importante alla polizia. Deve perciò essere ritrovato e chi meglio del fratello Eddie può riuscire nell’impresa? I fratelli Rico è un noir che Simenon scrisse nel 1952 nel corso del suo soggiorno americano e presenta le caratteristiche tipiche dei romanzi dell’autore belga: lo stile snello, accattivante, la perfetta descrizione dell’ambiente, la capacità di ricreare atmosfere, il ritmo equilibrato, l’abilità incontestabile di sondare gli animi che, nel caso specifico, è a dir poco sorprendente. Perché? Perche Eddie Rico cerca disperatamente di far di tutto per salvare il fratello pur sapendo che nella sua ricerca occhi invisibili lo spiano o addirittura lo precedono, ma la famiglia è la famiglia. Ma quale famiglia? Quella dei Rico, cresciuti sulla strada a New York e in cui solo Eddie è riuscito a raggiungere la posizione che desiderava, senza mai essere violento, ma con costanza e indubbie capacità? O l’altra famiglia, l’associazione criminale, che ha delle regole ben precise che devono sempre essere rispettate? È un dramma di Eddie, piccolo boss, che raggiunta una posizione intende mantenerla senza patemi d’animo, ma che avverte anche il richiamo del sangue, il legame con il fratello e sterilmente cerca di salvarlo. Lunghi viaggi in aereo, anche in automobile, la verdeggiante pianura della Florida, la torrida California del Sud sono i palcoscenici di questa vicenda, in cui si segue il percorso di Eddie per ritrovare Tony, sempre in bilico fra rispettare le regole e trasgredirle per una volta, per amore verso il fratello. Questo travet del crimine non impietosisce, però, è solo un ingranaggio di una macchina di cui lui non è consapevole. Tutto lì deve procedere perfettamente, non ci devono essere intoppi, perchè esistono le regole e queste appunto devono essere rispettate. Come si comporterà allora Eddie? Leggete il romanzo e lo saprete, accompagnatelo nel suo peregrinare, assistete al suo dissidio interno fra obbedienza cieca e uno spiraglio di umanità, condividete con lui la tensione emotiva fino all’ultima pagina e credo proprio che al termine resterete più che soddisfatti.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi pubblicati
sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e racconti
pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e memorie.
Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a JeanPauhlan, da
Faulkner a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
30 Giugno
I vestiti delle donne di Isabella Bossi Fedrigotti Barbera Editore
Narrativa racconti Un racconto vale tutto il libro Di Isabella Bossi Fedrigotti mi sono sempre piaciuti lo stile della scrittura, lineare, scorrevole, mai greve, e l’oggetto delle sue opere, che affonda sempre nella memoria della sua famiglia e di quell’ambiente, montanaro e agricolo al tempo stesso, tanto da costituire un piacevole ritorno alla natura e a cose vecchie, ma che suscitano interesse.. Negli ultimi anni, però, o per una precisa scelta, o perché l’autore non riesce a trovare in epoche passate materiale da costituire una valida trama per un romanzo, Isabella Bossi Fedrigotti ha provato a scrivere d’altre cose, più attuali e meno frutto di esperienze dirette. Ed è questo il caso di I vestiti delle donne, quattro racconti con un titolo che è un po’ fuorviante, visto che di abiti si parla solo nel primo (organza arancione). Devo purtroppo dire che i primi tre, benché ben scritti e anche piacevoli da leggere, mi hanno un po’ deluso, perché ho riscontrato una certa banalità che non è propria dell’autore. Donne sull’orlo di una crisi di nervi, donne sole che non sanno come trascorrere il Natale e anche un uomo, di una certa età, scapolo – ma che si atteggia a macho – che spia la vicina forse disponibile, ma che potrebbe rivelarsi una fin troppo facile conquista sono i personaggi che animano i primi tre racconti, di cui, se non è possibile definirsi soddisfatti, però nemmeno stizziti, insomma si lasciano leggere, senza che rimanga dentro qualcosa. La raccolta è salvata come qualità dall’ultimo (Giù in strada) che, guarda caso, pesca ad ampie mani nella memoria, con i ricordi di una Isabella bambina, a cui non è permesso uscire di casa, e che pertanto è costretta ad ascoltare i rumori della strada, a guardare dalla finestra, e così scopriamo un mondo che non è poi così vecchio, ma che oggi appare antico: le donne che a maggio vanno al rosario, i carri, con i frutti della vendemmia, che trainati dai buoi s’avviano alla cantina, un quadro quasi bucolico che stride con l’epoca attuale, dove lungo la via corrono le auto così veloci che spesso non si riesce a coglierne neppure il colore. Questo racconto è una piccola sinfonia, un lento adagio in cui immagini e sensazioni sono espresse in modo più che convincente, con quell’abilità che ho potuto apprezzare nelle sue opere migliori ( Magazzino vita, Il primo figlio, Casa di guerra, Di buona famiglia, Amore mio uccidi Garibaldi). Da leggere, pertanto.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor
Budischowsky (Rizzoli, 2003) e Il primo figlio (Rizzoli,
2008).
25 Giugno
Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani Feltrinelli Editore
Narrativa romanzo Il dramma dell’emarginazione L’essere perseguitati in base a una legge perché si è nati ebrei e l’essere emarginati solo perché si è nati omosessuali sono i percorsi quasi paralleli di cui tratta questo romanzo breve di Giorgio Bassani, parte integrante di quel grande progetto letterario che molto opportunamente chiamò Il romanzo di Ferrara. La vicenda del dottor Fadigati, conosciuto e stimato medico otorinolaringoiatra, con avviato studio in città, può essere solo un pretesto per delineare l’esistenza di chi, per natura o per legge, è definito un diverso, ma è anche emblematica di un falso puritanesimo che al giorno d’oggi farebbe sorridere, ma che negli anni 30’, in cui in Italia predominava tanto da sembrare eterno il fascismo, era più che mai radicato. Stimato si è detto questo clinico, almeno fino a quando, pubblicamente, non rivela la propria sessualità, perché allora, all’impietosa luce del sole, si insinua nei cittadini dapprima un senso di scherno e di ilarità e poi una vera e propria emarginazione che si traduce in un calo marcato della clientela dello studio medico, in un isolamento in cui l’interessato avverte colpe che non ha. Non è un caso, poi, che pur non approvando il suo comportamento, l’autore e la sua famiglia non lo evitano, già in procinto di essere considerati pure loro diversi in quanto ebrei. Sintomatico di questo atteggiamento, se non di consenso, almeno di comprensione, è quel puvraz che pronuncia il padre dell’autore, apprendendo, raggiunta la famiglia a Riccione per le vacanze, che quella persona che così tanto stima – e che continuerà a stimare – ha manifestato pubblicamente, con grande scandalo, le sue tendenze accompagnandosi al Grand Hotel con un giovane studente sfaccendato, amico del Bassani. L’amante non è altri che un gigolò, senza alcuna morale, che va con le donne, ma che non disdegna gli uomini quando questa compagnia sia ben fruttifera. Gli spasimi di Fedigati, le sue gelosie, il lento scendere nel baratro sono descritti in modo splendido e con una penna guidata da un grande senso di pietà; sono pagine in cui l’autore riesce a cogliere il tormento dell’esistenza che può avere solo un innamorato tradito e un uomo che avverte palpabilmente un progressivo isolamento, da cui non potrà uscire se non con un gesto estremo, con un suicidio che i giornali di regime faranno passare per incidente. La vicenda si svolge mentre già la stampa comincia ad attaccare gli ebrei, tanto da parlare di imminenti leggi razziali, che di lì a poco in effetti verranno promulgate. L’ansia di questi israeliti, che memori di antiche persecuzioni sono sempre attenti a cogliere sintomi avversi, è ben esposta e procede di pari passo con le chiacchiere e gli atteggiamenti dei ferraresi nei confronti del dottor Fadigati. Due diversità, dunque, ed entrambe incolpevoli, un senso di graduale afflizione che pervade gli animi, che rende insicuri, un’inconscia sensazione di colpevolezza quando invece colpevoli non si è, incidono le pagine come rasoi, descrivono in un italiano colto e ricercato il passaggio dai timori alla disperazione, condannano senza se e senza ma l’atroce delitto dell’emarginazione, un altro crimine di cui si macchierà il fascismo, incapace di fornire agli italiani un ideale diverso da quello che gli fu proprio, cioè la violenza per la violenza, la discordia civile, il senso dell’inutilità di una vita non libera di essere vissuta. Non ho altro da aggiungere, salvo che questa piacevolissimo libro, che appaga in tutto e per tutto, lascia alla fine un senso di disorientamento, quasi di incredulità, come se certi fatti – e non dico quelli del romanzo – non possano essere accaduti, quando invece sappiamo che altri ben più gravi avvennero, come l’Olocausto conferma. Giorgio Bassani nacque a Bologna il 4 marzo 1916 e morì a Roma il 13 aprile 2000. Di famiglia ebraica, patì le persecuzioni razziali e durante gli anni di guerra partecipò attivamente alla resistenza. E’ solo dopo il 1945 che si dedica all’attività letteraria in via continuativa, sia come scrittore che operatore letterario (suo è il merito di aver caldeggiato all’editore Feltrinelli la pubblicazione de Il gattopardo).
Poeta raffinato, Bassani ottenne il successo di pubblico con Il
giardino dei Finzi Contini, di cui fu curata anche una
trasposizione cinematografica da parte di De Sica.
21 Giugno
Italiani, brava gente? Un culto duro a morire di Angelo Del Boca Neri Pozza Editore Storia
Autoassoluzione Nei ricordi dei pochi vecchi che sono rimasti in vita e che hanno conosciuto il fascismo riaffiora ogni tanto una frase, allorchè si parla dei crimini nazisti: noi italiani eravamo diversi, tanto che nei paesi occupati dicevano sempre “Italiani, brava gente”. E per quanto sembri strano, si è creato un culto di questa frase, tanto che a volte riaffiora, soprattutto quando si vuole distinguere il nostro comportamento, in certe circostanze, da quello tenuto da altri popoli. La domanda che mi pongo e che si è posta anche lo storico Angelo del Boca è se questo modo di dire risponda a verità. Ne è uscito un libro, ricco di fonti, da cui sembrerebbe che quell’italiani brava gente sia un modo per autoassolversi, poiché, sia in guerra che in pace, non solo non siamo stati esenti da critiche, ma addirittura sovente i nostri comportamenti sono risultati devastanti, in questo in verità in linea con quelli di altre nazioni, fatta eccezione per i tedeschi, che in materia di violenza e brutalità sono su un piano decisamente superiore. L’analisi storica di Del Boca è relativa a un secolo e mezzo, dalla lotta al brigantaggio, compiuta con metodi brutali alla conclusione della seconda guerra mondiale, con una proiezione più ridotta fino a quasi i giorni nostri. C’é semplicemente da inorridire, perché non poche volte le nostre azioni politiche e militari si sono tradotte in un genocidio, come accaduto per la rivolta dei libici appena conquistati, per la guerra d’Etiopia e per la nostra occupazione dei Balcani nel corso della seconda guerra mondiale,. Ma questi comportamenti scellerati non hanno colpito solo altre popolazioni, ma anche degli italiani, come appunto nella guerra al brigantaggio, e con l’ordine, impartito da Cadorna e dal Presidente del Consiglio, e avallato dal re, di non far giungere pacchi viveri ai nostri soldati prigionieri degli austriaci, così che molti morirono di stenti. C’è spesso una cattiveria nei nostri capi che mi è incomprensibile, cattiveria che raggiunge le vette più alte durante il fascismo, con il trio Mussolini, Badoglio e Graziani che avrebbe fatto la gioia di Belzebù. Tutti e tre si credevano dei geni, ma erano meno di niente, così che anche vincere la guerra d’Etiopia, il cui esercito era poco armato, diventò un problema a cui si sopperì con il ricorso ai gas asfissianti e con il terrore che colpiva soprattutto la popolazione. Non sto a raccontare quel che accadde quando ad Addis Abeba Graziani fu oggetto da un attentato, da cui uscì ferito, con orde di italiani, militati e civili, che diedero la caccia ai neri per tre giorni, facendo scempio dei cittadini etiopici, e che successivamente investì tutti i notabili e i monaci, oggetto di esecuzioni di massa e sommarie. Nel Balcani non andò diversamente e, soprattutto in Slovenia, il paese fu messo a ferro e fuoco, con il chiaro intento di eliminare quelle genti. Il generale Roatta, responsabile militare, un uomo viscido come un’anguilla e crudele come uno sciacallo, si lagnava ogni giorno che il numero dei fucilati era troppo basso e che pertanto non si doveva andare molto per il sottile, bastando il sospetto, non la prova. Quel che è peggio, però, è che a guerra finita sia Graziani che Roatta, benchè da più nazioni si reclamasse la loro estradizione come criminali di guerra, furono protetti, e non mi si dica che questo trattamento di riguardo dipendeva dall’avvio della guerra fredda e che agli americani risultavano graditi due simili personaggi in quanto anticomunisti, perché nel loro caso non è vero. Li protessero, infatti, la Democrazia Cristiana, il Vaticano e indirettamente perfino Togliatti con la famosa amnistia. Graziani e Roatta potevano così certamente dire, per il trattamento ricevuto: Italiani, brava gente. Dunque, questo motto è quasi sempre stato usato a proposito e Del Boca conclude, trovandomi d’accordo, che se si deve parlare di italiani come brava gente questo deve riguardare l’esercito del volontariato che, disinteressatamente, ogni giorno presta la sua assistenza a chi ne ha bisogno. Ne raccomando, pertanto, vivamente la lettura.
Angelo del Boca (Novara
1925), saggista e storico del colonialismo italiano, ha insegnato
storia contemporanea all'università di Torino. È stato insignito di
tre lauree honoris causa dalle università di Torino (2000), Lucerna
(2002) e Addis Abeba (2014). Tra le sue numerose e importanti opere
ricordiamo: L'altra
Spagna (1961), I
figli del sole (1965), Giornali
in crisi (1968), I
gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia (1996), Il
mio Novecento (2008), La
guerra d'Etiopia. L'ultima impresa del colonialismo (2010), Da
Mussolini a Gheddafi: quaranta incontri (2012).
18 Giugno
La Madama di Antonio Tenisci Presentazione di Patrizia Debicke van der Noot Copertina di Vincenzo Bosica Edizioni Tabula Fati
Narrativa romanzo storico Una tragedia scespiriana Di Antonio Tenisci avevo già letto Nuvole rosse sotto il mare, un buon romanzo storico sulla battaglia avvenuta a Ortona fra gli alleati e i tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale, con questa cittadina diventata una sorta dui piccola Stalingrado. L’autore vive lì e quel luogo gli deve essere tanto caro da ambientarvi un giallo storico, dalle tinte fosche, dal sapore scespiriano. Infatti in La Madama c’è di tutto: la lotta per il potere, amici e nemici, i buoni e i cattivi, i tradimenti, un incesto e infine un delitto, la cui soluzione è affidata a un capitano “Moro”, vale a dire a un nero. Da quest’opera è nata poi una pièce teatrale di successo, ma trasformarla per il teatro non deve avere costituito una grossa difficoltà per Tenisci, vista l’impostazione e la struttura del romanzo, diviso più in quadri che in capitoli, in ciascuno dei quali dominano, a turno, i protagonisti, attraverso i cui occhi possiamo vedere la scena e per ciò che dicono seguire la trama e comprendere lo stato d’animo e l’atmosfera. Le pagine non sono tante (104), ma questa brevità è più che giustificata dal fatto che l’intera vicenda si svolge nell’arco di poche ore in una notte. Se probabilmente la quasi totalità dei personaggi è di fantasia, sicuramente esistita è invece la Madama, appellativo attribuito a Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore Carlo V e che in realtà entra nella storia di Ortona, avendola acquistata. Nonostante il titolo la sua presenza nell’opera è limitata, non certo da comparsa, ma da attore di secondo piano e comunque non protagonista. Tuttavia il suo inserimento appare indispensabile per conferire al romanzo una sua precisa collocazione temporale e per essere il pretesto (il suo arrivo in città) per imbastire una trama complessa, che si dipana in una serie di verità che si susseguono e in una crescente tensione emotiva a cui contribuiscono certamente il delitto e le indagini, ma anche la tragedia familiare che gradualmente si consuma. Sembra non esservi speranza per i personaggi di uscire dalla tenebrosa galleria in cui sono entrati e che percorrono fino al termine, dibattendosi, di fronte alla verità, come falene intorno a una lampada. Opera indubbiamente originale, nonostante qua e là alcuni richiami scespiriani, La Madama si presta a una veloce e gradevole lettura.
Antonio Tenisci
vive a
Ortona in Abruzzo dopo anni di lavoro a Roma e Napoli. È stato
consulente informatico presso la Direzione Generale di Telecom Italia
e in seguito responsabile del presidio internet della Camera dei
Deputati.
16 Giugno
Il Grande Dio Pan di Arthur Machen Introduzione H.P. Lovecraft Prefazione di A. Machen a cura di Alessandro Zabini Tre Editori
Narrativa Un mondo parallelo La realtà è ciò che vediamo o esiste un altro mondo, parallelo al nostro, di cui non sappiamo nulla? Come fare per verificare se la seconda ipotesi non è una pura invenzione? A questo provvede il Dr. Raymond con un intervento chirurgico che, modificando la struttura del cranio di una giovane volontaria, innesta un terzo occhio al fine di poter vedere questo mondo nascosto. L’intervento riesce e la ragazza resta scioccata, terrorizzata per quello che ha visto. Questo si potrebbe definire l’antefatto, ma il romanzo fornisce uno sviluppo della trama, teso a trasmettere al lettore quel fremito misto di paura e di curiosità che è proprio del genere horror che non è certo fra i miei preferiti. Tuttavia, di fronte a qualcosa che non ha solo lo scopo di stupire, ma di rintracciare in noi quella perversità che è propria della bestia ho continuato a leggere, ammetto con un certo piacere. Senza descrivere altro della vicenda, a tutto beneficio del lettore, ritengo opportuno fare alcune considerazioni.. Siamo nell’epoca del famoso Dr. Jekyll e Mr Hyde e non è un caso se nell’Inghilterra vittoriana sorgono simili opere, volte anche a smascherare quell’aspetto di puritanesimo degli anni della Regina Vittoria. Non c’è di peggio, infatti, che nascondere o non far vedere, per incuriosire chi osserva, per fargli pensare che il mondo non è così, ma che dietro le convenzioni c’è ben altro e magari qualcosa di violento ed estremamente trasgressivo. Il Dio Pan – così il Dr. Raymond chiama questa realtà parallela – era una divinità pagana con tendenze orgiastiche che non mancano nel libro di Machen e che suscitarono all’epoca grande scandalo. Peraltro, l’aspetto trascendente dell’opera è riscontrabile anche nel concetto che il nostro mondo è solo illusione e che la verità autentica va ben oltre, in un orrore cosmico che vede presenti divinità naturali, esistenti ancor prima che comparisse l’uomo, divinità di cui Pan è l’ambasciatore, il messaggero o il rappresentante supremo, comunque vogliamo chiamarlo, perché ha dentro di sé il significato di ogni cosa, ogni istinto umano, l’anima e il respiro della natura. È una visione ben contrapposta a quello del Dio della nostra religione, nel senso anche che a certe condizioni è tangibile, come accade con l’esperimento del terzo occhio. E questa compenetrazione in lui di istinti umani e di essenza della natura ne fa un essere a cui inconsciamente somigliamo, soprattutto quando diamo libero sfogo a pulsioni soffocate da quel mondo di parvenza che ci siamo costruiti. Non è un romanzo per tutti, nel senso che dobbiamo, per leggerlo, aprire un terzo occhio virtuale guardando dentro di noi, andando a cogliere quanto più di nascosto e di innominabile celiamo. Così come il mistico si abbandona al crescente pulsare della fede, per vedere il nostro Dio Pan dobbiamo dimenticare dove siamo e quel che siamo; é ovvio che non è strettamente necessario un simile esercizio per leggere il libro, ma è indispensabile per trarne i frutti una volta terminato. Poi ognuno può apprezzare lo sviluppo della vicenda, appagarsi anche con le scene orgiastiche, ma questo non era il fine di Machen che voleva invece che ognuno potesse vedere il suo Dio Pan. Il romanzo è di per sé abbastanza breve, ma nell’edizione in mio possesso (Tre Editori, Roma, 2016) c’è una corposa seconda parte intitolata Appunti su alcune fonti di Arthur Machen, curata da Alessandro Zabini, di grande aiuto per la comprensione dell’opera, così come propedeutici alla stessa ed egualmente utili sono la prefazione dell’autore e un breve articolo (Arthur Machen e la paura cosmica) scritto da Howard Phillips Lovecraft. Ma non è finita, perche questa edizione è di notevole completezza, ricomprendendo un ragguardevole saggio (Il risveglio della selva) di Susan Johnston Graf e una breve, ma completa antologia panica, in cui sono presenti altri saggi, prose e poesie di diversi autori, ma tutti nomi noti, perché si va da Plutarco a Pessoa, a Pascoli, tanto per citarne alcuni. È quindi evidente che l’argomento ha sempre interessato, dall’antichità a oggi, e del resto Pan c’è sempre stato e sempre ci sarà. Da leggere, senza dubbio.
Arthur Machen (1863-1947)
è uno dei più importanti autore dell'orrore e del mistero. I suoi
libri, ai confini tra sogno e morte, ragione e inconscio, hanno
influenzato scrittori come H.P. Lovecraft e Stephen King. Oltre alla
sua opera più famosa, 'Il grande dio Pan', Machen ci
ha lasciato capolavori quali 'Le colline dei sogni', 'I tre
impostori', 'Il popolo bianco'. Il racconto 'Gli Arcieri', sugli
angeli che avrebbero aiutato le truppe inglesi all'inizio della prima
guerra mondiale, è diventato una leggenda.
12 Giugno
Claretta di Roberto Gervaso Bompiani Editore Storia biografia Morire per amore La vita di Claretta Petacci non avrebbe avuto risalto storico se non avesse condiviso la tragica fine con Benito Mussolini, l’uomo di cui era innamorata; infatti lei sarebbe stata solo una delle tante amanti del duce, ma quell’averlo seguito nella sua disperata fuga verso la Svizzera, quando avrebbe potuto mettersi in salvo con la famiglia in Spagna e pur consapevole dei gravi rischi a cui sarebbe andata incontro seguendo il suo uomo, la pongono in una luce diversa, in quella di una innamorata a tal punto da non abbandonare nel momento del più grave pericolo la persona che ama. Se l’esecuzione di Benito Mussolini ha un fondamento (già il CLN ne aveva decretato la messa a morte) quella di Claretta non sembra trovare una concreta spiegazione e forse è il caso di dire che pure lei è stata uccisa, perché si è trovata nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Poi, il suo corpo fu appeso a un distributore a Milano in piazzale Loreto, insieme con quello del suo Ben (così chiamava affettuosamente Mussolini) per poi essere addirittura sepolto sotto falso nome nel Cimitero Maggiore sempre di Milano. Ci vollero poi diversi anni perché il governo italiano autorizzasse la traslazione della salma a Roma nella tomba di famiglia sita al Verano. Ma chi era veramente Claretta Petacci? Chi era mai questa donna che si innamorò di un uomo che avrebbe potuto essere suo padre? Alla risposta, necessariamente incompleta, ma comunque assai prossima alla verità risponde Roberto Gervaso con quella coscienziosità che gli è propria, quella professionalità di storico teso, per quanto possibile, ad avvicinarsi almeno a quella che fu la realtà. Il lavoro non deve essere stato facile, perché Claretta è un personaggio del più puro romanticismo: sposata, conosce il duce e si innamora, si divide dal marito e starà a lungo e nell’ombra accanto a Mussolini, ben sapendo che lui non chiederà mai la separazione alla moglie Rachele e che le infedeltà continueranno, perché sono uno dei vizi di un uomo di bocca buona in fatto di donne, che vanno dalle prostitute alle attrici. Infatuazione, si potrebbe definire forse, nel senso che lei ama più il duce che l’uomo Mussolini e così forse anche si spiegherebbe perché non tentò di salvarsi. Resta il farro, che lungi dal farla passare per un eroina, è una donna che merita rispetto ed è la stessa opinione di Gervaso, questa volta meno disponibile all’ironia, ma più animato nello stendere questa biografia da un autentico senso di pietà. Mi pare superfluo aggiungere che la lettura è indubbiamente consigliata.
Roberto Gervaso è
nato a Roma il 9 luglio 1937. 7 Giugno
Barbari. di Alessandro Barbero
Laterza Editori Analogie storiche "Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e squilibri al suo interno, ma forte di un'amministrazione stabile e di un'economia integrata; all'esterno, popoli costretti a sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla fame e dalla guerra, e che sempre più spesso chiedono di entrare; una frontiera militarizzata per filtrare profughi e immigrati; e autorità di governo che debbono decidere volta per volta il comportamento da tenere verso queste emergenze, con una gamma di opzioni che va dall'allontanamento forzato all'accoglienza in massa, dalla fissazione di quote d'ingresso all'offerta di aiuti umanitari e posti di lavoro. Potrebbe sembrare una descrizione del nostro mondo, e invece è la situazione in cui si trovò per secoli l'impero romano di fronte ai barbari." Inizia così questo interessante saggio storico e subito ci si accorge di una straordinaria analogia con l’epoca attuale, caratterizzata da flussi migratori che ogni giorno che passa paiono sempre di più incontrollabili. Il motivo per cui l’Europa non riesce a contrastare queste masse di fuggiaschi è in pratica lo stesso che è andato a cercare Barbero per lo stesso fenomeno, non certo di ieri, ma di parecchi secoli fa- L’impero romano, giunto alla sua massima espansione, non aveva in animo di continuare le conquiste con nuove guerre, ma nuove guerre vittoriose significavano schiavi, cioè mano d’opera a basso costo; in uno stato come quello, pur in presenza di forti disuguaglianze sociali, nessuno moriva di fame, grazie proprio all’opera degli schiavi. Togliete gli schiavi e i campi non daranno più messi, dalle miniere non verranno estratti più minerali, oppure, in alternativa, sarebbe stato necessario remunerare adeguatamente i “liberi” che avessero voluto diventare salariati e operai. E allora perché non approfittare delle condizioni di estrema necessitò di popoli che fuggivano la fame o le guerre? Aggiungo che essendo questi immigrati non schiavi potevano andare a ingrossare le legioni che servivano sempre più numerose per difendere i confini da nemici vecchi, ma soprattutto nuovi;le reclute, così assoldate, erano simili a truppe mercenarie, sulla cui fedeltà non c’era poi da far tanto conto. Non è quindi un caso se i nostri politici dicono che gli immigrati sono una ricchezza, che la nostra agricoltura e industria ne hanno estremo bisogno. Solo che un flusso incontrollato e crescente finisce con il rompere equilibri che parevano consolidati, per minare strutture che sembravano non scalfibili. Anche allora ci furono, senza essere risolti, i problemi di integrazione che ci sono adesso, insomma è il caso di dire che all’origine di tutto c’è sempre il dio denaro, a cui si piega qualsiasi volontà, senza tener conto del dopo, perché c’è sempre un dopo e questo può essere peggiore, assai peggiore, della soluzione dell’originario problema. L’impero romano si sfaldò e si precipitò in un oscuro medioevo; speriamo che il ricorso storico non sia simile anche nelle conclusioni. A Barbero va dato il merito di aver affrontato il problema con la consueta correttezza e serietà, con un occhio rivolto ai giorni nostri, realizzando così un libro il cui contenuto dall’epoca imperiale romana pare proiettarsi sinistramente nel XXI secolo.
Alessandro Barbero, nato a Torino nel 1959, è professore
ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale a Vercelli.
Studioso di storia medievale e di storia militare, ha pubblicato fra
l’altro libri su Carlo Magno, sulle invasioni barbariche, sulla
battaglia di Waterloo, fino a Lepanto. La battaglia dei tre
imperi (2010). È
autore di diversi romanzi storici, tra cui: Bella
vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo (Premio
Strega 1996) e Gli
occhi di Venezia (2011).
1 Giugno
La
catena Baldini & Castoldi Editori Narrativa romanzo storico autobiografico Il consolidamento del fascismo La catena completa in modo impeccabile la trilogia con cui Emilio Lussu dapprima ha parlato con Un anno sull’altipiano della Grande Guerra, conflitto dal forte impulso nazionalistico e quindi, in un certo senso, propedeutico del fascismo, quindi dell’avvento dello stesso con Marcia su Roma e dintorni e infine del consolidamento della dittatura proprio con l’opera di cui mi accingo a scrivere. In ogni caso si tratta sempre di esperienze dirette, di vita vissuta, ma mentre il romanzo che si svolge sull’altopiano di Asiago e che è senz’altro uno dei libri di più forte impatto nel denunciare l’insensatezza e l’inutilità della guerra lascia più spazio alla creatività, i due successivi finiscono con il diventare la disamina storica di un periodo che si concluderà, dopo tanti lutti e tragedie, nel 1945. Mussolini, raggiunto il potere, avverte la necessità di consolidarlo, diventando il padrone assoluto e, come in tutti i regimi totalitari, instaurando il principio secondo il quale o si è con il dittatore, o si è un nemico, da isolare, da rendere inoffensivo tanto da annientarlo. E’ di questa fase che parla Emilo Lussu con La catena e che va dall’assalto alla casa dello scrittore di un centinaio di fascisti, a cui lui cercherà di opporsi uccidendone uno, al successivo processo, all’assoluzione combattuta e grazie a giudici onesti, ai provvedimenti del Tribunale Speciale grazie ai quali fu confinato a Lipari, da cui, insieme a Carlo Rosselli e Francesco Nitti riuscì a riparare in Francia con una rocambolesca fuga, che ebbe grande rilievo internazionale e che fu uno smacco per il regime. Le azioni poste in essere da Mussolini per consolidare la sua posizione, come per esempio alcuni attentati alla sua persona armati dalla sua stessa mano, le nuove leggi che di fatto impedivano qualsiasi opposizione, il funzionamento dei Tribunali Speciali, la difficile esistenza dei confinati, dei loro familiari e dei loro amici danno vita a un quadro talmente orrendo che è lecito chiedersi come oggi ci sia ancora gente che crede nella bontà del fascismo (come del resto, in contrapposizione, ci sono quelli che ancora sognano un ritorno al comunismo staliniano). Il tutto è raccontato in modo notevolmente efficace, perché si è trattato di esperienza diretta e l’atmosfera fosca, cupa che aleggia in quelle pagine e che può intimorire oltre misura il lettore è saggiamente stemperata da una sempre presente ironia, anche se amara. Senza retorica, senza esaltazione dei propri meriti, Lussu ci ha lasciato una testimonianza indispensabile per comprendere tante cose, anche per capire come per circa un ventennio una intera nazionale, fra partecipazione e più spesso indifferenza, si sia lasciata abbindolare da un uomo che voleva essere il padrone del mondo , ma che era senza qualità e che dal trono su cui si era issato finì appeso per i piedi alle strutture di un distributore di benzina a Milano. Da leggere, quindi, e magari da inserire nei programmi scolastici.
Emilio Lussu (Armungia,
4 dicembre 1890 – Roma, 5 marzo 1975), combatté durante la Grande
Guerra come ufficiale di fanteria della Brigata Sassari. Fondatore
del Partito Sardo d'Azione (1919), fu deputato nel 1921 e 1924 e
partecipò alla secessione aventiniana. Antifascista, nel 1929 fuggì
da Lipari con Carlo Rosselli e Fausto Nitti, coi quali a Parigi fondò
il movimento "Giustizia e libertà". Fu tra i dirigenti della
resistenza e, nel dopoguerra, senatore nelle prime tre legislature.
Presso Einaudi ha pubblicato Un
anno sull'altipiano, Marcia
su Roma e dintorni, e Il
cinghiale del Diavolo.
27 maggio
Le
guerre italiane 1935-1943
Edizioni Einaudi Le guerre fasciste Dal 3 ottobre 1935, data in cui iniziarono le operazioni militari contro l’Etiopia, al 2 maggio 1945 l’Italia fu sempre in guerra, un triste primato nella nostra storia e, quel che è peggio, non fu dovuto a un incolpevole coinvolgimento, perché si trattò di conflitti avviati da noi, con formali dichiarazioni di guerra in alcuni casi e in altri con improvvise aggressioni. I teatri operativi furono i più vari e gli esiti non sempre fortunati, per una nostra cronica deficienza di mezzi adeguati e per una perniciosa e costante impreparazione non solo sul campo, ma anche in sede progettuale. La guerra d’Etiopia, quella di Spagna, nel Mediterraneo, nei Balcani, in Africa settentrionale e in Russia furono volute da Mussolini, un uomo la cui vanità lo portò a sottovalutare gli altri e a sopravvalutare se stesso, la stessa vanità che lo indusse a costituire la Repubblica Sociale Italiana , con il risultato di avviare una sanguinosa e devastante guerra civile. Già ho scritto, in altre occasioni, che il capo del fascismo, oltre ad avere quasi nessuna qualità, era succube del suo stesso mito e, man mano che passavano gli anni, pur ridimensionando il suo ruolo, aveva un’ambizione mai soddisfatta w tale da offuscargli quel poco cervello che gli era proprio. Al riguardo basti pensare a quanto ebbe a dire orgogliosamente al suo segretario nel 1944, al ritorno da una visita in Germania all’amico e padrone Adolf Hitler:“ Una volta finita vittoriosamente questa guerra, tutta l’Italia settentrionale, fino al Po, sarà annessa al Reich. Il resto diventerà una colonia, di cui io sarò il viceré”. Da padrone del mondo a viceré, da padre ideologico di Hitler a succube dello stesso, una parabola discendente che si chiuse con la sua esecuzione. Di queste guerre, promosse esclusivamente dal duce, parla questo libro di Rochat, noto storico militare, e in effetti viene trattato proprio il loro aspetto strategico, dimostrando, senza ombra di dubbio, che lo sforzo massiccio in Etiopia e poi in Spagna depauperò il nostro esercito, rendendo di fatto impossibile, per almeno un decennio, la partecipazione ad altri conflitti, e invece Benito Mussolini, pur ben consapevole, non ne tenne conto, giocando d’azzardo, contando sulle vittorie degli alleati e su un po’ di fortuna, con conseguenze disastrose. Come il suo alter ego Hitler era convinto di essere un grande stratega e che avesse un senso la politica anche in campo militare; sbagliava e l’Italia conobbe i dolori e gli orrori della guerra. Mussolini non fu sfortunato, poiché nulla fece per preparare adeguatamente i suoi progetti di conquista, fu semplicemente un folle che ancor oggi trova un certo seguito in gente che non vuole vederlo per quello che era: incapace, feroce e pavido. La trattazione di Rochat è molto puntuale, infarcita da innumerevoli dati sulla consistenza dei nostri mezzi e di quelli dei nostri avversari, sulla condotta delle campagne e sui loro esiti. Purtroppo questa sovrabbondanza di elementi di valutazione se da un lato si commenta da sé, dall’altro appesantisce non poco il discorso, rendendo poco gradevole la lettura. Non ho nulla da obiettare sulle capacità di Rochat, storico assai stimato, ma credo che se fosse riuscito a introdurre – e le occasioni non mancavano – qualche spunto di ironia la piacevolezza ne avrebbe beneficiato non poco. Lo stile invece è incolore, accademico, più da testo universitario che da libro di amena e istruttiva lettura. Comunque, per chi volesse documentarsi sulle guerre italiane e di come nacquero e si svolsero il volume mi sembra di grande utilità e interesse, per cui la lettura è senz’altro consigliata.
Giorgio Rochat (1936)
è stato professore di Storia contemporanea e poi di Storia delle
istituzioni militari nelle Università di Milano, Ferrara e Torino. Ha
studiato e studia la storia militare, coloniale e politica
dell'Italia contemporanea. Tra le sue opere più recenti: La
Grande Guerra 1914-1918 (con
Mario Isnenghi, Bologna 2000 e 2008); Le
guerre italiane 1935-1943 (Einaudi,
2005 e 2008).
22 Maggio
La casa di Barbara La camera degli sposi di Edgarda Ferri Tre Lune Edizioni Narrativa romanzo breve
La signora con due bande bianche sui capelli Mi corre l’obbligo di una opportuna premessa: se avete visto, nel corso di una gita a Mantova, la famosa Camera degli sposi o Camera picta, che si trova nel Castello di San Giorgio, imponente fortezza adiacente il celebre Palazzo Ducale, oltre a rimanere stupiti per la straordinaria bellezza dell’affresco di Andrea Mantegna, forse vi sarete chiesti chi sono i personaggi ritratti e che occasione, del tutto particolare, il grande pittore aveva voluto celebrare A queste domande risponde Edgarda Ferri con La casa di Barbara, uno strano romanzo storico che ha più della storia narrata che della prosa, per quanto, considerando alcuni aspetti, fra i quali la fluidità del racconto, la capacità di sondare interiormente i personaggi e un pizzico, ma è solo un pizzico, di creatività, tutto sommato si è indotti giustamente a pensare che non è un vero e proprio saggio. Visto che il titolo è La casa di Barbara, la Ferri ha voluto ripercorrere, almeno fin dal momento del suo arrivo a Mantova, la vita di Barbara di Brandeburgo, nipote dell’imperatore Sigismondo, promessa in sposa quando aveva solo dieci anni, al diciannovenne Ludovico, figlio ed erede del Marchese Gianfrancesco Gonzaga. Il matrimonio fu celebrato un po’ più tardi, ma lei era ancora poco più di una bambina. Fu un matrimonio combinato come si usava fra nobili, con tanto di prezzo della sposa, che costò ai Gonzaga ben 25.000 fiorini. Eppure l’unione fra questa fanciulla non bella e che all’inizio non sapeva una parola d’italiano, e Ludovico, che pure non era certo un adone, fu uno di quelli rari in cui la coppia combinata da altri visse d’amore e d’accordo. Barbara era una donna intelligente, colta (parlava quattro lingue), tenera, ma anche decisa; lui, spesso assente per le guerre, finì con il trovare in lei quel porto sicuro a cui ritornare. Di figli non ne nacquero pochi, ma purtroppo tutti con il segno della tara ereditata dalla madre di Lodovico, Paola Malatesta. Infatti, sia i maschi che le femmine, chi più chi meno, portavano sulla schiena quella gibbosità che è più conosciuta con il nome di gobba. Se era meno difficile trovare una moglie per i figli maschi, era quasi impossibile che qualche nobile accettasse di sposare una femmina con quella protuberanza, come accadde con Dorotea, promessa a Gian Galeazzo Visconti, che però poi rifiutò decisamente di unirsi a una deforme. Dorotea per il dolore morirà giovane, gettando un’ombra di perenne mestizia sui genitori. Barbara è un personaggio straordinario, una donna che sa governare, ma che conosce la pietà e rifulge fra tutte quelle figure che sembrano messe lì apposta affinchè i visitatori le ammirino, desiderando di sapere i loro nomi e le loro vite. Le mani prodigiose e la mente fuor del comune di un pur tignoso Andrea Mantegna li hanno consegnati ai posteri, dando loro una presenza anche dopo la morte. La capacità di narrare dell’autore ci porta a conoscerli, ad ammirarli o a coprirli di disistima, ma in ogni caso a renderci partecipi di vite che hanno brillato tanti secoli fa. Senza per forza cercare di indulgere alla commozione, la Ferri ha saputo toccare le corde giuste e, pur rigorosamente attenta ai fatti storici, è riuscita a suo modo a realizzare anche lei un dipinto, con mano ferma, ma lieve, senza ricorrere alla retorica e arrivando anche a vette sublimi. Leggetelo, perché è imperdibile, e poi magari venite a Mantova, andate a vedere la Camera degli sposi e vi sembrerà di trovarvi di fronte ai ritratti di vecchi amici.
Edgarda Ferri,
giornalista, saggista e scrittrice.
16 Maggio
La melodia di Vienna di Ernst Lothar Edizioni e/o Narrativa romanzo La storia
siamo noi
Mi permetto solo di aggiungere che alla lettura piacevolissima di
tutte le pagine si accompagnerà alla fine una struggente malinconia,
nella consapevolezza che in fondo tutti siamo pedine della storia e
che per tutti c’è un tempo che mai più ritornerà.
9 Maggio
I prigionieri dei Savoia La vera storia della congiura di Fenestrelle di Alessandro Barbero Editori Laterza
Storia Smontata una bufala mediatica Joseph Goebbels, ministro della propaganda del terzo Reich, le cui capacità di imbonitore sono fuor di dubbio,ebbe a dire:ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità. Perché ho pescato dalla mia memoria questa peraltro famosa citazione? Da alcuni anni un gruppo di storici, o meglio pseudo storici revisionisti, ma che si potrebbero anche definire neoborbonici, sta cercando di minare la già poca coesione nazionale con una pretesa verità, secondo la quale ai soldati del Regno delle Due Sicilie presi prigionieri dai garibaldini e dai piemontesi sarebbe stata riservata un sorte non dissimile da quella degli ebrei vittime dell’olocausto. Ci sono state pubblicazioni al riguardo, ma anche una diffusione capillare su Internet, che ho potuto verificare di persona e che mi ha lasciato piuttosto perplesso. Dico subito che non ho preso per oro colato le asserzioni di questi revisionisti, ma, considerato quanto di strano può accadere nel nostro paese, mi sono detto che una simile accusa, i cui elementi probatori in verità sono assai esili, meritava un approfondimento onde accertare la sua fondatezza. La perplessità è derivata sai dai toni accesi, sia confrontando i vari interventi, con numeri e notizie non concordanti. Tanto per citare un caso, l’Auschwitz del XIX secolo, l’antico forte di Fenestrelle, viene indicato sito a 2.000 metri di altezza, anziché a 1.200, e non credo si tratti di un errore, perché le temperature fra le due quote sono molto diverse e a quella più alta è molto più freddo, il che serve a giustificare lo sterminio, non solo per stenti, ma anche per la rigidità del clima, accampato dai revisionisti secondo i quali i soldati borbonici ivi rinchiusi - e sarebbero stati quelli che avevano rifiutato l’arruolamento nell’esercito piemontese –, coperti solo da camicioni di tela, sarebbero periti nel corso del lungo inverno. Alessandro Barbero, per quanto piemontese, è uno storico capace e coscienzioso e ha ritenuto necessario effettuare la verifica, da cui è scaturito questo saggio che, essendo fatto di tanti numeri e notizie probatorie capillari, può riuscire di non agevole e particolarmente piacevole lettura; tuttavia l’opera ha il pregio di smontare, senza ombra di dubbio, la teoria revisionista. A Fenestrelle furono rinchiusi temporaneamente pochissimi soldati borbonici, ma non come prigionieri, bensì in attesa di destinazione, e in ogni caso non vi trascorsero l’inverno e se vi furono dei decessi questi furono solamente quattro e per malattia. Quindi, le persecuzioni, i maltrattamenti, il chiaro intento di dare la morte a questi sconfitti sono solo menzogne e la circostanza è di particolare gravità ove si consideri che l’intento mistificatorio è di dividere gli italiani, ancora poco uniti, e in un certo senso di contrapporre un meridione arretrato cronicamente a un settentrione visto come uno sfruttatore delle sane energie del sud. Simili pseudo storici, incapaci di supportare le loro teorie con un’analisi storica completa ed esauriente, hanno la possibilità di portare avanti il loro discorso secessionista solo perché siamo in democrazia, in cui vige quella stessa libertà di parola che se ritornassimo, come nelle loro intenzioni, ai bei tempi di Franceschiello, sarebbe totalmente proibita. Barbero, data l’importanza della questione, è stato ancora più scrupoloso del solito nel reperire le fonti e i documenti probatori, lavoro non certo facile, ma che costituisce il supporto indispensabile per dire con pressoché totale certezza che non vi fu alcun sterminio e che la teoria dei revisionisti si basa solo su chiacchiere e illazioni, senza che esista al riguardo il benché minimo elemento probatorio. Quindi I prigionieri dei Savoia è assolutamente da leggere, e non solo per conoscere un aspetto della nostra storia spesso trascurato, ma per non dare il minimo credito alle tante e irresponsabili voci presenti su Internet.
Alessandro Barbero, nato a
Torino nel 1959, è professore ordinario presso l’Università del
Piemonte Orientale a Vercelli. Studioso di storia medievale e di
storia militare, ha pubblicato fra l’altro libri su Carlo Magno,
sulle invasioni barbariche, sulla battaglia di Waterloo, fino al recenteLepanto.
La battaglia dei tre imperi (2010). È autore di diversi romanzi
storici, tra cui: Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo (Premio
Strega 1996) e Gli occhi di Venezia (2011).
3 Maggio
I passeri di Giuseppe Dessì Ilisso Editore Narrativa romanzo
Livido come un plumbeo autunno Quando Giuseppe Dessì scrisse nel 1955 I passeri, aveva già dato alle stampe un romanzo di intensa umanità e anche di speranza come Michele Boschino, un’opera in cui è presente un’accentuata identità fra l’uomo e la natura in cui vive. Ebbene I passeri è tutta un’altra cosa, racchiuso fra i muri di una vecchia casa, tanto che sembra che gli esterni non esistano, che quei mattoni costituiscano, al contempo, un rifugio e una prigione per chi vi abita, in un autunno livido che si scioglie in un inverno per nulla radioso. È un romanzo di lancinanti solitudini, di personaggi che vivono senza la speranza di un domani, stretti nell’abito cucito loro addosso dal destino e da cui nemmeno cercano di uscire o di ribellarsi a una condizione a cui, tutto sommato, sono indifferenti. Viziato da una trama complessa che non di rado mette a disagio il lettore e con uno stile che non sembra quello dei romanzi di Dessì che ho già letto sono rimasto francamente un po’ sconcertato, perchè sembra il risultato di un’opera concepita in un periodo di depressione, scura com’è, uno sfogo disperato a uno stato di sofferenza interiore che non sempre il lettore si sente di accettare. A scanso d’equivoci, non è che I passeri sia sconsigliabile, ma per l’impostazione, i toni, l’intricata vicenda, la staticità credo non si possa far rientrare fra i libri più riusciti di Giuseppe Dessì. È un peccato, perché mi ero abituato bene con le opere di questo autore e quello che mi auguro è che si tratti di un caso isolato, di un momento poco propizio e infelice nella sua produzione, almeno per quanto riguarda i romanzi che ho già letto (Paese d’ombre, Il disertore e Michele Boschino).
Giuseppe Dessì nacque a
Cagliari il 7 agosto 1909 e trascorse a Villacidro, cittadina alle
pendici del Monte Linas, una difficile, inquieta adolescenza. La
scoperta casuale di una biblioteca murata che custodiva, assieme a
tanti altri libri, il Catéchisme positiviste e il Cours de
philosophie di Comte, il Discorso sul metodo di Cartesio,
l’Ethica di Spinoza, la Monadologia e la Teodicea di
Leibniz, il Piccolo compendio del Capitale di Cafiero… fu
l’occasione per disordinate letture filosofiche e letterarie che lo
portarono sull’orlo della follia.
Lì Dessì frequentò, oltre a Varese
(che aveva già conosciuto in Sardegna, grazie a Cantimori), Carlo
Cordié, Mario Pinna, Carlo Ludovico Raggianti, Aldo Capitini…,
laureandosi nel 1936, dopo avere studiato a lungo Tommaseo, con una
tesi su Manzoni discussa con Luigi Russo.
In seguito a generosa donazione della
moglie Luisa Babini e del figlio Francesco Dessì-Fulgheri le carte
Dessì sono da anni depositate all’Archivio Contemporaneo “A. Bonsanti”
del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze, a disposizione degli
studiosi.
Fonte Fondazione Giuseppe Dessì
29 Aprile
Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945 di Mario Isnenghi
Edizioni Il Mulino Gli italiani e le guerre Che Mario Isnenghi sia un grande storico è sicuramente fuor di dubbio, ma che sappia raccontare la storia non solo per gli studenti degli atenei, ma anche per una vasta ed eterogenea platea è un’altra cosa, una qualità che, secondo me, non gli è propria. Di suo avevo già letto La Grande Guerra, opera per certi versi interessante, ma viziata da un tono accademico che di certo non consente al lettore di appassionarsi e di sentirsi partecipe. Anche questo libro (Le guerre degli italiani Parole, immagini, ricordi 1848 – 1945), presenta il medesimo difetto che, pertanto, deve ritenersi congenito; non si pretende che abbia il carisma di Denis Mack Smith o le capacità di attrarre di Alessandro Barbero, ma resta il fatto che fra il sapere e il diffondere questo sapere spesso resta un abisso; nella circostanza, poi, l’impostazione dell’opera, che pure è interessante, appare dispersiva, perché il raccontare dei conflitti che hanno caratterizzato l’Italia di circa un secolo non avviene secondo un ordine cronologico, bensì sulla base delle tipologie delle testimonianze storiche, e cioè, e solo per citarne alcune, i proclami, i quotidiani, la corrispondenza dei militari e i nomi delle vie. Non c’è dubbio che questa strutturazione sia assai originale, ma presenta anche lo svantaggio che può, e sovente ci riesce, disorientare. Ne esce un quadro del tutto particolare, il risultato dell’esatto incastro dei numerosi e variegati pezzi di un grande puzzle, in cui c’è di tutto: retorica e cattivo gusto, esaltazione e scoramento, fatica e dolore, tanto dolore. Oserei dire che Isnenghi più che impegnato a parlarci delle tante, troppe guerre che hanno visto coinvolto un popolo come il nostro che si atteggia a pacifico, ha inteso fare una ricerca sociologica per comprendere e descrivere l’atteggiamento degli italiani nei confronti della guerra. In questo senso l’impostazione è quella giusta – e non avrebbe potuto fare altrimenti – e l’opera assume un valore del tutto particolare per conoscere come eravamo, come siamo e forse come saremo. In tal caso il risultato cambia e diventa più che apprezzabile, tanto da consigliarne vivamente la lettura, pur con i limiti dianzi precisati del tono accademico utilizzato.
Mario Isnenghi è
nato a Venezia nel 1938 e ha insegnato Storia Contemporanea
all’Università Ca’ Foscari di
Venezia. E’ autore di numerosi libri di storia, fra in quali I
vinti di Caporetto nella letteratura di guerra (Marsilio,
1967), Il mito della
Grande Guerra. Da Marinetti a Malaparte (Laterza,
1970), Le guerre degli
italiani. Parole, immagini, ricordi. 1848 – 1945 (Mondadori,
1989), La grande guerra (Giunti,
1993), L’Italia del
fascio(Giunti, 1996), La
tragedia necessaria. Da Caporetto all’otto settembre (Il
Mulino, 1999),Garibaldi fu ferito. Storia e mito di un
rivoluzionario disciplinato (Donzelli,
2007),Garibaldi fu ferito. Il mito, le favole (Donzelli,
2010), Ritorni di
fiamma. Storie italiane(Feltrinelli, 2014)
26 Aprile
Ora ti conto un fatto di Piero Chiara Arnoldo Mondadori Editore SpA Narrativa
Piero Chiara è stato un narratore di eccelsa qualità, capace di portare alla luce, nei suoi difetti, ma anche nelle sue qualità, quel piccolo mondo dei paesi di una provincia di cui, con il tempo, si sarebbe persa sicuramente la memoria. Grazie a lui abbiamo potuto conoscere una galleria di personaggi indimenticabili (il tombeur de femmes Emerenziano Paronzini di La spartizione, il cornificatore Augusto Vanghetta di Il pretore di Cuvio, lo straordinario Anselmo Bordigoni di Il balordo e il Camola e il Tolini di Il piatto piange, solo per citare i più famosi). Si tratta di prose lunghe, cioè di romanzi, ma Chiara eccelleva anche con i racconti, la cui raccolta più famosa è forse L’uovo al cianuro. L’autore ha una straordinaria abilità affabulatrice, tanto che nel leggere si ha l’impressione di averlo davanti mentre lui ci racconta, dote che doveva avere anche suo padre quando la sera riuniva la famiglia e iniziava a narrare con queste parole: Ora ti conto un fatto. E Ora ti conto un fatto è appunto il titolo di questa raccolta di prose brevi, che presenta alcuni racconti già usciti in altri volumi, come appunto L’uovo al cianuro, mentre diversi risultano inediti. La caratteristica che li accomuna è che non sono frutto di pura invenzione, ma derivano da fatti in cui Chiara è stato partecipe o testimone, oppure di cui lui ha sentito parlare da altri; ovviamente, poi, la sua creatività li amplia e arricchisce, ma comunque sono tutte storie vere, come del resto i suoi romanzi. Si tratta in tutto di 23 racconti, scritti in un arco di tempo ampio, che va dagli anni ’30 al dopoguerra e, come sempre accade, in presenza di numerose prose ce ne sono di più riuscite e altre meno, ma il livello medio resta sempre piuttosto alto. Se si crede che ci siano numerose occasioni per ridere dico subito che queste sono poche, anche perché l’intento dell’autore era quello di fissare la memoria del suo trascorso. Prevale quindi una natura intimistica in cui le opportunità per riflettere non mancano di certo e al riguardo mi permetto di segnalare gli ultimi tre: Il paolotto, con un avventuroso viaggio in Alto Adige nell’autunno del 1945, Tra i pargoli innocenti, che prende spunto da una visita al camposanto e che finisce con il diventare un pacato approfondimento della natura dell’esistenza, ed E’ stato il freddo, in cui il clima rigido, oltre che protagonista, assume sembianze quasi umane. Ma anche i primi della raccolta, con l’infanzia da discolo, hanno una valenza che va ben oltre il ricordo e alternano momenti quasi comici ad altri idilliaci, con descrizioni del lago e dei suoi monti che lasciano stupefatti perché, oltre che perfette, fotografiche, riescono a ricreare , in modo semplice, ma incisivo, l’atmosfera. Quindi non posso che consigliarne la lettura, mai affaticante, anzi sempre più che gradevole. Piero Chiara nacque a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i più amati e popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi, quasi cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo, conterraneo e grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie che Chiara amava raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori, 1962), che segna il suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara scrisse con eccezionale prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.
E’ stato autore
particolarmente fecondo e fra le sue numerose pubblicazioni figurano Il
piatto piange (1962), La spartizione (1964), Il balordo (1967), L’uovo
al cianuro e altre storie (1969), I giovedì della signora
Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La stanza
del Vescovo (1976), Il vero Casanova (1977), Il cappotto di
Astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Vedrò
Singapore? (1981), Il capostazione di Casalino e
altri 15 racconti(1986).
25 Aprile
SARO (Rosario)
23 Aprile
Guanti bianchi di Edgarda Ferri Skira Editore
Narrativa romanzo La fine di una dinastia Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, vittime di un attentato dei nazionalisti serbi persero la vita l’erede al trono dell’impero austro-ungarico Francesco Ferdinando d’Asburgo e sua moglie Sophie Chotek; l’evento in sé, per quanto grave, sarebbe stato confinato nei fatti, non sempre lieti, che costellano la storia se non avesse invece costituito il pretesto per l’inizio di un conflitto enormemente sanguinoso, più conosciuto con il nome di prima Guerra Mondiale. Se forse è vero che nessuno voleva uno scontro aperto, è altrettanto vero che nulla fu fatto per impedirlo, con conseguenze nefaste per chi vi si impegnò militarmente soprattutto per tentare di risolvere il problema, invece ormai senza soluzione, di una inarrestabile decadenza. Furono sufficienti infatti pochi anni per cancellare dalla scena europea alcune grandi monarchie, che ormai da tempo apparivano in inesorabile declino; sparirono così i grandi regni e imperi di Russia, di Turchia, di Germania e di Austria-Ungheria. Perché ciò avvenne? Perché una grande dinastia quale quella asburgica giunse alla fine dei suoi giorni? E’ a queste domande che Edgarda Ferri intende rispondere con il suo romanzo storico Guanti bianchi, partendo proprio da quel funesto 28 giugno 1914. Ed è lì che con l’improvvisa scomparsa dell’Arciduca, nel vuoto di un potere rappresentato dall’imperatore Francesco Giuseppe, vecchio e stanco e soprattutto atrofizzato nel suo personaggio di regnante, padre di tante patrie di cui ormai non conosce più i figli, prende corpo una figura normalmente non di primo piano in una dinastia, ma che nella circostanza ha il potere di dettare regole e comportamenti a cui tutti devono soggiacere. Si tratta del principe Alfred di Montenuovo, il Gran Ciambellano, il cui compito è ora di organizzare le solenni esequie, secondo un protocollo rigido, pomposo, fuori di ogni logica e anche fuori dal tempo. Lui può tutto, ciò che decide è legge e deve essere obbedito; è un uomo insensibile, perfino gretto, che di certo non aveva in simpatia l’Arciduca, per non parlare si Sophie Chotek che, per quanto contessa, era troppo poco nobile per sposare un erede al trono. Infatti il futuro imperatore d’Austria avrebbe dovuto sposare solo una figlia di re e ce ne volle a Francesco Ferdinando per convincere Francesco Giuseppe a dare l’assenso al matrimonio, assenso frutto di un compromesso di una meschinità incredibile: la sposa avrebbe dovuto vivere nell’ombra, come se non ci fosse stata. E anche questo è un bel problema per il Gran Ciambellano, costretto a far convivere un funerale di prima classe con un altro di terza, un catafalco immenso su cui collocare il corpo dell’arciduca e qualche cosa di infinitamente più modesto per la moglie. Tuttavia, per gentile concessione, in un apparente impeto di umana pietà, il principe di Montenuovo consentirà che sulla bara di Sophie, esposta per due ore nella cappella palatina dell’Hoffburg, vengano messi un paio di guanti bianchi e un ventaglio nero. Perché? Per sancire un indiretto legame con la famiglia del marito in quanto lei da nubile era stata dama di corte della moglie di un arciduca Asburgo. Sophie era stata solo una dama di corte, quasi una cameriera di rango nobiliare, e tale era da considerarsi ancora. Non si tratta quindi di umana pietà, bensì di un ulteriore affronto a una donna che in vita sua aveva avuto solo il torto di amare l’erede al trono. E in un’atmosfera come questa, nella cappa opprimente del vecchio e stantio che l’attentato ha reso ancora più cupa, è evidente che ci troviamo di fronte alla degenerazione di un sistema che, divorando se stesso, finisce con l’implodere. Il ritmo è dovutamente lento perché tale deve essere ed Edgarda Ferri ha saputo dare a un dopo (dopo l’attentato) il senso ben preciso di una cerimonia funebre con cui una dinastia finisce con il seppellire se stessa. Da leggere senz’altro.
Edgarda Ferri,
giornalista, saggista e scrittrice.
18 Aprile
Casanova Storia di un filosofo del piacere e dell'avventura di Roberto Gervaso Rizzoli Editore Storia Biografia Il grande amatore che non sapeva amare Giacomo Casanova (Venezia, 2 aprile 1725 – Dux, 4 giugno 1798) è stato un uomo dai mille volti e, a suo modo, un personaggio irripetibile; in un’epoca, quella dei lumi, in cui la ragione sembrava dare spiegazione di ogni cosa, ma che vide il fiorire di individui che ancora riuscivano a cogliere frutti dall’ignoranza e dalla superstizione, uomini come Cagliostro, o il conte di Saint Germain, Casanova fu un attento e abile osservatore, come testimoniato dalle sue memorie. E se fu senz’altro un avventuriero, ma anche un alchimista, un filosofo e un agente segreto, il suo nome é sempre stato associato alla figura del grande amatore, del massimo tombeur de femmes, attribuzione esagerata, anche se non infondata, ma che in epoca successiva ha diviso i suoi numerosi e spesso famosi biografi fra detrattori e incensatori. Roberto Gervaso, con questo volume, frutto di un lavoro di certosina pazienza volto a verificare, con altre fonti, la coincidenza con quanto narrato nell’Histoire de ma vie, senza omettere gli aspetti negativi ha invece teso a porre in evidenza le sue grandi qualità di letterato. Uomo del XVIII secolo il veneziano ci ha fornito una pregevole descrizione della sua epoca, una sorta di belle epoque troncata dall’avvento della rivoluzione francese. Errabondo, sempre in movimento da una corte all’altra, Casanova ha saputo leggere e interpretare il sui tempo, fornendoci un contributo indispensabile per una migliore conoscenza del secolo dei lumi. Certo fu anche un avventuriero, ideatore di truffe finalizzate a supportare finanziariamente il suo esagerato modo di vivere, caratterizzato da un lusso sfrenato; tutto era messo in atto per soddisfare il suo accentuato narcisismo e per inserirsi nella ristretta cerchia dei nobili, di cui fu un parassita. Seppe abilmente approfittare delle naturali debolezze di una casta chiusa e immobile e in pratica riuscì a vivere, quasi sempre da gran signore, senza lavorare. Tuttavia il suo elevato grado di cultura, che lo portò ad incontrare e a misurarsi come filosofi come Voltaire, ci dice che non fu un semplice imbonitore da quattro soldi, ma un individuo dotato di una complessa personalità che aveva improntato la sua esistenza al carpe diem. In questo contesto si inserisce il suo aspetto più noto di grande amatore, meritato senz’altro anche se poi, a conti fatti, sembrerebbe abbia posseduto non più di duecento donne. E fra queste c’erano le predilette lolite, ma anche le tardone (a cui spillava soldi) e non mancavano nemmeno mercenarie che gli si concedevano contro pagamento. In questo turbinio di rapporti, a volte di gruppo, finì con l’incappare più di una volta in qualche malattia venerea, come lo scolo e la gonorrea, da cui uscì guarito curandosi con certi suoi impiastri. La donna del momento, qualunque essa fosse (e fra queste ci fu anche una gobba), era sempre la più bella e più desiderabile della precedente, e che lui si innamorasse veramente ogni volta non c’è dubbio, ma era estremamente volubile e quel ricercare nell’amore solo l’aspetto sessuale finì con il pregiudicare la possibilità di un’esistenza normale e lo portò a una vecchiaia casta (per i definitivamente sopiti ardori) e solitaria, in cui non poté che rivivere i bei tempi grazie al ricordo e scrivendo le sue memorie. Queste, un’autentica opera d’arte, sono appunto analizzate criticamente da Gervaso con la sua sottile ironia, soprattutto ove Casanova esagera, come nel caso dei rapporti avuti in una notte, il cui numero è fuori da ogni logica. Tuttavia, è per lo più sincero e finisce con il diventare simpatico, anche da vecchio, emarginato, rinchiuso nella sua solitudine, che solo il ricordo del passato riesce in parte a lenire. L’uomo, il grande amatore, muore in silenzio, non circondato da affetti, che non aveva mai cercato: insomma, per quanto paia un ossimoro, a conti fatti non aveva saputo amare. Questa biografia è veramente splendida e si legge con grande piacere, grazie anche allo stile snello e incisivo dell’autore.
Roberto Gervaso è
nato a Roma il 9 luglio 1937.
10 Aprile
Squilibri di Milvia Comastri Antonio Tombolini Editore
Narrativa racconti Instabilità Ho avuto modo di conoscere la scrittura di Milvia Comastri nel lontano 2006 allorché recensii il suo primo libro, Donne, ricette, ritorni e abbandoni, una raccolta di racconti il cui comune denominatore è la preparazione del cibo. Ne apprezzai lo stile fresco e semplice, che non poco contribuiva alla gradevolezza della lettura. Successivamente, nel 2012, è uscita un’altra raccolta di racconti, Colazione con i Modena City Ramblers che è caratterizzata da una varietà di tematiche che ancor di più offre la possibilità di attrarre esigenze diverse, accontentando una più variegata popolazione di lettori. Anche in questo caso ne ho scritto la recensione, evidenziando la sensibilità e delicatezza che accompagna queste prose e fermo restando quelle caratteristiche stilistiche che mi avevano in precedenza colpito. Due opere, due raccolte di racconti, a riprova dell’inclinazione della scrittrice per la narrativa breve (occasionalmente, si diletta anche di poesia) sono pertanto caratteristiche della sua produzione e infatti il terzo libro, da poco pubblicato, è analogo nella realizzazione ai precedenti. Squilibri è una raccolta di racconti (in tutto venticinque) il cui tema dominante é l’instabilità, intesa nella più ampia accezione del termine e quindi ricomprendendovi l’ingiustizia, la sopraffazione, la mancata accettazione di se stessi e la marcata diversità che fa sì che i personaggi si possano configurare come vittime di una società il cui equilibrio comporta anche lo squilibrio di non pochi suoi componenti. Per esempio, è questo il caso del primo racconto (Che cosa hai fatto) in cui una ragazza, vittima anni prima di una violenza del branco, quando un’altra fanciulla viene stuprata dagli stessi individui, si decide di denunciarli. Ma un errato senso del pudore del consesso sociale di cui lei fa parte finirà per usarle una violenza più sottile e più devastante, di fatto emarginandola, comportamento che assumerà anche sua madre. Guai quindi a violare le regole non scritte di una comunità, ad alterare un apparente equilibrio, perché in tal caso si finisce con l’essere messi fuori. Adesso non intendo parlare di altri racconti, altrimenti rischierei di togliere il piacere della scoperta ai lettori, ma preferisco soffermarmi sugli intenti civili dell’opera, presenti anche in passato, ma in modo meno evidente. L’autore ha la capacità di osservare da un punto di visualizzazione elevato e spogliandosi da quei preconcetti che inconsciamente ci portiamo dentro; in questo modo riesce a togliere il velo all’apparenza e a portare alla luce insanabili fratture fra la società e diversi suoi membri, un insieme di individui che hanno la caratteristica di essere involontariamente carnefici ( fa più male della violenza l’indifferenza, o peggio la supina accettazione) anche per non alterare quel fragile equilibrio su cui si basa ogni società. E così la vittima che si ribella diventa due volte vittima, marchiata indelebilmente per colpe che non sono sue e che sono invece i torti subiti. Trattandosi di diversi racconti, per quanto ovvio ci sono quelli che mi sono meno piaciuti e quelli che invece ho particolarmente gradito; tra questi ultimi, oltre al citato Che cosa hai fatto, inserisco anche I miei amati figli sconosciuti, di rara delicatezza. Lo stile è sempre accattivante e se voglio trovare un difetto, che in effetti non è tale, è la tristezza per lo più dominante, ma in fondo, se ci si guarda bene intorno, non ci sono abbastanza motivi per essere allegri. In conclusione, Milvia Comastri riconferma le positive impressioni che già avevo ritratto dalla lettura delle due precedenti raccolte e quindi questo libro è senz’altro consigliato.
Milvia Comastri è nata nel 1946 a Bologna, città in cui è
ritornata a vivere da qualche anno. Una devastante passione: la
lettura. E un grande amore per la scrittura. Con una predilezione per
i racconti dei quali ha già pubblicato due raccolte, nel 2005 e nel
2012: Donne, ricette, ritorni e abbandoni e
Colazione con i Modena City Ramblers.
7 Aprile
Michele Boschino di Giuseppe Dessì Prefazione di Carlo Alberto Madrignani Ilisso Editore Narrativa romanzo
La banalità è solo apparente Questo narratore, di cui ho già letto gli splendidi romanzi Paese d’ombre e Il disertore non finisce di stupirmi, tanto che continuo a chiedermi perché sia caduto nell’oblio, domanda di cui non accetto la più che logica risposta che questa è la fine di chi sa parlare, senza mere astrazioni, dell’uomo e della sua esistenza. Quest’opera è apparentemente assai semplice, anche se presenta come al solito più piani di lettura. Infatti ci sono quelli della terra dell’autore, quella Sardegna arcaica a cui Dessì è senz’altro indubbiamente legato, ma c’è anche quello della terra intesa in senso puramente materiale, cioè di quel mondo rurale immobile per tanti secoli e che poi nel volgere di pochi anni, dopo la seconda guerra mondiale, è sparito, fagocitato da una mentalità di profitto che ha trasformato il contadino in agricoltore e poi in industriale. In tal modo la specificità dell’ambiente isolano, chiuso in se stesso, arroccato su una difensiva da ogni novità, finisce con l’andare ben oltre il ristretto spazio a cui lo confina anche la mentalità della civiltà contadina per estendersi a tutti i rurali di questo mondo, almeno quali erano fino a non molto tempo fa. Ma se questa è la cornice di un quadro dipinto magistralmente, al centro dell’attenzione di Dessì c’è l’uomo, questa fragile creatura che, salvo rari casi, non riesce a emergere dall’anonimato della moltitudine, E in effetti la vita di Michele Boschino, questo contadino sardo il cui possesso di un paio di buoi e di un pezzo di terra costituisce la massima aspirazione, è di una banalità sorprendente, sembra una delle tante esistenze che non meritano memoria. E invece l’abilità sta nel fatto che tanti eventi che ci sono comuni assumano caratteristiche di particolarità, come nel caso della veglia del padre morente o del matrimonio, e ciò perchè il sapiente gioco di luci e ombre li fa assurgere a qualche cosa di straordinario e di irripetibile. Non solo questo però, perché dal punto di vista strutturale Dessì ha diviso il romanzo in due parti: nella prima si narra in terza persona degli anni forse migliori di Michele Boschino, a differenza della seconda, in cui lo troviamo solo, in miseria, esacerbato da quelle prepotenze dei parenti che avevamo inciso sulla vita di suo padre; tale condizione ci viene descritta in prima persona da Filippo, un giovane che nel percorrere il suo presente si trova sulla strada il nostro protagonista, in una ideale congiunzione fra il passato e tempi assai successivi, quasi a voler dimostrare che nella lotta per l’esistenza non vi è scorrere di lancette. Sono di rango sociale diverso, uno vecchio e l’altro giovane, ma nella vicenda sono indissolubilmente uniti da un destino, a loro indifferente, in un mondo campagnolo talmente immobile da sembrare senza tempo. Non ci troviamo di fronte a due eroi, ma a due comuni mortali, anche se Michele riluce più di Filippo perché conosciamo molto della sua vita, fatta di lavoro e di umiltà; niente di particolare si potrebbe dire, se non che la banalità del vivere è come un grido lacerante, se pur muto, della condizione di passività a cui ogni uomo è assoggettato. Non è facile trovare un autore che riesca a rendere così bene un’esistenza apparentemente anonima, a darle smalto, a ricordarci che se la vita di ognuno di noi può apparire del tutto simile, pur tuttavia é sempre irripetibile.
Giuseppe Dessì
(Cagliari 1909-Roma 1977) trascorse l’adolescenza nel paese d’origine
della famiglia, Villacidro, poi scelto come luogo poetico per le sue
opere. Molteplici, fin da giovanissimo, le letture, anche filosofiche
(Spinoza, Comte e Gentile), che si rifletterono più tardi sulla sua
concezione artistica di scrittore e sceneggiatore. Nel 1936 si laureò
in Lettere presso l’Università di Pisa. Dapprima insegnante, quindi
Provveditore agli Studi in diverse sedi della Penisola, esordì come
scrittore nel 1939 con la raccolta di racconti La
sposa in città e
con il romanzo San
Silvano. Agli anni ’40 risalgono invece la pubblicazione
di Michele
Boschino (1942)
e il forte impegno politico, partecipò, tra l’altro, alla fondazione
della sezione sassarese del Partito Socialista. Tra i romanzi più
importanti possiamo ricordare: I
passeri (1955), Il
disertore (1961)
e Paese
d’ombre, che gli valse il Premio Strega nel 1972. Morì a
Roma nel 1977.
4 Aprile
Los caprichos de la luna (I capricci della luna) di Maria Teresa Santalucia Scibona Traduzione di Emilio Coco Prologo di Marcello Falletti Di Villafalletto Grupo Editorial Sial Pigmalion
Poesia Nella Luna, in tutto, in noi È strano che, nonostante sappiamo tutto di lei, che anni fa alcuni astronauti americani vi abbiano posato i piedi sopra e abbiano potuto constatare quanto il suo suolo sia arido e quanto la sua atmosfera sia inospitale, la luna continui a rappresentare ancora per noi qualcosa di misterioso e di mistico. Non credo che ci sia stato un poeta, sia fra quelli famosi che fra quelli misconosciuti, che non abbia voluto dedicarle dei versi, e così non poteva mancare all’appello anche Maria Teresa Santalucia Scibona con questa raccolta, edita in Spagna e quindi bilingue, in cui il nostro satellite, senza entrare in tutte, è pur tuttavia oggetto di più di una poesia a partire da quella (I capricci della luna) che dà il titolo al volume. Non credo, però, che l’obiettivo dell’autrice senese fosse quello di ritagliarsi un angolo di celebrità, a cui in particolare si aspira scrivendo della luna, che ripeto non costituisce l’intera opera, ma solo una parte modesta.. Infatti, gli altri versi sono afferenti a momenti del giorno, a visioni paesaggistiche, a quelle sensazioni ed emozioni che un animo sensibile può ritrarre dall’osservazione del creato. E se l’intento metafisico forse non è così evidente, in un’artista religiosa come la Scibona il ricamare la perfetta bellezza di un mondo che non finisce di stupire è un implicito riconoscimento della presenza della divinità a cui, pur nella ieraticità delle poesie, tende ad avvicinarsi nel contesto di un’estasi mistica.. Certo il disegno che regola ogni cosa, che presiede a questa incomparabile perfezione, non può che essere frutto di qualcosa che esula dal normale raziocinio della mente umana per confluire in un’accettazione supina che si sviluppa nella fede di ogni giorno. Solo così è possibile che lo stupore davanti al nostro satellite, che la struggente malinconia che assale quando scende la sera, che l’idilliaca visione di un pescatore e di una sirena all’alba e che il sogno di un paradiso in terra come Shangrila trovino una spiegazione, che non risponde alla logica, ma ai battiti del cuore, nell’immensità di un dio che è presente in ogni cosa, che scandisce il tempo, che orienta i nostri destini e che è da sempre in noi. Ciò che non ci è possibile comprendere, ciò che è troppo complesso per noi poveri esseri che non siamo che un’infinitesima parte del tutto diventa improvvisamente chiaro, quasi come la folgorazione di Paolo sulla strada per Damasco, basta che ci spogliamo da quella saccenteria, che è propria di noi esseri umani, e ci guardiamo intorno, senza però dimenticare di vedere anche dentro di noi. É
bella questa raccolta, forse la migliore della Scibona e fra l’altro
sono poesie talmente armoniche e ben equilibrate, con felice scelta
di forma espressva, che leggere è un autentico piacere. M. Teresa Santalucia Scibona è nata e vive a Siena. Impegnata da anni in organizzazioni per la diffusione della poesia in Italia, nel 2005 la Biblioteca Universitaria senese della Facoltà di Lettere e Filosofia, ha istituito un Fondo Letterario a suo nome.
Nel 2000, dal Concistoro del Mangia, è
stata insignita di medaglia d'oro di civica riconoscenza, per alti
meriti culturali. Nel 2009 il Comitato Direttivo Idilio Dell'Era, le
ha assegnato il Premio alla Carriera "Idilio Dell'Era".
24 Marzo
A proposito di Mussolini di Denis Mack Smith Laterza Editori Saggistica storica
Mussolini spogliato del mito A distanza di più di mezzo secolo dalla sua morte e quindi sopite le passioni credo sia opportuno chiedersi chi sia stato veramente Benito Mussolini, al di là di quel che tutti sappiamo di lui (il capo del fascismo, il dittatore, l’uomo che portò l’Italia alla sventura della seconda guerra mondiale e che poi alimentò quella guerra civile che tanti lutti ha causato al paese). Era il capo di stato che con atteggiamento marziale passava in rivista le truppe? Era il padre di tutti, sorridente e affettuoso, quando si presentava agli italiani? O era forse il lavoratore che dava l’esempio nel corso della battaglia del grano? Era colui che prometteva gloria all’Italia e che invece la condusse alla rovina? Chi lo conobbe, almeno per essere stato comandato da lui nel ventennio, sembra in preda a un mito indistruttibile che anzi nel trascorrere del tempo si autoalimenta (ormai sono rimasti in pochi, ma fra i vecchi fascisti aleggia sempre la figura del Duce come fu a suo tempo costruita), e questo nonostante la realtà dei fatti, ma i vecchi si possono scusare, perché in fondo vivono del passato. Mentre quelli che non hanno alcuna giustificazione sono i giovani, quelli che parlano di un Mussolini come non è mai stato, tanto da pensare che lo vagheggino. A questi e a chi vuole sapere di più consiglio di leggere questo piccolo libro di Denis Mack Smith, in cui sono ben delineate le ossessioni, la retorica, i tradimenti e il narcisismo esasperato del duce. Ne esce una figura tragicomica, un individuo dalla dubbia sanità di mente, pur con quella capacità che gli deve essere riconosciuta di aver incantato, almeno fino alla seconda guerra mondiale, il popolo italiano. Vi sono raccontati episodi che se non avessero poi condotto allo sfacelo del paese sarebbero anche divertenti, con quest’uomo convinto di sapere tutto e che invece sa poco e niente, che non ascolta - ma nemmeno vuole – i consiglieri, che gioca d’azzardo con la pelle degli altri, che è abituato a raccontare menzogne a cui finisce con il credere anche lui. È un uomo che di anno in anno accentra sempre più potere e la cui mente va di pari passo oscurandosi. Il partito, che ha forgiato, finisce con l’identificarsi con lui che agli inizi forse aveva qualche capacità politica, che poi però, in assenza di concorrenti, è svanita, tanto che non trova di meglio per liberarsi di due personaggi pericolosi per il sui potere di mandarli in pratica in esilio (Grandi ambasciatore a Londra e Balbo governatore in Libia). Fra tante incapacità, in una vanità smisurata ci sarebbe almeno da attendersi un buon carattere e invece era crudele (non certo come Hitler e Stalin), ma comunque feroce con chi, a suo giudizio, poteva mettergli il bastone fra le ruote, come nel caso di Ida Dalser, sposata solo in chiesa, e del figlio avuto da lei Benito Albino, non solo osteggiati, ma perseguitati e rinchiusi in manicomio affinchè non parlassero. Il mito dunque é stato un bluff, perché nessuna di quelle caratteristiche positive che gli erano state costruite rispondeva a verità; anzi, Benito Mussolini era quasi una nullità e forse in questa nullità si ritrovava una parte di un popolo che amava sognare. Il giudizio è troppo severo? Beh, vediamo cosa dicono tre personaggi suoi contemporanei che non possiamo certo definire di parte avversa. La moglie, donna Rachele, l’ha ricordato così:”mio marito pareva un leone, e invece, tutto sommato, era un pover’uomo.”. Il genero, Galeazzo Ciano, dando un consiglio a Bastianini, destinato alla carica di sottosegretario agli Esteri, lo avverte che in passato “fu possibile parlare a Mussolini ma adesso non vuole più sentire nessuno e vuol aver ragione lui, ma per fortuna le sue opinioni mutano come il vento.”. Ma il giudizio più preciso ed esauriente è quello di un fascista notoriamente colto, Bottai: “Mussolini è l’unico uomo che Mussolini non abbia mai tradito; é stato indotto in una serie di errori dagli anni, dalle donne, dalla lue, dall’ulcera, dall’invidia e dall’odio.”. Vi
consiglio, anzi raccomando vivamente la lettura di questo piccolo
grande libro. Renzo Montagnoli
21 Marzo
Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali di Alessandro Barbero Laterza Editori Storia Ecco il Medioevo visto da chi lo ha vissuto Donne, madonne, mercanti e cavalieri è uno strano saggio storico, così diverso da quelli a cui ha abituato Alessandro Barbero, il cui talento e la cui competenza sono fuori discussione. Per comprendere meglio ciò che intendo dire mi avvalgo di un passo della sua introduzione all’opera in cui viene specificata la finalità della stessa; infatti Barbero scrive “Chi erano, come pensavano, come vedevano il mondo uomini e donne del Medioevo?”. Il compito che si è assunto lo storico torinese, cioè mostrarci come era la società dell’epoca, appare assai arduo, perché le fonti sono purtroppo limitate e i mezzi per la conoscenza sono quasi inesistenti; al riguardo, ricordo che la stampa all’epoca non c’era ancora e che quindi non esistevano i giornali, ma anche i libri erano pochi e con diffusione limitata, visto che dovevano essere scritti a mano, così come le loro copie, e che la carta come la conosciamo noi era ben diversa e costosa, insomma si ricorreva alla pergamena. Eppure, qualcuno ha lasciato ai posteri un’opera illuminante di cui si è avvalso Barbero per il suo lavoro e laddove questa non c’era , perché è appunto questo il caso di Giovanna d’Arco, analfabeta, ha attinto le indispensabili notizie dagli atti del processo a cui fu sottoposta. Aggiungo, inoltre, onde dimostrare ulteriormente le difficoltà incontrate, che gli scritti basilari non sono finalizzati a descrivere quanto si era proposto lo storico torinese, ma nei loro contenuti è necessario trovare ciò che interessa e proporlo all’attuale lettore, secondo un preciso filo logico che non venga mai meno allo scopo prefissato, magari arricchendolo di annotazioni, sovente velate di ironia, anche per rendere più agile e gradevole la lettura. I personaggi, che inconsciamente ci descrivono il mondo medievale, sono tre uomini e tre donne, una giusta par condicio, soprattutto in un periodo storico che vedeva il massimo assoggettamento della femmina al maschio. Alcuni di questi soggetti sono famosi, altri meno, ma in ogni caso le notizie che ci forniscono sono tali da poter farci comprendere come era il mondo in cui vissero, un mondo in cui la religione aveva un aspetto predominante, con un Dio con la barba, cioè cattivo e vendicativo, tale da incutere terrore ai fedeli più sprovveduti, che erano la maggior parte. Inoltre, del resto come oggi, anche se in misura totalmente anelastica all’epoca, la società era rigorosamente classista, con i servi della gleba e i signori, cioè i cavalieri; in mezzo, sempre più importante, c’era una borghesia di medici, professori, artigiani, commercianti e banchieri che aveva l’aspirazione, consapevole dell’importanza delle sue funzioni, di decidere il destino di città, di sostituire nell’amministrazione dei comuni i nobili che, ovviamente, facevano di tutto per conservarla. Ne esce il quadro di un medioevo non statico, ma che va progressivamente ad accentuare quel dinamismo che poi porterà all’età d’oro del rinascimento. È lecito chiedersi perché questi protagonisti hanno scritto le loro opere, in un periodo storico in cui ben pochi leggevano, ma credo che la spiegazione sia innata in ogni uomo: lasciare traccia di sé, cercare in tal modo di assicurare un surrogato di vita dopo la morte. A questi personaggi (frà Salimbene da Parma, Dino Compagni, Jean de Joinville, Caterina da Siena, Christine de Pizan e Giovanna d’Arco) va riconosciuto il merito di essere riusciti a parlarci di un mondo ormai passato; ad Alessandro Barbero va il nostro plauso per essere riuscito a realizzare lo scopo di questo saggio, realizzando un’opera di grande interesse e di piacevole lettura.
Alessandro Barbero,
nato a Torino nel 1959, è professore ordinario presso l’Università
del Piemonte Orientale a Vercelli. Studioso di storia medievale e di
storia militare, ha pubblicato fra l’altro libri su Carlo Magno,
sulle invasioni barbariche, sulla battaglia di Waterloo, fino al recente Lepanto.
La battaglia dei tre imperi (2010). È autore di diversi romanzi
storici, tra cui: Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo (Premio
Strega 1996) e Gli occhi di Venezia (2011).
19 Marzo
Ultimo viene il corvo di Italo Calvino Edizioni Mondadori
Narrativa racconti I primi racconti Questa raccolta di racconti, di diverse tematiche, è costituita dai primi lavori in prosa di Italo Calvino, ben lontani quindi dai successivi con cui l’autore si rivelerà uno dei più grandi narratori italiani del XX secolo. Nel leggerli si riscontra subito un certo approccio primitivo alla scrittura, una ricerca stilistica ben lungi dall’essere perfezionata e una varietà di temi che fa pensare al fatto che le epoche di stesura devono essere state necessariamente ben diverse. Grosso modo queste prose, per lo più brevi, si possono far rientrare in tre filoni: il primo è attinente l’ambiente e la natura della sua regione, la Liguria, pervaso da venature poetiche, alcune più riuscite, altre meno, con una certa impronta bonaria che tende a mettere in risalto delle figure emblematiche, quasi sempre picaresche; il secondo è una serie di ricordi d’infanzia e il terzo, che è il migliore, attinge a piene mani all’esperienza vissuta nel corso della Resistenza, esperienza che darà i suoi frutti più riusciti con il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. La lettura rimane sempre agevole, perché Calvino non è uomo che si arrovella in percorsi tortuosi del ragionamento e nel caso specifico poi l’approfondimento è quasi sempre limitato, preferendo l’autore che sia la vicenda in sé narrata a proporre al lettore quesiti e dovute riflessioni, finendo così per coinvolgerlo direttamente. Per quanto ovvio, in trenta racconti ce ne sono di buoni e di altri meno riuscito, tanto è vero che nelle edizioni successive (questa è la prima) Calvino provvederà a stralciarne, Personalmente credo che quelli sulla Resistenza siano i migliori e che il più bello in assoluto sia quello che dà il nome all’intera raccolta, cioè Ultimo viene il corvo, una sorta di duello fra un soldato tedesco isolato e un ragazzo partigiano dalla mira infallibile. C’è da dire anche che non è possibile riscontrare in queste prose quella visione metaforica surreale dell’umanità che sarà il tratto dominante del “grande” Calvino e che questi lavori, se pur gradevoli, appaiono assai minori rispetto alla sua produzione, ma ciò non deve costituire motivo per non leggerli, perché rappresentano la testimonianza del percorso letterario di un autore che troverà alla fine uno stile, una struttura e una tematica che ancor oggi stupisce e appassiona.
Italo Calvino (Cuba
1923 - Siena 1985) dopo gli studi e la Resistenza in Liguria si
laureò in Lettere a Torino. Dal 1947 al 1983 lavorò a vario titolo
per l'editore Einaudi. Visse a Sanremo, a Torino, a Parigi, e dal
1980 a Roma. Collaboratore di quotidiani e riviste, diresse insieme
con Vittorini «il menabò di letteratura». Tra le sue opere: Il
sentiero dei nidi di ragno (1947), Ultimo viene il corvo (1949), Il
visconte dimezzato (1952), Fiabe italiane (1956), Il
barone rampante (1957), I racconti (1958), Il cavaliere
inesistente (1959),Marcovaldo (1963), Le Cosmicomiche (1965), Ti
con zero (1967), Le città invisibili (1972), Se una
notte d'inverno un viaggiatore (1979), Palomar(1983), Lezioni
americane (1988).
10 Marzo
Cinque storie ferraresi. di Giorgio Bassani Feltrinelli Editore Narrativa Gli anni più tragici della dittatura Scritti negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale (tranne uno, il primo della serie, abbozzato nel 1937 ed edito nel 1940) questi cinque racconti ("Lidia Mantovani", "La passeggiata prima di cena", "Una lapide in via Mazzini", "Gli ultimi anni di Clelia Trotti" e "Una notte del 43") furono pubblicati, riuniti in un unico volume, dalla Einaudi nel 1956, ottenendo un immediato successo di critica e di pubblico, coronato nello stesso anno dal conferimento del prestigioso Premio Strega. Tutte le prose sono accomunate dall’ambientazione (la città di Ferrara) e dalla malinconica consapevolezza che gli italiani amano troppo presto dimenticare, aderendo, spesso inconsciamente, al noto motto chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Tuttavia, il filo conduttore è costituito dalla opprimente cappa della dittatura fascista in dissoluzione, che vive, negli ultimi anni del conflitto, un rigurgito di violenza, tragica e inutile, come se le teste calde volessero portare con sì nella tomba anche gli altri, cioè quelli non come loro. Da questo punto di vista l’opera presenta l’indiscutibile pregio di farci capire, attraverso delle storie semplici e realmente accadute, come poté capitare che un regime, apparentemente dissolto dopo il 25 luglio del 1943, finisse con il rialzare la testa, dando vita a quello stato fantoccio che fu la Repubblica di Salò. Bassani lo fa parlando della sua Ferrara, terra di grandi squadristi, tra i quali Italo Balbo, e in cui la guerra civile prese avvio con l’eccidio di undici innocenti avvenuta nel novembre del 1943, che l’autore sposta a dicembre. Ferrara è una città di provincia, a economia agricola, una sorta di grosso paese che l’autore ben conosce e descrive perfettamente, nelle sue strade e nei suoi personaggi, ma che riflette, per estensione, l’intera Italia, così che leggendo quelle pagine si comprendono tante cose, si capisce perché a guerra finita i processi ai criminali fascisti si siano quasi sempre conclusi in una farsa, così che dopo aver sollevato un gran polverone questo sia ritornato ad adagiarsi dove era prima, insomma un po’ il concetto del Gattopardo, alla cui pubblicazione l’intervento di Bassani fu determinante. L’impressione che ho ricavato è che forse ò’autore, con questi suoi racconti, ha inteso dire che la natura del fascismo è innata in noi italiani, menefreghisti, prepotenti, pronti a scendere a qualsiasi compromesso, a cambiar casacca, ma restando sempre noi stessi. L’esperienza degli ultimi settanta anni parrebbe purtroppo dar ragione al narratore ferrarese, confermando ancora una volta che la storia è fatta di cotsi e ricorsi e che, contrariamente a quel che si dice, non insegna nulla, o meglio che da essa non impariamo, o non vogliamo imparare nulla. Da leggere, perché lo merita. Giorgio Bassani nacque a Bologna il 4 marzo 1916 e morì a Roma il 13 aprile 2000. Di famiglia ebraica, patì le persecuzioni razziali e durante gli anni di guerra partecipò attivamente alla resistenza. E’ solo dopo il 1945 che si dedica all’attività letteraria in via continuativa, sia come scrittore che operatore letterario (suo è il merito di aver caldeggiato all’editore Feltrinelli la pubblicazione de Il gattopardo).
Poeta raffinato, Bassani ottenne il successo di pubblico con Il
giardino dei Finzi Contini, di cui fu curata anche una
trasposizione cinematografica da parte di De Sica.
3 Marzo
Il disertore di Giuseppe Dessì Punto di fuga Editore
Narrativa romanzo Silenzio, solo silenzio Dopo aver letto lo splendido Paese d’ombre ho deciso che era necessario conoscere meglio questo autore sardo che tanto mi ha stupito per le indubbie eccelse qualità letterarie, onde anche verificare che quella non fosse da considerarsi un’opera unica e fortunata. È così che ho reperito, non senza difficoltà, Il disertore (e mi sto ancora chiedendo come sia possibile che noi italiani ci dimentichiamo i lavori di artisti così grandi, spesso andando a preferire altri, magari accattivanti, ma senz’altro qualitativamente inferiori). È questo un romanzo più breve, ma più complesso, scritto nel solito italiano perfetto, senza tanti fronzoli, per nulla dispersivo, anzi intenso in ogni frase. Non sto a raccontare la vicenda, di indubbia originalità, con questa povera madre che ha perso gli unici due figli nel corso della prima guerra mondiale che, nella trama, è finita da poco tempo. In verità caduto in combattimento è solo il più vecchio, mentre il più giovane, dato per disperso, ha invece disertato e arrivato, fra mille traverse, nella sua isola va a morire nella capanna in montagna dove lavorava il latte degli ovini. Il conflitto, quell’enorme mattanza, ha lasciato i suoi segni e il sangue dei morti si è riversato inesorabile sui vivi; in tanti hanno perso un familiare, in troppi c’è una sofferenza che con il tempo s’indebolirà, ma in una madre che è stata privata delle sue due uniche creature, una povera donna in tutti i sensi, si è aperto un tempo senza futuro, una lenta silenziosa agonia in cui il dolore regna sovrano; ci sono poi quelli che hanno sperato in un mondo più giusto, che si sono illusi con le false promesse e che, sulla scorta del successo della rivoluzione bolscevica, reclamano quei diritti sempre a loro negati e inoltre c’è una classe reazionaria che intende mantenere a ogni costo i suoi privilegi, ricorrendo anche alla forza e appoggiando apertamente il nascente fascismo; e infine, in contrapposizione a coloro che soffrono in silenzio i loro caduti, ci sono quelli che vogliono ricordarli pubblicamente, dando vita a cerimonie e monumenti pasciuti di quella retorica che è sempre foriera di nuovi conflitti. In questo scenario, fra scontri di piazza, non solo verbali, tanto che ci scappa anche il morto, ci sono tre personaggi di grande umiltà che danno vita al racconto: la madre dei due figli caduti, Mariangela Eca, una donna che sembra un’ombra, Don Pietro Coi, viceparroco del paese, un sacerdote scomodo, perché non allineato con i potenti, e il dottor Urbano Castai, medico di un altro villaggio, amico dall’infanzia con il prete, persona capace nella sua professione, uomo libero e indipendente, e perciò visto come strano o addirittura come anarchico. Ognuno dei tre ha un ben preciso ruolo: la prima, la donna, è il ritratto dell’intenso dolore rappresentato dal suo silenzio, il secondo è l’uomo di fede tormentato da un dubbio irrisolvibile (infatti ha assistito il disertore morente, ne ha raccolto anche la confessione, con grande senso di pietà non solo come religioso, ma anche come essere umano e continua a chiedersi se ha fatto bene a non denunciarlo, un obbligo derivante dall’appartenenza allo stato); il terzo, il medico, nulla sa dell’uomo che ha disertato, ma lo intuisce e lo aiuta. Sono tre personaggi emblematici di tre esseri umani che sanno di avere una coscienza, che sono disposti a correre dei rischi per non andare contro questa coscienza, che non conosco alternative, mosse politiche o altro, perché hanno nell’animo quella fiammella che li distingue dalle bestie e inoltre, per loro natura, sono pacifici e di conseguenza, anche se non esplicitamente, aborrono la guerra, Quindi, come nel caso di Paese d’ombre, i piani di lettura sono più d’uno, anche se nel caso specifico la ricerca intimistica è prevalente. Sono cessati i fragori dei cannoni, gli strepitii delle armi, per chi se n’è andato, per chi è caduto sul campo di battaglia deve restare solo il silenzio a fronte di roboanti commemorazioni che pretendono di rendere collettivo un dolore che può essere solo individuale. Nell’assenza di suoni e rumori che chiude il libro si viene vinti dalla commozione, si resta un poco assorti nel pensare alle vittime di quella carneficina e anche noi apprezziamo cosa è il valore e il significato di quel silenzio. Imperdibile.
Giuseppe Dessì nacque a
Cagliari il 7 agosto 1909 e trascorse a Villacidro, cittadina alle
pendici del Monte Linas, una difficile, inquieta adolescenza. La
scoperta casuale di una biblioteca murata che custodiva, assieme a
tanti altri libri, il Catéchisme positiviste e il Cours de
philosophie di Comte, il Discorso sul metodo di Cartesio,
l’Ethica di Spinoza, la Monadologia e la Teodicea di
Leibniz, il Piccolo compendio del Capitale di Cafiero… fu
l’occasione per disordinate letture filosofiche e letterarie che lo
portarono sull’orlo della follia.
Lì Dessì frequentò, oltre a Varese
(che aveva già conosciuto in Sardegna, grazie a Cantimori), Carlo
Cordié, Mario Pinna, Carlo Ludovico Raggianti, Aldo Capitini…,
laureandosi nel 1936, dopo avere studiato a lungo Tommaseo, con una
tesi su Manzoni discussa con Luigi Russo.
In seguito a generosa donazione della
moglie Luisa Babini e del figlio Francesco Dessì-Fulgheri le carte
Dessì sono da anni depositate all’Archivio Contemporaneo “A. Bonsanti”
del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze, a disposizione degli
studiosi.
Fonte Fondazione Giuseppe Dessì
26 Febbraio
I Savoia, re d’Italia di Denis Mack Smith BUR Biblioteca Universale Rizzoli Saggistica storica
Fecero e disfecero l’Italia Come sua abitudine Denis Mack Smoth ha scritto un saggio storico sui Savoia re d’Italia con la ben nota imparzialità e logica stringente che gli sono proprie. Certo, questi personaggi coronati non sono sconosciuti, ma il conoscerli meglio, per quel che effettivamente furono, è il grande pregio di questo libro. La dinastia dei Savoia, forse quella più duratura in Europa, ne emerge in modo chiaro, limpido, senza reticenze, per quel che rappresentò per il nostro paese, nel bene, ma soprattutto nel male. Regnò sull’Italia dal 1861 al 1946, allorchè Umberto II abdicò sulla base del referendum a lui avverso fra monarchia e repubblica, tenutosi il il 2 giugno dello stesso anno. In tutto si è trattato di quattro re nell’arco di nemmeno un secolo, monarchi che mai diedero prova di voler regnare per il bene comune degli italiani, condizionati da una mentalità feudale che li faceva ritenere superiori a tutti e non censurabili. Di ognuno Smith ci fornisce un quadro esauriente, parlando di quanto hanno fatto, quasi sempre sbagliando, e di quanto non hanno fatto e che invece avrebbe dovuto essere realizzato. Il giudizio è impietoso e può anche stupire alla luce del fatto che l’autore è nato e vive in uno stato monarchico, ma dove il re ha più una funzione rappresentativa che politica, ed è il primo a riconoscere l’inviolabilità della democrazia, con tutti i suoi diritti e doveri, validi anche per lui e non limitati ai suoi concittadini. Già la dinastia dei Savoia avrebbe potuto perdere il trono nel corso della prima guerra mondiale, dopo il disastro di Caporetto, ma si preferì, soprattutto da parte degli alleati, mantenerla in vita onde evitare di aggiungere a uno sconquasso militare una profonda crisi istituzionale. E pensare che tutto era cominciato nel migliore dei modi, con Vittorio Emanuele II re d’Italia, ma già allora si poteva notare come il comportamento del monarca fosse inferiore alle aspettative e inadeguato ai problemi di uno stato appena nato. Rozzo, per certi aspetti volgare, ostile nei confronti dei politici prese l’abitudine, come i suoi successori, di tenere i piedi in due scarpe, con un indirizzo ufficiale di politica estera diramato agli ambasciatori in aperto contrasto con certe sue manovre sotterranee, di cui i nostri rappresentanti all’estero non erano a conoscenza, con frequenti casi di gaffes diplomatiche che solo per la scarsa considerazione che avevano di lui i reggenti degli altri stati non ebbero fatali conseguenze. Non era una nullità, ma in ogni caso era inadatto al ruolo che ricopriva. Ancora peggio fu il figlio Umberto I, succeduto al padre nel 1878; di indole conservatrice, diede avvio all’avventura coloniale italiana, segnata da tragici insuccessi e dai costi esorbitanti fatti pagare alla popolazione. Il suo è stato un regno di grande corruzione (basti pensare allo scandalo della Banca Romana); inoltre Umberto I appoggiò sempre apertamente un primo ministro come Crispi, che era un autentico farabutto. Fu fautore della Triplice Alleanza con Austria e Germania e sul piano interno una sanguisuga di prima categoria, e guai a chi osava protestare, anche civilmente, perché l’uomo era spietato (ricordate il massacro a Milano del 1898 operato dai cannoni del generale Bava Beccaris con oltre duecento morti fra i dimostranti che pacificamente chiedevano il calmiere del prezzo del grano con una riduzione dell’esosa e odiosa tassa sul macinato?). Fu proprio questa strage ad armare la mano dell’anarchico Gaetano Bresci che a Monza il 29 luglio del 1900 esplose contro il sovrano tre colpi di rivoltella che lo uccisero. La vedova Margherita, che era sua cugina e quindi anche lei una Savoia, ancor più conservatrice del marito, lo pianse coniando anche il famoso appellativo di “Re buono”, del tutto fuori luogo dati i precedenti. Gli successe Vittorio Emanuele III, senz’altro il peggiore, per quanto un po’ più intelligente degli altri. Di meriti che gli si possono attribuire non ne vedo e mi sembra giusto porre in evidenza invece i demeriti che riassumo brevemente. All’approssimarsi della prima guerra mondiale cominciò con il perfezionarsi nel tenere un piede in due scarpe, sostenendo la triplice alleanza mentre invece stava brigando per tradirla e passare alla triplice intesa; nel corso del conflitto poi protesse sempre il comandante in capo generale Cadorna, sebbene la sua incapacità divenisse ogni giorno più manifesta e fu a malincuore, perché costretto dagli alleati, a sostituirlo dopo Caporetto con il generale Diaz; Mussolini non sarebbe andato al potere se lui non l’avesse designato quale nuovo presidente del consiglio e la sua lunga amicizia con il dittatore gli fece chiudere più di un occhio, come sul delitto Matteotti e sulle leggi razziali; non batté ciglio nel caso della guerra d’Etiopia, ben sapendo che sarebbe stato un disastro per le casse dello stato e per quanto tentennante (un giorno sì, un giorno no) sottoscrisse l’atto di entrata del paese nel secondo tragico conflitto mondiale; restò fedele al duce nonostante le sconfitte, sebbene l’opposizione al fascismo crescesse nel paese in modo massiccio e a livello di qualsiasi classe, salvo poi farlo arrestare dopo la famosa seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943. Il suo capolavoro, però, doveva ancora arrivare e fu il modo in cui furono condotte le trattative con gli alleati per pervenire a un armistizio; infatti, mentre trattava con gli emissari americani e inglesi, lasciava aperta una porta ai tedeschi, ma quel che è peggio fu l’8 settembre del 1943, giorno in cui alla radio il Maresciallo Badoglio, dietro sue precise disposizioni, comunicava l’avvenuta cessazione delle ostilità con gli ex nemici, senza essere chiaro, e senza peraltro aver predisposto il necessario su che comportamento avrebbero dovuto tenere i militari italiani di fronte alla comprensibile reazione dei tedeschi (aggiungo che il re aveva rifiutato un consistente aiuto militare, costituito dal soccorso di una divisione di paracadutisti americana, nel timore di veder sminuito il suo prestigio); poi, i personaggi di questo zoo di incapaci, di inetti e di vigliacchi si diedero alla fuga, tipico di chi tradisce e qui i traditi furono ben tre: i tedeschi, gli alleati e il popolo italiano. Di Umberto II, succeduto al padre, che abdicò poco prima del referendum c’è ben poco da dire, anche lui poco capace, ma almeno, viste le tradizioni di famiglia, sincero. Questi sono stati i Savoia re d’Italia e proprio non se ne sente la mancanza; comunque è sempre meglio conoscerli di più e questo libro di Smith è un’indispensabile fonte a cui attingere a piene mani e con vero interesse.
Denis Mack Smith
(Londra, 3 marzo 1920) è lo storico inglese più noto nel nostro Paese
e ha scritto libri relativi alla storia italiana dal risorgimento in
poi.
22 Febbraio
I Pitard di Georges Simenon Traduzione di Eliana Vicari Edizioni Adelphi Narrativa romanzo
In lotta con i Pitard e il mare Se Louis Ferdinand Celine non avesse detto a proposito di Georges Simenon: «Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard, per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni», probabilmente non avrei letto questo romanzo, perché, solo per una sensazione, pensavo che mi sarei trovato di fronte a un’opera assai difforme dalla produzione del narratore belga. In effetti i Pitard è un giallo del tutto atipico, perché l’unico elemento che possa far pensare a una trama di questo genere è un biglietto anonimo che, quasi all’inizio del libro, il comandante Lannec si trova per le mani e che paventa il mancato ritorno al porto di partenza della nave da lui comandata, il Fulmine del Cielo. Questa è un mercantile, con svariati anni dal varo, ma in buono stato che Lannec ha acquistato con il suo secondo e, a fronte di una quota dilazionata del prezzo pattuito, con la garanzia del patrimonio della suocera, la signora Pitard, di cui lui ha sposato la figlia, che a tutti costi è voluta venire a bordo per accompagnarlo in quello che si può definire il primo viaggio della nuova proprietà. La minaccia non è dirompente, ma insinua dubbi, soprattutto in chi, andando per mare, sa di poter andare incontro a tanti rischi. Per quanto i Pitard appaiano sullo sfondo della vicenda sarà il loro comportamento ad accompagnare come un’oscura minaccia la rotta della nave. La presenza a bordo della moglie di Lannec, dal carattere spigoloso, appare già fin dall’inizio una fonte di potenziale conflitto in un ambiente di lupi di mare, che hanno nel sangue un profondo cameratismo. Sarà così un viaggio indimenticabile, un incubo che si palesa con gradualità, alimentato dalle tensioni emotive dei protagonisti e dalla forza bruta della natura. Fra mille difficoltà, incidenti, anche mortali, il Fulmine del Cielo riuscirà a ritornare al porto di partenza, ma per Lannec e il suo equipaggio la vita non potrà essere più quella di prima e resteranno segnati per sempre da un’esperienza che non è da augurare neppure al peggior nemico. La maestria di Simenon è fuori discussione, con quella sua comprovata capacità di sondare l’animo umano, in una fine analisi psicologica che riguarda, oltre il rapporto del comandante con la moglie, anche quello con i suoi uomini. Le atmosfere brumose, le tensioni che si vengono a instaurare sono rese in modo splendido, così come pressoché perfette mi sono sembrate l’ambientazione, con una vita di bordo a cui pare di partecipare, e la descrizione della forza immane della natura, con le onde che spazzano la nave e sembrano volerla ghermire, con gli uomini che, trepidanti, cercano di opporvisi. In certi momenti, nel ricreare il dramma della tempesta che si abbatte sul bastimento, mi sono figurato la scena e ho ritrovato certi spunti epici come nel romanzo di Melville Moby Dick o nel film Master and Commander, diretto da Peter Weir e interpretato magistralmente da Russel Crowe. Non si tratta solo di autosuggestione, ma l’abilità di Simenon è tale da avere l’impressione di rollare con la nave e di andare su e giù, si avverte la stretta allo stomaco degli uomini dell’equipaggio che, stremati, continuano a impegnarsi per salvare le loro vite. I Pitard, in cui si inserisce anche un elemento di sciocca superstizione, non sarà un thriller in senso stretto, ma è comunque uno di quei libri che non solo si leggono con grande piacere, ma che riescono ad avvincere dalla prima all’ultima pagina. Insomma, ci troviamo di fronte all’ennesimo capolavoro di Simenon.
Georges Simenon, nato a
Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
19 Febbraio
Carlo Magno. Un padre dell'Europa di Alessandro Barbero Editori Laterza
Storia Padrone (non padre) dell’Europa Carlo, detto Magno, nacque il 2 aprile 742 in una località imprecisata e morì ad Aquisgrana il 28 gennaio 814, vivendo quindi per circa 72 anni, un lasso di tempo che oggi ci pare alla portata di tutti, ma che all’epoca era privilegio di pochi. Figlio di Pipino il Breve divenne re dei Franchi nel 758, allorchè scomparve suo padre; ne continuò la politica, volta da un lato a continue conquiste e dall’altro a mantenere un rapporti privilegiato con i Papi. Sul piano militare estese sempre di più i confini del regno, conquistando addirittura quello longobardo e venendo così in soccorso al pontefice Leone III che ne temeva l’espansione, aiuto che fu talmente apprezzato tanto da incoronarlo imperatore a Roma in un soleggiato mattino del Natale dell’800. Certo, questa nuova corona non faceva che sancire gli straordinari risultati ottenuti in tanti anni dai Franchi, popolazione di origine germanica, ma assumeva un significato del tutto particolare, in quanto il territorio dominato era di tale ampiezza da far risorgere l’impero romano d’occidente, senza dimenticare il privilegio di tenere con lo scettro anche la qualifica di difensore della cristianità. Insomma, Carlo di strada ne aveva fatta e poteva ben dirsi soddisfatto, con un riconoscimento della sua potenza anche dal punto di vista della legittimità. Infatti, la corona postagli sul capo dal papa, rappresentante di Dio in terra, era il segno di una volontà non umana, ma divina, a che lui fosse considerato a tutti gli effetti il signore dell’Europa. E’ di questo personaggio che parla il bel saggio storico di Alessandro Barbero, di quest’uomo che aveva in verità una visione non solo di conquista, ma di riunificazione di tanti territori europei fino a ricostituire nuovamente il Sacro Romano Impero d’Occidente. Da lì a definirlo uno dei padri dell’Europa può anche sembrare un azzardo, ma in ciò lo storico piemontese è confortato dal fatto che nel 1957 Schuman, Adenauer e De Gasperi, nel gettare le basi della futura Unione Europea, scelsero come patrono di quella che sarebbe stata la nuova realtà proprio Carlo Magno. Senza voler contestare le teorie di Barbero, storico oculato e che di certo ne sa molto più di me, non sono del tutto d’accordo nel considerarlo uno dei padri dell’Europa; infatti la visione dell’imperatore dei Franchi non era tanto rivolta al futuro, bensì al passato, appunto a quel Sacro Romano Impero d’Occidente che di per sé sembra la negazione di una confederazione quale dovrebbe diventare il nostro continente; gli si possuo però attribuire i meriti di essere riuscito a pervenire a una fusione fra latini e germani, di aver avviato riforme, fra cui, importantissima, quella di un unico sistema monetario, una moneta argentea che può essere considerata un euro primitivo. Come al solito Barbero è capace di presentarci il personaggio in tutte le sue sfaccettature, durante la vita di ogni giorno, una giornata fitta di impegni e lunghissima, perché Carlo era sostanzialmente un accentratore, e delegava poco. I capitoli più belli sono quelli relativi alla guerra, al governo dell’impero, all’impulso dato all’economia, alla macchina militare franca. Fu certamente un grande sovrano, ma la sua figura è oggetto di tante leggende che lo hanno fatto diventare un mito, attribuendogli capacità e meriti di gran lunga superiori a quelli che effettivamente aveva. Il suo regno, comunque, costituì una sorta di piccolo rinascimento in un medioevo prima confuso e chiuso in se stesso. Fu però solo una parentesi e proprio per questo il merito è tutto suo. Da leggere, ovviamente.
Alessandro Barbero,
nato a Torino nel 1959, è professore ordinario presso l’Università
del Piemonte Orientale a Vercelli. Studioso di storia medievale e di
storia militare, ha pubblicato fra l’altro libri su Carlo Magno,
sulle invasioni barbariche, sulla battaglia di Waterloo, fino al recenteLepanto.
La battaglia dei tre imperi (2010). È autore di diversi romanzi
storici, tra cui: Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo (Premio
Strega 1996) e Gli occhi di Venezia (2011).
12 Febbraio
Severina di Ignazio Silone Presentazione di Geno Pampaloni
Arnoldo Mondadori Editore
Spes ultima Dea Non aggiungo altro, ma vi invito a leggere questo libro.
Ignazio Silone nasce
a Pescina (Aq) il 1° Maggio 1900 e muore a in Svizzera a Ginevra il
22 agosto del 1978.
7 Febbraio
Io, Partenope di Sebastiano Vassalli
Edizioni Rizzoli
“Ho raccontato l’Italia” così termina l’ultimo romanzo di Sebastiano Vassalli, scritto quando era già consapevole dell’inesorabile progredire del male che l’aveva colpito e che poi l’ha condotto al trapasso il 26 luglio 2015. Questa breve frase, che sintetizza l’intento di tutte le sue opere, ha il sapore di un commiato, un saluto definitivo ai lettori che tanto hanno avuto modo di apprezzarlo. A volte, al termine di un libro l’autore riporta delle note conclusive a maggior chiarimento del testo, ma in questo caso Vassalli ha posto come oggetto di quelle poche paginette un vocabolo che non lascia dubbi: congedo. Per quanto non spinga sulla vena della commozione, quel suo voler giustificare il perché di tutta la sua attività letteraria, con un sottofondo di tenue malinconia, non può non toccare chi legge, non può fargli dimenticare le tante piacevoli e costruttive ore trascorse con la lettura dei suoi libri e sapere che quello sarà l’ultimo, perché il fato ha voluto così, porta a un senso di mestizia e stempera in fondo la tensione emotiva che è cresciuta dentro nel leggere Io, Partenope, che non è forse la sua migliore opera, ma che chiude egregiamente un ciclo destinato appunto a spiegare a noi stessi, gli italiani, chi siamo. La vicenda di Io, Partenope, in cui la protagonista suor Giulia Di Marco, meglio conosciuta come suor Partenope, è esistita veramente, non è di quelle che possono attrarre come la trama della Chimera, ma Vassalli con opportuni accorgimenti narrativi ripropone un antico conflitto fra potere spirituale e potere temporale, con una Chiesa incline al totale dominio dei suoi fedeli, a cui non è lasciata la benché minima possibilità di un credo autonomo; tutto quello che è al di fuori del comandato diventa eretico, nel concetto dell’infallibilità del papa. Che suor Partenope sia una religiosa che crede in Dio con tutta la sua anima e il suo corpo è fuor di dubbio, che lei attraverso la preghiera raggiunga un punto di contatto con il Creatore è palese e che ritragga, raggiungendo l’estasi, un beneficio spirituale e fisico è inoppugnabile, ma è pratica che si discosta dalle rigide regole della Chiesa e soprattutto è esercitata da una donna, da sempre vista dagli ecclesiastici come un essere inferiore e impuro. Poco conta che raccolga intorno a sé un crescente numero di fedeli, anzi ciò viene visto come un pericolo per il potere di una istituzione religiosa che non solo da sempre predica bene e razzola male, ma che ha come politica principale l’assoggettamento dei suoi fedeli. In poche parole, la Chiesa dell’epoca - ma anche delle precedenti e delle successive - è composta da religiosi che, invece di cercare l’unione con Dio, vuole esclusivamente dominare. E le conseguenze per un’eretica come suor Partenope ( e sono tutti eretici quelli che cercano veramente di vivere da cristiani ) sarà tragica, anche se a lei sarà risparmiata la vita, a differenza della protagonista della Chimera. Le pagine che parlano di questa donna, dei suoi trascorsi miseri, della sua fede genuina e delle angherie a cui viene sottoposta sono per me le migliori del libro, mentre l’ultima parte, in cui si narra della sua amicizia con il noto architetto e scultore Gian Lorenzo Bernini mi è sembrata meno interessante, per quanto la descrizione di una Roma travolta dal “puttanesimo” sia quanto mai efficace e paragonabile, proprio per il vuoto morale che permea la città pontificia, al mondo attuale. Peraltro, come l’opera termina come detto con il Congedo, inizia con un Prologo, on cui rifulge il genio creativo di Vassalli, perché l’autore torna indietro nel tempo, nel ‘600 e segue un’anziana signora fin dentro una chiesa e lì la convince a raccontare la sua vita. La donna è suor Giulia Di Marco, terziaria francescana, che poi in una sorta di narrazione in prima persona, come in un’autobiografia, spiegherà il perché verrà meglio conosciuta come suor Partenope. Vassalli deve avere molto amato questo personaggio, come di certo amava la vita che avvertiva ogni giorno spegnersi e forse quell’invenzione di tornare indietro nel tempo, come se questo non esistesse, non è solo letteraria, ma nasconde l’inconscio desiderio di trovarsi poi in un altro mondo dal tempo immobile, una vaga speranza a cui aggrapparsi prima ancora di chiudere per sempre gli occhi. Leggetelo, perché lo merita.
Sebastiano Vassalli è
nato a Genova nel 1941 ed è morto a Casale Monferrato nel 2015.
Presso Einaudi, dopo le prime prove sperimentali, ha pubblicato La
notte della cometa, Sangue
e suolo, L'alcova
elettrica, L'oro
del mondo, La
chimera, Marco e
Mattio, Il
Cigno, 3012,
Cuore di pietra, Un
infinito numero, Archeologia
del presente, Dux,
Stella avvelenata, Amore
lontano, La morte
di Marx e
altri racconti,L'Italiano, Dio
il Diavolo e la Mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, Le
due chiese e Comprare
il sole.
2 Febbraio
Nerone
Rubbettino Editore Damnatio memoriae Lucio Domizio Enobarbo (Anzio, 15 dicembre 37 – Roma, 9 giugno 58), più noto come Nerone, è stato il quinto e ultimo imperatore romano della dinastia giulio-claudia, figlio adottivo dell’inetto imperatore Claudio. Conosciuto per l’incendio di Roma, di cui diede la colpa ai cristiani, che per questo furono ferocemente perseguitati, depravato oltre ogni limite, è sempre stato considerato come il simbolo del male assoluto. Ma fu veramente così? Non poco, anzi tanto, contribuirono a questo quadro altamente negativo sia la Chiesa cristiana, che poté così portare al suo mulino i non pochi – ma non furono comunque tanti – martirizzati e due storici romani, di epoca successiva, Svetonio e Tacito, entrambi membri dell’aristocrazia, che trovava la sua naturale collocazione in quel senato così tanto disprezzato da Nerone. Appare evidente, quindi, che le notizie su questo imperatore romano finiscono con il mancare di quel requisito di obiettività che dovrebbe essere proprio dello storico, tanto che in epoca moderna gli studiosi, esaminando i testi che ci sono pervenuti, pur senza poter arrivare a una certezza, hanno rivalutato il personaggio. Non è stato da meno Roberto Gervaso, con questo suo Nerone, opera che, a differenza delle sue altre che ho letto, non mi ha convinto del tutto. Certamente le poche fonti a disposizione, peraltro come si è visto prevenute, non contribuiscono a un chiarimento e di ciò deve essere dato atto all’autore che in buona sostanza, sulla base di congetture, magari anche non improbabili, perviene a un giudizio salomonico, nel senso che Nerone non fu né peggiore, né migliore degli altri imperatori, fatta forse eccezione per Augusto e per Adriano. Si trattava, come nel caso degli altri, di un tiranno, di un padrone assoluto, spesso oggetto di congiure che, scoperte, si risolvevano in bagni di sangue. Né gli si può imputare di aver provocato l’incendio di Roma, anche se la plebe, opportunamente manovrata dagli onnipresenti cospiratori, cercò di incolparlo e lui trovò un miglior capro espiatorio rappresentato da quei cristiani che, benché Roma fosse ampiamente tollerante in materia religiosa, preferivano, come una setta, professare il loro credo di nascosto. Se è indubbio che i primi anni del suo impero furono i migliori e i più proficui per Roma, grazie alla costante presenza di due abili consiglieri come il filosofo Seneca, che era stato il suo precettore, e Afranio Burro, prefetto del pretorio, successivamente, con il ricorrere delle congiure, una delle quali ordita dalla stessa madre, che lui poi fece uccidere, lo portarono a disinteressarsi del lavoro di statista e a occuparsi esclusivamente di due passioni che aveva fin da giovane, e cioè l’ars poetica e le gare con i cavalli. Quando poi conobbe un commerciante di equini, tale Tigellino, fu come un colpo di fulmine, poiché trovò in questo individuo la perfidia e la cattiveria che ancora non si erano manifestate nel suo primo periodo di regno; lo nominò capo dei pretoriani e da allora esplose a Roma la violenza, fiorì il terrore, di cui tuttavia non fu vittima il popolino, a cui Nerone continuò a dimostrare il proprio interesse con donazioni di cibo e con l’allestimento di spettacoli gladiatori. In effetti lo scontro avveniva fra il potere assoluto del tiranno e quello nominale del senato, e in verità prevalse sempre Nerone, fino a quando Tigellino, nella sua sete di odio, non cercò di considerare fra i partecipanti a una congiura gente che non c’entrava, ma che aveva un potere notevole, quello militare; inoltre, i Pretoriani, con la promessa di un ingente guadagno, si ribellarono e il senato lo depose. Nerone fuggì dal suo palazzo e si diede la morte in una dimora suburbana di proprietà di un liberto. Il Senato, sperando così forse di riacquistare i pieni poteri – ma non fu così - decretò per lui la damnatio memoriae e iniziò così quella cattiva fama che è pervenuta ai giorni nostri. Gervaso, comunque, con grande e anche forse troppa prudenza, preferisce darci un ritratto tutto sommato positivo nei primi anni di governo e assai negativo nei successivi, lasciando comunque intendere che non è da considerare il mostro che ci è stato dipinto, bensì un uomo dei suoi tempi, con innumerevoli vizi, ossessionato dalle congiure e violento quel tanto che serviva in uno stato che per stare in piedi aveva bisogno di reiterare la forza. In tutta franchezza quest’opera non ha particolarmente arricchito la mia conoscenza, ma comprendo i limiti di una pressoché impossibile ricerca, attesa la scarsa attendibilità delle poche fonti storiche. Tuttavia, la capacitò dell’autore di inquadrare il personaggio in un ben preciso periodo storico, in un contesto che giustifica per certi aspetti il comportamento del tiranno, sono elementi che se non portano a una certezza in ordine all’operato di Nerone, consentono però una lettura assai piacevole e ricca di spunti di sicuro interesse.
Roberto Gervaso è
nato a Roma il 9 luglio 1937.
29 Gennaio
Anime di vetro Falene per il commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni Edizioni Einaudi Narrativa romanzo Un polpettone indigesto Ritengo opportuna una premessa affinché sia possibile meglio comprendere le mie motivazioni in ordine al giudizio dell’opera: ho avuto modo di leggere i romanzi con protagonista il commissario Ricciardi allorché questi erano editi da Fandango; mi sono piaciuti molto, anche se più di una volta ho espresso all’autore i miei dubbi sulla prosecuzione di una serie caratterizzata sì da personaggi accattivanti, ma con una trama gialla esile e poco interessante. Ho pure consigliato a De Giovanni una diversificazione della sua produzione, scrivendo per esempio dei noir o dei thriller, un po’ come a suo tempo ha fatto Georges Simenon. Si vede però che l’autore napoletano non ha né il talento, né la creatività del romanziere belga, poiché ha preferito inaugurare un’altra serie ambientata ai tempi nostri in un commissariato di polizia napoletano, di cui ho letto il primo (I bastardi di Pizzofalcone) che ho gradito talmente da non essere interessato ai successivi. Tuttavia, la mia simpatia per il commissario Ricciardi, per il brigadiere Maione, per il dottor Modo ha fatto sì che decidessi di sborsare 19 euro per questo Anime di vetro, nella speranza di una lettura gratificante. Dico subito che mi sono sbagliato e che mi sono trovato per le mani un polpettone, indigesto per tanto motivi. La considerevole lunghezza nuoce all’opera, tanto più che una parte non trascurabile è dovuta a una reiterata descrizione dei protagonisti, che in una serie, oltre che superflua, è del tutto inutile. Se poi prendiamo l’abitudine dell’autore di inserire un prologo, degli intermezzi e un epilogo, magari con l’intento di meglio spiegare, in un desiderio di parlare delle passioni umane anche con un approccio filosofico, peraltro di modesta levatura, si può benissimo comprendere come il lettore, più che interessato, finisca con l’essere frastornato, tanto più che, come sempre, la trama gialla è esilissima, con una soluzione finale questa volta altamente improbabile, a cui si accompagna anche una novità costituita dall’interessamento dell’OVRA (la polizia segreta fascista) per Ricciardi. Se questo doveva essere nelle intenzioni dell’autore la ciliegina sulla torta, messo lì, senza nemmeno qualche accenno precedente, sembra del tutto fuori posto e inoltre De Giovanni commette l’errore di far apparire gli agenti segreti come degli incapaci, e invece purtroppo non era così, perché invece erano notoriamente molto validi. A onor del vero il romanziere napoletano si deve essere accorto che era opportuno inserire dei nuovi personaggi dopo la morte della tata Rosa, e così sì è inventato uno spasimante di Enrica, un maggiore tedesco di fede nazista che tuttavia appare uno stereotipo, che probabilmente si finirà con il ritrovare in un seguito. La melodrammaticità dell’autore, inoltre, qui si accentua in un effluvio di pianti, di gelosie e di tormenti, degni di un romanzo d’appendice ottocentesco, ma che finiscono con il togliere spessore ai protagonisti, rendendoli delle macchiette. Questa inclinazione di De Giovanni all’eccesso, se da un lato può servire a conquistare nuovi lettori che amano le opere strappalacrime, presenta però l’inconveniente di non accompagnarsi a un velo di sottile ironia che sdrammatizzerebbe le situazioni, alleggerendo così la prosa e accontentando forse anche quegli appassionati di lettura che non amano situazioni al limite e anche oltre. Insomma, da qualsiasi lato lo si voglia guardare, questo romanzo presenta marcati aspetti negativi che non sono compensati da quelli positivi, costituiti quasi esclusivamente dall’empatia fra il lettore e i personaggi costruita faticosamente nei libri precedenti; anzi, devo dire che Ricciardi, Maione e tutti gli altri hanno finito con il perdere quell’alone di simpatia che così tanto mi era gradito. Di conseguenza, il mio giudizio non può che essere totalmente negativo, non consigliandone la lettura, poiché per chi già conosce i personaggi sarebbe una cocente delusione e per chi invece per la prima volta si accosta a Ricciardi finirebbe con il non desiderare leggere i precedenti che invece sono ben altra cosa. Maurizio de Giovanni nasce nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Nel 2005 vince un concorso per giallisti esordienti con un racconto incentrato sulla figura del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Il personaggio gli ispira un ciclo di romanzi, pubblicati da Einaudi Stile Libero, che comprende Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera (Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore e Anime di vetro. Nel 2012 esce per Mondadori Il metodo del Coccodrillo (Premio Scerbanenco), dove fa la sua comparsa l'ispettore Lojacono, ora fra i protagonisti della serie dei Bastardi di Pizzofalcone, ambientata nella Napoli contemporanea e pubblicata da Einaudi Stile Libero (nel 2013 è uscito il secondo romanzo della serie, Buio, nel 2014 il terzo, Gelo, e nel 2015 il quarto,Cuccioli). Nel 2014, sempre per Einaudi Stile Libero, de Giovanni ha pubblicato anche l'antologia Giochi criminali (con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli). In questo libro appare per la prima volta il personaggio di Bianca Borgati, contessa Palmieri di Roccaspina, sviluppato in Anime di vetro.
Nel 2015 è uscito
per Rizzoli il romanzo Il
resto della settimana.
24 Gennaio
Paese d’ombre di Giuseppe Dessì Ilisso Editore Narrativa romanzo
L’irripetibile vita di Angelo Uras Se si vuole conoscere il perché degli insanabili squilibri dell’Italia odierna e si vuole comprendere l’incompiutezza di quel grande periodo storico rappresentato dal nostro Risorgimento si deve leggere questo romanzo, un’opera che per valenza letteraria e per i contenuti può essere definita un capolavoro della nostra letteratura. Dietro la vicenda di Angelo Uras, orfano di padre e di condizioni disagiate che eredita bambino un vasto patrimonio dall’eccentrico e anticonformista conte e avvocato Francesco Fulgheri, diventando da adulto un uomo di grande impegno civile, si cela ben altro, si sviluppa un discorso sul mancato obiettivo del nostro Risorgimento, vale a dire quell’unione di spirito e di sostanza di tutti gli italiani, sostituita dall’unificazione delle burocrazie dei precedenti singoli stati, colpa soprattutto del reale intento dei Savoia di ampliare, in danno di tutti, il loro regno. La Sardegna diventa l’esempio di un’emarginazione di esseri umani abulici e richiusi in se stessi, intolleranti a un’autorità che li spolpa e li persegue, uno sfruttamento che a suo tempo caratterizzò anche il meridione, ribellatosi attraverso un fenomeno troppo sbrigativamente definito con il termine di brigantaggio. Il romanzo ha più piani di lettura e accanto a quello storico e sociologico figura, maestoso, quello naturalistico, con un’evidenziazione marcata del paesaggio della Sardegna che si compone come una pellicola di fronte a chi legge, natura che si vuole mantenere incontaminata il più possibile, poiché il rapporto fra la stessa e gli abitanti è indissolubile. Ci sono descrizioni di panorami e di atmosfere incredibilmente belle, c’è la forza delle tradizioni che accomuna un popolo che trova nelle sue origini lo stimolo per sopravvivere all’asservimento. Qualcuno potrebbe pensare a certe opere di Grazia Deledda, ma è tutto molto diverso, perché in Dessì c’è un realismo che evita di cadere in qualsiasi stereotipo, senza ricorrere alla ricerca di dubbi usi tipici di una regione; in Paese d’ombre c’è tutta la Sardegna, quella di ieri e quella di oggi, perché l’autore sa cogliere il carattere della sua gente, sa interpretarne i sentimenti, sa portare avanti il discorso di un riscatto che appare sempre di più in’illusione di fronte a uno Stato lontano e insensibile. Tutto ciò viene raccontato in modo avvincente e semplice, in un italiano che oserei definire perfetto e che di certo Manzoni invidierebbe, insomma è proprio il caso di dire che questo romanzo s’ha da leggere soprattutto a scuola, e il fatto strano è che, benché nel 1972 si sia aggiudicato il Premo Strega, è poco conosciuto, ma senza voler essere maliziosi il motivo di questo oblio appare evidente poiché il potere centrale di uno Stato immobile e che sempre più va allontanandosi dai suoi cittadini non ha alcun interesse che quest’opera, che lo denuncia, sia portato a una conoscenza sempre più ampia. Il mio commento sarebbe però incompleto se non accennassi almeno a un altro piano di lettura che è quello dei sentimenti, ben evidenziati nel corso della vita di Angelo Uras, un uomo dalla grandiosa umiltà, un eroe tuttavia borghese, orientato sempre a venire incontro alle esigenze dei più miseri, combattuto fra la mentalità inconscia che gli deriva dalla sua condizione agiata e il desiderio di sanare ingiustizie sociali fin troppo evidenti e stridenti. In questo contesto, come per tutti gli esseri umani, non mancano, anzi sono ben presenti l’amore e l’affetto, la passione e la temperanza, in una vita che se gli ha dato tanto, altrettanto gli ha tolto. Ci sono parti indimenticabili, come quelle della morte della sua adorata madre, in un dolore consapevole della fine di una donna la cui esistenza viene naturalmente meno, anche se nelle sofferenze di un male incurabile; c’è tutto lo strazio per la morte di parto della prima moglie, il suo primo e unico amore, e infine c’è la rassegnazione che porta sempre la vecchiaia. La sua è stata una vita irripetibile, una continua cavalcata fra gioie e dolori, quasi un sogno il cui ricordo, per quanto attenuato, negli ultimi anni riaffiora per dargli uno scopo per tirare avanti, e il tutto è scritto con mano leggera, ma precisa, in una completezza di approfondimenti che raramente mi è capitato di trovare. Sì, questo romanzo s’ha da leggere perché alla fine sorgerà una misurata commozione che quasi subito si tramuterà in un accentuato senso di serenità.
Giuseppe Dessì nacque a
Cagliari il 7 agosto 1909 e trascorse a Villacidro, cittadina alle
pendici del Monte Linas, una difficile, inquieta adolescenza. La
scoperta casuale di una biblioteca murata che custodiva, assieme a
tanti altri libri, il Catéchisme positiviste e il Cours de
philosophie di Comte, il Discorso sul metodo di Cartesio,
l’Ethica di Spinoza, la Monadologia e la Teodicea di
Leibniz, il Piccolo compendio del Capitale di Cafiero… fu
l’occasione per disordinate letture filosofiche e letterarie che lo
portarono sull’orlo della follia.
Lì Dessì frequentò, oltre a Varese
(che aveva già conosciuto in Sardegna, grazie a Cantimori), Carlo
Cordié, Mario Pinna, Carlo Ludovico Raggianti, Aldo Capitini…,
laureandosi nel 1936, dopo avere studiato a lungo Tommaseo, con una
tesi su Manzoni discussa con Luigi Russo.
In seguito a generosa donazione della
moglie Luisa Babini e del figlio Francesco Dessì-Fulgheri le carte
Dessì sono da anni depositate all’Archivio Contemporaneo “A. Bonsanti”
del Gabinetto G. P. Vieusseux di Firenze, a disposizione degli
studiosi.
Fonte Fondazione Giuseppe Dessì
14 Gennaio
Minacce di morte e altri racconti di Georges Simenon Traduzione di Marina Di Leo Edizioni Adelphi Narrativa racconti Collana gli Adelphi – Le inchieste di Maigret
Maigret in pensione Continuo nella lettura dei racconti gialli di Simenon, soprattutto in questo periodo che viaggio spesso in treno, il che mi consente, durante il tragitto, di iniziarne e di ultimarne anche più d’uno. Nel caso di Minacce di morte e altri racconti si tratta di cinque prose di diversa lunghezza (in totale l’opera consta di 166 pagine), con alcune più riuscite e altre meno, come nel caso di quella che dà il titolo all’opera, con un tentato omicidio in un ambito familiare caratterizzato da una grettezza quasi inverosimile. Nella circostanza Simenon ha calcato un po’ troppo la mano, con dei personaggi un po’ all’eccesso e quindi sicuramente meno credibili. Di miglior qualità mi sono parsi Vendita all’asta, ambientato in un’osteria di campagna in cui viene assassinato uno dei partecipanti all’asta di una limitrofa tenuta agricola e Il prigioniero della strada, un pedinamento parigino, in cui nasce fra il sospettato e il commissario una sorta di scommessa a chi cederà per primo. I migliori, a mio avviso, sono L’enigmatico signor Owen e Quelli del Grand Café, che presentano la novità di un Maigret in pensione. Nel primo l’ex commissario si trova a soggiornare in un Grand Hotel della Costa Azzurra in cui viene commesso un delitto, nel secondo, che è un autentico gioiello, lo troviamo, con la consorte, in un paesino di campagna dove si è ritirato a vivere, una volta cessato il servizio. In questo Simenon ricrea in modo perfetto quella che è la vita di un pensionato il cui problema è di trovare come passare il tempo e allora c’è la pratica della pesca, il lavoro nell’orto e la puntuale partita a carte di ogni giorno in un bar, sempre con gli stessi giocatori, di cui uno viene ammazzato. Il piacere della lettura non risiede tanto nella ricerca dell’assassino, quanto nell’atteggiamento dell’ex commissario nel dilemma fra disinteressarsi del delitto o dare il suo prezioso contributo alle indagini. È un Maigret combattuto fra il risolversi a iniziare una nuova vita, o a continuare a essere pesantemente influenzato dalla precedente, e in questo dubbio amletico emerge ancora una volta la straordinaria abilità di Simenon, che ci fornisce l’immagine di un uomo che non si rassegna ad abdicare, ma che comprende anche che un certo tempo è finito e che di questo dovrà serbare solo il ricordo. Ed è proprio questo racconto che secondo me si contrappone in modo chiaro a quello più modesto che dà il titolo all’opera e che ci permette di scoprire un altro Simenon, capace di ricreare con acume e abilità un comportamento del tutto umano in una persona che, dopo aver lavorato con passione e dedizione per tanti anni, si vede ora costretta a reinventarsi la vita: è un lampo di genio di un autore che, essendo un’artista, non andò mai in pensione, né poté trovarsi in una simile situazione.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per
esempio,
bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
9 Gennaio
Garibaldi di Denis Mack Smith
Edizioni Mondadori
Aveva un cuore immenso Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807 – Caprera, 2 giugno 1882) è un personaggio storico talmente famoso che sembrerebbe superfluo leggere una sua biografia. A scuola se ne parla diffusamente e viene sempre presentato come il più grande patriota italiano, come colui che risultò determinante, nell’ambito del nostro Risorgimento, per giungere all’unità nazionale. Ci viene sempre descritto come l’eroe dei due mondi, per le imprese compiute nell’America meridionale, si esaltano le sue qualità di condottiero, lo si presenta come un uomo in camicia rossa che monta un cavallo bianco e che incita gli italiani alla riscossa. Si accenna appena alla sua onestà e frugalità, quando si dice che dopo l’impresa dei mille, con la consegna al re Vittorio Emanuele II del Regno delle Due Sicilie non volle onori e prebende, ma che si ritirò nel suo eremo di Caprera accontentandosi solo di un po’ di sementi da piantare in quella terra arida e sassosa. È inutile che aggiunga altro, poiché sto parlando di un mito, di un individuo le cui gesta ancor oggi destano meraviglia e fanno pensare a un che di unico e di irripetibile. Ci si chiede, pertanto e comunque, se non si tratti di una leggenda, di un’esaltazione collettiva e chi era veramente Giuseppe Garibaldi. Denis Mack Smith ci fornisce la risposta con questo libro, scritto con l’esperienza e la capacità che gli sono note, ma anche con il cuore, perché l’autore inglese, al pari dei suoi connazionali, ha per il nostro Giuseppe un’autentica venerazione, il che non gli impedisce di scremare il mito per arrivare a un ritratto veritiero, da cui risulta un uomo semplice e umile, dotato di una grande forza di volontà e di un cuore immenso. In questo modo Garibaldi risulta addirittura superiore al suo mito e pagina dopo pagina viene suscitata nel lettore un’autentica commozione. Ed è proprio nello sfatare certe esagerazioni che nel tempo sono maturate sul personaggio, nello scoprire la sua vera e autentica natura che questo rifulge come il sole in un limpido cielo primaverile. Come condottiero fu un eccellente tattico, con diverse vittorie, ma anche alcune sconfitte, e un pessimo stratega, ma ciò non toglie che le uniche vittorie italiane nella seconda e nella terza guerra di indipendenza sono esclusivamente merito suo. Il riunire gli italiani in un unico stato fu da lui considerata una missione, nell’ambito di una visione generale che tendeva ad aiutare gli oppressi nel ribellarsi al giogo straniero, sia che questo fosse quello austriaco, sia che fosse quello argentino. E per quanto sia possibile credere che fosse un guerrafondaio, più di altri sognava un mondo di pace, in cui non esistessero più servi e padroni, senza con ciò desiderare l’eliminazione di chi godeva di tante ricchezze, ma elevando il livello economico delle masse, che alla sua epoca spesso e volentieri facevano la fame. Arrivò, per primo, a ipotizzare un consesso di stati il cui scopo fosse quello di dirimere le controversi che insorgessero fra gli aderenti, anticipando coso l’istituto dell’ONU, e intuì che all’Europa, per ritrovare un suo ruolo ben specifico e ovviare al calo della sua influenza a beneficio degli Stati Uniti d’America, era necessaria un’ unione dei suoi stati. La sua spontaneità si accompagnava a un’innata ingenuità, di cui più volte fece le spese, soprattutto nelle macchinazioni che gli ordirono i politici (in primis Cavour) e lo stesso Vittorio Emanuele II, che avrebbe dovuto trattare molto meglio chi gli aveva così tanto ampliato il regno, ma c’era poco da aspettarsi da un re meschino, falso e vile. In un’Italia sabauda, dove esplose la disgrazia della corruzione, ne fu totalmente immune, anzi cercò ripetutamente di sensibilizzare il parlamento perché desse l’aiuto indispensabile alla quasi totalità degli italiani, che vivevano in condizioni miserabili ed erano costretti ad emigrare per sopravvivere. L’Italia che aveva così tanto contribuito a creare non rispondeva certo alla sua visione di un popolo felice e sempre ebbe nel cuore le sorti di chi, ed erano tanti, la stragrande maggioranza, viveva nella più completa indigenza, sfruttata per un pezzo di pane che non era mai sufficiente a saziare; sempre a loro andò il suo pensiero nella vecchiaia, afflitto da una dolorosa artrosi che ben presto gli impedì di camminare- Fu certamente lo sceneggiatore, attore e regista del nostro Risorgimento, un insieme di ruoli che seppe interpretare con assoluta dedizione. Si spense come aveva vissuto, povero ma da uomo dignitoso e consapevole che aveva dato tutto se stesso, senza pretendere e senza avere avuto nulla in cambio. Chiese di essere cremato su una pira, ma il re e i politici gli fecero un ultimo tiro, con solenni funerali di stato, un affronto anche da morto a colui che era sempre vissuto in grandiosa umiltà. Da leggere e rileggere, perché scoprire l’autentica grandezza di un mito non vuol dire demolirlo, ma rendersi conto come la realtà possa essere ben superiore al mito stesso.
Denis Mack Smith
(Londra, 3 marzo 1920) è lo storico
inglese più noto nel nostro Paese e ha scritto libri relativi alla
storia italiana dal risorgimento in poi.
8 Gennaio
Anima di corallo
Recensione 4 Gennaio
Il ponte sulla Drina di Ivo Andric Traduzione di Bruno Meriggi
Arnoldo Mondadori Editore S,p,A,
Il rispetto per gli altri Almeno io ne sapevo ben poco della storia dei Balcani e in particolare della Bosnia, teatro di un recente conflitto derivante dalle varie secessioni della Repubblica di Jugoslavia, ora non più esistente. Eppure si tratta di fatti di nazioni che ci sono abbastanza vicine, ma che ci sono soprattutto note per massacri di cui spesso ci sfuggono i motivi. Il problema è che quelle zone ci sono sempre sembrate delle semplici entità geografiche, dapprima assoggettate all’impero ottomano e poi a quello austro.ungarico, territori che nel nostro immaginario sembravano costituire un’unica entità e che invece erano e sono popolati da nazionalità ben diverse e ben distinte. Nel leggere questo romanzo storico, scritto da Andric fra il 1942 e il 1943, pubblicato nel 1945 appena finita la seconda guerra mondiale, ne possiamo sapere motto di più e peraltro in modo piacevole, benché il ritmo sia lento, come i secoli in cui si svolge la trama, ma è lo scotto da pagare per poter finalmente capire. Tutto si svolge nella cittadina di Visegrad, sita nella parte orientale della Bosnia, in un arco di tempo che va dal XVI secolo fino alla Prima guerra mondiale. Il protagonista non è una persona, ma un ponte eretto sul fiume Drina per volontà di Mehmed Sojolovic Pascià, un Visir dell’impero ottomano originario del luogo. Questa costruzione, imponente e anche ardita, vede impassibile, come la pietra di cui è fatta, avvenimenti, fatti e conflitti che accaddero in questo lungo periodo in quella terra. Si sviluppano così una serie di racconti, anche di aneddoti, ambientati intorno al ponte o anche sullo stesso dando vita a un romanzo storico epico e di grande respiro, corale, ma anche individuale, con cui Andric ci rende edotti della storia di Visegrad e dell’intera Bosnia, un cuscinetto interposto fra le culture orientali e quelle occidentali, fra la religione mussulmana e quella cristiana, luogo di passaggio di mercanti che si spostano da un mondo all’altro, così che le genti balcaniche si mescolano, inevitabilmente contaminate da altre civiltà, in uno scambio continuo, che se da un lato rappresenta una fonte insperata di crescita, dall’altro è motivo di conflitti, spesso sanguinosi. Ivo Andric descrive e racconta con un senso di umana pietà, approfondendo le tematiche e senza mai giudicare, ma non solo, perché ha la capacità di farci rivivere situazioni e ambienti, finendo con il porgerci la mano per poter entrare anche noi nel cuore di quella che é l’ex Jugoslavia. Pagina dopo pagina si finisce con l’essere avvinti e giunti all’ultima mi sono accorto che Andric è riuscito a sfatare i miei preconcetti, in un messaggio, di grande efficacia, di pace e di rispetto, non solo fra quelle etnie, ma per tutte le etnie, poiché la storia che ognuno di noi si porta dietro, quella che chiamiamo le nostre radici merita lo stesso rispetto di quella degli altri. E quindi Il ponte sulla Drina va oltre il semplice romanzo storico, ma è una di quelle opere che restano patrimonio dell’umanità.
Ivo Andric fu
uno dei maggiori rappresentanti delle letterature slave
novecentesche. Nato nel 1892 nelle vicinanze di Travnik (Bosnia), è
appunto alle lontane e complesse vicende storiche del suo paese che
Andric dedicò la propria attenzione di scrittore dalla forte impronta
realistica. Durante gli anni che precedettero il primo conflitto
mondiale e la costituzione dello Stato iugoslavo aderì al movimento
irredentista serbo e per questo venne condannato anche al carcere e
al confino. In seguito si dedicò alla carriera diplomatica,
soggiornando in diverse città europee, e approfondendo nel frattempo
la vocazione letteraria. Risale agli anni Trenta la pubblicazione di
alcuni volumi di novelle e al 1945 quella dei due romanzi maggiori, La
cronaca di Travnik eIl
ponte sulla Drina. Dopo la Seconda guerra mondiale Andric
continuò la sua attività di scrittore e nel 1961 venne insignito del
premio Nobel. Morì a Belgrado nel 1975.
2 Gennaio
Il divano di Istanbul di Alessandro Barbero
Sellerio Editore Palermo Storia
La Sublime porta L’impero ottomano, chiamato anche Sublime porta, è durato più di sei secoli, all’incirca dal 1300 fino al 1922 e prima che iniziasse la sua decadenza, avviata nel 1699, quando i turchi, pressati dagli austriaci, dovettero abbandonare l’Ungheria e la Transilvania, fu una potenza antagonista del mondo occidentale, costituendo una reale minaccia per i vari stati europei. Per quanto mi sovviene la memoria, però, a scuola si insegna poco e in modo lacunoso anche una sua breve storia, confinandola più alla minaccia costante dei pirati saraceni e alla famosa battaglia navale di Lepanto, uno dei rari episodi da cui gli ottomani uscirono sconfitti. Nello studente si crea così l’immagine di una potenza feroce, di uno stato impostato e retto ben diversamente da quelli che erano i suoi antagonisti e in pratica si ritrae l’impressione di qualche cosa di lontano dai nostri interessi al punto da non richiedere una maggior conoscenza. È quasi inutile che dica che questo è un errore, perché molto della storia medievale e soprattutto rinascimentale europea potrebbe essere capito meglio solo che si dedicasse un po’ più di attenzione alla Sublime porta. Ho ritratto questa opinione dalla lettura di questo interessante libro (Il divano di Istanbul), scritto da Alessandro Barbero, uno storico di cui vado sempre più apprezzando il rigore logico e l’indubbia obiettività. Il titolo in verità può apparire fuorviante, richiamando quel pezzo d’arredamento quasi sempre presente nelle nostre case e grazie al quale possiamo riposare senza dover necessariamente dormire, a meno che non ci troviamo di fronte a un televisore acceso. No, quel divano non c’entra, perché in turco è con il termine divan che si indica il governo. Fatta questa premessa, preciso che il lavoro di Barbero, a cui non manca di certo la capacità di rendere attraente e comprensibile un’opera anche a un profano, nella circostanza, come impostazione, appare più cattedratico, pur non assumendo caratteristiche di grevità, e d’altra parte non potrebbe essere altrimenti perché per parlare di un impero così diverso è stato quanto mai necessario dedicare ogni capitolo a una sua caratteristica. Si apprende così che, benché il Gran Sultano, cioè l’imperatore fosse mussulmano, vigeva la più ampia liberta religiosa, che i famosi giannizzeri, la miglior fanteria, era reclutata, come del resto gli addetti di corte e il Gran Visir e l Visir, cioè il primo ministro e gli altri ministri, fra i giovani cristiani dell’impero, che i sudditi, a differenza che in occidente, non erano servi della gleba, legati mani e piedi ai feudi, ma completamente liberi. Sembrerebbe, quindi, uno stato con tanti pregi, ma non mancavano i difetti, fra cui un’endemica corruzione, una continua sete di conquista e anche una chiusura alle novità (influsso questo della religione mussulmana) che faceva scontare un’arretratezza non solo artistica, ma anche economica. Di conseguenza, come tutti gli stati, era caratterizzato da luci e da ombre, ma ciò non toglieva il desiderio dei nostri servi della gleba di esservi sottomessi, pur paventando le incursione dei pirati saraceni, spesso protetti dagli ottomani, e che quanto a ferocia sembra non avessero uguali: arrivavano sulle coste, sbarcavano, assalivano i villaggi, uccidevano gli uomini, oppure li rendevano schiavi, violavano le donne, per poi portarle via per venderle pure loro come schiave. L’esercito ottomano, normalmente, si comportava meglio, ma ciò non toglieva, come anche nel caso degli armati europei, che la conquista di una città sovente finisse in saccheggi e violenze. Il merito di Barbero è di aver sollevato il velo su questo grande stato, facendoci conoscere cos’era e com’era, temuto, ma anche rispettato, un coacervo plurireligioso e multilinguistico, che molto contava sull’agricoltura, all’epoca una delle più floride, a volte dominato da Sultani debosciati, altre da uomini di grande talento, come nel caso di Solimano il magnifici, detto anche Il legislatore. Ne esce così un quadro che pur in un numero di pagine non ampio, ci offre una serie di notizie che ci portano a conoscere un mondo di cui sapevamo l’esistenza, ma che ci sembrava confinato al di là di una linea che marcava il passaggio dalla realtà alla fantasia. Da leggere, ci mancherebbe altro.
Alessandro Barbero,
nato a Torino nel 1959, è professore ordinario presso l’Università
del Piemonte Orientale a Vercelli. Studioso di storia medievale e di
storia militare, ha pubblicato fra l’altro libri su Carlo Magno,
sulle invasioni barbariche, sulla battaglia di Waterloo, fino al
recente Lepanto. La battaglia dei tre imperi (2010).
È autore di diversi romanzi storici, tra cui: Bella
vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo (Premio
Strega 1996) e Gli
occhi di Venezia (2011).
|
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Poetare.it © 2002