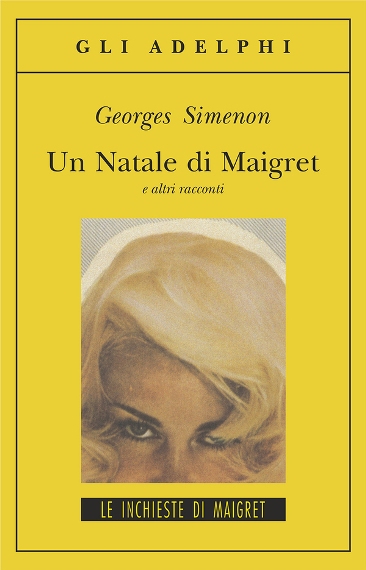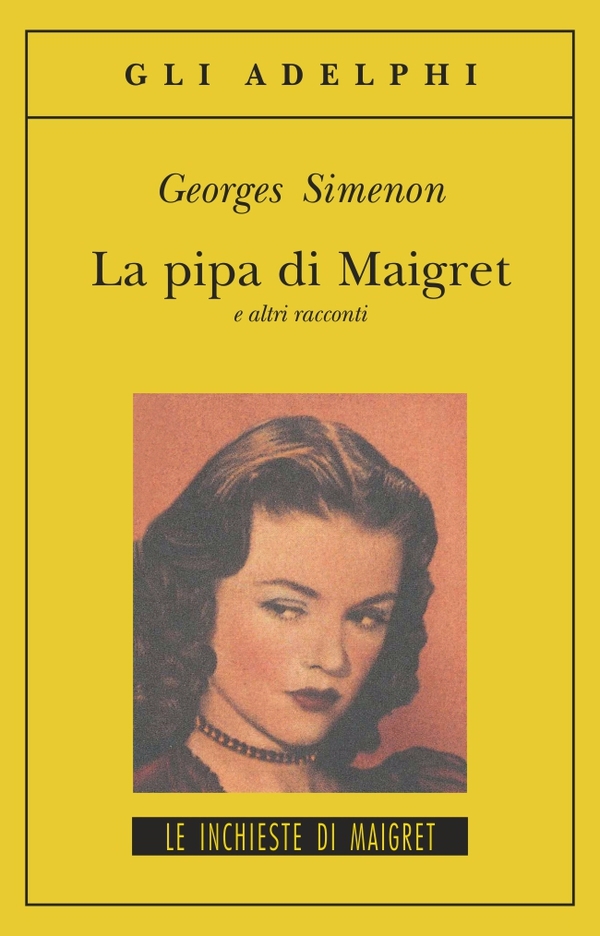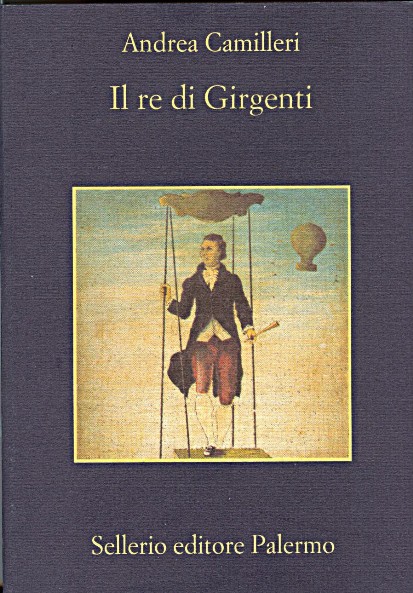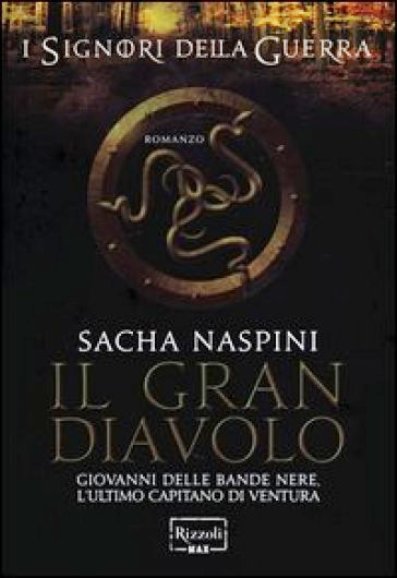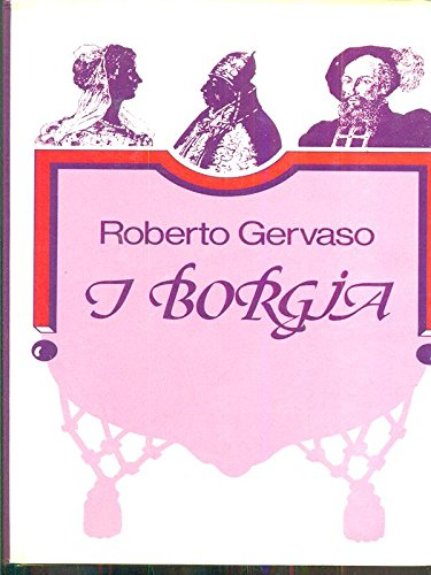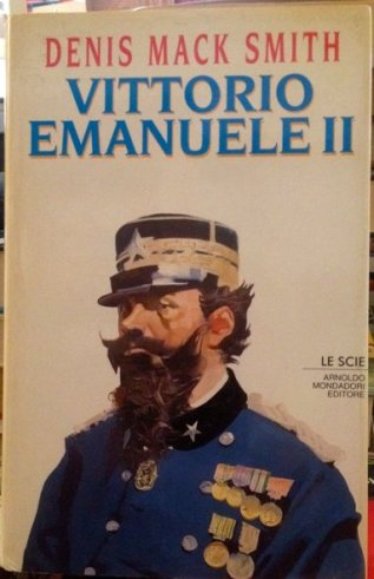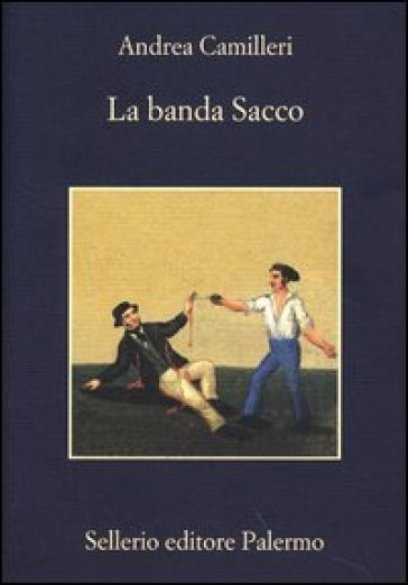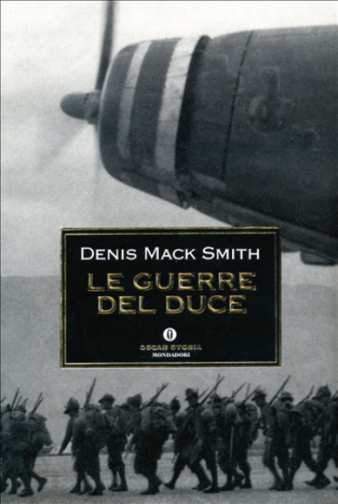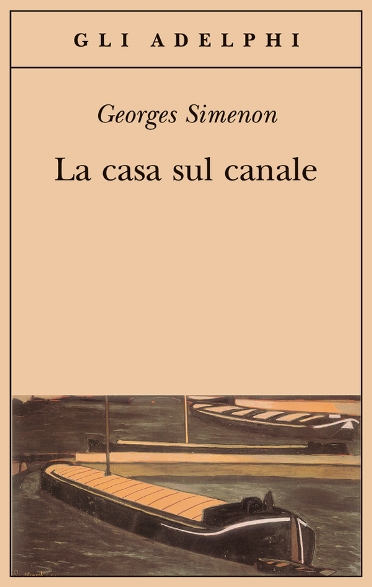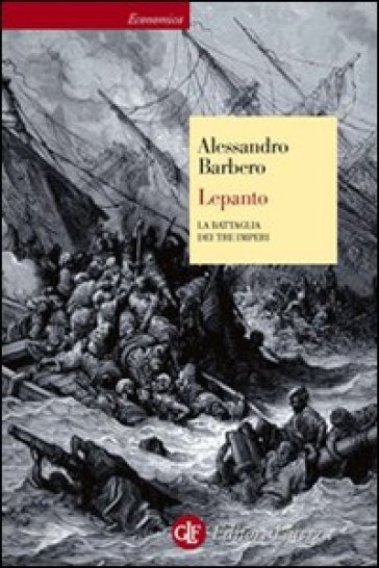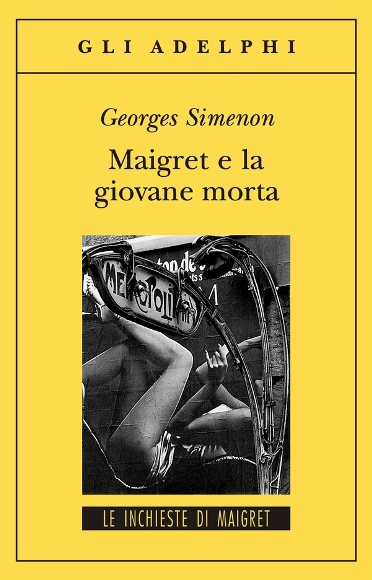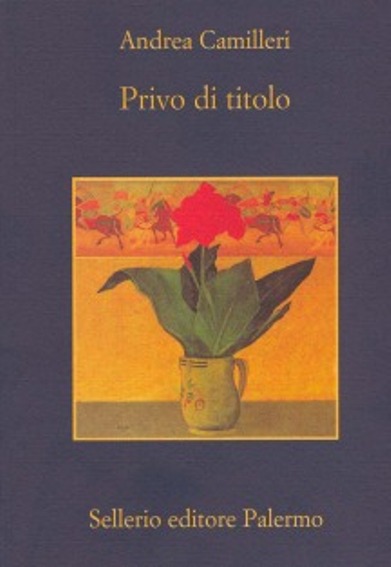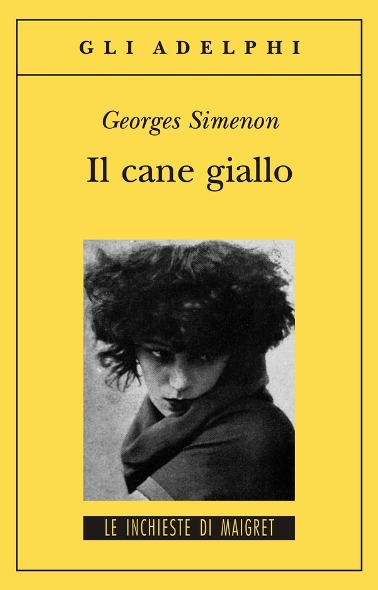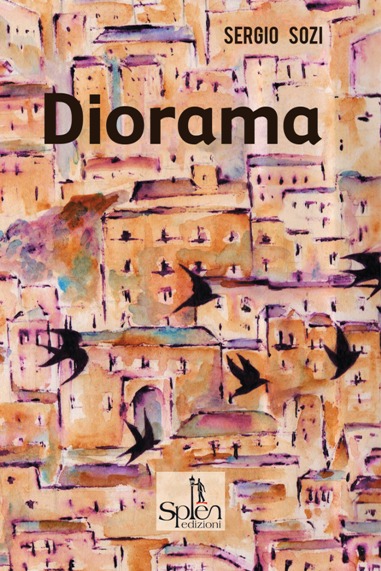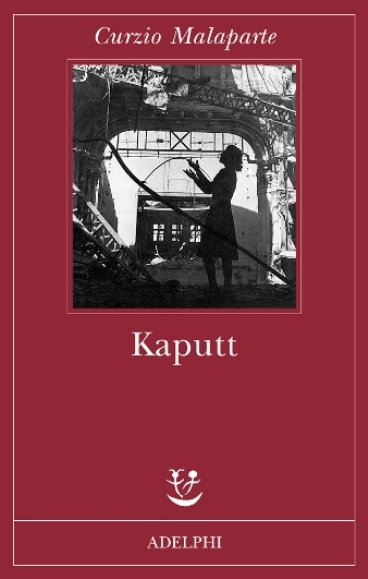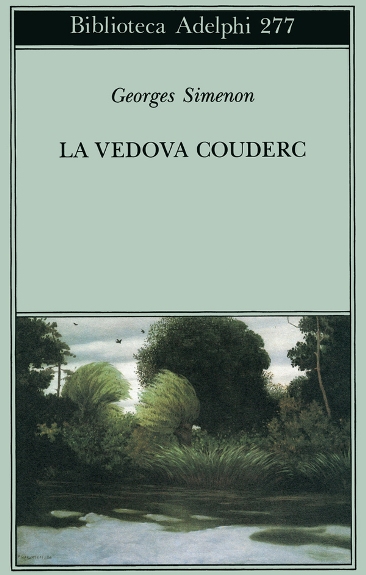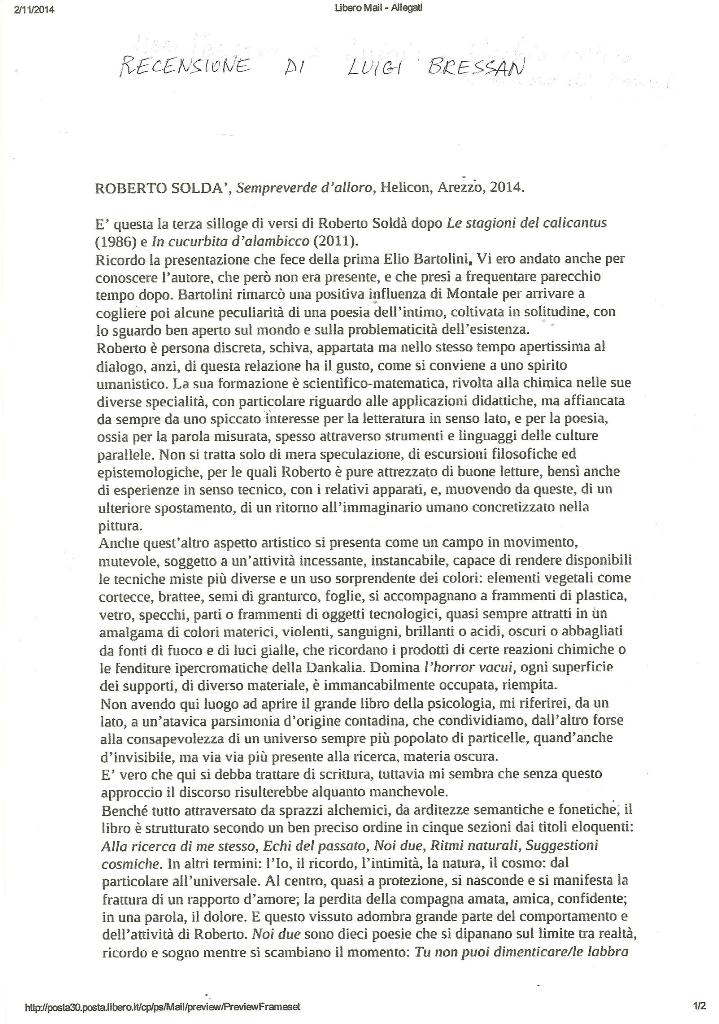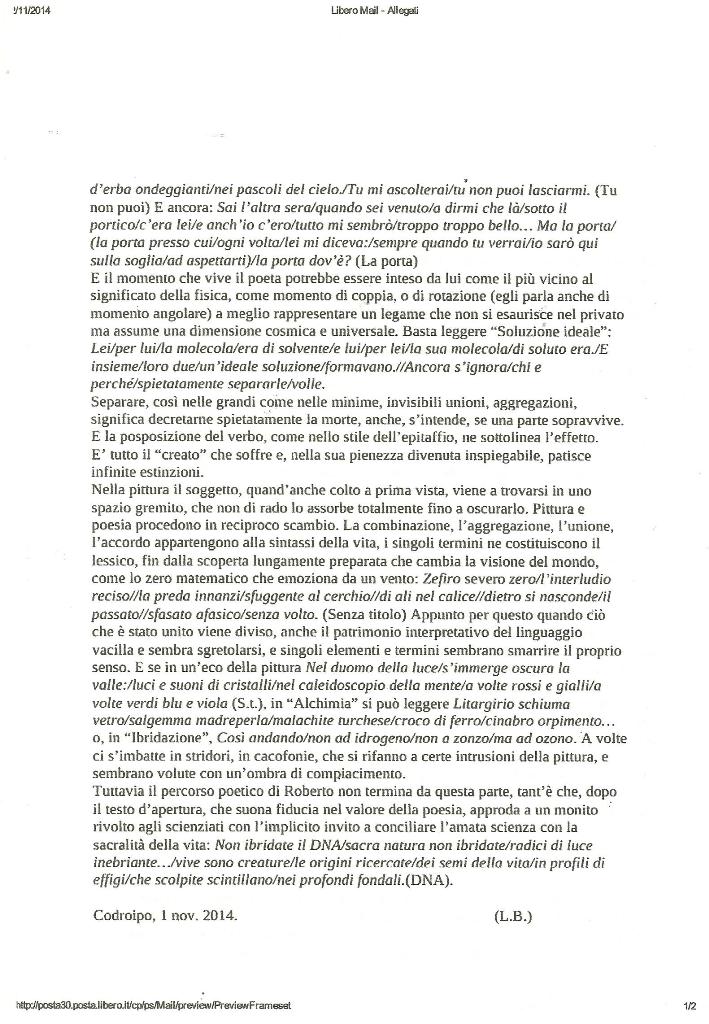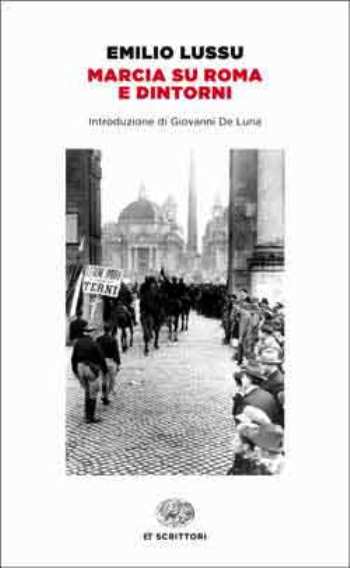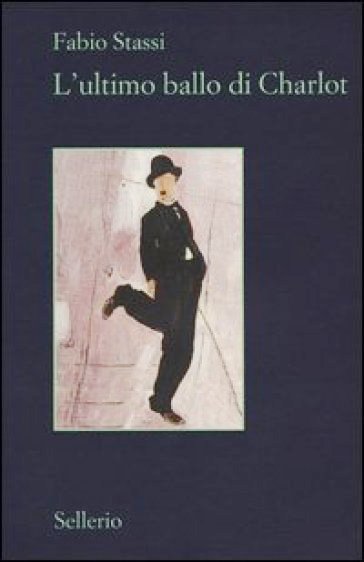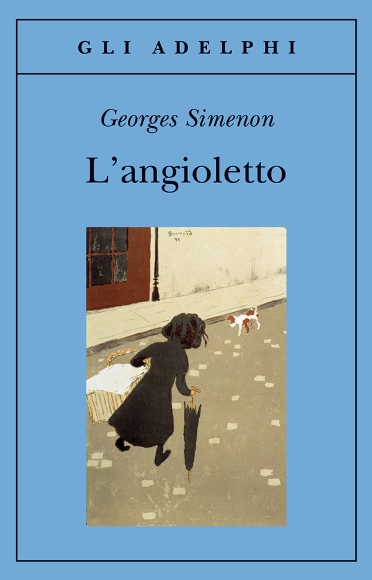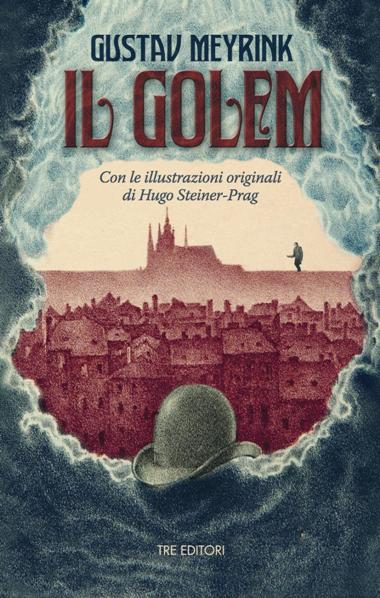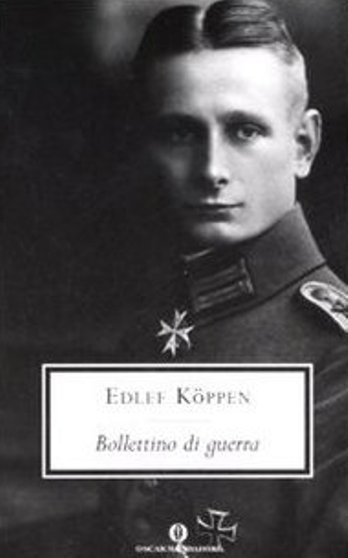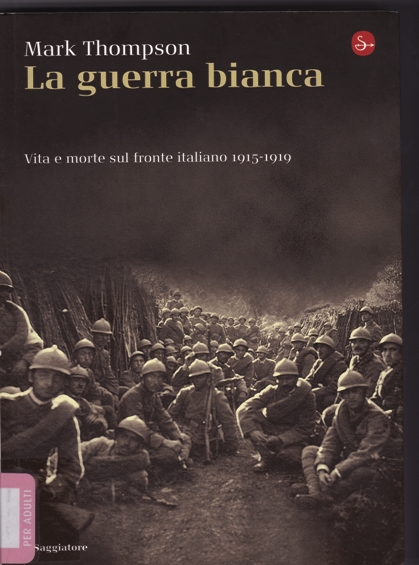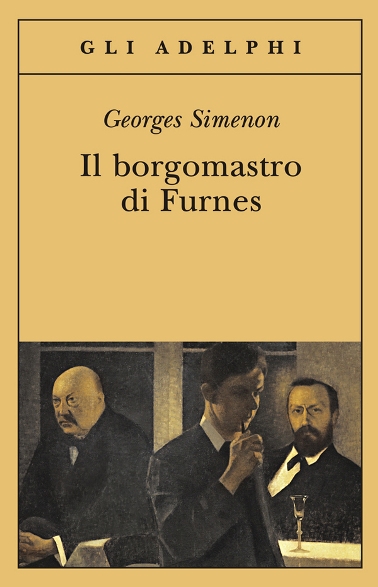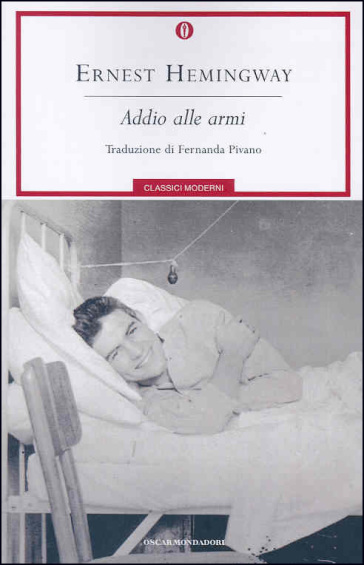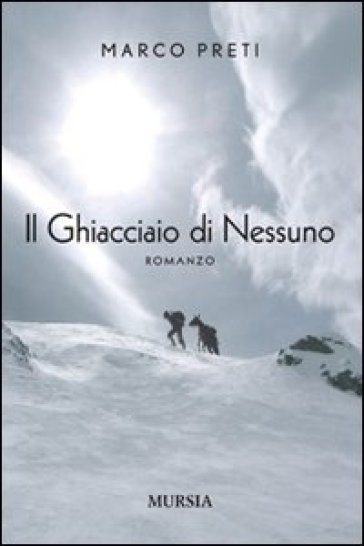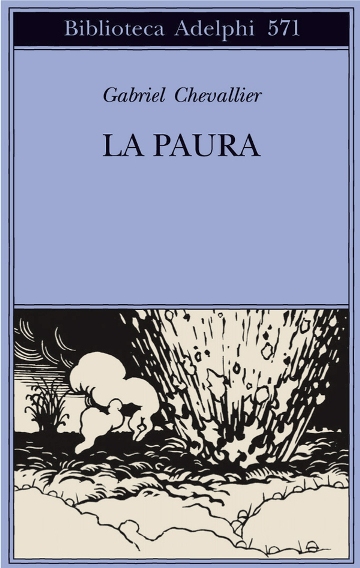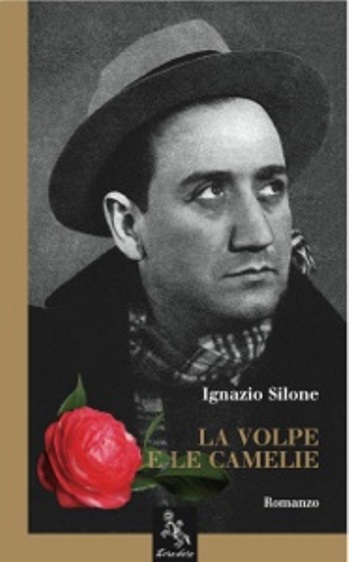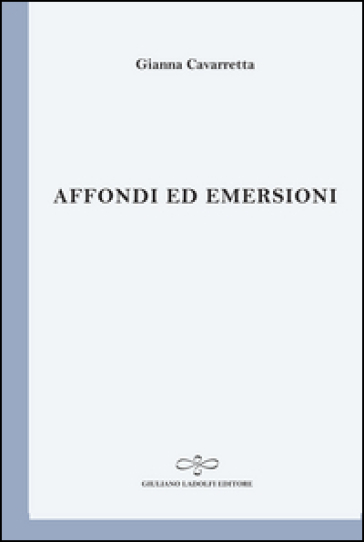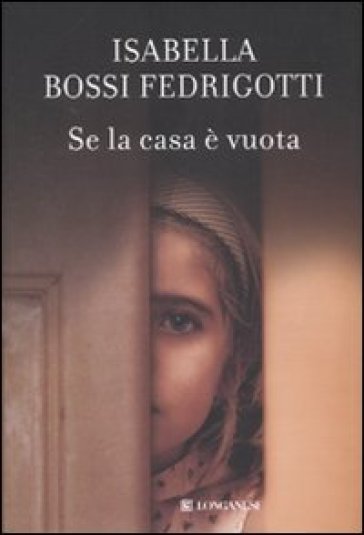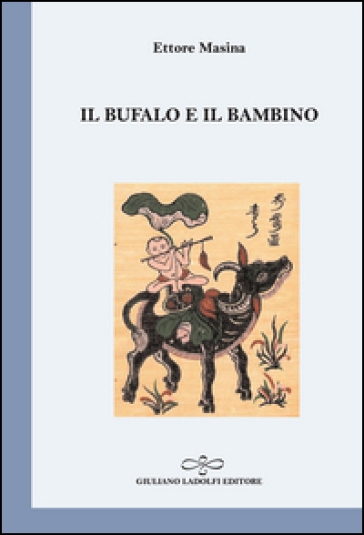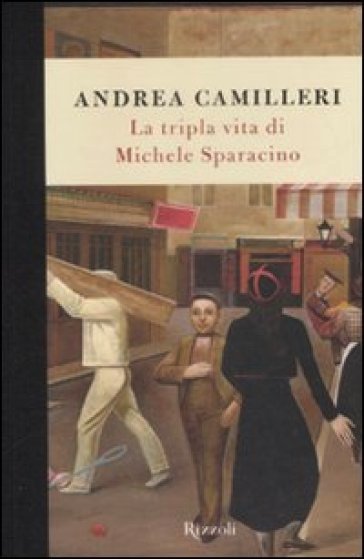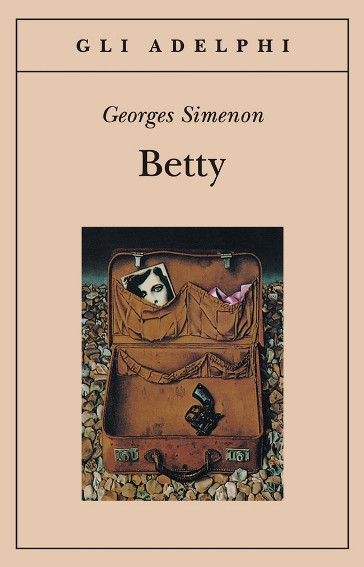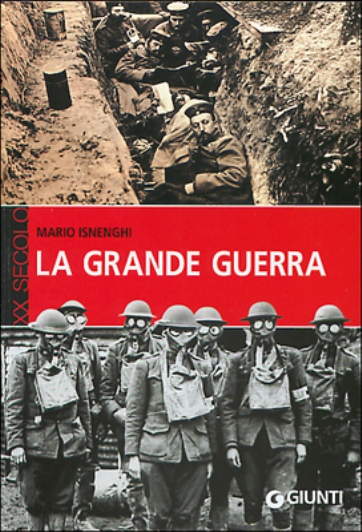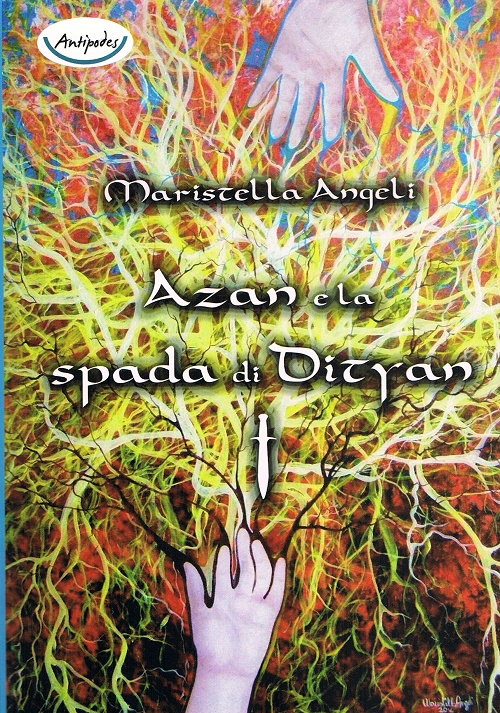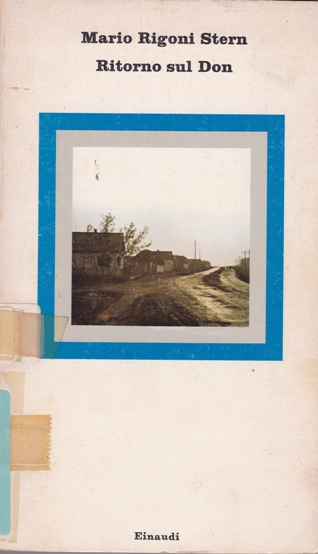Recensioni
2015
![]()
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Commenti Poesie consigliate La Giostra della satira Concorsi La Sorgente delle poesie
|
Questa pagina raccoglie le recensioni di romanzi, libri di racconti, volumi di poesia e di altro genere letterario (libri di saggi, viaggi, teatro, ecc.), film. |
Recensioni 2012
Recensioni 2013
Recensioni 2014 (Gennaio-Settembre)
Recensioni 2014 (Ottobre-Dicembre)
|
23/12/2015
Un
Natale di Maigret Traduzione di Marina Di Leo Edizioni Adelphi Narrativa racconti Pagg. 167 Il regalo di Babbo Natale Georges Simenon è talmente bravo che mi riesce sempre più difficile scrivere un commento critico delle sue opere; non è facile infatti trovare nuove parole per descrivere la sua straordinaria abilità nel sondare l’animo dei suoi personaggi, nel proporci, con apparente semplicità, situazioni in cui con brevi frasi si riesce a comprendere perfettamente l’atmosfera, senza dimenticare ls capacità di fornirci una precisa descrizione dell’ambiente che si materializza davanti agli occhi del lettore; inoltre é dotato di una creatività così ampia da riuscire a proporre nuovi testi la cui originalità li impreziosisce ulteriormente. Sono tutte caratteristiche che si ritrovano in ogni sua opera, anche in questa raccolta di tre racconti abbastanza lunghi;.i primi due sono accattivanti e gradevoli e ritengo di non dover spendere una parola di più, preferendo soffermarmi sull’ultimo che dà il titolo all’intero libro. Sarà perché siamo prossimi al Natale con le sue magiche atmosfere che però vanno disperdendosi, ma Un Natale di Maigret mi è piaciuto in modo particolare. Inizia con la mattina della festività, Maigret che, già sveglio, si gode il tepore del letto, ma che poi decide di alzarsi ed è ancora in vestaglia quando riceve la visita di due dirimpettaie, un’anziana zitella e la zia, madre di fatto adottiva, di una bambina che si trova forzatamente a letto da un po’ di tempo a seguito di una frattura. Una delle due è poco ciarliera, ma la “signorina”, che è una estimatrice di Maigret, insiste e così salta fuori che la bambina asserisce di aver visto nella sua camera da letto - e di notte - Babbo Natale, che le ha lasciato una bambola. La fantasia di bimbi? No, perché la bambola, nuova, c’è davvero e nessuno di casa l’ha donata. Da lì nasce un giallo la cui bellezza risiede nello sviluppo di un’indagine del tutto atipica (il commissario non va al Quai del Orfevres, ma resta in casa, anzi la sia abitazione diventa una succursale della polizia), infarcita di tanti particolari che, senza far perdere di vista il percorso per la soluzione dell’enigma, propone un Maigret casalingo e dà spazio anche a sua moglie, quasi sempre silenziosa e intenta a cucinare, ma che ogni tanto pone domande al marito che saranno punti ben precisi per risolvere il caso. L’atmosfera natalizia, il nevischio, Maigret tenero con la bambina, a cui farà visita, il ritmo non convulso, ma volutamente lento accompagnano una trama di straordinaria originalità rappresentano un piacere particolare per il lettore, tanto che gli sembrerà di essere presente, di respirare l’aria fredda dell’inverno, di avvertire il profumo dei cibi che la signora Maigret sta preparando e infine di rammentare che quello era ancora un Natale come si deve, e non una festa come quella di oggi, votata non alla fede, ma al consumismo.
Georges Simenon, nato a
Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
18/12/2015
La monaca di Monza di Roberto Gervaso Edizioni Bompiani Biografia
Eros e Thanatos Che la vicenda di suor Virginia Maria, al secolo Marianna de Leyva y Marino (Milano, 4 dicembre 1575 – Milano, 17 gennaio 1650) avesse, e ha tuttora, tutti i crismi per attrarre la curiosità, spesso morbosa, della gente è fuor di dubbio. La relazione amorosa con il conte Gian Paolo Osio presenta caratteristiche di sicuro interesse: passione sfrenata, la profanazione del convento, ripetute uccisioni e perfino due nascite. Tuttavia che all’epoca nei monasteri potessero coesistere preghiera e carnalità sfrenata non era una stranezza, anche perché molte delle ospiti non si trovavano lì per autentica vocazione, ma vi venivano richiuse da padri che intendevano tramandare il patrimonio solo al primogenito, senza dimenticare anche i casi, non rari, di giovani che prendevano il velo unicamente per sfuggire alla miseria e con essa allla scarsa e irregolare alimentazione. I fatti di sangue, peraltro, non mancavano, dettati da gelosie o da opportunità. Ma allora perché tanto interesse per quella che è più conosciuta come la monaca di Monza? Se Alessandro Manzoni non ne avesse parlato nei Promessi sposi probabilmente non ci sarebbe stata tanta notorietà; il narratore lombardo la inserì, cambiandone il nome dei protagonisti, rispettivamente in Gertrude e in Egidio, probabilmente per dimostrare quanto in quell’epoca, nonostante la Controriforma, la rilassatezza dei costumi fosse imperante e anche per esaltare maggiormente, per contrasto, la fede, profonda e integerrima, di personaggi come il cardinale Federico Borromeo, che infatti avrà una parte in questa vicenda. Con ogni probabilità Manzoni apprese di questa tresca nel corso delle ricerche da lui effettuate e propedeutiche alla stesura dei Promessi sposi; infatti, trovò le carte del processo e altro, così che ebbe gli elementi per interessarlo, un po’ come fece nel caso degli “untori”, di cui scrisse anche un saggio storico (Storia della colonna infame) ed egualmente fece per suor Virginia Maria e Gian Paolo Osio (La monaca di Monza). Questa vicenda interessò non solo il popolino, ma anche storici e registi cinematografici, che diedero vita a pellicole per lo più boccaccesche. Anche Roberto Gervaso ha voluto dire la sua e lo ha fatto da storico appassionato, razionale e imparziale. Nel presentarci l’epoca, l’ambiente e le origini dei protagonisti l’autore ci fa entrare piano piano in una vicenda che oserei definire più squallida che boccaccesca, con questo lazzarone del conte Osio che soddisfa sessualmente non solo suor Virginia, ma anche altre due monache, e spesso gli incontri avvengono simultaneamente con queste tre donne. Senza peraltro scriverlo, sollecita così un’immaginazione che porta a fantasticare su amplessi multipli, su laide carezze e su qualsiasi immaginabile, e anche inimmaginabile, gioco erotico. Ma se Gervaso non è un bacchettone, non è nemmeno un cultore del boccaccesco: si limita a raccontare solo quel che sa dalle carte in suo possesso ricorrendo spesso alla sua sottile ironia, che può essere scambiata solo da un lettore disattento per compiacimento sessuale. No, non si deve temere questo; se il Manzoni nei Promessi sposi per descrivere l’incontro di Suor Virginia con Osio, scrive che, al richiamo di quest’ultimo, La sventurata rispose (in questa brevissima frase ci sta tutto il possibile della tresca che sarebbe stata avviata e la gravità del gesto), lo storico invece descrive con minuzia il fatto, sulla scorta degli elementi in suo possesso, opera anche di altri storici di quel periodo e dei secoli successivi. Però, mette in guardia, nel senso che, secondo la sua esperienza, dà maggiore o minore credibilità a questo o a quell’altro scritto, ritraendone una comprensione personale che partecipa al lettore. Questa è una tecnica che gli è comune e che impreziosisce il saggio, in una ricerca di una verità che si avvicini il più possibile alla realtà. Peraltro, non si esime da un giudizio sui protagonisti, con Suor Virginia che amava solo carnalmente il conte Osio e che non conosceva, né ebbe modo di conoscere un amore diverso, fatta eccezione per quello verso Dio che permeerà la sua lunga esistenza dopo la condanna a essere murata viva (nel senso che dovette vivere in un esiguo spazio chiuso, senza possibilità di vedere il sole, ma con un’apertura che permetteva il passaggio del cibo); la sua diventerà una dedizione assoluta, tanto da convincere il cardinale Borromeo che non solo si era redenta, ma che stava diventano una santa. Se Gian Paolo Osio era un farabutto già prima di conoscere Suor Virginia, se si macchiò di orrendi delitti, per cui fu condannato a morte in contumacia (morì colpito da bastonate mentre era ospite in casa di quello che credeva un amico), tuttavia era effettivamente innamorato di suor Virginia, e non solo sotto l’aspetto sessuale, finendo con il rivelare un carattere diverso da quello che si sarebbe atteso, tanto da prendersi cura, finchè gli fu possibile, della figlia che l’amante aveva partorito. Senza togliere nulla ai suoi tanti demeriti, finisce con il dimostrarsi un essere che sapeva veramente amare, nel modo più assoluto e completo; in questo non era di certo ricambiato, anzi era considerato nulla di più di un semplice giocattolo sessuale. Si tratta quindi di una storia, vera, a tinte forti, in cui l’abilità e il senso di misura di Gervaso sono messe a dura prova, ma quel che ne esce è un racconto che non può lasciare indifferenti, è una vicenda in cui gradualmente le sfumature di morbosità si scolorano, per lasciare il posto a una pietà non di maniera, in cui ognuno dei protagonisti, da carnefice diventa volontariamente vittima. Da leggere, senza il minimo dubbio.
Roberto Gervaso è
nato a Roma il 9 luglio 1937.
14/12/2015
L’angelo del fango di Leonardo Gori Edizioni Rizzoli Narrativa romanz0
Fango su fango Trecentoquarantotto pagine non sono di certo poche e alla fine del libro, quasi costretto a leggere con ben poche interruzioni a causa dell’intricata e appassionante trama, sono arrivato esausto, ma anche soddisfatto. Se La città d’oro mi è sembrato un romanzo per nulla riuscito, con L’angelo del fango ho ritrovato il Gori dei tempi migliori, tanto per intenderci quello di Nero di maggio e di Il passaggio, romanzi in cui il protagonista principale è il capitano dei carabinieri Bruno Arcieri. E non è quindi un caso se anche in quest’opera giganteggia Bruno Arcieri, invecchiato, da pensione, ma diventato nel frattempo colonnello del SID, il servizio segreto italiano. Il palcoscenico è sempre Firenze, ma non quella della visita di Hitler nel 1936 e della liberazione della città avvenuta nell’estate del 1944, bensì quella devastata dall’alluvione dell’Arno del 4 novembre 1966. A ben guardare il romanzo presenta, se pur indirettamente, un collegamento con la lotta per la liberazione di Firenze del 1944 e quindi con Il passaggio, ed è un filo riannodato debolmente, ma che nella circostanza lascia ampi margini di azione a un autore che sembra ritrovare nel fascismo repubblichino o in quello post bellico il terreno ideale per inventare le sue storie. Se le altre narrate hanno trame tutto sommato semplici, questa invece è oltremodo intricata e pur tuttavia scorre su binari ben precisi su cui l’autore è riuscito a farla procedere in un crescendo di colpi di scena e di tensione che vanno a tutto vantaggio del piacere della lettura. Inoltre, come per il passato e nel caso specifico ancora di più, le descrizioni della devastazione della città e dell’atmosfera che vi regna sono elementi particolarmente qualificanti che non poco contribuiscono ad avvincere, in alcuni casi anche impressionando, con il colore funereo del fango e il tanfo della nafta uscita dai serbatoi, che danno una vera e propria sensazione del marciume di una palude. La decomposizione del paesaggio non fa altro che anticipare una decomposizione delle coscienze che possiamo riscontrare nei notabili che quasi fanno a botte per stare accanto al Presidente della Repubblica in visita e ai tragici giochi di potere di cui solo per un soffio Arcieri non resterà vittima. Ma se nel romanzo sulla liberazione di Firenze, nonostante i lutti, i morti colpiti dai cecchini fascisti, le vendette lasciano spazio a un domani di speranza, in L’angelo del fango tutto comincia e finisce con una massa d’acqua fangosa a lordare, o comunque a cercare di lordare anche chi della dignità e della coerenza ha fatto un principio di vita. Nei giochi sporchi dei servizi segreti il colonnello Arcieri rappresenta un mondo passato, di una generazione che ancora credeva che fare il proprio dovere con coscienza e nel rispetto delle norme fosse il codice etico a cui uniformarsi. Immersi nella fanghiglia, ma non ancora lordati dentro sono i tanti giovani, venuti da ogni dove, che sguazzando nel putridume cercano di recuperare i libri della Biblioteca Nazionale; chissà che loro riescano a mantenere la purezza di cuore necessaria, ma il timore è che si perdano poi negli infiniti rivoli del fango morale. L’epoca degli anni di piombo è a due passi, con gli scellerati attentati e gli estremisti rossi e neri che faranno a gara per alimentare la strategia della tensione, probabilmente marionette manovrate da un abile burattinaio di cui non verremo mai a sapere il nome. Ecco nella trama di L’angelo del fango ci sono anche i prodromi di un periodo che mi è toccato vivere, iniziato con l’attentato di Piazza Fontana a Milano e culminato con quello alla stazione di Bologna. Mi pare superfluo aggiungere che la lettura di questo libro, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco nel 2005, è senz’altro raccomandata.
Leonardo Gori
è nato a Firenze nel 1957 ed è uno dei caposcuola della narrativa di
tensione italiana. È autore di oltre dieci romanzi di successo: dai
thriller ambientati nel recente passato come Nero di maggio (Hobby &
Work 2000), alla spy-story e ai romanzi di intrigo a sfondo storico
come Le ossa di Dio (Rizzoli 2007) e La città del sole nero (Rizzoli
2008). Con L’angelo del fango (Rizzoli 2005), Leonardo Gori ha vinto
i più importanti premi letterari dedicati alla narrativa gialla, a
cominciare dal prestigioso Premio Scerbanenco. Insieme a Marco Vichi
ha scritto il romanzo Bloody Mary (Einaudi, 2010) e con lo storico
medievista Franco Cardini Lo specchio nero e Il fiore d’oro (Hobby &
Work 2004 e 2006).
6/12/2015
La pipa di Maigret e altri racconti di Georges Simenon Traduzione di Marina Di Leo Edizioni
Adelphi Narrativa racconti Collana gli Adelphi – Le inchieste di Maigret
Quattro autentici gioielli Abituato ai romanzi di Simenon, che è uno dei miei autori preferiti, ho avuto la naturale curiosità di verificare se anche in una prosa assai più breve quale il racconto il narratore belga riuscisse a dimostrare le sue straordinarie capacità. Infatti, benché si tratti sempre di narrativa, la lunghezza assai più contenuta impone un notevole sforzo al fine di esporre in poche pagine una vicenda completa, che nel caso del giallo si può riassumere in uno o più delitti, nelle indagini e nell’assicurare alla giustizia il colpevole o i colpevoli. Quindi ci sono necessariamente anche meno parole per l’analisi psicologica dei personaggi e per ricreare ambiente e atmosfera, aspetti che Simenon cura in modo particolare, ottenendo risultati di assoluta eccellenza, magari lasciando in secondo piano l’intreccio vero e proprio. Dico subito che la lettura di La pipa di Maigret e altri racconti mi ha lasciato stupefatto perché non solo l’autore è riuscito a far emergere le sue capacità, ma anche a imbastire delle trame che sono particolarmente avvincenti e che si fanno apprezzare per la rigorosa logica a cui sono improntate. Senza ovviamente svelare il contenuto di ognuno di questi quattro racconti, di lunghezza variabile, dico che il primo, quello che dà il titolo al libro, vede un testimone che ruba la pipa del commissario, il secondo (Non si uccidono i poveri diavoli) ha il suo immancabile omicidio di un uomo tanto umile e modesto da passare quasi inosservato, ma che forse nasconde un’altra esistenza, il terzo (La testimonianza del chierichetto), che è poi quello che mi è piaciuto di più, presenta un interessante accostamento nei comportamenti di un bambino e di un vecchio, il quarto (La vecchia signora di Bayeux), caratterizzato dall’omicidio di una vecchietta, ripropone la nota avversione di Simenon per il mondo fatuo di una certa borghesia di provincia. Tutti e quattro i racconti hanno come protagonista il commissario Maigret, talora in trasferta per motivi di lavoro in piccole cittadine francesi, mondi spesso silenziosi e chiusi, dove facilmente un viso nuovo può apparire come un intruso. In verità, questo è l’ambiente preferito dall’autore, perché in una comunità ristretta, benchè le indagini possano sembrare più facili, scontano tuttavia un miscuglio di maldicenza e di omertà. Questo libro, che si legge velocemente, non dovrebbe mancare nella biblioteca degli amanti del giallo e in particolare di quelli che reputano Simenon un narratore che, al di là del genere, ha lasciato un segno indelebile nella storia della letteratura.
Georges Simenon, nato a
Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
24/11/2015
Orizzonti di gloria
Castelvecchi Editore
Il delirio del potere Ci si chiede però il perché un comportamento simile, perché il generale dell’armata accolga, se pur in parte, il desiderio di vendetta del comandante Absolant. Che senso può avere fucilare degli individui per un reato che non hanno commesso? La conclusione è che nel mondo la giustizia non esiste mai, mentre l’ingiustizia é la norma, ma che soprattutto quegli uomini non vengono fucilati per un delitto che non hanno commesso, ma come esempio agli altri, che d’ora in poi sapranno che non esistono alternative: o morire per la vittoria, oppure morire davanti a un plotone di esecuzione. Chi potrebbe salvarli, cioè il comandante d’armata, non lo fa, perché non solo è convinto che l’esecuzione costituisca il miglior monito, ma anche per quella perversa prevaricazione che consente a uomini indegni anche del loro grado di dimostrare il loro potere assoluto, per l’inconsapevole appagamento che costoro possono ritrarre nel decidere il destino di esseri umani e che con ogni probabilità ripaga ampiamente gli insuccessi derivanti unicamente da una perniciosa miopia. È inutile che aggiunga che Orizzonti di gloria merita ampiamente di essere letto.
HUMPHREY
COBB
(1899 –
1944), sceneggiatore e romanziere, nato a Siena da genitori
anglosassoni. Dopo aver prestato servizio nell’esercito canadese per
tre anni durante la Prima Guerra Mondiale, rientra negli Stati Uniti
per lavorare dapprima nel mercato azionario, poi nella marina
mercantile, nell’editoria, in pubblicità, e infine per l’Office of
War Information – antesignano della Cia – redigendo materiale di
propaganda. Cobb è inoltre autore di None But the Brave(1938)
e della sceneggiatura del film San Quintino (1937) con
Humphrey Bogart.
21/11/2015
Il re
di Girgenti
Sellerio Editore Palermo
Narrativa romanzo Un tentativo di riscatto Andrea Camilleri, di tanto in tanto, rispolvera fatti e personaggi del passato, quasi del tutto caduti nell’oblio, per trarre lo spunto per interessanti e piacevoli romanzi storici. È il caso di quell’autentico capolavoro che è Il birraio di Preston, oppure di La setta degli angeli, una sorta di bunga bunga di inizi ‘900. Il re di Girgenti é basato su un fatto accaduto realmente nella prima metà del XVIII secolo ad Agrigento, allorché un semplice contadino, uno di quelli che lavoravano a giornata, tale Michele Zosimo, più conosciuto come Zosimo, per alcuni giorni divenne re della città. Che un umile lavoratore della terra, un plebeo potesse diventare un capo popolo e assurgere, sia pure quasi nel tempo di un battito d’ali di farfalla, al trono di un improvvisato regno è materia di per sé particolarmente interessante e in cui Camilleri si getta a capofitto. In sé la vicenda, a parte lo scalpore, non sarebbe gran cosa se l’autore siciliano non ci mettesse tanto del suo, con la rappresentazione di un mondo atavico, in cui sopravvivono – quando ci riescono – migliaia di poveri diavoli, accanto alla stridente realtà dell’opulenza di nobili, la cui indolenza e protervia non viene minimamente scalfita dall’abbondanza di superfluo. Questo terreno, così spaccato, è la coltura ideale perché possa dare i natali a qualcuno che osi sollevare la testa, diventando il simbolo dei sudditi considerati dai padroni più bestie che uomini. Accanto alla figura di Zosimo, esistito veramente, la cui vita è ovviamente romanzata da Camilleri, si ritagliano un angolo di notorietà tanti altri personaggi, del tutto di fantasia, che danno una coralità all’opera tale da costituire uno dei motivi del suo successo. Ma se nell’analisi sociologica dei villani dell’epoca l’autore siciliano fa rientrare un certo alone di magia e di un empirico e rozzo esoterismo, ha la capacità tuttavia di innestare una trascendenza non di maniera, in un’opera che unisce riso e anche pianto, perché il Re di Girgenti non abdicherà, né sarà costretto a farlo; non è tanto l’attribuzione del titolo il suo reato, quanto invece quello di aver richiesto un po’ di giustizia e di umanità. Per la sua ribellione, per la ribellione di un popolo di derelitti che lo ha seguito, finirà sulla forca ed è proprio l’esecuzione forse la parte più riuscita del romanzo; in quelle pagine la parola vola alta e si tocca il sublime. Quindi tanto di cappello a Camilleri e a questo suo lavoro, a cui nuoce solo quel suo linguaggio di dialetto siciliano italianizzato che a volte è comprensibile solo a senso, impedendo così di apprezzare la bellezza della parola giusta al momento giusto.
Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e
sceneggiatore. Ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il
volume, I
teatri stabili in Italia (1898-1918). Il
suo primo romanzo, Il
corso delle cose, del 1978, è stato trasmesso in tre
puntate dalla TV col titolo La
mano sugli occhi. Con questa casa editrice ha pubblicato: La
strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992),La
bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un
filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca (1997), La
concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il
re di Girgenti(2001), La
presa di Macallè (2003), Privo
di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza
Musumeci (2007), Il
casellante (2008), Il
sonaglio (2009), La
rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010,
anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie di Vigàta (2011), La
setta degli angeli (2011), La
Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La
banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014), Il
quadro delle meraviglie. Scritti per teatro, radio, musica, cinema (2015), Le
vichinghe volanti e altre storie d'amore a Vigàta (2015);
e inoltre i romanzi con protagonista il commissario Salvo Montalbano: La
forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il
ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La
gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il
giro di boa (2003), La
pazienza del ragno (2004), La
luna di carta (2005), La
vampa d'agosto (2006), Le
ali della sfinge(2006), La
pista di sabbia (2007), Il
campo del vasaio (2008), L'età
del dubbio (2008), La
danza del gabbiano (2009), La
caccia al tesoro (2010), Il
sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi(2011), Una
lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un
covo di vipere (2013), La
piramide di fango (2014), Morte
in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano (2014), La
giostra degli scambi (2015).
15/11/2015
Il Gran Diavolo Giovanni dalle Bande Nere l’ultimo capitano di ventura di Sacha Naspini
Rizzoli Editore Quel gran diavolo del dio della guerra Giovanni dalle Bande Nere, al secolo Giovanni di Giovanni de’ Medici (Forlì, 6 aprile 1498 – Mantova, 30 novembre 1526) è stato forse il più noto condottiero italiano, uno di quegli uomini d’arme che, unitamente alle truppe di cui disponevano, si mettevano al soldo di vari Signori per combattere nelle guerricciole – ma anche in grandi conflitti – che nel Rinascimento erano piuttosto frequenti. Sul suo ardimento e sulla sua capacità tattica non ci sono dubbi, mentre difettava di doti di stratega, tanto che non fu mai messo a capo degli eserciti dei vari committenti, a differenza per esempio del marchese Francesco II Gonzaga. Discendeva, per parte di madre (Caterina Sforza, la Signora guerriera di Imola e Forlì) dal ben più capace condottiero Muzio Attendolo Sforza, dal qualeti ereditò lo spirito indomabile e il coraggio; il padre Giovanni faceva parte di un ramo cadetto della famiglia Medici, come si sa ricca e assai potente. Benché quindi ci fossero tutti i presupposti affinchè il giovane Giiovanni potesse diventare di fatto il padrone di Firenze (lo diverrà suo figlio Cosimo) spinto da uno spirito di avventura indomito preferì abbracciare il mestiere della guerra, che gli diede un’ampia popolarità in un alone quasi di mistica leggenda, a cui contribuì anche la sua morte in ancor giovane età. Scrivere di quest’uomo significa quindi rievocarne la memoria, magari presentandolo come un cavaliere senza macchia e senza paura, andando incontro facilmente ad abusati stereotipi. Sacha Naspini, che si può dire abbia visto crescere come narratore e di cui ho individuato subito l’innato indubbio talento, alla prima prova con il romanzo storico non è caduto in questi tranelli, ma ha congegnato un’opera, che pur fedele alla realtà, si esprime attraverso una visione originale, resa anche possibile dal fatto che la vicenda del condottiero viene esposta attraverso gli occhi di un personaggio che ritengo di fantasia, anzi agli inizi è tutto un alternarsi di capitoli dedicati alle vite di Giovanni e di Nicolò Durante (così si chiama quello che è forse il vero principale protagonista). Le due esistenze procedono parallele per un poco, poi convergono giusto quando il lettore potrebbe affaticarsi nel passare da pagine dedicate all’uno o all’altro, mossa abile che consente anche di avere un’idea ben precisa dei caratteri di entrambi. In particolare Nicolò Durante é appassionato di erbe officinali che ne fanno un alchimista, nonché è fedele alla tradizione del suo paese della Conca del Fucino, con la processione di Pentecoste, con la statua di San Domenico portata in giro per le vie ricoperta da serpenti vivi, alcuni dei quali lui si porta sempre appresso in una sacca legata in vita, da cui li toglie per tenerli arrotolati al braccio, onde trarre dal loro comportamento gli esiti dei prossimi scontri, come un vero e proprio negromante. Se Giovanni è un personaggio relativamente semplice, ben più complesso è Nicolò, che osserva, partecipa con valore ai combattimenti, ma sembra sempre assorto nei suoi pensieri, quasi che per lui quella guerra che porta la morte servisse solo per avere di che vivere, non inseguendo certo sogni di gloria, tutto teso a dare risposte alla sua sete di conoscenza. Nel primo c’è il Rinascimento nella sua futura decadenza, nel secondo appare uno spiraglio di quell’illuminismo che si realizzerà ben più tardi. Si potrebbe dire che uno è la forza pura e l’altro è invece l’emblema della ragione. È intorno a loro due che si svolge la vicenda, in un mondo in cui si massacra con indifferenza e con altrettanta indifferenza si è massacrati. Spade contro picche, ma già prendono piede gli archibugi che uccidono senza che si veda il nemico negli occhi. Il mondo delle giostre e dei tornei è al suo crepuscolo e Giovanni dalle Bande Nere rappresenta l’ultimo sole, ancorché morente in una nebbiosa giornata di novembre. Senza enfasi, rifuggendo ogni retorica, razionale e imparziale Sacha Naspini ci accompagna in questa lunga cavalcata di fine epoca, e senza mai ergersi a giudice, grazie anche a una vena di pietà, ci fornisce l’immagine di un Giovanni de’ Medici vivo e vitale come doveva essere, ma egoista e vanitoso, cattivo marito e pessimo padre, insomma questo gran diavolo, come era anche soprannominato, era solo un dio della guerra, incapace di reggere il peso della pace. Leggetelo, perché questo romanzo è bellissimo.
Sacha Naspini (Grosseto, 1976) è autore di
numerosi romanzi, tra i quali I sassi (Il Foglio Letterario,
2007) I cariolanti (Elliot, 2009), Cento per cento (Perdisa
Pop, 2011), Le nostre assenze (Elliot, 2012), e scrive per il
cinema e la tv.
11/11/2015
Il Trio dell’arciduca di Hans Tuzzi
Bollati Boringhieri Editore Narrativa romanzo Pagg. 158 Guerra di spie È il mese di giugno del 1914 e tutta l’Europa è in ebollizione; anche se la vita sembra scorrere tranquilla nei fasti della Belle Epoque soffiano venti di guerra sempre più forti. Dal mare di Trieste viene ripescato il corpo esanime di Celik Yilmaz, un mercante levantino che è anche l’informatore di un giovante agente segreto imperialregio. Si potrebbe pensare a una disgrazia, ma un segno inequivocabile sul capo della vittima è la prova che si tratta di un omicidio. Perché uccidere un pesce così piccolo? Che cosa aveva di così importante da riferire e che si è voluto che non arrivasse alle orecchie dei servizi segreti austriaci? Sono queste le domande che si pone Neron Vukcic, montenegrino, giovane, ma molto intraprendente, dotato di un finissimo intuito, insomma in breve uno dei migliori agenti di cui disponga l’Austria. Inizia così una spy story che pagina dopo pagina si tinge sempre più di giallo, in un gioco di spie che vede coinvolti anche altri stati, in una corsa tesa a evitare, o a realizzare a seconda di una delle parti contrapposte, l’evento scatenante di quella che sarà chiamata la Grande Guerra. È forse superfluo che dica che Neron riuscirà a giungere alla soluzione, ma senza che il suo paese ne tragga vantaggio, perché la ragion di stato dei politici a volte è di una sottigliezza che cela perfidi interessi. Questo è il primo libro di Hans Tuzzi, che leggo e posso dire che è stata una gradevole sorpresa. Quest’autore, che nonostante il nome è italianissimo (si tratta in effetti di Adriano Bon, nato a Milano nel 1952 e docente universitario) è quel che si suol dire una buona penna. La sua è una scrittura fluida, scorrevole, uno stile fresco che, comunque, riesce a mettere in risalto capacità di ricreare atmosfere veramente encomiabile e poi si ha sempre l’impressione che per questo narratore lo scrivere un libro sia un gioco appassionante, volto sì a coinvolgere il lettore, ma a rendere anche gioioso partecipe lui stesso. E se qualche sospetto ho avuto in ordine al personaggio dell’agente imperialregio (giovane, ma di buona stazza, misogino, appassionato di orchidee) puntualmente alla fine ha trovato conferma, perché l’abile spia, messa in disparte con il pretesto di seguire un’indagine di nessuna rilevanza, matura l’idea di emigrare, di andare in America, dove già in prospettiva si vede sempre chiuso in casa, a coltivare orchidee, a santificare i pasti, a inglesizzare il suo nome, che tradotto sarebbe Nero Woolf. Posso quindi confermare che Il Trio dell’arciduca è un prodotto di ottima fattura che si legge con vero piacere, tanto che mi sono ripromesso di mettere in agenda altri libri di questo autore.
Hans Tuzzi è l’apprezzato
autore dei celebri gialli ambientati a Milano che hanno come
protagonista il commissario Melis: Il Maestro della Testa sfondata
(2002), Perché Yellow non correrà (2003), Tre delitti un’estate
(2005). Gli ultimi sei, La morte segue i magi (2009), L’ora incerta
fra il cane e il lupo (2010), Un posto sbagliato per morire (2011),
Il principe dei gigli e Casta Diva (2012 e 2013, entrambi già apparsi
in Tre delitti un’estate), Un enigma dal passato (2013) sono tutti
pubblicati da Bollati Boringhieri.
7/11/2015
I Borgia di Roberto Gervaso Club Italiano dei Lettori Rizzoli Storia Affari di famiglia Rodrigo, Cesare e Lucrezia Borgia sono nomi che evocano un passato fatto di sfrenata lussuria, di intrighi, di ferocia e di veleni. Infatti i loro contemporanei ci hanno sempre fornito questo ritratto, li hanno sempre presentati come la malvagità al massimo livello, non esseri umani quindi, bensì mostri da esecrare in eterno. L’unanimità dei giudizi, fatta qualche rara e sporadica eccezione, sembrerebbe dimostrare che il quadro fornito possa rispondere a verità, ma sorge più di un dubbio, soprattutto ove si consideri che gli altri potenti rinascimentali non erano certo degli stinchi di santo. E allora perché così tanta acredine, perché un odio così radicato? È probabile che sia stata la reazione per lo scampato pericolo delle signorie che regnavano su un’Italia spartita in tanti staterelli e che fece gola a Rodrigo Borgia, allorché era pontefice con il nome di Alessandro VI, al fine di dare agli eredi possedimenti e relativa sovranità trasmissibili di padre in figlio. Certo, il Papa era un monarca assoluto, che governava su ben due regni: lo stato delle anime e quello pontificio. Però il suo potere derivava da un elezione e non poteva essere trasmesso; di conseguenza, l’unico modo per assurgere agli onori di un casato era solo quello di impossessarsi delle terre altrui, su cui dominare. E se ne ebbero timore piccole signorie come i Gonzaga a Mantova e gli Este a Ferrara, quasi altrettanta paura la provarono gli Sforza a Milano, i Patrizi della Serenissima a Venezia e i notabili di Firenze.. Scrivere quindi dei Borgia, riportare la loro storia non è un lavoro facile, fra tante fonti preconcette e necessita di procedere con la massima razionalità ed è ciò che ha fatto Roberto Gervaso con I Borgia. Prima di tutto ha voluto rappresentare com’era il panorama italiano, delineando in modo rapido, ma esauriente quali erano le famiglie dominanti all’epoca, e con criteri più approfonditi la situazione a Roma, capitale dello stato pontificio. Le notizie costituiscono quasi un’indispensabile premessa, perché altrimenti non sarebbe possibile comprendere il contesto in cui Rodrigo Borgia, prima vicecancelliere sotto ben cinque papi e poi pontefice lui stesso con il nome di Alessandro VI, ebbe a operare. Né meno importante è la parte riservata ai suoi predecessori, nepotisti, avidi e lussuriosi. L’ascesa di Rodrigo, i suoi primi passi come sovrano assoluto, procedono congiuntamente con le vicende dei figli, di cui i più celebri furono senza ombra di dubbio Cesare, detto il Valentino, e Lucrezia. Gervaso, nel caso di avvenimenti più importanti, non tralascia peraltro di citare l’opinione di loro contemporanei, esprimendo pure la sua secondo un criterio improntato esclusivamente al raziocinio. Ed è qui che si apprezza la valenza dello storico, capace di raccontare i fatti e di accogliere, di più o di meno, le versioni che altri diedero, senza mai affermare nulla, ma cercando solo l’unica spiegazione possibile. Lo stile è indubbiamente fluente, mai greve, spesso venato da una salutare ironia che talvolta trascende a una moderata comicità, come nel caso della descrizione dell’aspetto del re di Francia Carlo VIII, che mi ha strappato più di un sorriso. Inoltre è consapevole che dal suo modo di procedere potrebbe essere scambiato per un difensore dei Borgia, il che non è vero, e allora il suo tono, soprattutto quando si tratta di darne un giudizio, si fa più distaccato e si accentuano invece i pareri che a suo tempo diedero ii contemporanei. Non manca tuttavia del senso di pietà, come quando descrive la morte di Alessandro VI, per malaria, la mancanza di rispetto per le sue spoglie da parte dei camerieri personali, oppure la fine ardimentosa di Cesare, caduto in un’imboscata in Spagna e crivellato da colpi di lancia. Si sbilancia solo per Lucrezia, una figura vittima della ragion di stato, dolce, mite, ubbidiente, non certo l’avvelenatrice come viene ingiustamente ricordata; se a Roma con il padre e il fratello forse aveva condotto una vita al limite della decenza, a Ferrara, diventata sposa di Alfonso d’Este, si era ampiamente riscattata, tanto che morì quasi in odore di santità. Che giudizio pertanto si può dare di Rodrigo e Cesare Borgia? Il primo era la mente, il secondo il braccio, pur non essendo certo stupido. Sognarono e quasi riuscirono a concretizzare l’impossibile; il primo certamente non è stato un esempio del buon cristiano, quale dovrebbe essere un papa, ma rese alla Chiesa un grande servigio, rendendola più forte e con confini dello stato più stabili; pessimo papa, potremmo dire, ma di certo Rodrigo fu un grande statista e riguardo ai metodi utilizzati erano quelli all’epoca in voga in ogni signoria. Cesare era diabolico, capace di tessere inganni intricati, ma fu anche un grande condottiero e un buon amministratore dei territori conquistati; vendicativo, non andava tanto per il sottile, ma in un’epoca in cui scannarsi pareva essere il passatempo preferito, lui di certo non era quel mostro che la storia descrive. Entrambi erano, né più né meno, uomini del loro tempo, entrambi sognarono di fondare un regno ed entrambi fallirono, più per sfortuna che per incapacità. Quel che è certo è che se avessero vinto, la loro memoria sarebbe ben diversa, perchè, come si sa, la storia è scritta sempre dal vincitore. I Borgia è un libro bellissimo, che si legge con la stessa passione e attrazione di un thriller avvincente, ma qui non c’è finzione, c’è solo la descrizione di quanto accaduto in uno scorcio del Rinascimento.
Roberto Gervaso è
nato a Roma il 9 luglio 1937.
3/11/2015
Il catalogo delle amiche di Isabella Bossi Fedrigotti BUR
Biblioteca Universale Rizzoli
Dieci ritratti Dieci ritratti di donne, le amiche, costituiscono questo libro di Isabella Bossi Fedrigotti. Sono rappresentate nella loro caratteristica più saliente, in ciò che è più prorompente della loro personalità. Così c’è quella che da il meglio di sé quando la casa va a fuoco, o comunque quando c’è un incidente; c’è chi è nata per servire e ne è orgogliosa, c’è addirittura quella che ormai non più giovane è quasi rassegnata all’idea di non sposarsi più. Non credo che si tratti di amiche della narratrice, ma sono degli emblemi di personalità femminili che non è raro incontrare, ognuna delle quali ha pregi, ma soprattutto difetti e anche i pregi possono diventare difetti quando vengono platealmente ostentati. Intendiamoci, non è che Cristina, Ludovica, Stefania, Amelie, Francesca, Emanuela, Renata, Margherita, Fabrizia ed Emilia siano esseri riprovevoli, è che ognuna ha una spiccata personalità che, a seconda dei punti di vista, può caratterizzarle in bene o in male. Del resto si sa quanto sia più disponibile a fare un’analisi spietata una donna, soprattutto quando il soggetto è femminile, ma in Isabella Bossi Fedrigotti non c’è malevolenza, anzi, grazie anche a un’ironia di sottofondo, si trova un affetto sincero nei confronti di questi personaggi che sa così ben descrivere con la sua consueta scrittura elegante e fluida. A voler trovare un difetto in questo libro non è facile, però, questa volta, come mai era accaduto in altri suoi lavori, Isabella Bossi Ferdrigotti pare motivata più che altro a soddisfare le esigenze di una lettrice, piuttosto che di un lettore, senza tuttavia mai dare l’impressione di aver voluto spettegolare. Questo non rientra nelle sue abitudini, tesa invece a rappresentare situazioni e vicende che universalmente possano interessare. Forse questo mio rilievo dipende dal fatto che sono un uomo e che pertanto con non poche difficoltà cerco di entrare nella complessa psicologia femminile. Ci sono certi personaggi di cui sono riuscito a comprendere meglio lo scopo della narratrice, mentre per altri mi è rimasto qualche dubbio. Lungi dall’essere una prosa rosa e quindi frivola qui, a riflettere bene, c’è invece sempre della sostanza, costituita dal personale dramma di vivere che accomuna uomini e donne, ognuno secondo il suo sesso e le sue caratteristiche. Tuttavia, non credo di sbagliare dicendo che si tratta di un libro minore nella produzione della scrittrice, per lo meno rispetto a opere di grande rilievo come Casa di guerra e, soprattutto, Di buona famiglia; in ogni caso, e ritengo opportuno evidenziarlo, la lettura risulta sempre gradevole, grazie anche a delle vere e proprie chicche, come nel caso della prima del catalogo, Cristina, una donna che si fa in quattro in occasione delle disgrazie altrui e che, quando colpiscono il marito di un’amica, si presta a soccorrerlo anima e corpo, con una salutare ginnastica erotica. Da leggere, quindi.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor Budischowsky (Rizzoli,
2003) e Il primo figlio (Rizzoli, 2008).
30/10/2015
Vittorio Emanuele II
Edizioni Mondadori Il primo re d’Italia Vittorio Emanuele II (Torino, 14 marzo 1820 – Roma, 9 Gennaio 1878) è stato l’ultimo re di Sardegna e il primo re d’Italia. Fu sotto il suo regno, infatti, che furono combattute la seconda e la terza guerra di indipendenza, che avvenne la spedizione dei mille, che si ebbe la presa di Roma. Quindi è il protagonista principale di quel periodo storico che ha preso il nome di Risorgimento, nel corso del quale si pervenne all’unità d’Italia e proprio per questo motivo a scuola lo si studia come il fondatore della patria e si tende a presentarlo come un galantuomo, indomito, ardito, un vero e proprio condottiero. Per principio non mi fido molto degli appellativi, perché per quanto riguarda casa Savoia troviamo Umberto I, il re buono, talmente buono da far massacrare per mezzo delle truppe del generale Bava Beccaris uomini, donne e bambini che manifestavano pacificamente, Vittorio Emanuele III, il re guerriero, del cui ardimento dette prova l’8 settembre 1943 fuggendo come una lepre e lasciando gli italiani in balia della ritorsione dei tedeschi. Certo che per definire galantuomo un individuo ci devono essere delle specchiate prove che si è sempre comportato onestamente, ma nel caso di Vittorio Emanuele II non se ne trovano, così come non si trovano elementi che dimostrino la sua disonestà, benché voci popolari gliela attribuissero, e magari erano le stesse voci che dicevano che non era il primogenito di Carlo Alberto, ma di un macellaio fiorentino, fatto passare per un Savoia erede al trono in quanto quello legittimo era perito in un incendio. Di questa diceria c’è traccia (poche righe in verità) in questo bel libro di Denis Mack Smith, che sappiamo storico attento e imparziale. A onor del vero, per quanto abbia cercato di far piena luce sul primo re d’Italia, lo studioso inglese lamenta che le sue fonti sono sovente lacunose, altre volte precostituite e che soprattutto non ha potuto accedere, come tanti altri, all’archivio riservato di Casa Savoia, di cui sono ora in possesso Emanuele Filiberto e il padre. Ma c’è un’ulteriore stranezza: non è mai stato possibile, anche in passato, visionare la corrispondenza fra Vittorio Emanuele II e Cavour, il che fa sorgere il dubbio che tanta ostilità possa derivare dal tentativo di evitare di incrinare il mito di un uomo che è stato il padre della patria. A scuola ormai si è sempre studiata la figura di questo re, in verità amato dai suoi sudditi, secondo un tracciato impostato più di un secolo fa e che offre dell’uomo una visione simpatica, paternalistica, come si attende la gente che deve vedere in lui il primo degli italiani in tutto. A studiare era una schiappa, perché ne aveva ben poca voglia e scarsa intelligenza, da adulto era un tipo grossolano, amante della buona cucina e delle donne, di qualsiasi condizione sociale fossero. Benché cercasse di comportarsi da monarca assoluto, per la scarsa abilità politica doveva accettare le decisioni dei suoi presidenti del consiglio, fra i quali il più noto era Cavour, un camaleonte opportunista che nelle sue trame spesso scavalcava il sovrano. Come militare non mancava di coraggio, ma difettava, e non poco, di strategia e di tattica; inoltre, problema costante nella storia del nostro paese, era incapace di preparare il paese alla guerra ed è proprio il caso di dire che se non ci fosse stato il determinante aiuto dei francesi nella seconda guerra di indipendenza e l’alleanza con la Prussia nella terza molto probabilmente non si sarebbe mai raggiunta l’unità d’Italia. Insomma, quest’uomo chi era effettivamente? Credo che la miglior risposta sia contenuta nel libro; infatti, Denis Mack Smith scrive: “In vita, Vittorio Emanuele II fu molto rispettato e abbastanza popolare. Veniva onorato come il re che nel 1849 aveva rifiutato di rinnegare lo statuto, come l’uomo che nel 1859-61 aveva presieduto all’unificazione italiana e, dopo il 1861, come il padre e il simbolo della nazione unita.” Per quanto concerne la difesa dello statuto albertino, però, vi é da dire che avendone l’impero austro-ungarico uno ancor più liberale, non pretese che quello concesso dal Regno di Sardegna nel 1848 venisse rinnegato e quindi fu gioco facile mantenerlo in essere. Poi sempre Smith fa notare come fu successivamente alla sua morte che il sovrano divenne un mito, con dei panegirici scritti su di lui con cui gli fu riservato un posto, ben poco giustificato, fra i più grandi monarchi di tutti i tempi e di tutti i paesi. Nella realtà, pur con le limitazioni di conoscenza di cui ho accennato e che potrebbe incrinare irreparabilmente questo mito, Vittorio Emanuele II, che non si pose mai il problema dell’unità nazionale, ma solo l’obiettivo di ingrandire il suo piccolo regno, era considerato dai sovrani dell’epoca e dai loro ministri un uomo magari simpatico, ma di scarso spessore, ben poco istruito, portato a commettere gaffes madornali e, soprattutto, infido. Mi chiedo cosa salterebbe fuori se fosse possibile leggere la corrispondenza di Vittorio Emanuele II e quali segreti siano così importanti da richiedere una secretazione della stessa.. Forse un giorno sapremo e magari sarà poi necessario riscrivere la nostra storia, ma nel frattempo i secoli cancelleranno la memoria e forse ben pochi saranno in grado di dire cosa abbia rappresentato quel re per l’unità d’Italia. Intanto accontentiamoci di questo studio di Denis Mack Smith, che unisce alla solita imparzialità anche una scorrevolezza che stimola a leggere di come poté accadere che grazie a un piccolo regno e al suo re un’intera nazionalità si trovò finalmente unita nel suo paese.
Denis Mack Smith (Londra, 3
marzo 1920) è lo storico inglese più noto nel nostro Paese e ha
scritto libri relativi alla storia italiana dal risorgimento in poi.
27/10/2015
La
banda Sacco
Sellerio Editore Palermo Narrativa Il difetto di essere onesti Giunto all’ultima pagina non ho potuto fare a meno di dare sfogo alla rabbia che mi si era accumulata dentro, rabbia per una vicenda della storia del nostro paese che dà la misura di quanta strada ci sia ancora da percorrere per arrivare a un autentico Stato di diritto. Non a caso Umberto Terracini ebbe a scrivere “Penso che il caso sia unico nella storia giudiziaria italiana pur così pesante di capitoli sciagurati.”. Infatti, almeno fino a oggi, non esiste un caso in cui un cittadino sia colpito dalla giustizia per la sua onestà e per il suo senso civico. Camilleri, sulla base di una corposa documentazione, ce ne parla, ci dice come sia potuto accadere che una famiglia laboriosa e rispettosa delle leggi, come quella dei Sacco, abbia avuto la vita stravolta e addirittura sia finita in carcere, a seguito di una connivenza fra mafia e politica che non è ancora stata debellata. I Sacco vivevano a Raffadali in provincia di Agrigento, erano persone dedite, con passione, al lavoro, oneste e benvolute, ma non accettarono le imposizioni della mafia, così che, per non essere eliminati, si dettero alla macchia, stravolgendo la loro vita. E se c’era da sperare in un cambiamento quando il famoso prefetto Mori, mandato da Mussolini in Sicilia con pieni poteri per combattere la mafia, questo venne alla svelta fugato, per il comportamento delle forze dell’ordine, irriguardoso di ogni legge; ne fecero le spese anche i Sacco, che avevano pure il torto di essere socialisti. Finirono braccati dalla mafia e dalla polizia, fino a che dovettero arrendersi e furono tradotti in carcere; processati, vennero riconosciuti colpevoli, pur in assenza di prove, ma solo di testimonianze inattendibili, e furono condannati all’ergastolo, tranne che per uno, a cui fu comminata una pena detentiva minore, anche se considerevole. Ci fu la volontà di condannare ben sapendo che erano innocenti; i giudici emisero le sentenze commettendo un errore di cui erano consapevoli e così la mafia e il potere politico fascista, riappacificatisi, poterono festeggiare una vittoria che per loro era vitale, perché se l’esempio dei Sacco fosse stato seguito dagli altri onesti cittadini oggi non avremmo bisogno di tenere in organico il pool antimafia. I Sacco rifiutarono la domanda di grazia, e in quanto innocenti pretesero invece la revisione dei processi. Solo in tarda età furono convinti ad accettare la grazia, spiegando loro che poi si sarebbe provveduto a una lunga revisione che, per quanto ne so, non è mai avvenuta. Questo bellissimo libro di Camilleri è un pugno allo stomaco, perché l’autore ci accompagna passo dopo passo nella disperazione di questi uomini onesti, nella loro fede in un mondo migliore che non vedranno mai. L’autore non cerca di impietosire, racconta con una professionalità da storico, ma con lo stile di un romanziere, affinché il cognome Sacco non debba essere ricordato come quello di una banda di malfattori, bensì come quello di uomini vittime della mafia e dell’ingiustizia di uno stato che manda assolti i colpevoli e perseguita gli innocenti Da leggere, ci mancherebbe altro.
Andrea Camilleri
(Porto Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e
sceneggiatore. Ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il
volume, I teatri
stabili in Italia (1898-1918). Il
suo primo romanzo, Il
corso delle cose, del 1978, è stato trasmesso in tre puntate
dalla TV col titolo La
mano sugli occhi. Con Sellerio ha pubblicato: La
strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992),La
bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un
filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca (1997), La
concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il
re di Girgenti(2001), La
presa di Macallè (2003), Privo
di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza
Musumeci (2007), Il
casellante (2008), Il
sonaglio (2009), La
rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010,
anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie di Vigàta (2011), La
setta degli angeli (2011), La
Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La
banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014), Il quadro delle meraviglie. Scritti per
teatro, radio, musica, cinema (2015), Le
vichinghe volanti e altre storie d'amore a Vigàta (2015); e
inoltre i romanzi con protagonista il commissario Salvo Montalbano: La
forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il
ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La
gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il
giro di boa (2003), La
pazienza del ragno (2004), La
luna di carta (2005), La
vampa d'agosto (2006), Le
ali della sfinge(2006), La
pista di sabbia (2007), Il
campo del vasaio (2008), L'età
del dubbio (2008), La
danza del gabbiano (2009), La
caccia al tesoro (2010), Il
sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi(2011), Una
lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un
covo di vipere (2013), La
piramide di fango (2014), Morte
in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano (2014), La
giostra degli scambi (2015).
22/10/2015
Il confine
Editore Rizzoli I semi dell’odio Finita la prima guerra mondiale, il 10 settembre 1919 a Saint Germain.en-Laye fu firmato il trattato di pace con cui furono stabilite le ripartizioni territoriali dell’impero Austro-Ungarico e le modalità e le condizioni per la nascita della repubblica austriaca. Come al solito non si guardò alle legittime esigenze delle popolazioni interessate, ma ci si basò esclusivamente su criteri di espansione territoriale-economica e su caratteristiche volte meglio a difendere i confini nazionale degli stati vincitori. Fu così che l’Italia pretese, ed ottenne, che il suo territorio si espandesse fino al naturale spartiacque con l’Austria. In tal modo, il Tirolo, che prima era un’unica regione che a sud finiva a Riva del Garda, fu diviso in due, ricomprendendovi la parte ove si parlava prevalentemente italiano e quella in cui la lingua principale era il tedesco. Si trattava di zone soprattutto montuose, a economia agricola quasi di sussistenza e quindi intrinsecamente povere. Al momento e fino al 1922 non cambiò sostanzialmente nulla, a parte il fatto che quelle popolazioni, da diversi secoli parte integrante dell’impero austriaco, ora facevano parte del Regno d’Italia. Fu con l’avvento del fascismo che iniziò il periodo più buio per il popolo tirolese, che vide non solo negata la sua identità nazionale, ma che fu sottoposto a una italianizzazione violenta e forzata. E il regime trovò una valida sponda in un irredentista trentino, Ettore Tolomei che, sulla base del fatto che Druso, il figliastro di Augusto, aveva conquistato quelle terre facendone una provincia romana, asserì che le stesse dovevano quindi essere considerate territorio italiano. Era un suo pallino, tanto che nei primi anni del XX secolo si era dilettato a italianizzare i nomi tedeschi delle località del Sud Tirolo, ribattezzato Alto Adige. Ne uscì una toponomastica che sovente nulla aveva a che fare con il nome originario, ma al fascismo non interessava, perché quel che contava per lui è che lì, con le buone, ma soprattutto con le cattive, la popolazione di lingua tedesca fosse italianizzata. L’italiano diventò così l’unica lingua che si insegnava a scuola, i funzionari pubblici vennero sostituiti da italiani provenienti soprattutto dal Meridione e che spesso si comportavano da padroni. È in quel periodo che nasce l’odio di un popolo a cui viene negata l’esistenza; tuttavia, in base agli accordi fra Mussolini e Hitler, dopo che questi aveva annesso alla Germania l’Austria, fu “graziosamente” concesso agli altoatesini di lingua tedesca di optare per la Germania e così larga parte della popolazione, almeno per riacquisire la sua lingua e in un certo qual senso tradendo i principi dell’eroe nazionale Andreas Hofer, che più di un secolo prima era insorto contro la prepotenza del dominio bavarese, decise di accettare l’offerta del Fuhrer. Questo però comportava il trasferimento in Germania, solo in parte attuato, e il servizio militare nell’esercito germanico, che era l’unico effettivo scopo a cui mirava Hitler, bisognoso di un numero crescente di soldati per la sua politica espansionistica. È forse superfluo che dica che chi rimase in Italia peggiorò la sua situazione, che divenne oltremodo critica dopo l’8 settembre del 1943, allorchè tutta la regione Trentino-Alto Adige fu annessa al Reich. Finita la seconda guerra mondiale, gli altoatesini, ma anche i trentini, portarono avanti le loro richieste di autonomia;le cose, però, andarono per le lunghe, tanto che più di uno scalmanato di lingua tedesca riattizzò l’odio e iniziò il periodo degli attentati, dei morti fra le forze dell’ordine e dei reparti del nostro esercito, finchè si arrivò a concedere una sorta di indipendenza, o ampia autonomia, che, applicata, ha portato a soffocare i risentimenti e alla odierna situazione di convivenza pacifica. Il confine, questo strano libro che non si può definire un saggio storico vero e proprio, ma che posso considerare al massimo una riflessione personale, o anche un lungo editoriale d’opinione, parla di tutto ciò e Sebastiano Vassalli l’ha scritto quest’anno, per celebrare in anticipo la ricorrenza del centenario del famoso trattato del 10 settembre 1919; l’ha scritto in anticipo perché probabilmente sapeva che il suo tempo stava per finire, tanto che la morte l’ha colto il 26 luglio. Abituato ai suoi bellissimi romanzi, in cui il cuore si avverte pulsante, accompagnato da un pregevole stile, sono rimasto un po’ stupito per la scrittura giornalistica e per una certa freddezza di esposizione, che scompare solo nelle parti in cui traspare netta la sua accalorata passione per un mondo di pace, un mondo in cui tutti i popoli e tutte le etnie vivano in armonia. Certo, sa un po’ di retorica, ma non è una retorica vuota, è più di forma che di sostanza, e appare come il grande messaggio di un uomo che, consapevole della sua fine imminente, indica una strada di principi che, se rispettati e sinceramente accolti, possono portare gli esseri umani a una condizione di pacifica e serena convivenza. Da leggere.
Sebastiano Vassalli è
nato a Genova nel 1941 ed è morto a Casale Monferrato nel 2015.
Presso Einaudi, dopo le prime prove sperimentali, ha pubblicato La
notte della cometa, Sangue
e suolo, L'alcova
elettrica, L'oro
del mondo, La
chimera, Marco e
Mattio, Il
Cigno, 3012,Cuore
di pietra, Un
infinito numero, Archeologia
del presente, Dux,Stella
avvelenata, Amore
lontano, La morte
di Marx e altri racconti,L'Italiano, Dio
il Diavolo e la Mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, Le
due chiese e Comprare
il sole.
18/10/2015
Il
Grande Mago
Edizioni Rizzoli Così uguali, così diversi Nonostante tutti gli studi storici effettuati e le molteplici biografie, sia di sostenitori che di detrattori, ancor oggi il personaggio del conte Alessandro Cagliostro resta avvolto in un alone di mistero. Si tratta del truffatore Giuseppe Balsamo, oppure del nobile di origini portoghesi, grande umanista e autore del famoso motto “Liberté, Fraternité, Egalité”? Questo saggio di Roberto Gervaso, pur senza affermare nulla, anzi procedendo con particolare cautela, tenderebbe a identificare in un’unica persona Giuseppe Balsamo e Alessandro Cagliostro, sulla base di argomentazioni non solo plausibili, ma anche condivisibili. Ma credo che sia opportuno procedere per gradi, perché altrimenti il responso di Gervaso potrebbe riuscire ancora più misterioso del personaggio stesso. Giuseppe Balsamo nasce a Palermo il 2 giugno 1743, da umile, ma non misera famiglia, e fin da giovane si fa notare per essere uni scavezzacollo, propenso a delinquere per autentica vocazione. Sposa a Roma nel 1768 Lorenza Serafina Feliciani, analfabeta a differenza del marito che ha un’infarinatura culturale per alcuni anni di studi nell’Istituto San Rocco per gli orfani, e poi nel convento dei Fatebenefratelli di Caltagirone, dove era stato forzatamente rinchiuso onde cercare di raddrizzare quella sua indole ribelle e da sfaticato. La coppia avvierà una vita errabonda, sostando poco in ogni località, proprio perché lui campa di espedienti truffaldini, così che è costretto a spostarsi di sovente, il che non impedisce che di tanto in tanto venga rinchiuso in qualche carcere. Pur innamorato della moglie, la utilizza spesso per i suoi scopi, prostituendola, circostanza che alla signora non riesce difficile, visto che è per indole di facili costumi. I due viaggiano in Italia e all’estero ed è qui che approdano in Inghilterra, ove lui si ingegna a campare con le sue truffe; scoperto, finisce in galera per insolvenza, ma in forza delle grazie della moglie riesce a uscire. Poi, nuovi viaggi sul continente, e infine il ritorno a Londra nel 1776, un anno che è fondamentale, perché avviene qualcosa di sorprendente in Giuseppe Balsamo, che si trasforma da mariuolo di bassa levatura in un autentico incredibile personaggio. Cosa accadde di tanto importante? Il 12 aprile 1776 Giuseppe è iniziato alla massoneria, diventando in breve, da semplice adepto, maestro e poi gran maestro, capace di un proselitismo senza precedenti e talmente compenetrato nella nuova posizione da creare una nuova loggia, con rito egizio. Alla massoneria, si sa, aderiscono uomini e donne importanti, gente che conta, quasi sempre molto danarosa, insomma il terreno di caccia ideale per un truffatore come lui, che per far dimenticare le sue origini, prende il cognome di alcuni parenti, Cagliostro, assume anche un nuovo nome e dato che un titolo costituisce sempre una buona presentazione, diventa conte, per la precisione il conte Alessandro Cagliostro. Grazie ai confratelli può muoversi in tutte le corti europee e stupisce con i suoi prodigi di guaritore, di alchimista e di vaticinatore. C’è bisogno di denaro? Semplice, basta rivolgersi a Cagliostro, farsi dare un numero della lotteria e questo immancabilmente esce; si soffre di un malanno che nessun medico è ancora riuscito a guarire? Su va da Cagliostro e il corpo torna sano. La pietra dell’anello di fidanzamento sembra troppo piccola? Ci si rivolge a Cagliostro e il diamante o lo zaffiro aumentano di caratura. Pare incredibile che nel secolo dei lumi ci sia così tanta gente che crede a queste cose, e non si tratta solo del popolino, ma anche di nobili di alto lignaggio, come il cardinale di Rohan, che diventerà suo amico e che, involontariamente, lo trascinerà nella famosa truffa della collana della regina, da cui Cagliostro uscirà sì assolto, ma ormai irrimediabilmente compromesso. Infatti, se l’esito del processo gli è favorevole, il suo prestigio viene spezzato e gli amici massoni prendono le distanze da lui, togliendo in pratica l’indispensabile appoggio. Tornato a Roma con la moglie é imprigionato dal Sant’Uffizio e condannato, oltre che per truffa, per eresia e finirà la sua vita in un’orrida cella nel carcere di San Leo. Ci si chiede ora come abbia potuto trasformarsi il mariuolo Giuseppe Balsamo nel famoso e anche letterato conte Alessandro Cagliostro, un uomo che aveva l’immenso potere di suggestionare. Secondo Gervaso, anni prima aveva contratto in Spagna la lue; nel periodo di incubazione della malattia (circa 10 anni) la spirocheta, agente dell’infezione, aveva irritato le sue cellule cerebrali, esaltandogli le facoltà psichiche e stimolando la creatività come una vera e propria droga, dall’effetto sorprendente e non temporaneo. Il decorso del morbo, poi, la sua manifestazione avevano fatto sì che le cellule del cervello piano piano morissero, così che il Cagliostro che tornò a Roma era un uomo in cui la demenza stava prendendo il sopravvento. Ci si chiede anche perché lo Stato della Chiesa ce l’avesse così a morte con lui e questo atteggiamento trova una spiegazione nel timore del papato di un avvento rivoluzionario, come stava accadendo in Francia, un moto che si diceva propugnato dalla massoneria. Il colpire lui che era così famoso significava impedire una possibile rivolta a Roma, costituendo un monito a chiunque desiderasse cambiare lo status quo. C’è dell’altro, però; la loggia da lui fondata con rito egizio era impregnata di misticismo, pur non essendo atea, ma divenendo così un pericoloso concorrente della Chiesa cattolica. Resta la domanda se Giuseppe Balsamo e Andrea Cagliostro fossero la stessa persona. Il Cagliostro giudicato dall’Inquisizione, anche grazie alla testimonianza della moglie, risultava sposato in modo inoppugnabile con Lorenza Serafina Feliciani; inoltre, la somiglianza fra l’uno e l’altro era sorprendente. Quindi, è più che logico concludere che per quanto così uguali e così diversi fossero un’unica persona. Il libro di Gervaso è molto bello e appassionante; corredato dall’indicazione delle fonti e da una cronologia cagliostrana, si fa apprezzare per lo stile fluido e non accademico, per la capacità di ricreare un’epoca (notevole il suo capitolo sullo Stato della Chiesa, il più assolutista e il più arretrato sul finire del XVIII secolo), per i chiarimenti indispensabili, come il capitolo sulla Massoneria, spiegata in modo semplice, ma esauriente, per quella vena di ironia che traspare in occasione dei miracoli di Cagliostro, ma anche per un sottofondo di pietà per l’uomo che langue e muore in una fetida cella. Da leggere, senz’altro.
Roberto Gervaso è
nato a Roma il 9 luglio 1937.
14/10/2015
Ladro di sabbia
Prefazione di Narda Fattori
Fara Editore Poesia L’amore L’amore è uno dei temi che più frequentemente si possono incontrare in poesia, proprio perché è un sentimento comune a tutti gli uomini. Inoltre presenta il vantaggio di avere diversi aspetti, ognuno corrispondente a una vicenda vissuta. E quando si parla di poesie d’amore la mente corre subito al più grande autore di versi che svolgono questo tema, a quel Nazim Hikmet che ci ha lasciato splendide liriche, in cui passione, ardore, malinconia e dolore si fondono mirabilmente. Ora, per quanto non sia proponibile un paragone fra il grande poeta turco e Laura Pecoraro, autrice di Ladro di sabbia, tuttavia è sempre bello leggere dei versi in cui questo comune sentimento sembra sgorgare senza freni e paraventi, ora ruscello d’acque limpide e tranquille, ora torrente impetuoso che trascina e quasi travolge. Nelle poesie di questa silloge trova ancora una volta conferma che l’amore può essere gioia, ma anche dolore, può essere il motore di una vita, foriero di nuove scoperte, ma anche può diventare una lunga agonia interiore. Quello che nasce è straripante, è un’emozione da cui è piacevole lasciarsi avviluppare; quello che muore è una tristezza intensa che accompagna giorni del più scuro grigiore anche se in cielo brilla il sole. Forse di tutti i sentimenti e le emozioni l’amore è il più sincero e ciò che si prova non viene espresso attraverso il filtro del pudore, ma è gridato, non sussurrato, è uno squarcio dell’animo che impietosamente si mostra agli occhi di tutti, ed è così che queste liriche appaiono, a volte liete, più spesso dubbiose, ancora in altre occasioni dolorose, e comunque sempre gridate, come se a lasciar fluire liberamente ciò che si prova finisse con il diventare una certezza di uno stato in cui dapprima inconsapevolmente siamo entrati. Ma è anche uno sfogo, è il desiderio di scaricare quella tensione che è dentro e che nel frastuono espressivo viene attenuata. Eh sì, l’amore è un sentimento che non ha vie di mezzo, è l’inconsapevole fardello che istintivamente ci portiamo appresso e qualunque sia il peso, si tratti di gioia o di dolore, in fin dei conti non vogliamo liberarcene, perché sappiamo di quanto la vita potrebbe essere vuota se non ci fosse. Laura Pecoraro non è da meno, il suo stile fluido dà meglio l’impressione di quel ruscello o di quel torrente di cui parlavo e finisce con lo specchiarsi in una realtà che da soggettiva diventa oggettiva, perché non c’è nessuno che in questo campo non abbia provato, in misura minore o maggiore, le stesse pene. Da leggere, ci mancherebbe altro.
Laura Pecoraro (1980)
nasce a Nocera Inferiore (SA)
e cresce a Campobasso in Molise. Attualmente risiede a Rimini. È
docente di scuola primaria e svolge attività di libero professionista
in qualità di Pedagogista clinico. È referente regionale P.Ed.I.As.
– Pedagogisti e Educatori Italiani Associati per l’Emilia Romagna. Ha
pubblicato la raccolta di poesie e racconti brevi Frammenti
di Sterlizia (Fump Edizioni, 2014). È presente nell’antologia
poetica Tra un fiore colto e l’altro donato (Aletti Editore,
2015) con la poesia Bocciolo. Ha prefato i libri La cura
del sogno ( 2013) e Pietre, rose e altri versi(2013) del
poeta molisano Sergio Marchetta (Regia Edizioni).
10/10/2015
Un sicario alla corte dei Gonzaga di Tiziana Silvestrin
Scrittura & Scritture Edizioni
Narrativa romanzo giallo Un trittico riuscito E così, dopo aver letto I leoni d’Europa e Le righe nere della vendetta, mi sono dedicato all’ultimo dei tre romanzi fino ad ora pubblicati, Un sicario alla corte dei Gonzaga, stesso protagonista il capitano di giustizia Biagio Dell’Orso, medesima epoca (il XVI secolo) e identica ambientazione nella Mantova ducale di quello che fu probabilmente il più famoso della dinastia, Vincenzo. L’intreccio giallo non fa una piega, con un misterioso sicario che attenta più volte alla vita del duca, sempre scampato miracolosamente, ma in vece sua sono perite altre persone. L’indagine si presenta particolarmente difficile, perché mancano sia l’identità dell’assassino, sia quella del mandante e di conseguenza Biagio Dell’Orso annaspa nel buio, anche perché il sicario, se fallisce nel suo incarico, non lascia altre tracce, se non il veleno a cui è ricorso e, in un’occasione, la prima, quando perde, nello scassinare una porta, uno zaffiro che, insieme ad altre pietre grezze, tempestava l’elsa di un pugnale utilizzato nell’occasione come un grimaldello. Se la caccia allo sconosciuto assassino si presenta di estrema difficoltà, ancor più arduo è determinare il mandante, perché, come tutti i signori dell’epoca, il duca Vincenzo ha più di un nemico. Che siano i Turchi contro i quali si appresta a battersi in Ungheria a difesa della Cristianità, e soprattutto dell’Impero? Che si tratti di Ferruccio Farnese, la cui sorella è rinchiusa in un convento a Parma dopo l’annullamento del matrimonio con Vincenzo, per l’impossibilità di lei di poter congiungersi con il marito e quindi di procreare? Che c’entrino i Medici e soprattutto Bianca Capello, cortigiana veneziana, poi amante di Cosimo e infine diventata sua moglie, sul conto della quale i Gonzaga avevano non poco spettegolato? Insomma, di possibili interessati alla morte del Duca ce ne sono diversi, ognuno dei quali per ragioni le più disparate. Come venirne a capo? Non intendo svelare altro, perché la trama avvincente e incalzante di questo giallo storico, che vede di volta in volta la sua ambientazione a Mantova, a Parma, a Venezia, a Praga e a Vienna è una di quelle che invitano a scorrere velocemente le pagine, ansiosi di arrivare alla soluzione, che puntuale troviamo alla fine, logica in tutti i suoi aspetti. Certo c’è il rischio che, a lasciarsi prendere dalla smania di sapere chi siano il colpevole e il mandante, non ci si soffermi sullo stile fluido dell’autrice, sulle descrizioni essenziali e in funzione dello scopo, su aspetti che possono apparire secondari, ma che contribuiscono non poco alla gradevolezza dell’opera. Mi riferisco ai colloqui, mai banali, fra il consigliere ducale Marcello Donati e Biagio dell’Orso, alla storia d’amore fra quest’ultimo e la bella veneziana Rosa, che ci si augura di vedere finalmente sotto lo stesso tetto non saltuariamente, all’atmosfera della piccola città cinta dai laghi che quasi miracolosamente si svela ai nostri occhi negli scorci più suggestivi, nella variopinta folla che ogni giorno vi vive. Tiziana Silvestrin è veramente brava e sono certo che meriterebbe un consenso assai superiore a quello attuale, peraltro non marginale. Mi chiedo se stia procedendo a scriverne un quarto; è un sospetto e una speranza, visto che il libro si chiude con una frase che Donati dice a Dell’Orso: “C’è qualcosa che devi vedere, qualcosa …di spaventoso.”. Insomma, per quanto ovvio, anche il lettore brama vedere cosa ci sia di così spaventoso, una frase che se non è una certezza di un seguito, lascia però ben sperare. Al riguardo, e la notizia è recentissima, Tiziana Silvestrin mi ha confermato che fra non molto uscirà un quarto romanzo, con il bravo capitano di giustizia impegnato in un’altra difficile indagine.
Nell’attesa, la lettura di Un
sicario alla corte dei Gonzaga è più che consigliata, anzi è
vivamente raccomandata.
Tiziana Silvestrin
ha
scritto i seguenti romanzi, tutti pubblicati da Scrittura & Scritture
Edizioni: I leoni d’Europa (2009), Le righe nere della vendetta
(2011), Un sicario alla corte dei Gonzaga (2014).
6/10/2015
Le
guerre del Duce
Edizioni Mondadori L’uomo della (im)provvidenza È fuor di dubbio che l’assoluto protagonista del famoso ventennio, e cioè Benito Mussolini, sia personaggio meritevole di attenti studi e di ricerche storiche, se non altro per il fatto che nella nostra ancora giovane Italia mai c’era stato (e la speranza è che non ne vengano altri) un personaggio dalle così marcate caratteristiche da costituire quasi un unicum, nel bene e soprattutto nel male. Così di pubblicazioni su di lui e sul fascismo ce ne sono a bizzeffe, tanto che è il caso ormai di dire che si è arrivati a conoscere pressoché quasi tutto. Questo saggio del noto storico Denis Mack Smith si limita, e si fa per dire, alle guerre intraprese da Mussolini, che per natura, egocentrico come era, fu un guerrafondaio, pur di tanto in tanto atteggiandosi a pacifista. Nel dire che Mussolini fu il fascismo e il fascismo fu Mussolini si delinea apertamente la caratura e le vesti di quest’uomo, alla continua ricerca di un appagamento personale che non riusciva mai a raggiungere. Di certo non aveva le idee chiare: prima socialista e anti interventista, di colpo sostenne l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 e poi fu lesto a cavalcare il malcontento popolare della cosiddetta vittoria mutilata e della effervescenza prerivoluzionaria del dopoguerra per impadronirsi del potere e diventare, di fatto, dal 1925 il padrone assoluto del paese. Occorre riconoscergli una grande capacità, derivante dall’esperienza quale direttore del quotidiano socialista L’Avanti, vale a dire l’abilità, non comune, di fare propaganda, facendo passare per vere notizie false e per false quelle vere. Non è che l’Italia, grazie alla sua presenza al governo, avesse migliorato la sua condizione economica e sociale, ma, in forza della dittatura e delle sue invenzioni, vere e proprie menzogne, se il popolo non aveva di che rallegrarsi del modesto reddito e della diffusa disoccupazione, però poteva almeno sperare in un miglioramento della situazione. Veniva detto che l’Italia era un paese egemone, ben organizzato, con i treni puntuali, la gente fiera e orgogliosa di discendere dagli antichi romani, tutte menzogne che avevano un certo successo in una plebe indottrinata già a scuola e in un mondo di fatto chiuso all’esterno. Un altro millantato punto di forza era l’onestà dei gerarchi fascisti, ma non rispondeva a verità, poiché questi erano dei macroscopici corrotti e Mussolini lasciava fare, ma tramite la polizia segreta si documentava sulle malefatte onde renderli ricattabili. Come è possibile comprendere al fascismo e al suo capo nulla importava degli italiani, se non la loro sottomissione ottenuta con un’abile propaganda. Mussolini diventò così un mito, alimentato da lui stesso, con promesse roboanti, puntualmente disattese, tanto che è possibile dire che, al contrario di quanto proclamato, non era il fascismo al servizio degli italiani, bensì erano questi che con il tacito consenso potevano mantenere in vita questo grottesco teatrino. A forza di raccontar menzogne, purtroppo, il duce finì con ritenerle verità e qui iniziò una parabola discendente - che ci sarebbe stata in ogni caso, perché la situazione economica, già non soddisfacente, andava peggiorando - che condusse il dittatore a un delirio di onnipotenza tale da fargli credere che sarebbero state sufficienti solo le sue minacce di espansione per ottenere nuovi territori. In ciò si sentì confortato dai successi della guerra d’Etiopia, di quella di Spagna e di quella d’Albania, vittorie osannate come gigantesche e che invece si ottennero per il rotto della cuffia ed evidenziarono la grave impreparazione militare del nostro esercito, carente di mezzi e di uomini addestrati. Per avere ragione degli Etiopici si dovette ricorrere ai bombardamenti aerei indiscriminati e all’uso dei gas asfissianti, metodi entrambi caldeggiati da Mussolini, con un comportamento criminale che fu sempre una sua caratteristica; nel caso della guerra civile spagnola, i volontari fascisti (camicie nere e migliaia di disoccupati arruolatisi per sfuggire alla fame) furono clamorosamente battuti da un esercito irregolare a Guadalajara, il che convinse Mussolini a impegnarsi ulteriormente con uomini e armi, dissanguando di fatto le riserve valutarie nazionali; per l’Albania ci fu un’invasione da operetta senza spargimento di sangue, giacchè gli albanesi non avevano un esercito. Secondo lo stile propagandistico fascista queste furono considerate vittorie superiori a quelle conseguite dai più grandi generali della storia e il merito era da attribuirsi solo e unicamente al Duce. Il bello è che Mussolini credette davvero di essere un condottiero, tanto che, oltre ad accentrare presso di sé il ministero degli esteri, si prese anche quello della Guerra e quello dell’Aeronautica. In questi campi basilari era niente di più di un dilettante e quel che è peggio, a parte la politica estera fatta di un tira e molla che lo screditò non solo di fronte agli inglesi e francesi, ma anche ai tedeschi, ben consapevole delle difficoltà delle nostre Armi non fece nulla per avviare una razionale politica produttiva di ordine bellico, pur vantando di continuo l’inizio di una grande guerra, con cui il nostro paese avrebbe avuto il dominio assoluto del Mediterraneo e l’espansione verso est nei Balcani. Si potrebbe dire che giocava d’azzardo, ma, purtroppo, non aveva l’asso nella manica, anzi aveva l’Asse, il trattato di reciproco aiuto con la Germania nazista che arrivò a sottoscrivere senza leggerlo con dovuta attenzione e solo in seguito si accorse delle clausole capestro che conteneva. In continua altalena fra scendere in campo con i tedeschi, o restare neutrale, oppure addirittura affiancarsi agli inglesi e francesi, ma desideroso di nuovo bottino da spartire al tavolo della pace grazie a qualche migliaio di morti, finì per credere nella guerra e nella vittoria lampo del Reich, attaccando la Francia che aveva già chiesto l’armistizio (un comportamento da autentico vigliacco) e buon per lui che l’atto di cessazione delle ostilità fu firmato alla svelta, perché altrimenti il nostro esercito avrebbe subito una catastrofica batosta sulle Alpi. Non pago di questo, pensò bene di attaccare la Grecia, che aveva un modestissimo esercito; dovettero intervenire i tedeschi per scongiurare la disfatta, così come le truppe del Reich accorsero alla svelta in Libia dove solo 30.000 soldati inglesi travolsero la nostra armata che contava effettivi cinque volte superiori. In un crescendo wagneriano impegnò truppe in Russia, con gli esiti che sappiamo, e nei Balcani dove si operò un’attività di polizia (e di pulizia etnica) con gravi atrocità (al riguardo, la mortalità nei campi di concentramento italiani era in linea con quelli nazisti di Dachau e Bergen-Belsen). Poi fu tutto un precipitare, con la fine che si meritava, del resto secondo una frase che aveva coniato e di cui andava fiero: se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. A conti fatti di lui si può ricordare – ammesso di considerarla una caratteristica positiva – l’abilità nel creare il suo mito, di cui poi divenne succube; per il resto era un incapace, cattivo e crudele, che amava circondarsi solo di uomini mediocri perché questi gli davano sempre ragione. In concreto era una mente gravemente disturbata, uno che si sopravvalutava, perennemente alla ricerca di qualcosa che lo vedesse protagonista. Dell’Italia e degli italiani non gli importava un fico secco e l’atto forse peggiore della sua vita fu quello di accettate la guida della Repubblica fantoccio di Salò, evento che determinò l’inizio di una sanguinosa guerra civile. Quindi aveva ragione Churchill quando diceva che era meglio avere l’Italia come nemico piuttosto che come alleato, e infatti fu una palla al piede per la Germania. La capacità di Denis Mack Smith di parlare di tutto questo in modo semplice e avvincente è veramente fuor del comune; il libro non stanca mai e vi si respira, pur da ex nemico, un invidiabile spirito di imparzialità. Le successioni degli eventi sono scandite senza intoppi e posso dire che si ha una concreta visione delle guerre del duce e non solo, perché quel che più conta, l’analisi psicologica di Mussolini è veramente approfondita. Non mancano poi pagine zeppe delle indispensabili fonti, così che questo è un saggio di primaria importanza, uno di quei volumi che non dovrebbero mai mancare nelle biblioteche personali e scolastiche, onde, comprendendo il passato, evitare il suo ripetersi in futuro.
Denis Mack Smith
(Londra, 3 marzo 1920) è lo storico inglese più noto nel nostro Paese
e ha scritto libri relativi alla storia italiana dal risorgimento in
poi.
2/10/2015
Saro (Rosario)
Commento di Cinzia
Baldazzi
Solo brevi domande
esiliate
Prefazione di Pierino
Gallo testo albanese a fronte
Fara Editore
Poesia
Poesia d’oltremare L’Albania è certamente un piccolo stato, sia come superficie che come popolazione (rispettivamente circa 29.000 Kmq. e 2.900.000 abitanti ); eppure questa terra a noi vicina, che si potrebbe definire al di là del mare, certamente non sviluppata economicamente come noi, è una fucina culturale, come testimoniato dai non pochi narratori le cui opere sono pubblicate anche nel nostro paese. Non mancano i poeti e Griselda Doka è una di questi, con due sillogi già pubblicate: Soglie, per i tipi di Aletti, e appunto Solo brevi domande esiliate, edita da Fara di Rimini, che è un punto di riferimento per gli autori di poesia. Nello scorrere i versi delle liriche che compongono questa raccolta ho avvertito, chiara, l’emozione di riproporre il proprio passato, quello vissuto in una terra dissimile della nostra, per quanto così vicina, separata come è da un braccio di mare. C’è una vena di nostalgia del tutto naturale in un immigrato, benchè il trascorso risenta di una vita influenzata dalla dittatura di quello che era un regime comunista, una sorta di avamposto dell’ortodossia sovietica nell’Adriatico, ma non proteso a occidente, bensì rinchiuso su se stesso. L’albanese è un popolo anche in passato segregato nei suoi ristretti confini, ma sempre fiero della sua identità, soggetto spesso ad altri, ma corposamente ostile a omologarsi a civiltà diverse, insomma un mondo a sé stante che rivive in questi versi, che aprono squarci su realtà che ci sembrano così lontane pur essendo così vicine. C’è forza, c’è fierezza, c’è la certezza che indipendentemente da quel che sarà la storia gli schipetari sempre esisteranno. Non sono mai stato in Albania, conosco alcuni immigrati, ma credo che questa silloge, pur nell’ individualità dell’autore, possa aiutare non poco a conoscere questa gente, che per un breve periodo fu unita al regno d’Italia, dopo essere stato più a lungo territorio d’influenza del nostro paese. Certo si nota che in questo processo di comunicazione a volte la prolissità non manca, come pure lo stile avrebbe necessità di essere affinato, anche se è giusto tener conto dell’età dell’autrice che giustifica una certa acerbità letteraria. Tuttavia, i sentimenti, le emozioni che risaltano nei versi testimoniano una volta di più la grande capacità della poesia, che è anche quella di avvicinare mondi diversi, con lingue differenti, sì da giungere a un unico linguaggio, che non ha bisogno di interpretazione: quello del cuore. E questo, credetemi non è certo poco, in un’epoca in cui spesso si assiste invece a un frequente arzigogolare che tende il lettore ad allontanarsi, anziché ad avvicinarsi alla poesia. Da leggere, ovviamente.
Griselda Doka è nata a Tërpan, Berat (Albania).
È attualmente dottoranda in Studi letterari, linguistici, filologici
e traduttologici presso l’Università degli
28/9/2015
Comprare il sole Edizioni Einaudi Narrativa romanzo Come vivere infelici e scontenti È da poco che Sebastiano Vassalli ci ha lasciato, proprio nell’anno in cui risultava candidato al Nobel per la letteratura, premio di cui era sicuramente meritevole, per quella sua scrittura fluida capace, con straordinaria leggerezza, ma anche con grande efficacia, di mostrarci le storture della società, le incongruenze di un mondo che cerca la felicità al di fuori di quello che è l’uomo, in una costante mortificazione dei sensi che porta invece a una continua e sempre più grave scontentezza. E così anche Comprare il sole rientra in questa tematica, questa volta però svolta sotto forma di favola, una favola impietosa, senza lieto fine, corrosiva nel suo significato, soprattutto se chi legge ogni tanto fa una pausa per una riflessione sulla sua esistenza e sulla società di cui è parte, la società dei consumi, in funzione della quale è continua la ricerca del denaro per acquistare sempre nuovi oggetti, sovente del tutto inutili, ma che dovrebbero assicurare quella felicità a cui si tende e che invece di avvicinarsi, si allontana sempre di più. La vicenda di Nadia Motta, ragazza senza arte né parte, con madre femminista e due amanti (uno babbeo e uno intelligente), è emblematica di questa situazione; come tanti esseri umani vive senza un ideale e l’unica cosa che conta è il denaro per acquistare tutto ciò che si desidera; per un colpo di fortuna vince la stratosferica somma di 21.600.000 Euro al super-lotto e invece di aprirsi un nuovo periodo di apparente felicità prende avvio un autentico calvario. Come non far sapere agli altri della vincita, come incassare la somma in tutta sicurezza, come sfuggire al fisco e ad eventuali malintenzionati, come investire, restando anonimi, questa ricchezza, sono tutti quesiti che frullano immediatamente nella testa di Nadia e che la assillano in una crescente tensione. La felicità del primo momento, alla notizia della vincita, diventa un lontano ricordo, cacciata da tante preoccupazioni, non ultima quella di essere consapevoli di vivere in un mondo in cui tutto è regolato dal denaro e poiché si vive in funzione di esso fa gola a molti e così non pochi cercano di accaparrarlo anche con metodi illeciti. Nadia Motta così precipita in breve dal paradiso all’inferno, ma non aggiungo altro, perché lascio al lettore il piacere di lasciarsi avvincere dalla trama, dalla scrittura semplice e immediata, e infine a fare le dovute riflessioni stimolate da questo romanzo che, se non è uno dei capolavori dell’autore, è pur sempre di eccellente livello e quindi più che meritevole di attenzione.
Sebastiano Vassalli è
nato a Genova nel 1941 ed è morto a Casale Monferrato nel 2015.
Presso Einaudi, dopo le prime prove sperimentali, ha pubblicato La
notte della cometa, Sangue
e suolo, L'alcova
elettrica, L'oro
del mondo, La
chimera, Marco e
Mattio, Il
Cigno, 3012,Cuore
di pietra, Un
infinito numero, Archeologia
del presente, Dux,Stella
avvelenata, Amore
lontano, La morte
di Marx e altri racconti,L'Italiano, Dio
il Diavolo e la Mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, Le
due chiese e Comprare
il sole.
25/9/2015
La
guerra dei nostri nonni. di Aldo Cazzullo
Edizioni Mondadori Poveri nonni! Sto seguendo sul quotidiano locale una rubrica intitolata “I diari raccontano della Grande Guerra”. È una lettura molto interessante anche se non ci sono commenti o approfondimenti, ma solo le pagine dei diari o le lettere inviate a casa dai nostri soldati. Si tratta di piccole storie, di drammi individuali, ma proprio per questo riescono a dare un’idea di quel che esattamente fu per i nostri nonni la Grande Guerra. Appreso che Aldo Cazzullo aveva scritto un libro non relativo ai grandi nomi di quel conflitto, ma a chi, a casa o al fronte, era impegnato ogni giorno a vivere e a combattere questa guerra ho deciso pertanto di procurarmelo con rapidità, perché la storia, vista dal basso, dalla moltitudine degli esseri umani ha una sua particolare valenza, svelando sentimenti autentici e mai intrisi di retorica. Purtroppo l’autore, nonostante l’abbondanza del materiale a disposizione, non è riuscito a trasmettere a chi legge le sensazioni, le emozioni e anche gli aneliti di chi, in battaglia o sul fronte interno, fu impegnato in quel sanguinoso conflitto. I motivi sono più d’uno: l’impostazione dell’opera, senza idee ben precise sul messaggio che con essa si voleva comunicare; il taglio giornalistico della scrittura, imputabile anche al fatto che Cazzullo è inviato ed editorialista del Corriere della Sera; il tono, che non è mai in linea con ciò che si sta scrivendo, nel senso che è distaccato quando l’autore dovrebbe essere partecipe ed è invece enfatico quando invece occorrerebbe la logica freddezza di un necessario approfondimento; ed è proprio nell’approfondimento che è carente, nel senso che manca questa caratteristica indispensabile per definire saggio storico il libro, che invece finisce con il trascinarsi in notizie, peraltro già ben note. Forse il desiderio di raccontare tutto è andato a discapito della qualità, ma questa è una colpa dell’autore che doveva senz’altro parlare della Grande Guerra nell’ottica degli umili soldati che l’hanno combattuta, ma poi questo obiettivo si deve essere perso per strada, fra tanti capitoli di argomenti diversi, che non hanno neppure un filo logico che li unisca. Ne risulta una sorta di minestrone, che se non è indigesto, però risulta anche senza sapore, al punto che dopo aver letto mi sono pentito di essermelo procurato. Dulcis in fundo le fonti non vengono citate ed è logico in un libro che non dice nulla di più di quanto già sapessimo, scritto per onorare la memoria dei nostri nonni che, però, se fossero ancora vivi, avrebbero non poco da risentirsi. Per quanto ovvio, non mi sento di consigliarne la lettura.
Aldo Cazzullo (Alba
1966), dopo quindici anni a «La Stampa», dal 2003 è inviato e
editorialista del «Corriere della Sera». Tra i suoi libri pubblicati
da Mondadori ricordiamo: I
ragazzi di via Po (1997,
2013), Testamento
di un anticomunista (con
Edgardo Sogno, 2000, Sperling & Kupfer 2010), Outlet
Italia (2007).
Nel 2011 ha pubblicato il romanzo La
mia anima è ovunque tu sia, tradotto all'estero. Sia Viva
l'Italia! (2010)
sia Basta
piangere!(2013) hanno superato le centomila copie; La
guerra dei nostri nonni (2014)
le duecentomila.
23/9/2015
La casa
sul canale
Edizioni Adelphi
Narrativa romanzo L’elemento destabilizzante Edmée, già orfana della madre, alla morte del padre si trasferisce nella regione del Limburgo, ospite della zia in una grande tenuta agricola, una terra bassa, coltivata a pioppeti e a erba da fieno. Vi giunge che è appena deceduto, all’improvviso, lo zio e quindi rivive il lutto, qui più marcato e stretto, proprio di una società rurale, immobile nel tempo, ligia a rituali monotoni e ossessivi, cupa e patriarcale. Sembra che lì la gioia e la vita siano bandite, in un grigiore quotidiano a cui non poco contribuisce il tempo atmosferico, dai rari cieli azzurri e dagli infiniti giorni di pioggia e di umidità, di neve e di gelo. Per Edmée è una sistemazione scioccante, lei che è un tipo esile e abituata alla vita della città, lei che è poco più di una ragazzina che è solo da poco che comincia a scoprire la sua femminilità. Nella nuova famiglia, oltre ad alcune cuginette, ci sono anche due maschi, il bel tenebroso Fred e lo zotico Jeff; Edmée, che ha una personalità contorta e sovente contrapposta, sperimenterà su di loro le sue sottili doti ammaliatrici ed è inutile che dica che l’effetto sarà devastante. Non voglio aggiungere altro, ma mi preme evidenziare come ancora una volta l’abilità di Simenon di sondare l’animo sia del tutto inarrivabile; scava, scava dentro con poche precise parole, mette a nudo i più reconditi recessi e i personaggi finiscono con il mostrarsi come in effetti sono, cioè diversi da quello che le consuetudini del vivere civile hanno omologato. Le personalità si presentano così contorte, viene in superficie quella bestialità che è in tutti noi ed Edmée sa bene come irretire i due fratelli, dando l’impressione di concedersi, per poi subito ritrarsi. Tuttavia, in quell’atmosfera quasi gotica in cui il grigio scuro sembra il colore predominante e dove il tempo scorre sempre uguale, lei è un elemento nuovo, quello destabilizzante, che il sistema non riesce a respingere perché in fondo lei ha saputo cogliere la debolezza dello stesso. E più i giorni passano, più appare probabile che possa esserci un’implosione, che quella giovane ragazza, il cui destino peraltro è segnato dalla tubercolosi da cui è affetta, è un veleno che lento corrode, che quello che sembra un gioco d’amore è in effetti un torbido tentativo di distruzione. Tutti i colori sono smorti in questo romanzo, come smorti sono i protagonisti che si lasciano condurre docilmente lungo la parabola segnata dal destino; non c’è mai un tentativo di ribellione e su tutto predomina la piena sottomissione alle leggi di natura. La casa sul canale è uno dei tanti capolavori di Georges Simenon.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
18/9/2015
La
storia manipolata Traduzione di M. Chiaroni Editori Laterza Saggistica storica La verità storica Non è facile fare lo storico, perché il suo obiettivo è di raccontare ciò che è effettivamente avvenuto e per far questo deve trovare il maggior numero possibile di fonti - valutando di volta se hanno scritto il vero -, nonché atti e documenti ufficiali pertinenti, ma anche in questo caso avendo la capacità e la pazienza certosina per discernere i falsi e gli autentici, e per questi ultimi verificare il loro grado di attendibilità. Da che mondo è mondo gli uomini, per diversi motivi, hanno cercato di manipolare la storia, capi di stato hanno costruito prove altrimenti inesistenti, hanno taciuto su elementi probanti o addirittura li hanno cancellati. Questo breve saggio di Denis Mack Smith ci parla di questa contraffazione, limitata solo all’Italia e per il periodo che va dal Risorgimento in avanti, di cui lo storico inglese è notoriamente assai competente. Su Cavour, su Giolitti, su Vittorio Emanuele III, su Mussolini e perfino su certi nostri politici ancora sulla cresta dell’onda è sceso implacabile lo sguardo dell’autore, dimostrando tante falsità considerate invece verità e mettendo in luce verità da sempre indicate come falsità. E non è solo questione di ragion di stato, ma molti vollero creare una storia parallela, opportunamente roboante, in contrapposizione a una realtà spesso meschina o addirittura tragica. Qualcuno potrà obiettare che era logico attendersi questo saggio dissacrante da un inglese, visto che i figli di Albione hanno sempre mostrato un tono di sprezzante sufficienza nei confronti degli italiani, ma in questo caso ci si sbaglia. Smith é uno dei più grandi storici del nostro risorgimento e non si può certo pensare che questa sua opera sia frutto di preconcetti, anche perché è facile dimostrare che se la manipolazione della storia colpisce ogni paese, pur tuttavia nel caso del nostro è una costante assidua, come se dovesse esistere una storia per il popolo e un’altra per pochi eletti. Il pensare che a scuola si studiano le vicende del nostro paese e che queste spesso sono inficiate da omissioni, da modifiche o addirittura da invenzioni mi fa sinceramente paura, perché questo significa che sì il popolo deve sapere, ma solo quello che torna di vantaggio a chi comanda e nelle forme e verità da lui imposte. Sono convinto, pertanto, che la lettura, peraltro gradevole, di questo saggio non sia solo doverosa, ma addirittura indispensabile.
Denis Mack Smith (Londra, 3
marzo 1920) è lo storico inglese più noto nel nostro Paese e ha
scritto libri relativi alla storia italiana dal risorgimento in poi.
12/9/2015
I leoni d’Europa
Scrittura & Scritture Edizioni Narrativa romanzo giallo
Uno stupendo affresco rinascimentale Ora da questo fatto vero la Silvestrin imbastisce una trama in cui non mancano abili spie, avventurieri, papisti e antipapisti, con la scena che si sposta da Mantova a Venezia, per poi ritornare a Mantova, per approdare poi a Milano e infine in Inghilterra dove può serpeggiare da un momento all’atro una guerra di religione fra cattolici e protestanti, ma che è soprattutto una guerra di potere fra la regina Elisabetta e Maria Stuarda, che poi si concluse con l’affermazione della prima e la decapitazione della seconda. La vicenda, con tanta carne al fuoco, è complicata, ma l’abilità della narratrice fa si che esista un perfetto percorso logico, a cui si è attenuta, così che la soluzione del caso è del tutto plausibile, senza dimenticare che il lettore non rischia di perdersi fra tanti nomi e fatti, trovando perfettamente inserite vicende non contestuali, ma di anni precedenti. E’ un piacere veder scorrere davanti agli occhi la fabbrica del Duomo di Milano, il porto di Londra sul Tamigi, la Venezia opulenta e quella misera, la piccola, ma preziosa Mantova; nulla è lasciato al caso, non c’è né una parola di troppo, né una parola che manca in questo stupendo affresco rinascimentale, la cui lettura risulta notevolmente piacevole.
Tiziana Silvestrin
ha scritto i seguenti romanzi, tutti pubblicati da Scrittura &
Scritture Edizioni: I leoni d’Europa (2009), Le righe nere della
vendetta (2011), Un sicario alla corte dei Gonzaga (2014).
9/9/2015
Lepanto
Editori Laterza Saggistica storica
Esauriente e piacevole Alla notizia dello sbarco degli ottomani a Cipro Venezia non poteva restare inerte, come disinteressati non potevano essere agli stati del Mediterraneo, perché era evidente che la minaccia di essere conquistati si rafforzava ogni giorno di più, così si ideò una spedizione con navi veneziane, del re di Spagna, dello Stato Pontificio al fine di contrastare questo tentativo di impadronirsi del Mediterraneo e con esso dei suoi traffici. Ma fra disaccordi di gestione sull’azione da intraprendere, picche e ripicche non si arrivò a uno scontro con la grande flotta ottomana. Era il 1570 e il naviglio ritornò ai propri porti, tentando, almeno la Serenissima, di arrivare a un accordo di pace con il Sultano. Le intenzioni di questo, tuttavia, come del resto di alcuni alleati, erano ben altre e così, dopo non poche difficili trattative, si arrivò nel 1571 a costituire, sotto l’egida di Papa Pio V, una Lega Santa a cui parteciparono il Granducato di Toscana, il Ducato di Savoia, i Cavalieri di Malta, la Repubblica di Genova, lo stato pontificio, l’impero spagnolo, con i Regni di Napoli e di Sicilia, e la Repubblica di Venezia. Si allestì una poderosa e agguerrita flotta costituita da 204 galee e 6 galeazze, con 28.000 soldati, circa 13.000 marinai e un gran numero di rematori, stimati in 43.000; la potenza di fuoco di questa armata marittima era assai notevole, rappresentata da circa 1.800 cannoni, di eccellente fattura, molti dei quali di grosso calibro. L’impero ottomano poteva opporre 216 galee, 64 galeotte e 64 fuste, un numero quindi superiore, ma lo stato di manutenzione di queste imbarcazioni era spesso inferiore a quello del naviglio avversario che, fra l’altro, era anche più moderno; sulle navi della Sublime Porta erano imbarcati 34.000 soldati, pochi con archibugio, a differenza degli avversari, 13.000 marinai, 41.000 rematori e solo 750 cannoni, soprattutto di piccolo calibro. Al comando alla Lega Santa era Don Giovanni d’Austria, alla flotta ottomana Alì Pascià. Lo scontro avvenne il 7 ottobre 1571 nelle acque antistanti la cittadina greca di Lepanto e, dopo alterne vicende e rovesciamenti di fronte, si concluse con una grande vittoria della Lega Santa, che affondò e catturò circa 189 navi nemiche, contro la perdita di soli 17 suoi vascelli; tanti furono gli schiavi catturati e i soldati uccisi e fra questi il comandante in capo Alì Pascià. Se si pensa che con questo grande successo si riuscì a porre freno all’espansionismo turco ci si sbaglia di grosso, poiché continuarono le conquiste in terraferma e anche in mare, per quanto limitate a isole geograficamente greche, come Creta, oppure all’Africa settentrionale, come la Tunisia. Invece fu una battuta d’arresto per la marina turca, da cui non riuscì più a risollevarsi e, soprattutto, il successo della Lega Santa ebbe un valore simbolico più grande di quello bellico, sia perché in tanti anni era la prima grossa sconfitta patita dagli ottomani, sia perché questi rinunciarono per sempre a dominare su tutto il Mediterraneo. Benchè la flotta fosse stata ricostruita in un solo anno, i vascelli risultavano inferiori come qualità e armi in dotazione a quelli della Cristianità e se anche serpeggiava un naturale desiderio di riscatto e di rivincita, questo non avvenne, perché gli esiti drammatici di quello scontro avevano incrinato la sicurezza degli ottomani; a ciò aggiungasi che la Lega Santa fu rapidamente sciolta, anche per la morte del Papa che l’aveva così tanto sostenuta, venendo quindi a mancare in ogni caso l’avversario di prestigio per una nuova grande battaglia navale. Ecco, di questo conflitto, dei prodromi, della battaglia navale vera e propria, e delle sue conseguenze parla in questo libro Alessandro Barbero, con quella sua particolare capacità di avvincere gradualmente il lettore e di renderlo quasi presente ai fatti; non manca la sottile vena ironica che caratterizza lo storico piemontese, vena che alleggerisce il racconto ed è capace anche di sfumare fatti tragici e morti orrende. Lepanto è uno di quei libri che, benché assai lungo (ma molte pagine sono destinate alle corpose fonti bibliografiche, alle note e all’appendice), riesce a non stancare mai, a continuamente interessare chi, con vero piacere, lo sta leggendo.
Alessandro Barbero
insegna Storia
medievale presso l’Università del Piemonte Orientale, sede di
Vercelli. Studioso di prestigio, noto al largo pubblico, ha
pubblicato molti volumi. Bella
vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo è
il primo dei suoi romanzi di successo (Premio Strega 1996, tradotto
in sette lingue), al quale altri sono seguiti, tutti editi da
Mondadori. Per Laterza è autore di opere più volte ristampate, alcune
delle quali tradotte nelle principali lingue.
4/9/2015
La pelle
Adelphi Edizioni Un libro allucinante Se Kaputt può essere definito un libro crudele, La pelle invece può essere considerata un’opera allucinante, tanto è spinto all’estremo il desiderio di Malaparte di descrivere, in una Napoli prostrata e affamata dalla guerra, la prepotenza dei liberatori che come una peste divora gli abitanti spingendoli, per sopravvivere, a barattare l’unico bene che possiedono, il loro corpo. Certo nello scrittore toscano, che ricordiamo fascista della prima ora e poi, con il trasformismo che quasi sempre ci caratterizza, diventato ufficiale di collegamento con le truppe alleate, alberga un fondo di risentimento per gli antichi nemici che lo porta anche a eccedere nel descrivere le loro nefandezze, sovente estremizzate da una fantasia che intende rappresentare, attraverso il surreale, una realtà oggettiva di autentico e disperato squallore. Nel libro, infatti, incontriamo episodi di pedofilia, di orge sfrenate omosessuali e, poiché al peggio non c’è mai limite, anche di cannibalismo. Ma se nel comportamento della popolazione, in questo loro cedere a un ricatto che toglie ogni dignità, c’è la giustificazione del bisogno primario di riempire stomaci vuoti, nei vincitori invece c’è la frenesia di dimostrate la loro potenza economica, tale da soddisfare anche necessità che in altre occasioni e in altri luoghi non sarebbero emerse; anche loro annullano la propria dignità, ma in fin dei conti sono i peggiori, poiché non rispondono in questo alla necessità di soddisfare esigenze inderogabili; i vincitori appaiono così come degli dei a cui tutto è possibile e a cui tutto è concesso. Aleggia uno spirito di morte, ma non di morte del corpo, bensì dell’anima, un senso di putrefazione dei sentimenti e della dignità reso in modo splendido, e pur tuttavia Malaparte, forse conscio che alla lunga il lettore, dapprima stupito e poi annichilito, potrebbe arrivare a chiudere il libro schifato da tante oscenità, ha il pregio di alternare passi che oserei definire di autentica poesia, come quello che segue e che parla di quella che una caratteristica nota in tutto il mondo della città partenopea: “Simile a un osso antico, scarnito e levigato dalla pioggia e dal vento, stava il Vesuvio solitario e nudo nell’immenso cielo senza nubi, a poco a poco illuminandosi di un roseo lume segreto, come se l’intimo fuoco del suo grembo trasparisse fuor della sua dura crosta di lava, pallida e lucente come avorio: finché la luna ruppe l’orlo del cratere come guscio d’uovo, e si levò estatica, meravigliosamente remota, nell’azzurro abisso della sera. Salivano dall’estremo orizzonte, quasi portate dal vento, le prime ombre della notte. E fosse per la magica trasparenza lunare, o per la fredda crudeltà di quell’astratto, spettrale paesaggio, una delicata e labile tristezza era nell’ora, quasi il sospetto di una morte felice.” Mentre leggevo il libro mi sono ricordato di una pellicola di Pier Paolo Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma, che per certe scene richiama La pelle; ebbene il film è un macabro apologo del potere che dilania se stesso e forse Malaparte è quello che ha inteso dimostrare, cogliendo nei vincitori, e quindi nei detentori del potere, quel senso di immaturità che è propria degli uomini che, beneficiati da successi, si credono capaci di tutto, scandendo quasi a rotta di collo nella scala dell’abiezione e finendo così con l’essere i perdenti di se stessi. Nella pellicola sono rappresentati gli ultimi bagliori di un potere agonizzante, nel libro invece sono descritti i deliri di un potere trionfante, ma è questa l’unica differenza, poiché il potere in entrambi i casi corrode gli uomini che lo detengono e quindi una società è sana e salva solo se non c’è chi ha più potere degli altri, o comunque se a chi comanda sono delegati poteri ben limitati che fa sentire i detentori servi al servizio della comunità e non padroni. Pur con qualche riserva, in particolare per chi non sopporta scene sgradevoli, che tuttavia sono funzionali all’opera, La pelle è un libro senz’altro consigliato, perché è unico sotto tutti gli aspetti e a patto di tener conto del fine per cui è stato scritto.
Curzio Malaparte (Prato, 9
giugno 1898 – Roma, 19 luglio 1957). Il suo vero nome era
Kurt Erich Suckert. È
stato uno scrittore, giornalista e ufficiale dell’esercito italiano.
29/8/2015
La
fontana di Bellerofonte 1820 Tullio Pironti
Editore Narrativa romanzo storico
Sogno di libertà Mi è parsa indispensabile questa premessa perchè il romanzo storico di Celestino Genovese va inquadrato in quel periodo storico ed è di quei moti che parla, con tanti protagonisti veramente esistiti (sono quelli in cui è riportato anche il cognome) e altri di fantasia identificati solo con il nome. Così, nel pieno rispetto degli avvenimenti storici, l’autore ci porta a conoscere vicende che in genere a scuola sono frettolosamente insegnate e si può ben comprendere l’importanza di quei moti, senza l’esperienza dei quali probabilmente non sarebbe neppure nato lo stato italiano. I timori, le preoccupazioni, le speranze che accompagnano i rivoltosi ci rendono ben partecipi di una realtà che sembra anni luce lontana da noi, ci fanno fremere per l’anelito di libertà dei personaggi, ci rattristano per l’infausta sorte di Morelli e Silvati. L’autore è tuttavia molto accorto a non cadere in un romanzo storico troppo fedele alla storia, il che avrebbe potuto allontanare il lettore, anziché avvincerlo. E allora ha inserito dei personaggi di fantasia, che pur nel contesto generale, hanno una loro esistenza autonoma e alcuni (i principali) sono descritti in modo molto azzeccato, tanto da aver l’impressione che vadano materializzandosi davanti agli occhi di chi legge. La fontana di Bellerofonte 1820 è un romanzo riuscito e di ottima fattura; lo stile mai ridondante, ma non per questo povero, le descrizioni dei luoghi, concisa, ma d’effetto, la capacità di ricreare un’atmosfera tutta particolare e soprattutto il pregio di far conoscere ciò che a scuola viene sovente sbrigativamente detto sono tutti elementi qualificanti e che giustificano l’invito a leggerlo.
Celestino Genovese, psicoanalista,
è stato professore di Psicologia dinamica presso la Seconda
Università di Napoli.
25/8/2015
Maigret e la giovane morta
Traduzione di Laura
Frausin Guarino
Narrativa romanzo
Un Maigret paterno Maigret sembra prendere particolarmente a cuore il caso, mosso da un senso di pietà quasi paterno nei confronti della vittima, di cui ancora non si sa nulla, ma ha il viso, acqua e sapone, di una fanciulla perbene. Le indagini di Lorgnon e di Maigret procedono quasi in parallelo e poco a poco si viene a scoprire il nome della vittima e chi fosse, ma ancora nulla si sa del movente, indispensabile per poterne trovare l’assassino. È forse superfluo che dica che a capo di tutto verrò il nostro infallibile commissario Maigret, dimostratosi ancora una volta abile, ma anche umano, dietro quella scorza burbera che lo caratterizza. ll poliziesco è molto bello, con diversi personaggi che, mano a mano che le indagini procedono, portano un tassello al mosaico della verità, in una Parigi spesso livida, fra appartamenti ammobiliati, quasi sempre di modesto livello, gente ricca e gente povera, come la giovane morta, orfana di una famiglia che non ha saputo né educarla, né, soprattutto, darle affetto. Forse mai come questa volta Maigret si è preso a cuore il caso, non solo per il dovere, ma per la pietà che ha provato nel vedere quel povero corpo privo di vita; arriva perfino a non dormire la notte e l’impressione che ho avuto é che Simenon, scrivendo questo romanzo nel 1954, durante il suo soggiorno americano, fosse effettivamente preso da amore paterno, visto che l’anno prima gli era nata la figlia Marie-Jo, che poi finirà la sua vita tragicamente nel 1978. C’è troppo affetto in Maigret per non pensare a questa coincidenza e comunque sia resta il fatto che Maigret e la giovane morta è intriso da una vena di malinconica dolcezza, Da leggere, perché è molto bello.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
Per coloro che sono sensibili al mondo della poesia, penso che il saggio di Maria Carmen Lama dal titolo Verso la poesia alla ricerca di senso possa essere un interessante nonché gradevole contributo. Di piacevole lettura, colto, ma non pedante affronta i vari aspetti attinenti all’arte poetica. Che sia nato da un grande amore per tale forma d’arte, credo sia fuori dubbio in quanto, secondo il mio semplice parere di lettrice, lo si percepisce dall’inizio alla fine poiché di questo amore ne è attraversato come da una delicata musica di sottofondo. Poetessa lei pure, l’autrice traccia a grandi linee il percorso evolutivo dell’arte poetica partendo con la citazione del trattato di Orazio Ars poetica, caposaldo per i costruttori di versi, per poi ripartire dalla poesia del diciottesimo secolo e dai suoi principali autori.
Il saggio si
divide in due parti, comprensive rispettivamente di tre e due
capitoli.
Maria Carmen Lama
non tralascia inoltre di indicare le varie correnti che hanno
attraversato il mondo della poesia dal diciottesimo secolo ad oggi, a
partire dal simbolismo francese al trascendentalismo americano
analizzando la poetica dei vari rappresentanti sia stranieri che
italiani.
La seconda parte
di questo bel saggio è caratterizzata dal commento con cui l’ autrice
arricchisce poesie di grandi autori (Emily Dickinson, Mario Luzi,
Eugenio Montale, Pablo Neruda, Antonia Pozzi) nonché di autori
emergenti che l’hanno particolarmente affascinata (Elia Belculfinè,
Cristina Bove, Silvano Conti, Renzo Montagnoli, Giovanni Sciacovelli,
Valentino Vitali, Aurelio Zucchi).
Non sanno dire
niente le parole.
O le parole non
dette
Devo dire inoltre
che il saggio è supportato da una abbondante bibliografia la cui
lettura può essere quanto mai interessante per approfondire
ulteriormente i vari argomenti. E pure la consultazione dei vari siti
internet citati potrà donare dei momenti di arricchimento personale.
20/8/2015
Il
Tempo, grande scultore Traduzione di
Giuseppe Guglielmi
Un invito a riflettere Non si pensi che questo libro sia un’opera di narrativa, perché invece ci troviamo di fronte a una serie di rapidi saggi, di cui uno, per l’appunto Il tempo, grande scultore, dà il titolo all’intero volume. Di Marguerite Yourcenar avevo già letto Memorie di Adriano e L’opera al nero, due autentici capolavori, e mi ero reso conto della grande cultura di questa scrittrice belga, talmente brava da essere stata la prima donna ammessa all’Academie Française, e quindi non mi sono stupito scorrendo queste pagine di trovare riflessioni profonde sulla religione, sul tempo, solo per citare alcuni dei temi affrontati. Si tratta di saggi, come dianzi detto, brevi, ma non per questo inadeguati, anzi la capacità di sintesi della Yourcenar è notevole, tanto più che, nonostante la difficoltà degli argomenti, il grado di comprensibilità è veramente encomiabile. La sua prosa, scorrevole, per quanto improntata a un ragionamento filosofico, appare di ulteriore pregio qualora si consideri che non di rado si avvicina alla poesia, con l’armonia che le è propria e che accresce la gradevolezza della lettura. E se i temi sono quanto mai vari, pur essendo di primo acchito quasi banali, lo svolgimento si rivela una fonte preziosa e insostituibile di conoscenza. Prendiamo il primo saggio “Sopra un passo del Venerabile Beda”, che parla dell’avvento del cristianesimo in Inghilterra; a parte che sembra quasi un racconto, mira in effetti a trovare i motivi per i quali questa religione finì per prender piede, non osteggiata, anzi addirittura favorita nel caso specifico, in luogo di quelle esistenti. E il ragionamento è di una logica talmente stringente da non lasciare spazio ad altre spiegazioni. Personalmente il mio interesse si è indirizzato in modo particolate a Il tempo, grande scultore; mi sono infatti sempre chiesto se la nozione corrente di tempo sia esatta, cioè se esso misuri una successione di giorni, di notti, di ore, ecc,, per dare anche una misura agli accadimenti che si susseguono. Ebbene, secondo Marguerite Yourcenar il tempo, un termine di paragone fra epoche diverse, non può essere considerato come una successione di eventi, secondo un andamento che può essere lineare o progressivo, bensì come un agente atmosferico, uguale alla pioggia, al sole, al vento, in grado di incidere le statue, e non solo quelle, ma per estensione anche l’intero genere umano (non s’invecchia forse?). Questo concetto fa sì che il tempo non sia un metro di misura inventato dall’uomo, ma rientri nel grande coacervo delle leggi di natura. Il tempo non è né veloce, né lento: è così e basta e noi non ne siamo gli artefici, ma vi siamo assoggettati. Mi piace questo pensiero e mi trova d’accordo, anche perchè così ne conseguono molte risposte a non poche domande: se ancora non c’è risposta del perché si muore, si può ben comprendere invece perché si invecchia, un’accentuazione dell’età che non tocca solo l’uomo, ma anche le cose inanimate e per estensione l’intero universo. Non c’è che dire, perché riga dopo riga si è quasi gioiosamente costretti a riflettere, in un esercizio di cui noi siamo gli allievi e Marguerite l’insegnante, peraltro per nulla saccente, quasi volesse impostare con il lettore un dialogo, con benefici effetti per entrambi. Di conseguenza non mi limito a consigliarne la lettura, ve la raccomando vivamente, consapevole che se non è facile essere quasi costretti continuamene a riflettere, però, arrivati all’ultima pagina ci si accorge dell’arricchimento culturale di cui Marguerite Yourcenar ci ha fatto amabilmente dono.
Marguerite Yourcenar,
pseudonimo di Margherite de Crayencour, nasce a Bruxelles l’8 giugno
1903 e muore a Mount Desert il 17 dicembre 1987, dopo una vita
avventurosa ed errabonda. Le sue opere principali sono Alexis o il
trattato della lotta vana (1928), Il colpo di grazia (1939), L’opera
al nero (1968) e, soprattutto, Memorie di Adriano (1951).
16/8/2015
La
trappola di Maigret Traduzione di
Luciana Cisbani Narrativa romanzo
Caccia allo psicopatico La trappola di Maigret è un giallo perfettamente congegnato in cui Simenon sembra aver privilegiato la trama, la caratterizzazione dei protagonisti, l’atmosfera di paura di una grande città mezza vuota per le villeggiature estive, tralasciando un po’ l’ambientazione, così che la metropoli sembra anonima, quasi una metafora delle follie che possono nascere nei grandi agglomerati urbani. Francamente questo mio appunto non è che incida più di tanto sulla valenza dell’opera, ma è una semplice constatazione del fatto che cercare di penetrare nei meandri di una mente contorta esige all’autore in contropartita una minor attenzione per la scena o le scene in cui si svolge la vicenda. Tensione ed emozioni non mancano in questa caccia dapprima a un’ombra e poi alla stessa ombra dai contorni sempre meno vaghi, così che poco a poco si viene a delineare la figura di questo assassino psicopatico. La lettura, quindi, è senz’altro coinvolgente e appagante e pertanto mi sembra ovvio che ve la consigli.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
10/8/2015
Privo
di titolo Sellerio Editore Narrativa Romanzo storico
Che le dittature, in quanto tali e per reggersi, abbiano la necessità di un controllo stretto della stampa, anzi loro stesse diventino l’organo di comunicazione ufficiale, e che abbiano necessità di creare falsi miti per ornarsi di un alone leggendario è cosa risaputa. Se poi una di queste dittature è quella fascista, pur nella drammaticità dei suoi effetti, raggiunge vette altisonanti, ma anche ridicole, nella mistificazione dei fatti. Deve aver pensato a questo Camilleri quando ha scritto Privo di titolo, un romanzo in cui la drammaticità di un’esistenza schiacciata dall’alto lascia poco spazio a venature ironiche o addirittura comiche. Ma Camilleri è Camilleri e dunque in presenza di un regime vanaglorioso non può fare a meno di ricorrere a note satiriche, rafforzando così l’idea che dietro a un palcoscenico di divise, di retorica e di proclami ci fosse il niente, o meglio si nascondesse l’esistenza di uomini di pochi scrupoli che tenevano solo ed esclusivamente al potere. La narrazione inizia nel 1941, a un’adunata in cui si commemora la scomparsa violenta di un martire fascista, ucciso mentre con altri camerati aggrediva un esponente comunista. Da poco sedicenne Camilleri assiste alla cerimonia e nota un uomo che in disparte piange disperatamente; allora chiede a suo padre chi sia e lui gli risponde che si tratta dell’assassino. Poi si torna indietro nel tempo, a quel 1921 allorché il delitto in questione venne commesso; seguono le indagini, complesse perché non si vuol pervenire all’evidenza di cosa è accaduto, ma alla fine il processo a carico dell’imputato lo vedrà prosciolto, anche se la sua vita sarà costellata da una serie continua di vessazioni. La sentenza è del 1924, anno in cui Mussolini si reca in Sicilia, per la precisione a Caltagirone, per porre la prima pietra di una nuova città, Mussolinia, città fantasma, perché non verrà mai edificato nulla, vista l’intenzione di limitarsi a una cerimonia di promesse che diano lustro al regime senza impegnarlo. La visita non è senza intoppi, poiché scoppiano dei disordini, e nella loro descrizione spicca la vena satirica di Camilleri. I due fatti, l’assassinio e la prima pietra di Mussolinia, non sembrano collegati e invece lo sono, perché rappresentano l’abituale mistificazione di un regime; del resto, realizzata, nelle circostanze, con la creazione di un martire, che martire non è, e con la festa trionfale per l’avvio dei lavori di una città che non verrà mai costruita, perché non c’è la volontà di realizzarla effettivamente. L’approccio di Camilleri con l’ideologia fascista é tuttavia incompleto, cogliendone solo questa caratteristica, evitando tuttavia di scivolare nella parodia, come invece gli era capitato con Il nipote del Negus e con La pensione Eva. Comunque, pur con questo limite, si deve tributare il merito all’autore, che conta lettori a profusione, di contribuire a mostrare cos’era veramente il fascismo, perché oggi quelli che l’hanno vissuto dimostrano una scarsa memoria, mentre gli altri lo ignorano del tutto, o al più si limitano a considerarlo un regime dittatoriale, senza tuttavia sapere come sia un regime di questo tipo. Da leggere, quindi.
Andrea Camilleri (Porto
Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e
sceneggiatore. Ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il
volume, I teatri stabili in Italia (1898-1918). Il suo
primo romanzo, Il corso delle cose, del 1978, è stato
trasmesso in tre puntate dalla TV col titolo La mano sugli occhi.
Con questa casa editrice ha pubblicato: La strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992), La bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca(1997), La concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il re di Girgenti (2001), La
presa di Macallè (2003), Privo di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza Musumeci(2007), Il
casellante (2008), Il sonaglio (2009), La rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010, anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie diVigàta (2011), La setta degli
angeli(2011), La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014); e inoltre i romanzi con protagonista il
commissario Salvo Montalbano: La forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il giro di boa (2003), La pazienza
del ragno (2004), La luna di carta (2005), La vampa
d'agosto (2006),Le ali della sfinge (2006), La pista di
sabbia (2007), Il campo del vasaio (2008), L'età del
dubbio(2008), La danza del gabbiano (2009), La caccia
al tesoro (2010), Il sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi (2011), Una lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un covo di vipere (2013), La piramide di fango (2014).
3/8/2015
Il cane
giallo
Traduzione di Marina Verna
Narrativa romanzo Nel grigio più grigio Secondo giallo con Maigret di queste mie letture estive e ho ritrovato il Simenon a cui tanto piacevolmente sono abituato. La cura dei particolari, la precisa e riuscita ambientazione, l’atmosfera ricreata in modo mirabile sono prerogative del grande scrittore belga e sono presenti anche in questo Cane giallo, un poliziesco senza dubbio, anche se sono presenti richiami, nemmeno tanto velati, al romanzo gotico. La vicenda si svolge a Concarneau, una cittadina costiera bretone in un clima piovoso, sotto un cielo grigio che tende al nero, con il mare che sembra perennemente in burrasca. Lì forse si aggira un pazzo, un vero e proprio gigante che può ricordare il mostro di Frankestein e che, accompagnato da un cane giallo, parrebbe intenzionato a sopprimere alcuni cittadini della migliore borghesia e lì si reca da Rennes, ove è stato temporaneamente trasferito per organizzare la polizia locale, il commissario Maigret. Mentre la paura, per non dire il terrore, assale gli abitanti del luogo, l’unico, imperturbabile, è proprio il nostro grande investigatore, come se già conoscesse l’evoluzione degli eventi e quindi anche il nome dell’assassino. Non è un’impressione, perché è proprio così, visto che fin dalla prima vittima, per fortuna solo ferita, Maigret sembra in grado di trovare il bandolo della matassa. Tutto si concluderà nella prigione della locale gendarmeria, con un sospiro di sollievo di tutti i presenti, fatta eccezione ovviamente per l’omicida. La vicenda, pur lineare, non manca di colpi di scena e ancora una volta si potrà apprezzare le capacità investigative e la bontà d’animo del famoso commissario. Tutto qui? No, c’è dell’altro, poiché la naturale avversione di Simenon verso la gente che conta, che stende un invisibile reticolato fra sé e gli altri, considerati di rango inferiore, è ben espressa con la descrizione di un gruppo di borghesi, veri e propri falliti e che pur ostentano tutta la loro alterigia fatta da convenzioni che, soprattutto nelle piccole e medie realtà, sono funzionali a tenere ben distinte e separate le classi. Questi uomini, che si credono la crema della società, sono invece descritti come dei parassiti della peggior specie, ben contrapposti all’umiltà e alla tenerezza di Emma, la cameriera dell’Albergo più in vista di Concarneau, che nel grigiore della sua esistenza, privata di chi le voleva veramente bene, finisce ogni tanto nel loro letto, mettendo così in luce i loro bassi istinti e vite senza amore. Il giallo, la trama, i suoi sviluppi non possono che risultare graditi al lettore, ma quel guardare a un mondo fatuo e ipocrita, proprio di questi vitelloni, impreziosisce l’opera, è il tocco di grazia di un autentico maestro.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
23/7/2015
Diorama 21/7/2015
Kaputt a cura di Giorgio Pinotti
Adelphi Edizioni Narrativa racconti
Di Kaputt si potrà dire di tutto, nel bene e nel male, ma è indubbio che in chi lo legge lasci un segno profondo, un’incisione nella carne viva la cui cicatrice ci si porterà sempre appresso. Al riguardo, così scrive l’autore in premessa: “ Kaputt è un libro crudele. La sua crudeltà è la più straordinaria esperienza che io abbia tratto dallo spettacolo dell'Europa in questi anni di guerra. Tuttavia, fra i protagonisti di questo libro, la guerra non è che un personaggio secondario. Si potrebbe dire che ha solo un valore di pretesto, se i pretesti inevitabili non appartenessero all'ordine della fatalità.”. E se la guerra è appunto crudeltà lì c’è quella nazista, vale a dire il massimo che nemmeno conflitti passati, pur densi di orrore, ebbero a vedere. Ci sono scene che possono sembrare inventate, ma che ben sapendo di cosa erano capaci i tedeschi possono essere ritenute, se non vere, almeno possibili, come, per esempio, quella dei soldati russi, presi prigionieri, utilizzati nel gelido inverno come segnaletica stradale, a indicare una direzione, pietrificati nel sonno della morte. Non c’è solo orrore in questo libro che più che romanzo potrei definire una raccolta di racconti, di esperienze maturate, anche di articoli quasi giornalistici, senza un collegamento preciso fra loro, ma che comunque parlano sempre della guerra. Non c’è solo raccapriccio, ma anche il tentativo di dare una spiegazione logica al comportamento dei tedeschi, alla loro sistematica vocazione a portare solo la morte e, secondo Malaparte, la causa di tutto questo è la paura, non della morte, ma il timore di un possibile cambiamento, di un contatto con altri che possa venire a turbare l’ossessiva immutabilità del proprio stato; si tratta quindi di un’angoscia collettiva, propria di un popolo che, nel sognare la gloria, vede un mondo abitato solo da se stesso, finalmente libero da confini, da lacci e catene, da incontri con altri che possano minacciare la sua intrinseca fragilità. E’ un’opinione indubbiamente interessante quella per cui si uccide per paura, ma non trova spazio o non è approfondito il perché del perverso piacere di ammazzare, di quella fantasia funebre di cui i tedeschi hanno dato prova. La guerra per loro non è solo necessità, è compiacimento, è arroganza della violenza. Beninteso, al di là delle opinioni personali, questo libro ha diversi meriti, ma forse ciò che in verità gli nuoce è lo stile troppo erudito dell’autore, che se da un lato rende ancora più stridente l’immagine sanguinaria di un conflitto, accompagnando crudezza a pietà, dall’altro sembra dimostrare che Malaparte fosse ormai uno scrittore non in linea con la sua epoca, un compendio di Proust e di D’Annunzio, che mezzo secolo prima avrebbe reso felici i lettori, ma che ora invece pesa sulla piacevolezza della lettura, visto che al tono aulico si accompagna anche una marcata verbosità, che porta a dilatare eccessivamente i tempi, rischiando peraltro di far perdere il filo del discorso. Kaputt, insomma, è uno di quei libri da leggere solo dopo aver verificato la propria disponibilità ad accettare sia una prosa lenta, sia immagini che si possono senz’altro definire sconvolgenti, un evidente difetto che, pur tuttavia, riesce a trasmettere l’orrore di una guerra, già di per sé tragica in quanto tale, ma che nella fobia dei tedeschi divenne, si spera, irripetibile. Concordo infine sulla paura come una delle cause del terribile comportamento nazista e personalmente aggiungo che in fin dei conti i tedeschi avevano veramente paura, ma inconsapevolmente di se stessi.
Curzio Malaparte
(Prato, 9 giugno 1898 – Roma, 19 luglio 1957). Il suo vero nome era
Kurt
Erich Suckert. È stato uno scrittore, giornalista e ufficiale
dell’esercito italiano.
19/7/2015
Le
righe nere della vendetta Scrittura &
Scritture Edizioni Narrativa romanzo Non solo veleni Oreste Vannucci, il prefetto delle fabbriche dei Gonzaga, viene rinvenuto morto nel suo appartamento senza segni apparenti di violenza. Si scoprirà ben presto che è stato assassinato per mezzo di una camicia intrisa di un potente veleno; le indagini, per scoprire il movente e l’omicida, .sono avviate dal capitano di giustizia Biagio dell’Orso, un uomo tenace e mai domo. Inizia così il giallo storico scritto da Tiziana Silvestrin, una narratrice mantovana, appassionata di storia e in particolare di quella dei Gonzaga. Fra colpi di scena, tra personaggi esistiti realmente e con una storia parallela che vede protagonisti contrapposti Lucilla, una bella ragazza con vocazione da medico e il domenicano Giulio Doffi, capo della locale Santa Inquisizione. si sviluppa una trama quanto mai avvincente, capace di tenere il lettore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Lo stile non ridondante, ma nemmeno scarno e che definirei sobrio, l’esatta descrizione dei protagonisti, sia quelli esistiti veramente, sia quelli di fantasia, l’atmosfera di tensione sono innegabili qualità di questo romanzo, a cui in verità mi sono accostato con un po’ di titubanza, forse perché temevo fosse uno di quei prodotti in cui, a fronte di una vicenda intricata, si trascurava tutto il resto. E invece ho dovuto ricredermi, perché non si tratta di un’opera marginale, ma di un lavoro di eccellente qualità, come non se ne trovano tanti in giro, e credo che alcuni scrittori, immeritatamente blasonati, proverebbero invidia, solo se avessero l’umiltà e la compiacenza di leggerlo. Quel che intendo dire è che Le righe nere della vendetta meriterebbe un successo e una notorietà ben superiori. Dopo questo breve inciso, che tende a dimostrare che l’essere bravi autori sovente non è sufficiente per entrare nelle grazie di un numero rilevante di lettori, ritorno al romanzo della Silvestrin. Il capitano di giustizia, il nostro eroe, arriverà alla soluzione del caso, seguendo un filo logico che non fa una grinza, tanto che chi legge perverrà insieme a lui a scoprire il movente e l’assassino. Biagio dell’Orso è il Maigret dell’epoca e oltre a destare una immediata simpatia, ne ha anche alcune caratteristiche, come quello di essere sì intransigente nell’esercizio delle sue funziono, ma anche di essere dotato di una forte carica umana. In questo giallo storico ho molto apprezzato le splendide descrizioni di Mantova nel XVI secolo e così palazzi, piazze, vie e chiese si materializzano davanti agli occhi, tanto da non sembrare antiche e immote vestigia, bensì vive, come le genti che vi si trovano, una sensazione particolarmente piacevole e realistica che é un valido “di più” nel contesto dell’opera. Sono 292 pagine, che ho letto in pochissimo tempo, teso sempre a seguire quel filo logico per arrivare alla verità, un’impazienza che contrastava con il nascosto desiderio che la lettura non avesse termine. E, invece, per quanto ampiamente soddisfatto, sono purtroppo giunto alla conclusione, ma questo naturale rammarico è attenuato dal fatto che Tiziana Silvestrin ha scritto altri due romanzi con protagonista Biagio dell’Orso, libri che mi sono ripromesso di leggere quanto prima.
Tiziana Silvestrin
Questo lo sapeva anche Tiziana che
intanto si era messa a recitare. Entrata a far parte di una compagnia
di teatro amatoriale aveva iniziato a scrivere commedie. Ha scritto i seguenti romanzi, tutti editi da Scrittura & Scritture Edizioni:
I leoni d’Europa (2009), Le righe nere
della vendetta (2011), Un sicario alla corte dei Gonzaga (2014).
16/7/2015
I
ladri di sogni Lussografica
Edizioni La ricchezza dei poveri Occorre prendere atto che Salvo Zappulla ha la straordinaria capacità di permeare i suoi scritti di una sottile ironia, mai caustica, ma che è in grado di conferire alle sue opere una salutare levità che non poco concorre alla gradevolezza della lettura. Se poi consideriamo che si muove nella scia della migliore produzione surrealistica è possibile comprendere che in un narratore come lui, a cui certo la fantasia non fa difetto, l’opera plasmata sia prima di tutto un suo divertimento, che contagiosamente si trasmette a chi si accosta alle sue pagine. È anche questo il caso di I ladri di sogni, un romanzo tutto sommato breve (101 pagine), da cui ha tratto anche una fortunata versione teatrale che, presentata al Premio Massimo Troisi 2006, ha incontrato i favori dei giurati, classificandosi al secondo posto. L’idea di base di questo libro è talmente inverosimile da sembrare possibile, visti i continui progressi della scienza. A Ficodindia, anonimo paesino siciliano, dove il tempo è immobile da secoli, accade che ai cittadini, quasi tutti quelli di umili condizioni, vengano sottratti i sogni nel corso della notte, e quel che è peggio è che in tal modo viene loro impedito di sognare anche in seguito. Se uno non ha nulla al mondo l’unica cosa che gli resta è la speranza, che si concretizza durante il sonno nella realizzazione dei suoi desideri. Niente sogni, niente speranza, e così si diventa abulici, disinteressati, facilmente governabili. Perché sta in questo il messaggio metaforico di Zappulla: chi tiene il potere, per mantenerlo, ha la necessità di sottomettere i cittadini, togliendo loro perfino il desiderio di vivere e facendoli diventare quasi degli automi. Le pagine scorrono fra le denunce dei derubati e le esilaranti indagini della locale caserma dei carabinieri, finché del fatto non viene a conoscenza anche il governo che, motu proprio, si incarica di cercare quei ladri di sogni che in effetti non intende cercare. Come sarà la conclusione? Non intendo anticipare nulla, ma siamo in Italia e per di più in Sicilia, cioè in uno stato e in una regione dove non c’è più nulla di definitivo del provvisorio. Stupisce inoltre Zappulla con quel suo stile sobrio, ma preciso, con quella capacità di ricreare ambienti e atmosfere che è peculiarità di pochi narratori assai più conosciuti di lui e che, giustamente, incantano il lettore che non potrà a sua volta non essere attratto dallo svolgimento della trama, dalla perfetta descrizione di Ficodindia, da quell’immobile e assolata atmosfera di un paese che è la copia di tante analoghe realtà siciliane. Se con Kafka e il mistero del processo ero rimasto colpito da un’opera di elevato livello, con I ladri di sogni sono rimasto estasiato, tanto da leggerlo più volte al punto che di tanto in tanto entra nei miei sogni, che ho opportunamente blindato da qualsiasi tentativo di furto. Leggetelo e non è solo un consiglio, perché non potrete che essere poi più che soddisfatti.
Salvo Zappulla è
nato il primo marzo 1961 a Sortino (SR), dove tuttora vive.
I suoi romanzi sono stati corredati
da schede didattiche e adottati come testi di narrativa nelle scuole
medie. E’ il presidente dell’associazione culturale “Pentelite” che
organizza la Mostra Mercato dell’editoria siciliana a Sortino; è il
presidente del Concorso Letterario Nazionale “Città di Sortino”. Cura
annualmente la rivista “Pentelite”. Collabora alla pagina culturale
del quotidiano “La Sicilia”, alla rivista “I siracusani”, al
quindicinale “ La voce dell’Isola”. Nel 2006 si è classificato
secondo con un testo teatrale inedito al premio Massimo Troisi.
11/7/2015
La vedova Couderc Traduzione di Edgardo Franzosini
Edizioni Adelphi
Narrativa romanzo Destini incrociati Tati Couderc è una donna che ha già varcato la soglia degli otto lustri, non bella, ma interessante e possessiva, e come tale si comporta nella proprietà di campagna, di cui ha solo il possesso, giacché la titolarità di proprietario è del suocero, il vecchio Couderc, sordo come una campana, un po’ intontito, ma di certo non insensibile all’attrattiva dell’altro sesso. Giunta in quella casa quattordicenne come serva, era stata messa incinta dal figlio del padrone che poi aveva sposato. Morto il marito, Tati era restata con il vecchio e con il figlio, ben presto rivelatosi un fior di delinquente, tanto da essere spedito in Africa in un battaglione di punizione. Avida di guadagno, aveva lavorato come una stakanovista per curare da sola la campagna, cedendo ogni tanto alle voglie del suocero. Il mondo descritto mirabilmente da Simenon è una realtà chiusa, immobile, dove predominano gli istinti primordiali senza che ci sia spazio per dei veri sentimenti. L’incontro di Tati con Jean, un giovane di buona e agiata famiglia uscito da poco di prigione, dove era stato rinchiuso per un delitto, scatena una passione febbrile, ma ci sarà un terzo incomodo nella relazione carnale fra lei e lui. Come una pentola di fagioli che bolle e che minaccia a ogni istante di far saltare il coperchio, alla fine l’amore possessivo di lei finirà con lo scontrarsi con il risveglio in lui per carni più giovani, e, come in una tragedia scespiriana, si arriverà a un drammatico epilogo, con i protagonisti perfettamente nel loro ruolo, incapaci di sfuggire al loro destino. Mi riesce difficile, ogni volta che scrivo la recensione di un libro di Simenon, trovare parole nuove, perché la perfezione non ha bisogno di tante presentazioni o elogi: è così con’è e tutti possono accorgersene leggendo. Questo mondo rurale, in cui l’orologio del tempo sembra essersi fermato, o al più andare a rilento, gli odi, le passioni che lo caratterizzano, la grettezza dei sentimenti che l’accompagnano sono espressi con un ritmo cadenzato, ma volutamente lento, una realtà che non è certo un’invenzione, ma che era effettiva allorché Simenon nel 1940 scrisse il romanzo. Poi una guerra, la ricostruzione, il predominio dell’industria sull’agricoltura hanno cancellato quella civiltà contadina che non era solo caratterizzata dai toni aspri e accesi, dalle violenze improvvise che scuotevano il torpore, ma anche dalla solidarietà, di cui possiamo avere un assaggio in queste pagine quando Tati, malata, fa vendere i prodotti del fondo a una vicina sul mercato settimanale. Ma resta questa primitività, fatta di rapporti umani più carnali che amorosi, di faide familiari, di scontri e di sangue, che Tati e Jean interpretano alla perfezione, tanto da essere indimenticabili, proprio come Simon Signoret (Tatì) e Alain Delon (Jean) nel bellissimo film del 1971 intitolato L’evaso, tratto, peraltro liberamente, da questo stupendo romanzo di Simenon.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
2/7/2015
Il tocco abarico del
dubbio
Poesia L’importanza del dubbio Mi sia consentita una doverosa, ma anche opportuna premessa: quando ho avuto per le mani questo libro, mi sono subito chiesto che cosa potesse avere a che fare con la poesia un termine geografico come “abarico”. Per chi non lo sapesse, onde anche evitare una sua ricerca su un dizionario, per abarico si intende quella zona in cui le forze di gravitazione della terra e della luna si annullano, generando il cosiddetto punto zero. Lì, in campo neutro si potrebbe dire, si inserisce il dubbio, che non porta né alla verità, né alla menzogna, ma che ha il pregio non indifferente di mettere in discussione tanti concetti atavici precostituiti, stimolando una ricerca di conoscenza che porta gradualmente a una maggiore consapevolezza di ciò che siamo. Il dubbio quindi non è un elemento negativo, anzi si potrebbe dire che senza di esso l’evoluzione umana non sarebbe stata possibile; l’unico vero problema è che come si procede nella ricerca della conoscenza, sanando tanti dubbi, ne intervengono anche di nuovi. La limitata condizione dell’essere umano, la temporaneità della vita sono tutti fattori che portano alla crescita dei dubbi, ma del resto non oso nemmeno immaginare come potrebbe essere un’esistenza fatta di certezze acclarate e dimostrabili; con ogni probabilità sarebbe del tutto piatta, grigia e monotona. Nel leggere i versi delle belle poesie che compongono questa silloge emergono i dubbi dell’autore, dubbi relativi a quelle che credevamo certezze e invece non lo sono, dubbi legati alle aspettative ultime degli esseri umani (che ci sarà dopo la morte?) e anche dubbi sul come abbiamo impostato la nostra esistenza, sulla nostra limitata scelta di un ruolo che è soprattutto determinato dalle convinzioni della società in cui viviamo. Sostanzialmente la silloge è strutturata in cinque sezioni, ognuna delle quali è preceduta da una breve prosa poetica, una sorta quasi di introduzione; in queste sezioni vengono trattati i tanti temi dell’esistenza, che riguardano tutti e che perciò prima o poi dobbiamo affrontare. Di particolare ricerca è poi l’uso dei termini nelle varie poesie (verbi, sostantivo, aggettivi) sovente inconsueti, tanto che sembrano, anche se non lo sono, inventati, del tipo sgamare, bercio, valva, ecc. Non sono messi lì per dimostrare il grado di erudizione dell’autore, ma sono quelli più appropriati per giungere a esprimere concetti in aura poetica, vale a dire per accompagnarli dalla indispensabile armonia, e a proposito di questa il ritmo è necessariamente lento e per assimilarlo a un termine musicale potrebbe essere definito un adagio maestoso; d’altra parte questa studiata lentezza è quanto mai opportuna perché questa è poesia di meditazione, perché sono liriche, che nel portare il sentire di Angela Caccia, invogliamo a riflettere, vengono a toccare i nostri dubbi, portano a un necessario confronto e, soprattutto, mettono in discussione alcune nostre certezze. Ora qualcuno potrà anche pensare che non ha senso leggere una simile poesia, se conduce a un superlavoro di meningi, al che obbietterei che l’intelligenza non è materia inerte, ma è fatta per essere esercitata e che la conoscenza di noi non solo non è mai superflua, ma è addirittura indispensabile. Fra l’altro, se poi è della morte e sul dopo soprattutto che si parla, credo che in materia un confronto di opinioni, per quanto lontanissimo dall’essere risolutivo (con ogni probabilità non lo sarà mai), ci possa condurre però ad accettarla come una fase di un’esistenza che si avvia con la nascita e finisce con la dipartita. Non si troverà la soluzione se c’è sicuramente un dopo, ma senz’altro, con l’accettazione di un termine, si darà più valore alla vita, si cercheranno di riconoscere e di cogliere le tante opportunità che essa ci offre. Nulla deve andare sprecato e solo allora, cioè quando potremo dire di aver vissuto pienamente, quel salto nel buio ci farà meno paura, che siamo o no credenti. Da leggere, ci mancherebbe altro.
Angela Caccia è
nata e vive Cutro (KR). Tra i
concorsi vinti: Piazzetta (Salerno), Siracusa, Feile Filiochta International Poetry Competition 2003
(Dublino), Fiurlini(Olanda), Colapesce 2011,
medaglia Presidente Repubblica al premio Insanamente 2012 (Rimini),
Convivio 2012 (Giardini Naxos). Nel
fruscio feroce degli ulivi (Fara 2013,
prefato da Davide Rondoni, ha vinto il Premio Massa Città fiabesca e
il Concorso Città di parole – Firenze; II class.
al Premio Pascoli Barga; III class.
Ai premi Di Liegro 2013 e Camposampiero 2014).
28/6/2015
Marcia
su Roma e dintorni
Edizioni Einaudi
Amara ironia La visione quindi è soggettiva e riguarda soprattutto quanto accadde in quel periodo in Sardegna, la sua terra, ma che comunque è facilmente estensibile all’intero panorama nazionale, e questo anche grazie al fatto che l’autore all’epoca era membro della Camera dei Deputati in rappresentanza del Partito Sardo d’Azione, da lui fondato insieme a Camillo Bellieni, una forza politica per sua natura repubblicana e federalista, volta a ottenere per i pastori e i contadini sardi la distribuzione delle terre e dei pascoli di proprietà dei grandi latifondisti. In questo contesto, benché Lussu fosse stato un combattente di notevole valore durante la Grande Guerra, che lo aveva visto deciso interventista, non rientrò nel corposo gruppo degli ex combattenti che, per diversi motivi, si accostarono a Benito Mussolini, anzi lui osteggiò da subito e apertamente un movimento come quello fascista, basato su valori sterili e falsi e caratterizzato dalla continua violenza di cui peraltro fu più volte vittima. Comunque, se l’avversione per la nascente dittatura fu una caratteristica costante, il futuro narratore sardo ha la straordinaria capacità di descrivere i fatti, accompagnandoli con un’amara ironia che ben riesce a dimostrare come fu possibile che un paese uscito dalla guerra come vincitore, anziché operare per la ricostruzione, venisse funestato da continue violenze e che soprattutto un “quaquarqaquà” come Benito Mussolini, forte con i deboli e pavido con i forti, potesse prendere il potere assoluto. Il quadro di un parlamento inconcludente, del presidente del Consiglio Facta, il cui continuo ottimismo stride con la gravità della situazione, un re fellone come Vittorio Emanuele III, l’ostinazione dell’opposizione a procedere solo nel rispetto della legge quando l’avversario – ma sarebbe meglio definirlo nemico – invece della costituzione e delle leggi fa carta straccia dimostrano che l’avvento del fascismo non fu un fatto casuale, bensì il risultato dei favori a Mussolini di chi deteneva le leve del potere, in primis gli agrari, senza dimenticare che non furono pochi anche gli industriali, timorosi tutti di perdere i loro privilegi e volti a continuare gli arricchimenti che inevitabilmente erano venuti durante il precedente conflitto. Tuttavia, l’analisi di Lussu va ben oltre e inquadra in un modo impietoso le caratteristiche dei politici italiani, riscontrabili purtroppo anche oggi. Pur di mantenere il loro posto dorato la maggior parte, che si opponeva con veementi parole al fascismo, finì con l’indossare la camicia nera. Fu così che l’Italia diventò fascista, una dittatura che era iniziata con una marcia su Roma da operetta e, che poi soffocò in tutti i modi anche la minima opposizione, e che infine portò la nazione alla tragedia della seconda guerra mondiale; per non smentire il suo carattere, come noto Mussolini fu catturato mentre fuggiva travestito da soldato tedesco e finì appeso, con altri gerarchi, a Piazzale Loreto. Di tutto ciò che sarebbe accaduto Lussu nel 1931 non poteva sapere niente e anzi lui si trovava nella spiacevole posizione dell’oppositore fuggiasco; eppure, senza livore, anzi direi con serenità scrisse il libro, la cui lettura, a mio parere, più che raccomandata, è doverosa, soprattutto in un paese come il nostro che ogni tanto si lascia incantare dall’uomo di turno della provvidenza
Emilio Lussu (Armungia,
4 dicembre 1890 – Roma, 5 marzo 1975), combatté durante la Grande
Guerra come ufficiale di fanteria della Brigata Sassari. Fondatore
del Partito Sardo d'Azione (1919), fu deputato nel 1921 e 1924 e
partecipò alla secessione aventiniana. Antifascista, nel 1929 fuggì
da Lipari con Carlo Rosselli e Fausto Nitti, coi quali a Parigi fondò
il movimento "Giustizia e libertà". Fu tra i dirigenti della
resistenza e, nel dopoguerra, senatore nelle prime tre legislature.
Presso Einaudi ha pubblicato Un
anno sull'altipiano, Marcia su Roma e dintorni, e Il
cinghiale del Diavolo.
21/6/2015
Il
fiume di Eraclito Illustrazioni di Anna Perrone
Mnamon Edizioni L’amaro destino dell’uomo L’uomo non nasce mai solo, ma con il concorso della madre; muore sempre, invece, solo, solo anche se attorniato dagli affetti più cari, perché la dipartita non può essere che un evento del tutto personale. Se nei primi anni di vita non ha la consapevolezza del suo destino e ha fretta di crescere, di procedere nel tempo, con il trascorrere degli anni ogni tanto gli appare il ricordo di quella spada di Damocle che pende sul suo capo dal momento in cui è stato generato e quando l’età, con i primi acciacchi, manifesta tutto il suo declino, è più facile che sopravvenga il timore della morte, che i tanti segni, soprattutto fisici, danno in avvicinamento. E allora tanto più avvertiamo la miseria di un’esistenza in cui più sono i misteri delle conoscenze, durante la quale non c’è mai spazio per una concreta prospettiva futura. È in quel momento, nella presa di coscienza del nostro effimero tempo, che vorremmo una risposta a tante domande, ma soprattutto a quella: perché la vita ha un termine e come sarà il dopo? Ovvio che non sempre avremo delle risposte, soprattutto per questo quesito fondamentale, ma è anche vero che è l’occasione per interrogarci, per trasporre magari in versi la nostra intima inquietudine, proprio come ha fatto Adriana Pedicini con questa silloge intitolata Il fiume di Eraclito, uscita di recente, ma, ahimè, non in cartaceo, ma come e-book. Dico ahimé poiché credo che il profumo della carta, lo scorrere dei fogli siano un elemento insostituibile e che costituiscano non tanto un corollario, ma la giusta base di partenza per leggere e gustare un’opera. Comunque, trattandosi di una silloge, composta da un certo numero di poesie, la lettura risulta meno disagevole visto che é indubbiamente meno faticosa di quella di un romanzo in formato elettronico. Già il titolo mi ha incuriosito e allora ho pescato nella memoria, cercando di focalizzare l’opera di questo filosofo presocratico, per sua natura piuttosto criptico e mi è venuta in mente la correlazione fra il suo pensiero e il fiume. In buona sostanza, e questo lo sappiamo tramite Platone, Eraclito avrebbe detto:” che tutto si muove e nulla sta fermo" e poi confrontando gli esseri alla corrente di un fiume, avrebbe aggiunto che "non potresti entrare due volte nello stesso fiume" Che cosa significa? L’uomo non può fare la stessa esperienza due volte, poiché ogni entità, nella sua fittizia dimensione reale, è soggetta alla legge inderogabile del continuo mutamento. E pertanto non c’è alternativa alla morte e non è possibile che un essere vivente, venuto a mancare, abbia l’opportunità di morire ancora, perché ciò presupporrebbe una rinascita che per esperienza millenaria non si è mai verificata. Credo, pertanto, che il titolo sia abbastanza esaustivo dello spirito che ha animato le poesie della silloge, ma se la vita in queste condizioni può essere un’astratta e anche a volte reale sofferenza, proprio perché essa è una sola e irripetibile si deve viverla, cogliere le infinte occasioni e opportunità che può dare, al fine, in ciò parafrasando questa volta i versi di una mia poesia, di poter dire al termine che ogni minuto è stato degno di essere vissuto. Ma ciò non significa gioia di esistere, bensì di accettare consapevolmente il dolore di esistere, che può essere anche uno sprone per addentrarsi nel terreno nebuloso, ma gratificante della metafisica, cercando oltre il sipario dell’ignoto. Sì, la morte si sconta vivendo, diceva Sciascia, ma è anche vero che è un prezzo che tutti sono disposti a pagare. Le liriche, raccolte, permeate dello stile intimistico di cui ci ha abituato la Pedicini, pur nelle variegate espressioni, riflettono questa sofferenza interiore, che pur tuttavia, stemperata dalla ricerca di conoscenza, si tramutano in note di carezzevole malinconia. Ed è proprio questa capacità di smussare, di filtrare solitudini e ancestrali angosce, che consentono di comprendere e godere i versi che in pacato ritmo, quasi un adagio, scorrono, come il fiume di Eraclito, davanti ai nostri occhi. Da leggere, mi sembra ovvio.
Adriana Pedicini, vive
a Benevento. Già docente di lettere classiche nei Licei, scrive da
tempo, ma solo con la pensione ha iniziato a dare concretamente
visibilità alla sua scrittura. Ha pubblicato una raccolta di
racconti I luoghi della memoria, A. Sacco editore 2011, (1°
Premio nel Concorso Internazionale di Narrativa Taormina 2010) e una
silloge di poesie, Noemàtia, Lineeinfinite edizioni 2012. Tra
esse figura la poesia Mare Monstrum,I° premio al Premio
internazionale di poesia Otto milioni 2013, assegnato dal Comune
diTorrenova (Me). Ha anche curato Da Europa all’Europa (Ilmiolibro.it 2010),
dispense didattiche sul teatro antico e sull’origine della civiltà
occidentale, attraverso il mito di Europa e gli archetipi del
pensiero, del diritto, dell’arte, della letteratura. È presente con
poesie e racconti su varie antologie anche on-line. Collabora con
diversi blog e siti letterari. Inoltre ha pubblicato la silloge
Sazia di Luce (Il Foglio Letterario, 2013).l Per
contatti: adripedi@virgilio.it
18/6/2015
L’ultimo ballo di Charlot di Fabio Stassi
Sellerio Editore
Narrativa romanzo
La vita romanzata del famoso “vagabondo” L’ultimo ballo di Charlot è uno di quei libri che si leggono con piacere e vengono incontro a diverse aspettative: c’é chi desidera conoscere la vita di Charlie Chaplin e verrà accontentato con una bella biografia, per quanto sia romanzata; ci sono quelli che apprezzano molto i toni poetici e lirici e qui ne trovano un bel po’; ci sono infine coloro che sono sensibili ai problemi delle disuguaglianze sociali, alle miserie che da sempre affliggono il nostro mondo e pure essi saranno soddisfatti. Stassi in effetti ha scritto un’opera dai molteplici aspetti, inserendo nella biografia di Charlie Chaplin una vena di fantasia accompagnata da toni romantici, insomma per dirla breve ce n’è in abbondanza affinchè questo libro possa raggiungere e interessate variegate tipologie di lettori. Se é originale l’invenzione della morte che concede una dilazione alla dipartita purchè Chaplin la faccia ridere, c’è anche il mondo estremamente interessante del circo e del nascente cinema che riescono a dare il quadro di un’epoca in rapida evoluzione e in cui progressivamente viene sostituita la realtà effettiva con quella virtuale. Lo stile dell’autore è snello, per nulla greve, la sua capacità di ricostruire ambienti e atmosfere è fuori discussione, perfino la struttura dell’opera è riuscita, con questa sorta di autobiografia con cui Charlie Chaplin, in una lunga lettera, narra la sua vita al figlio minore l’ultimo Natale della sua vita, ultimo perché è consapevole del fatto che la morte questa volta non riderà e che quindi lo porterà via con sé. In tutta sincerità mi sono accorto che, mano a mano che procedevo nella lettura, si accompagnava al piacere un vago senso di corroborante serenità; inoltre ero teso di continuo ad andare avanti, a mettere dietro di me un bel po’ di pagine, pur sapendo che l’ora della morte del protagonista si avvicinava e con essa la fine del romanzo. Ero quasi tentato di gridare al capolavoro, preso com’ero in un turbine di sentimenti che l’opera mi aveva sollecitato, se non che l’ultimo appuntamento con la Morte mi ha risvegliato da questo bellissimo sogno, tanto è incongruente e spiazzante il finale, di chiara ispirazione esoterica in un romanzo peraltro non impostato in tal senso e quindi, a mio avviso, fuori luogo. Mi è sembrato come una pessima cravatta su un abito di eccellente confezione, ma quel che è peggio mi ha indotto a riconsiderare l’intera opera, con il risultato che ho rivisto il mio giudizio e così, secondo me, non si tratta senz’altro di un capolavoro, ma solo di un libro di buona fattura che sembra scritto proprio per venire incontro a ciò che i lettori chiedono. Quindi c’è un aspetto commerciale – che è giusto che ci sia -, ma che mi sembra preponderante, tanto che a ripensarci a mente serena posso solo dire che mi sono sì divertito, ma che in fin dei conti questo romanzo non ha aggiunto nulla di nuovo alla mia conoscenza, non mi ha stimolato riflessioni su temi importanti, in pratica ho lamentato che non ci siano opportuni approfondimenti. Di conseguenza è finito con il rimanermi dentro solo il piacere di averlo letto, che comunque non è poca cosa, ma che influisce inevitabilmente sulla valutazione complessiva; é insomma un buon libro, ma nulla di più.
Fabio Stassi
è autore di Fumisteria (GBM 2006, Premio Vittorini per il
miglior esordio), È finito il nostro carnevale (2007), La
rivincita di Capablanca (2008), Holden, Lolita, Zivago e gli
altri (2010), pubblicati da minimum fax. Con questa casa editrice
ha partecipato nel 2009 all’antologia Articolo1. Racconti sul
lavoro, ha scritto L’ultimo ballo di Charlot, in
traduzione in diciassette lingue (secondo classificato al Campiello
2013, Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave,
Premio Alassio), e ha curato l’edizione italiana di Curarsi con i
libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013)
14/6/2015
L’angioletto
Edizioni Adelphi
Narrativa
romanzo Lo stupore di vivere Devo ammettere che per la prima volta mi trovo in difficoltà nello scrivere una recensione e la circostanza mi stupisce ancora di più perché il romanzo di cui dovrei dissertare mi è piaciuto immensamente, forse anche troppo. Sarà per quel suo sapore di favola con la sua bella morale (la bontà intrinseca di un individuo alla lunga riesce a far superare tutte le difficoltà che si incontrano in una vita), sarà perché l’autore usa una prosa altamente raffinata che in più di un’occasione raggiunge vertici poetici, resta comunque il fatto che non mi riesce facile definire il protagonista, Louis Cuchas, che all’inizio vediamo bambino in un povero appartamento, ove dorme su un pagliericcio, accostato a quello dei suoi fratelli, tutti figli di padri diversi, di amici occasionali di una madre che fa l’amore con l’uomo di turno nell’unico vero letto, isolato dal resto della famiglia da un rozzo telo, in cui, un buco, permette a Vladimir, il più grande, di vedere tutto. Si inserisce qui una delle più belle pagine che mi sia capitato di leggere, con il “guardone” che si fa fare dalla sorella Alice una fellatio, così come entrambi hanno appena visto. Il bello è che nella narrazione di Simenon non c’è nulla di sconcio, né di morboso, e appare come un fatto del tutto naturale, data l’età dei protagonisti e l’ambiente povero e degradato in cui vivono. Ma torniamo a Louis, un bimbo che si sazia ogni momento di quanto può dare la vita, come una goccia d’acqua che scorre in un giorno di pioggia sul vetro della finestra, oppure osservando il negoziante di scarpe della bottega di fronte. Mai scontento, anzi beato, lui si accontenta del poco che ha a disposizione e, soprattutto, come lo sarà sempre, è in pace con se stesso. Piccolo di statura, certamente non robusto, a scuola si lascerà picchiare dagli altri, sempre con quel suo sorriso enigmatico e senza mai denunciare gli aggressori all’insegnante, ed per questo che è soprannominato l’angioletto. Vuole molto bene ai suoi familiari, ma ciò non toglie che le disgrazie non lascino in lui alcun segno, come quando muore la sorellina più piccola, oppure quando cade in combattimento, nel corso della prima guerra mondiale, un fratello. Louis è un artista, un amante della pittura, vista più che come fonte di guadagno (al denaro non da importanza) come realizzazione del mondo interiore in cui vive. Passeranno gli anni, diventerà uno dei più grandi pittori del secolo, ma lui non cambierà. Non ci saranno lutti o guerre che possano scalfire quella corazza che si è costruito e che racchiude ogni suo stupore. E a chi, ormai vecchio, gli porrà la domanda: “ Maestro, posso chiederle qual è l’immagine che ha di se stesso?”, risponderà, senza che sia necessario che rifletta a lungo. “Quella di un ragazzino.”. Ecco, in questa risposta sta tutto lo spirito di quest’uomo, a metà fra un santo e un genio; la vita è talmente bella e può dare tanto, basta saperlo cogliere. E Louis, da quando ha aperto gli occhi nella culla, ha raccolto a piene mani, cose anche che possono sembrarci di poco conto, ma che nella sua mente sono diventate un’inesauribile fonte di conoscenza, una serie di scoperte accolte con stupore e piacere, che hanno fatto di lui un essere del tutto sereno, quella serenità che mi ha pervaso, pagina dopo pagina, e che arrivato all’ultima mi ha fatto quasi gridare:”Questo romanzo è un grande capolavoro!!. Perché lo é, però? Perché ci serve su un piatto d’argento, ma che dico, di platino, il ritratto di un essere che non può esistere, ma che tutti ci illudiamo prima o poi di incontrare. Da leggere, senza il minimo dubbio..
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
7/6/2015
Il Golem a cura di Anna M. Baiocco
Tre Editori Narrativa romanzo Viaggio nell’inconscio Gustav Meyrink, il cui vero nome era Gustav Meyer, è stato un narratore nativo di Vienna diventato famoso grazie alla sua opera esoterica Il Golem, che ha preso spunto da una antica leggenda ebraica in cui una sorta di figura antropomorfa chiamata Golem (dall’ebraico gelem che significa materia grezza) può essere fabbricata da un ammasso di argilla da chi è a conoscenza della Kabbalah, ottenendo così un servo gigantesco, forte e ubbidiente, ma privo di anima. Tuttavia Il Golem di Meyrink è ben diverso e se quello della leggenda ricorre nei momenti di maggior bisogno del popolo ebraico, come simbolo protettore per fugare le paure, nel romanzo non c’è una specie di robot, bensì un viaggio onirico nell’inconscio. Pure la vicenda è ben diversa, pur restando quello spirito di fantasia della tradizione ebraica del Golem, e infatti si tratta sostanzialmente di un fantasma che con periodicità si aggira per il ghetto di Praga, creando scompiglio e sgomento fra i suoi abitanti. L’atmosfera che permea le pagine di questo libro è una di quelle che ben difficilmente si dimenticano, in quanto surreale e onirica al tempo stesso, in una contrapposizione fra sogno e realtà, con visioni, misteri e sdoppiamenti che possono anche spiazzare il lettore se la sua attenzione non è ben salda e che comunque rappresentano un percorso, un viaggio dentro l’inconscio. Come ben precisa la traduttrice Anna M. Baiocco nella sua preziosa e oserei indispensabile introduzione, la cui lettura mi sento vivamente di raccomandare onde comprendere meglio poi il romanzo stesso, la figura del doppio, ben presente nell’opera, è secondo gli insegnamenti dello yoga e a quanto scritto nella cabala, un corpo astrale, cioè puramente spirituale, indistruttibile e che quindi sopravvive alla morte. Peraltro, onde anche meglio comprendere l’elevata valenza di questo romanzo, vi è da dire che le intenzioni di Meyrink non erano tanto di stupire e di sconvolgere, come fine frequente della narrativa gotica, ma il suo Golem non è altro che l’artificio di cui si serve per delineare il percorso interiore della conoscenza. Si tratta quindi di un vero e proprio viaggio, sovente doloroso, nell’inconscio, in cui ansie e paure si materializzano per poi smaterializzarsi in un confronto, non sempre incruento, fra ciò che crediamo di essere e ciò che invece progressivamente ci viene rivelato lungo questo percorso che si può considerare una specie di autoanalisi. Benché lo stile non sia greve come quello di non pochi narratori mitteleuropei dell’epoca, la struttura risulta particolarmente complessa e quindi, come ho precisato più sopra, la lettura richiede la massima attenzione, perché implica che non ci si fermi solo al senso letterario, ma che anche noi si proceda senza remore in questo viaggio che in realtà di fantastico ha solo lo stupore che possiamo avvertire mano a mano che la scoperta prosegue. L’opera é indubbiamente complessa, ma a onor del vero l’aggiunta di note chiarificatrici a piè di pagina (una novità assoluta di questa edizione non solo in Italia, ma anche all’estero) aiuta non poco a risolvere dubbi e difficoltà di interpretazione. Quindi, mi pare evidente che Il Golem sia senz’altro meritevole di essere letto e che possa così costituire il supporto indispensabile per procedere noi stessi in questa stupefacente ricerca dell’aspetto più nascosto, ma più veritiero, di noi stessi. Da ultimo, il volume risulta arricchito da pregevoli illustrazioni di Hugo Steiner-Prag, che sanno puntualmente interpretare il senso dell’opera, contribuendo a un’ulteriore definizione dell’atmosfera che vi aleggia. Gustav Meyrink (1868-1932) fu uno dei più famosi scrittori del suo tempo. 'Il Golem', il suo libro di maggior successo, è la pietra angolare di un percorso volto a tracciare una via di conoscenza attraverso la divulgazione letteraria di profondi temi magici ed esoterici. Tra le opere principali figurano 'Il domenicano bianco', La Notte di Valpurga', Il volto verde', 'L'angelo della finestra d'occidente'.
Anna M. Baiocco insegna
lingua italiana all'Università di Economia di Vienna e studia da anni
il mondo di Meyrink.
Ha già
curato la
traduzione de 'Il domenicano bianco' (Tre Editori) e de 'La morte
viola' (Reverdito).
4/6/2015
Bollettino di guerra
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Senza infamia e senza lode Comprendo che l’editore, a fini pubblicitari, cerchi di osannare il suo libro, ma, almeno in questo caso, accostarlo a quel grande capolavoro che è Niente di nuovo sul fronte occidentale mi sembra francamente un po’ troppo. Intendiamoci, non è che Bollettino di guerra sia un’opera pessima o mediocre, perché se si vuole comprendere quello che fu la Grande Guerra per chi vi prese parte va più che bene, ma manca di indispensabili qualità per poterlo definire uno dei migliori resoconti letterari su quel conflitto. Koppen fu uno dei milioni di protagonisti di quell’immane macello e della sua esperienza ne parla diffusamente e con dovizia di particolari; quello di cui è carente è il talento letterario, così che Bollettino di guerra finisce con il diventare uno dei tanti scritti, interessanti senz’altro, ma di poca caratura, che non pochi reduci pensarono di stilare, per ricordare a se stessi e per far conoscere ad altri. Al fine di dargli la parvenza di un romanzo e non di un’autobiografia l’autore si è inventato un personaggio, un volontario in quella guerra nell’arma dell’artiglieria: Adolf Reisiger. Costui, giovane studente imbevuto di retorici concetti e naturalmente ardimentoso data la sua età, decide di arruolarsi e viene assegnato a un reggimento di artiglieria leggera, il che gli consentirà di non provare le angoscianti sensazioni del povero fante immerso nel fango delle trincee, limitandogli anche i pericoli, rivenienti per lo più dai tiri di controbatteria. Agli inizi sembra quasi un gioco, ma con il trascorrere del tempo finirà con l’accorgersi che onore e patria, per come gli sono stati inculcati, sono parole vuote e che lì, sul fronte occidentale, non si è altro che dei numeri, della carne fresca da avviare al macello. È evidente, pertanto, il motivo per il cui libro, pubblicato nel 1930, fu ben presto proibito dai nazisti, guerrafondai per natura e che perciò non potevano consentire che la loro retorica venisse smascherata dalla realtà. Di tanto in tanto, nella narrazione, ci sono degli intercalati costituiti da bollettini di guerra, da comunicati ufficiali, da articoli di alcuni giornali tedeschi, tutte notizie che presumo possano essere autentiche e che servono soprattutto a rendere più stridente la discrasia fra il roboante linguaggio dei sostenitori della guerra e la tragica realtà della stessa. Tuttavia, a volte l’inserimento non è così felice e fa calare un ritmo già di per sé un po’ troppo blando. Sarebbe stato meglio, forse, che Koppen avesse provveduto a degli approfondimenti sugli stati d’animo, su quell’ancora di salvezza che è il cameratismo che si instaura quasi obbligatoriamente fra i compagni di sventura, magari accompagnandoli da riflessioni sulla condizione umana, in particolare quando di fatto si è obbligati a uccidere. La lettura è comunque abbastanza piacevole e non mancano episodi di interesse, come una bella descrizione di un assalto francese alle trincee tedesche. Nel complesso, tuttavia, benché non ci sia un’esaltazione della guerra, ma una sua decisa condanna, il libro, per come è scritto, appare più come un articolo giornalistico che come un’opera letteraria e ciò è indubbiamente un limite, perché, dato l’argomento, si sarebbe potuto e dovuto fare di più, ma è evidente che il talento letterario è qualche cosa di innato e che comunque non rientra fra le caratteristiche di Koppen, che è solo un onesto e corretto memorialista di quella fu una sua devastante esperienza personale.
Edlef Koppen
(Genthin 1893 - Giessen 1939), figlio di un medico condotto a
Potsdam, partì volontario nel 1914 per il fronte francese,
abbandonando lo studio di Lettere e Filosofia a Monaco. Più volte
ferito, promosso sul campo, al termine della guerra fu rinchiuso in
ospedale psichiatrico evitando così la corte marziale. Congedato nel
1918, terminò gli studi e lavorò prima come redattore, traduttore,
editore, divenendo quindi responsabile delle trasmissioni letterarie
per la prima radio tedesca di Berlino. Licenziato all'avvento del
nazismo, morì dopo sei anni per i postumi delle ferite riportate in
guerra.
31/5/2015
Corviale cerca poeti a cura di Carla De Angelis e Antonio Trimarco
Fuorilinea Edizioni Poesia Antologia
Nel corso delle mie letture non è raro il caso che mi imbatta in volumi che sono delle vere e proprie antologie poetiche e che mi vengono inviati dai curatori o dall’editore confidando in un po’ di pubblicità e magari in una mia recensione. Per lo più di tratta di iniziative editoriali che contano sull’acquisto del libro da parte degli autori ivi pubblicati e in questo caso c’è un po’ di tutto, vale a dire accanto a testi per lo più modesti è possibile tuttavia trovarne qualcuno interessante. Altre volte il volume è invece il risultato di un concorso di poesia e in questo caso la qualità media è migliore; altre ancora, più sporadiche, sono il frutto di iniziative culturali, come è il caso appunto di Corviale cerca poeti. Ma, Corviale chi è? Si tratta di un quartiere di Roma, un po’ degradato, casermoni ove vive gente stipata, una sorta di periferia emarginata di una grande città. È però qui che ogni anno si svolge un piccolo grande festival della poesia, con il preciso intento di ribadire che la cultura e la passione per l’arte non sono caratterizzati da un luogo, ma dalle persone, da chi magari vive in quel luogo. Ciò premesso e nello scusarmi se mi sono dilungato, ma mi è parso necessario per comprendere lo spirito di questo libro, ritengo doveroso passare all’analisi critica dello stesso. Gli autori, alcuni a me noti, e le poesie sono in buon numero, ma non è questo elemento che valorizza, bensì i contenuti. Premetto ancora, e credo che buona parte del merito vada ai curatori, che mi sono trovato di fronte a poesie di buon livello qualitativo, soprattutto senza alti e bassi, cioè senza che vi siano testi di particolare rilievo e altri mediocri. Certo il tema era libero e come tale consente di poter dare il meglio di se stessi, ma se la capacità intrinseca dell’autore è assente i risultati finiscono con l’essere modesti, e questo non è proprio il caso. Nel leggere sono rimasto sempre soddisfatto, a volte di più, a volte di meno, e in ogni caso mai indispettito e invece continuamente interessato. Posso dire, e non temo di sbagliare, che è un’ottima antologia, caratterizzata da stili, pur diversi, ma comunque sempre armonici, con tematiche svolte con acume e senza leziosità. A voler parlare di ogni singola poesia rischierei di oltrepassare il limite logico di pagine per una recensione e allora preferisco limitarmi a una che più mi ha colpito (ma assicuro che la scelta non è stata facile, poiché tante mi sono rimaste impresse). Sarà per il mio viscerale amore per la natura, per descriverla pure io in numerose liriche, ma alla fine la scelta è caduta su Alberi, di Chiara Mutti, tratta peraltro da La fanciulla muta (Lepisma, 2012). “Ondeggiano, / spolverano il cielo / con le cime, e stanno / confitti come aghi nelle vene / i nostri padri. / Eppure lieve / è il loro stare / cuciti, come trine, / agli angoli del vento. / Infondono, nel sogno / infinitesimo di umani / l’ultimo respiro / degli dei.”. A parte la visione d’insieme che pone davanti agli occhi un bosco, un insieme di alberi, ci sono degli inserimenti che impreziosiscono il testo senza che si tratti di esibizioni di virtuosismo, ma che servono meglio a delineare e a supportare lo svolgimento, come quel passo “ cuciti, come trame. / agli angoli del vento”, con cui si evidenzia la forza muta e arcaica di questi vegetali, concetto che si rafforza nella riuscita chiusa. Ma non posso fare a meno di sottolineare l’effetto visivo che deriva dal verso “spolverano il cielo”, una trovata riuscitissima che mi ha incantato. Si potrebbe dire altro delle poesie di questa raccolta antologica, come per esempio del ritmo corretto riscontrato in ogni testo, ma in fin dei conti credo che sia più importante che evidenzi il grado di soddisfazione, assai ampio, che ho ritrovato arrivato all’ultima pagina, a cui hanno contribuito non solo Alberi, ma anche tutto gli altri componimenti. Chiuso il libro, mi sono sentito pervaso da un senso profondo di serenità e credo che se prima di leggere vedevo un quartiere malato e grigio, poi mi è apparso diverso, pervaso da una luce soffusa e delicata che lo ha trasformato in un’oasi di mistica bellezza.
Gli autori
28/5/2015
Come sasso nella corrente
Arnoldo Mondadori Editore Spa
Più che un sasso, un macigno Ho l’impressione che Mauro Corona stia invecchiando troppo rapidamente, perché altrimenti non si spiegherebbero in altro modo libri come La voce degli uomini freddi e questo Come sasso nella corrente, opere che, per quanto diverse, segnano a mio avviso un calo della creatività e, soprattutto, un accentuarsi di qualche difetto che prima invece era quasi sporadico. Inoltre, c’è una tendenza più marcata a cercare di assomigliare a Mario Rigoni Stern. Ma le differenze qualitative fra l’autore ertano e quello di Asiago anziché smussarsi, vanno accentuandosi. La cosa non mi stupisce, perché pur rientrando Mauro Corona fra i miei autori preferiti, non ha purtroppo la genialità di Stern ed è così solamente - ma non è poco anche ciò . un narratore di ottimo livello. Già avevo stigmatizzato La voce degli uomini freddi, incredibilmente candidato al Premio Campiello, e ora non posso fare a meno di essere scontento di Come un sasso nella corrente, una sorta di lascito dell’autore, che è una via di mezzo fra la necessità di volgersi all’indietro e fare un bilancio della propria esistenza e un memoriale, con cui ripercorrere il passato dandogli ordine. L’inizio, a essere sincero, mi ha folgorato, con un ritmo giustamente lento e un quadro, in cui sono più gli scuri che i chiari, e che può far ricordare certe opere dei pittori fiamminghi del rinascimento. Tuttavia, pagina dopo pagina, pur in presenza di accenni poetici, la scrittura è diventata sempre più verbosa, con la presenza di similitudini non sempre felici, tanto che in me è subentrato un senso di noia. L’assenza di dialoghi, poi, non fa che peggiorare la situazione, così che diventa sempre più difficile andare avanti, anche perché ho ricavato l’impressione che Corona gridi questa sua verità a un muro e non al lettore stesso. Fino a che punto sia stato sincero non lo so, ma mi resta più di un dubbio e questo non giova a un’opera in cui l’autore dovrebbe aprirsi, anche sfacciatamente, al mondo. Credo di non essere la sola voce fuori dal coro, anche se non pochi hanno visto questo libro come qualche cosa di grandioso, quasi un unicum, tanto da considerarlo irripetibile. Resta comunque il fatto, e credo che questo giudizio sia difficilmente contestabile, che in Corona si assiste da un po’ di tempo a un’accentuata involuzione, come se oltre a non aver più nulla da dire, continuasse a scrivere più per se stesso che anche per i lettori. Si spiegherebbe così come mai un narratore che fra le sue caratteristiche aveva anche quella di una straordinaria leggerezza di esposizione sia diventato greve come un macigno, al punto tale che non mi sento di consigliare la lettura del libro, soprattutto a chi vuole accostarsi a questo autore, perché altrimenti l’impatto potrebbe essere tale da non far desiderare di leggere altre sue opere, quelle di un non lontano passato, molto delle quali sono invece più che meritevoli di considerazione.
Mauro Corona è
nato a Erto (Pordenone) nel 1950. È autore diIl
volo della martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Gocce
di resina, La montagna, Nel legno e nella pietra, Aspro e dolce,
L'ombra del bastone, Vajont: quelli del dopo, I fantasmi di pietra,
Cani, camosci, cuculi (e un corvo), Storia di Neve, Il canto delle
manére, La fine del mondo storto (premio
Bancarella 2011), La
ballata della donna ertana, Come sasso nella corrente, Venti racconti
allegri e uno triste, Guida poco che devi bere: manuale a uso dei
giovani per imparare a bere, La voce degli uomini freddi (finalista
premio Campiello 2014),Una
lacrima color turchese e
delle raccolte di fiabe Storie
del bosco antico e Torneranno
le quattro stagioni. Ha pubblicato inoltre La
casa dei sette ponti (Feltrinelli,
2012) e Confessioni
ultime (Chiarelettere,
2013).
25/5/2015
La guerra bianca.
Il Saggiatore Edizioni Storia Grande Guerra, grande libro “<<Le trincee dove sono?>> domandò un ufficialetto appena arrivato sul San Michele. <<Trincee, trincee…>> fu la risposta laconica. <<Non ci sono mica, trincee, ci sono dei buchi.>>” Siamo abituati a leggere spesso libri di storia, magari assai validi, ma che costringono a procedere con difficoltà, per i continui richiami o rimandi, per quella meticolosa pignoleria che è propria del ricercatore, dell’uomo che cerca fra le carte un po’ più di verità. Si resta stupiti, quindi, quando ci si trova per le mani libri come La Battaglia. Storia di Waterloo, di Alessandro Barbero, oppure questo La guerra bianca, di Mark Thompson, testi che si leggono con facilità e con piacere, opere che pur essendo dei saggi storici sono scritte come romanzi, dei bei romanzi, con quella stessa scorrevolezza, capacità di ricreare l’atmosfera e l’ambientazione, con un ritmo equilibrato che quasi ti obbligano a non procedere a tratti, ma ti invitano a proseguire, ad andare avanti ai capitoli successivi per arrivare, purtroppo abbastanza presto, alla fine. E sì che il saggio di Thompson non svela nulla di nuovo, perché sulla prima guerra mondiale e, nel caso specifico, su quella che ci ha visto opporci all’Austria, in quasi un secolo hanno scritto a iosa; eppure La guerra bianca risulta di grandissimo interesse, perché l’autore, con uno stile fresco e mai greve, ci racconta tutto di questo conflitto, dalla nostra fase di non belligeranza fino alle discussioni del Trattato di Versailles, passando per le undici battaglie dell’Isonzo e anche per la dodicesima, quella della famosa ritirata di Caporetto. Considerato che l’autore è inglese temevo, a torto, il suo tono di sufficienza nei nostri confronti, ma se le sue critiche sono puntuali e forti per la condotta dei nostri comandanti, sono invece più blande, anzi direi sovente che si tratta di apprezzamenti per il comportamento dei nostri soldati, gli umili fantaccini mandati al massacro senza che loro sapessero il perché, o al più gli si diceva per liberare Trento e Trieste, località che in un Italia ben poco alfabetizzata erano ai più sconosciute. La strategia e le tattiche del comandante in capo, Cadorna, sono ben descritte ed è apprezzabile il tentativo di farne un’analisi psicologica, più che mai necessario trovandoci di fronte a un criminale che non aveva nessun rispetto per le sorti dei suoi soldati. Infatti, continuava imperterrito a concertare attacchi frontali, senza nessun senso, e nemmeno impressionato dalle ingenti perdite; del resto anche lui contribuiva direttamente af aumentare il numero dei morti, imponendo ai suoi ubbidienti sottoposti l’applicazione di condanne capitali, anche per reati di poco conto. Il soldato italiano, sotto Cadorna, era male equipaggiato, ben poco nutrito, considerato alla stregua di uno schiavo e quindi non c’è da meravigliarsi se nell’episodio di Caporetto ci furono degli sbandamenti, in buona parte giustificati dall’incapacità dei nostri generali a organizzare una difesa e spesso più lesti a scappar via; è però vero che molti reparti fecero il loro dovere fino in fondo, immolandosi sul campo per arginare l’avanzata nemica. Appaiono quindi immeritate, direi blasfeme le parole del proclama di Cadorna con il quale si scaricò dalle numerose colpe, imputando i nostri soldati di vigliaccheria, un comportamento il suo che la dice lunga sui suoi problemi mentali. Poi, sappiamo che con Diaz, forse non un grande stratega, ma comunque un abile organizzatore, le cose andarono meglio e si arrivò al trionfo di Vittorio Veneto, e con esso all’armistizio di Villa Giusti. Gli argomenti di cui ci narra Thompson sono tanti (ci sono perfino quelli dei poeti e letterati al fronte, nonché il periodo in cui gli austriaci, dopo Caporetto, imperarono su parte del veneto, con grandi tribolazioni della popolazione) e ce n’è per tutti i gusti, in ogni caso svolti in modo semplice e accattivante. A proposito del titolo questo può trarre in inganno, perché il pensiero corre immediatamente ai teatri dolomitici, come i ghiacciai dell’Adamello e della Marmolada, e invece della guerra in montagna, senz’altro meno importante, il libro ne parla assai poco, fatta eccezione per la famosa Strafexpedition, o Battaglia degli altipiani. In questo libro, invece, si tratta diffusamente della guerra combattuta sul Carso, con le sue rocce sbiancate e le montagne intorno completamente innevate in inverno. Molto opportunamente l’autore evidenzia alla fine dell’opera le fonti da cui ha attinto le notizie e non sono certo poche (un elenco di ben 18 pagine), testi i cui autori sono italiani e stranieri. Fra i primi troviamo Mario Isnenghi, uno dei nostri più noti e appezzati storici che tanto ha dissertato sul tema della Grande guerra, ma non mancano anche pubblicazioni di parti in causa, come i generali Luigi Capello e Luigi Cadorna, e fra gli stranieri un nome autorevole: Denis Mack Smith. La guerra bianca è un libro che merita ampiamente di essere letto e che consiglierei fosse adottato anche nelle scuole, affinchè gli alunni abbiano una visione realistica di quella che fu la Grande guerra, con il preciso intento di inculcare in loro la vocazione per la pace e il rispetto per la vita di ogni essere umano.
Mark Thompson
letterato e storico,vive e lavora a Oxford. Ha collaborato a lungo
con l’Onu nei Balcani. È traduttore dall’italiano di Umberto Saba e
Claudio Magris.
22/5/2015
Il
borgomastro di Furnes
Narrativa
romanzo Non si può sfuggire al proprio destino Joris Terlinck è il potente e temuto borgomastro di Furnes, un paese fiammingo. È un uomo venuto dal niente, di umile estrazione sociale, che è riuscito a farsi una posizione in modo poco chiaro e sicuramente non onesto, non proprio quello che ci si aspetterebbe da un individuo che atteggia la sua vita a una intransigente rettitudine. Ma si tratta solo di una facciata in un’esistenza segnata da una grettezza che tende a rendere Terlink un amorale, condotta in modo noioso, perché sempre uguale, senza autentici affetti, perfino fra le mura di casa in cui vegetano una moglie succube e malata, una figlia demente, perennemente segregata in una camera, e una domestica, che a suo tempo è stata l’amante del borgomastro. Tutto procede secondo un copione grigio e monotono, senza sussulti, ma è che è l’ideale per un uomo che vuole sancire la sua presenza come segno di potere, fino a quando in questo muro impenetrabile si apre una crepa. Ed è solo l’inizio, a un evento ne segue un altro, un altro ancora, e sarebbero l’occasione per dare una sterzata alla vita di Terlink, per farlo uscire per sempre da quella sua armatura volta a celare una corrosiva insoddisfazione che sfoga maltrattando gli altri. Ma l’uomo non coglierà l’occasione, non uscirà dal personaggio che si è costruito e la sua monotona vita tornerà a scorrere, come prima. E così rientrerà nel suo mondo, immutabile, in una commedia della vita di cui gli attori sono sì artefici, ma anche succubi. Non ci si può opporre al proprio destino, sembra dirci Simenon, così come, affinchè tutto funzioni alla perfezione, non si può mutare il proprio ruolo, e chi arriva a farlo, come Terlink, diventato da povero a ricco, deve più di tutti contribuire a che questo equilibrio non sia turbato, e lo può fare solo in un modo, vale a dire forzando la propria natura in un’esistenza di potere, ma anche di squallore. È ancora una volta confermata la straordinaria abilità di Simenon di sondare in modo pressoché perfetto l’animo dei personaggi, la sua è una fine analisi psicologica che non finisce mai di stupire, ma se l’ambientazione e l’atmosfera sono rese come sempre al meglio, quello che questa volta è invece criticabile è lo stile adottato, non quello fluente di tanti suoi romanzi, bensì una certa lentezza, accompagnata a volte da ripetitività, che appesantiscono non poco, rendendo la lettura meno piacevole del solito. Comunque, non è che questa mia critica possa inficiare il valore dell’opera che è invece di tutto riguardo, anche se, purtroppo, questo romanzo si presenta meno avvincente di tanti altri del narratore belga.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a
Jean Pauhlan, da Faulkner a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
17/5/2015
Orme intangibili
Prefazione di Vincenzo D’Alessio
Fara Editore
Collana Il filo dei versi Lungo la strada Che lo vogliamo o no noi viviamo la nostra esistenza come il percorso lungo una strada in una serie di esperienze che ci portiamo poi appresso e quella poetica è sola una di queste, anche se non la meno importante. Ci si può incontrare con altri de visu, ma anche partecipando il nostro essere in versi, sviluppando concetti e riflessioni che in chi li legge finiscono con il restare impressi come un’orma, per quanto intangibile. Ed è di questo che parla questa nuova silloge di Alessandro Ramberti, di queste orme che si fissano all’anima. L’opera è anche frutto della religiosità, non certo di maniera, dell’autore e questa si esprime in modo insolito, secondo una complessità semplice, un ossimoro per dire che a priori è necessario accettare l’impostazione dell’autore, in un opera breve, ma dal contenuto consistente, in cui avviene un vero e proprio convivio letterario a cui partecipano personaggi del passato, come Kant, Camus e Santa Teresa di Lisieux. C’è posto anche per il presente, soprattutto quando questo è costituito da un pontefice come Franesco, simbolo di una Chiesa che guarda alla religione che rappresenta, ma che non tralascia di battersi, in attesa della giustizia divina, per quella terrena. Non saprei dire se i versi di questa raccolta vengono a compendiare un concetto filosofico, o uno teologico, poiché il vivere secondo un credo religioso non è in contrasto con un concetto dell’esistenza che sia a dimensione dell’uomo, in pace con se stesso e con gli altri. In effetti lo spirito di Ramberti è assai vicino a quello di papa Francesco, perché comprende gli inevitabili dissidi fra la realtà esteriore e quella interiore, ma senza atteggiarsi a “magister” indica un percorso mistico che tutti possiamo trovare scavando dentro di noi fino al fondo dell’anima. Se guardiamo bene, se soprattutto ci astraiamo per un attimo dal contingente, il concetto che abbiamo di noi è misterioso, è tutto da scoprire e l’autore in questo ci aiuta, dandoci un metodo e un fine, in un’opera poetica in cui ciò che deve essere veramente osservato, rivoltato, analizzato è il contenuto. Non è forse il senso della vita che ogni tanto cerchiamo e che ci sfugge mentre stiamo per afferrarlo? Ecco, Ramberti ci fornisce gli strumenti: sta a noi volerli usare. Alessandro Ramberti è nato a Santarcangelo di Romagna nel 1960. Laureato in Lingue Orientali a Venezia, vince una borsa (1984-85) per l’Università Fudan di Shanghai. Nel 1988 consegue a Los Angeles il Master in Linguistica presso l’UCLA e nel 1993 il dottorato in Linguistica presso l’Università Roma Tre.
Ha vinto il premio “l’Astrolabio” con Racconti su un chicco di riso
(Tacchi Editore, 1991). Poesia: In
cerca (2004), Pietrisco (2006), Sotto
il sole (sopra il cielo) (2012).
Ha pubblicato come Johan Thor Johansson la puzzle-story La
simmetria imperfetta (1996)
e, con L’Arca Felice di Salerno, le plaquette Inoltramenti (2009)
e Paese
in pezzi? I monti e i fiumi reggono (2001,
nuova traduzione di 4 poesie di Du Fu). Gli è stata dedicata la Lettera
in versi n. 32 a
cura di Rosa
Elisa Giangoia.
È presente in antologie, riviste (un estratto di Orme intangibili è
inserito in ItalianPoetry Review,
VIII, 2013) e nel web.
15/5/2015 Recensione a cura di Antonio Magnolo di “Saro e altri racconti” di MARINO GIANNUZZO
Il testo “Saro e altri racconti” presenta al lettore otto frammenti di vita: alcuni brevi e concisi, “Gnazio, Buck, e Contrabbando”; altri con un intreccio più articolato “Le chiavi, Sfrattati, Tania, La giustizia di Tano” e infine “Saro” racconto lungo e, a ben ragione, da ritenersi romanzo breve. Otto contesti diversi, certamente, ma è possibile trovare un filo logico che li lega, al di là dei fatti narrati; il nesso va ricercato nell’ansia mai sopita di giustizia, nel desiderio di veder riconosciuto per tutti il diritto al rispetto, che si deve ad ogni persona umana. E Buck? Non è una persona, è un cane … ma ha i sentimenti di una persona. Intrappolato da “Le pareti” che “scendevano quasi a strapiombo nella cava, perché di cava di pietra si trattava: questo era evidente. Buck desiderò essere una rondine”. Sa di dover morire e l’ultimo sguardo è al cielo dove volteggiano le rondini; ora fisse, punti neri “stelle spente, vaganti per il cielo”. Il lettore si sente coinvolto da profonda emozione e commozione. Non sembra la condizione di un cane, sembra piuttosto la condizione di tanti diseredati stanchi per il peso del vivere; l’augurio che anche per loro l’ultimo sguardo abbia l’azzurro del cielo. In Gnazio, la caricatura di un losco sanguisuga vittima della sua spropositata ingordigia e del coraggio spregiudicato ed incosciente di “un giovane di circa vent’anni che io non conoscevo e ... Neppure l’esattore pareva conoscesse ...” In contrabbando l’intima soddisfazione, di un umilissimo Andrea, in cui il lettore si identifica, per esser riuscito con il suo ingegno a superare il controllo dei dazieri, “di tutto si trasportava, con mille sotterfugi, eludendo la vigilanza e i controlli degli uomini del dazio”, per portare a casa il necessario, in un tempo che la fame rodeva lo stomaco di adulti e bambini. Sorride Andrea per lo smacco di “quello che doveva essere il capo” per esser riuscito a sporcargli di “merda” l’incauto dito …, e sorride il lettore. “Le chiavi”, inappuntabile descrizione di rapporti di vicinato, spesso inveleniti da futili motivi, come il passaggio preteso/negato su una strada vicinale. I personaggi sono descritti attraverso i dati distintivi del loro carattere; i ritratti che il lettore si raffigura sono stupende caricature di personaggi che non è certo difficile ritrovarsi intorno. In “Sfrattati”, il contrasto di vizi e virtù che a diverso titolo recitano i vari attori in una scena purtroppo frequente, ora più che mai. Su tutti spicca la figura tragicamente losca di Carlo Brunella, vero responsabile … d’aver buttato sulla strada la povera madre; per fortuna l’astio del lettore termina quando “si udì la sirena della volante della polizia. Quando si dileguò non si udì più nulla: se l’erano portato.” In “Tania” la voglia crudele di vendetta per aver voluto a tutti costi trovare un colpevole a una disgrazia, … inchiodata su una sedia a rotelle, verso una sorella rea solo d’accudirla, di restarle a fianco; per il fatto di essere più bella ed essere quindi la preferita, la prescelta. A nulla valgono i vincoli di sangue quando l’odio come fuoco divampa, alimentato da invidia e gelosia che tutto divora. “La giustizia di Tano” racconta il dramma di un animo onesto, quello del protagonista. Tano ha perfettamente intuito che la morte della suocera in realtà è un omicidio perpetrato dal marito, Saruzzo, ma ha sbattuto la testa contro l’inefficienza della giustizia, contro l’ignavia del cognato Peppe, contro le paure della moglie Sabina timorosa per un presente in cui non mancano gli stenti … per essere pronta a scoprire laceranti inconfessabili segreti familiari. Toccherà a “Saro” spezzare le remore di preconcetti stilemi di vita. Se, infatti, in questi racconti vi è la rappresentazione di “Un mondo di “vinti” che fanno ricordare i personaggi verghiani” con Saro si approda ad altro grande narratore: Corrado Alvaro. Nel suo capolavoro, di “Gente in Aspromonte”, egli descrive vita e costumi di gente semplice, da sempre asservita, ma che riscopre il coraggio, il sapore dolce-amaro della rivolta e del riscatto. Ed anche il nostro autore, Marino Giannuzzo, non sembra immune a questo richiamo, al desiderio … che giustizia sia fatta. Già in “Gnazio” l’anonimo giovane si era ribellato, ma il suo era stato un gesto immediato, istintivo, di incoscienza … appunto. Ben diversa la vendetta di Saro, studiata e pianificata fin nei minimi particolari. Ed infatti Saro avrebbe potuto essere un personaggio del grande scrittore calabrese, Corrado Alvaro, non importa se ha preferito chiamarlo Antonello e non Saro. In entrambi i personaggi ritroviamo l’incarnazione del desiderio di giustizia della gente, la voglia di dire - basta ai soprusi! -, con la decisione di farsi giustizia da sé. Sembra di rileggere l’auspicio messo in bocca ad Argirò, padre di Antonello eroe della rivolta in Aspromonte: - Qui in questo paese non c’è scampo per nessuno, con questi mariuoli che comandano. Bella rivincita che sarebbe per me, per noi tutti, che da casa nostra uscisse qualcuno che potesse parlare a voce alta, e li mettesse a posto. Come non leggervi anche il pensiero di Saro, desideroso di vendicare la morte del padre! Saro pagherà il suo prezzo, e assai salato. Per un momento di gloria vestirà i panni dell’eroe, da tutti osannato (ed è qui che il nostro autore si avvicina tanto ad Alvaro), salvo poi a pagar lo scotto di vedersi tradito dalla ragazza amata, Ilenia, e ancor peggio da Lucio, amico fratello, di un’intera vita (e qui ricompare prepotente Verga). E' difficile per il lettore estraniarsi dai fatti e dai personaggi, perché ciascuno si vedrà, anche solo in parte, rappresentato con gli alti e i bassi delle proprie vicende, parte infinitesima di un ingranaggio il cui nome è … vita.
Sogliano Cavour
01. 05 2015 Antonio
Magnolo
12/5/2015
Addio alle armi Arnoldo Mondadori Editore S,p.A. Narrativa romanzo Più amore che guerra Quest’anno, come noto, ricorre il primo centenario della Grande Guerra, che per l’appunto per noi avvenne con l’inizio delle ostilità fissato per il 24 maggio1915. Non è un caso quindi se in questo periodo leggo molti libri sulla prima Guerra Mondiale e fra questi non poteva mancare – ma trattasi di opera da me letta anni fa – Addio alle armi, di Ernest Hemingway, scrittore americano assai noto che pur tuttavia non stimo molto per quel suo stile troppo distaccato e certe tematiche che non mi sono appetibili. Di questo romanzo, pubblicato nel 1929, si è da più parti detto che è un’opera fra le migliori di quelle che trattano di questo grande evento bellico; personalmente non sono d’accordo, perché se è vero che l’epoca è quella prima, durante e dopo la ritirata di Caporetto, il conflitto rimane sullo sfondo e dubito perfino che in buona parte sia frutto di un’esperienza personale (Hemingway prese parte alla guerra come conducente di ambulanze) perché proprio in quello scorcio di anno 1917 lo scrittore americano, con ogni probabilità, non era ancora in Italia, così che abbraccio l’ipotesi di Fernanda Pivano secondo la quale di esperienza personale certamente si tratta, ma di quella maturata nel corso del 1922 durante la disastrosa ritirata greca dalla Tracia, in cui lui era presente. Del resto, non era forse nemmeno nelle intenzioni dell’autore di parlare di una fase della Grande Guerra, bensì di scrivere un romanzo d’amore ambientato durante la stessa, un po’ come nel caso di Via col vento. E in questo trovo conferma ancora una volta in Fernanda Pivano, la sua prima traduttrice, che fa giustamente presente che il titolo inglese (a Farewell to Arms) è sibillino e può dare luogo a un’altra traduzione, proprio per il doppio significato presente in Arms, che vuol dire armi, oppure braccia, intendendo in tal caso quelle della donna amata. Fra l’altro non c’è un lieto fine e quindi prende ulteriore forza quell’ipotesi di traduzione in Addio alle braccia. E anche per come la storia è imperniata e sviluppata potrei dire che per un romanzo sulla guerra è quasi fuori tema, tema che invece è ben centrato come vicenda d’amore, dagli esiti finali non certo positivi, come abitudine del narratore americano. Al riguardo ricordo un altro suo famoso romanzo (Per chi suona la campana) in cui chi muore non è però la donna, ma il suo amante. Ciò premesso, appurato che la guerra è solo uno sfondo, resta la storia di questo amore travagliato, sulla cui confezione non ho nulla da eccepire, fermo restando che lo stile un po’ troppo distaccato non è riuscito ad appassionarmi. Di conseguenza concludo dicendo che Addio alle armi è un buon romanzo, ma niente di più, anche se comunque è meritevole di essere letto.
Ernest Hemingway (Oak
Park, Illinois, 1899 - Ketchum, Idaho, 1961), tra i più grandi
scrittori anglosassoni del Novecento, ha ricevuto il premio Nobel per
la letteratura nel 1954.
Giornalista e corrispondente di guerra, ha partecipato alla guerra
di Spagna e alle due guerre mondiali. Amante dell'avventura, del
rischio, delle forti emozioni e della festa, ha vissuto tra l'altro a
Parigi e Cuba. È morto suicida.
8/5/2015
Gli occhi di Venezia Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa romanzo
La giustizia della Serenissima Già ho avuto modo di apprezzare Alessandro Barbero come storico, di cui ho letto due saggi: l’interessante e convincente 9 agosto 378 il giorno dei barbari e lo stupendo La battaglia Storia di Waterloo. Mi piacciono il suo stile semplice, ma non povero, la capacità di approfondire senza risultare greve e in generale quella dote non frequente, ma che fa la differenza, vale a dire la straordinaria attitudine a coinvolgere il lettore. Quando sono venuto a conoscenza del fatto che è anche autore di romanzi storici (con uno, Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo, ha vinto addirittura nel 1996 il Premio Strega) ho voluto immediatamente leggerne uno e la mia scelta è caduta su Gli occhi di Venezia, sia per il periodo – il XVI secolo, che per me di notevole interesse – in cui si svolge la vicenda, sia perché, come riportato nel risvolto di copertina, la storia é veneziana, cioè nasce nella città lagunare quando ancora l a Serenissima era una grande potenza mediterranea. Ebbene, non solo l’ho letto, ma si potrebbe anche dire che l’ho divorato, tanto è appassionante e quasi tiene incollato dalla prima all’ultima pagina (e le pagine non sono proprio poche, ma ben 434). Il Doge, il Consiglio dei Dieci, questo potere che ha ovunque occhi per perpetuarsi, i mille giochi segreti dei nobili che contano e che amministrano una ferrea giustizia francamente di parte occupano una parte non indifferente di questo volume, da cui esce l’atmosfera opprimente di una oligarchia che a Venezia fa il bello e il cattivo tempo. Sono rari i condannati delle classi alte e privilegiate, mentre risultano frequenti e anche eccessivamente dure le pene a carico dei poveri, magari per reati di poco conto e sovente solo per una critica in pubblico all’operato del governo. Non manca tuttavia l’avventura vera e propria, con viaggi, per mare e per terra, negli immensi territori dell’Impero Turco, fra miseria e opulenza sfacciata. A ciò aggiungasi la storia d’amore fra Michele e Bianca, novelli sposi, ma ben presto separati a causa di una giustizia che, per far piacere a chi è potente, se la prende con i deboli. Tuttavia, dopo mille peripezie e per l’interessamento della moglie di un nobile potranno incontrarsi nuovamente, lui ottenendo giustizia, non tanto per la sua innocenza, ma perché nel gioco delle ambizioni di chi conta fa comodo assolverlo e riabilitarlo, non senza che prima si volesse considerarlo reo per quanto incolpevole. Il lieto fine ci sta tutto, con la punizione anche di nobili traditori e ladri, ma in bocca resta un retrogusto amaro, con quella conferma che la giustizia usa una bilancia con due pesi e due misure, distinguendo fra chi ha potere e chi invece è un povero diavolo. Il romanzo è molto bello, avvincente, e quindi la lettura è indubbiamente consigliata.
Alessandro Barbero insegna
Storia medievale presso l’Università del Piemonte Orientale, sede di
Vercelli. Studioso di prestigio, noto al largo pubblico, ha
pubblicato molti volumi. Bella
vita e guerre altrui di Mr. Pyle,
gentiluomo è il primo
dei suoi romanzi di successo (Premio Strega 1996, tradotto in sette
lingue), al quale altri sono seguiti, tutti editi da Mondadori.
6/5/2015 Saro
e altri racconti Saro, Tano, Carlo Brunella, Gnazio, Aspanu, Tania sono solo alcuni dei personaggi del mondo di “SARO e altri racconti”. Un mondo di “vinti”, che fanno ricordare i personaggi verghiani. Ma non esistono i vinti se non hanno vita anche i vincitori in questo mondo contadino, in questo mondo di umili che si dànno da fare per sopravvivere. Così è di Lucio, di Ciccio Corsini, di Amalia, di Ilenia, della signora Letizia e di altri personaggi marginali. Sembrano personaggi di un tempo che fu, verrebbe da pensare, ma di fatto sono personaggi ancora presenti in tante realtà contadine di oggi, particolarmente del Salento e della Sicilia occidentale e centrale. Realtà vissute, osservate ed amate dall’autore. Racconti brevi per non tediare il lettore. Ogni personaggio viene descritto con pochi tratti, quasi asciutti. Le caratteristiche individuali nascono dalle azioni e dai comportamenti di ciascuno, senza particolari lungaggini introspettive, che trascinano il lettore a giungere rapidamente in fondo al racconto. http://www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/narrativa/saro-e-altri-racconti-ebook.html
3/5/2015
Il Ghiacciaio di Nessuno
Mursia Edizioni Lassù sulle montagne… Ci sono romanzi che, pur non essendo gialli o noir, creano una tensione emotiva fin dalla prima pagina e continuano in crescendo, fino all’ultima. Si tratta di poche opere, perché non è facile ingenerare un simile pathos e fra queste poche c’è sicuramente Il Ghiacciaio di Nessuno. Non è solamente un libro sulla montagna, ma anche sulla guerra, la Grande Guerra. Infatti le vicende narrate si svolgono pressoché esclusivamente nel gruppo dell’Adamello, su cui si affacciano, da opposte direzioni, la Lombardia e il Trentino-Alto Adige e all’epoca il territorio italiano e quello austriaco. In questa zona impervia, con temperature spesso polari, divise dal ghiaccio dell’Adamello, il ghiacciaio di nessuno, si fronteggiarono fra difficoltà ambientali, aggravate dalla mutevolezza del tempo, il nostro esercito . per inciso il corpo degli Alpini, per lo più lombardi - e quello austriaco . i Kaiserjäger, frequentemente trentini e quindi di lingua italiana. Non si trattava di grossi contingenti di truppe, anche perché il terreno risultava povo adatto ad attacchi massicci e invece più idoneo a isolati colpi di mano. Nel libro si avvertono chiaramente le difficoltà del vivere ad alta quota, sembra perfino di sentire il freddo, tanta è la capacità dell’autore di trasmettere sensazioni e anche emozioni; ci sono personaggi indimenticabili, come il capitano Mor, il tenente Cattaneo o il Belva, ma soprattutto ci sono loro, gli Alpini, uomini di poche parole, bevitori, gran brontoloni, ma il cui spirito di abnegazione è arcinoto. In mezzo a paesaggi straordinari, descritti splendidamente, a notti in cui la luna si specchia nel ghiacciaio e ad albe mozzafiato avvengono scontri, scaramucce, per una piccola conquista di territorio, per un passo, per una cima. Gli alpini si sacrificano, spesso inutilmente e lo stesso accade per i Kaiserjager, e poiché si tratta di montanari di valli limitrofe non è difficile che nel combattimento si trovino di fronte degli amici. Non c’è condanna per la guerra, ma nemmeno esaltazione, anche se non mancano occasioni per un pacato e sano patriottismo. Su tutte le storie brilla quella del tenente Italo Cattaneo, che fa da filo conduttore dall’inizio alla fine; questo giovane studente di architettura di Ponte di Legno è un grande scalatore e si misurerà con la montagna anche alla fine, e in gara con lui, una gara crudele, troverà un suo vecchio amico, ora diventato nemico . Sarà uno scontro senza vinti, né vincitori e non intendo anticipare altro, perché le ultime pagine sono particolarmente commoventi. E’ indubbio che all’autore siano stati di particolare aiuto la sua esperienza come scalatore e come regista cinematografico; le ascensioni sembrano riprese da una cinepresa, con tutti i campi possibili, tanto che si ha l’impressione di essere parte della cordata; il panorama e gli episodi bellici fruiscono di un’analisi e di una visione da più angolazioni, il che consente quasi di essere presenti. Tuttavia i veri protagonisti del romanzo sono la natura, con la sua forza immensa, e l’uomo che la sfida; c’è ovviamente la guerra, ma questa pare proprio il ritratto della stupidità degli uomini disposti a morire, più che per la Patria, per il senso del dovere, oppure per quello spirito di fratellanza che accomuna i membri del corpo degli Alpini, pronti a gioire insieme in caso di vittoria e a soffrire subito dopo in silenzio nel ricordo dei compagni caduti. Il romanzo non è breve (sono 312 pagine), ma pur cercando di arrivare il più velocemente possibile all’ultima, si vorrebbe che non finisse mai. Da leggere, quindi, perché Il Ghiacciaio di Nessuno, pur non essendo un capolavoro, è un’opera senz’altro eccellente e appassionante.
Marco Preti
nasce a Brescia nel 1956. Dopo il liceo si dedica alla sua
grande passione, la montagna, e diventa maestro di sci, guida alpina
e professore di educazione fisica. Considerato uno degli scalatori
più eclettici della sua generazione, collabora con le maggiori
riviste di alpinismo. A trent’anni comincia a occuparsi di
cinematografia e realizza una cinquantina tra film e documentari per
Rai (Geo & Geo), National Geographic e Discovery Channel nei posti
più remoti del pianeta, ricevendo numerosi riconoscimenti
internazionali.
30/4/2015
E
la vita che viene
Fara
Editore
Poesia
Il
tempo ritrovato C’è comunque in tutta la raccolta un senso di brezza ristoratrice, un ritorno alla natura che non può che infondere una ragionata serenità, l’acquisizione della consapevolezza di che cosa in realtà siamo, miniature, spesso imperfette, nell’immenso libro dello scorrere del tempo, in un senso mistico dell’esistenza che sempre più appare come un ciclo brevissimo nell’eternità dell’universo. Da leggere, senza il benché minimo dubbio.
Adelaide Ricci, medievista e
docente di Storia medievale (Università di Pavia, sede di Cremona), è
autrice di numerosi saggi e di alcuni volumi. È direttore artistico
dell’ensemble musico-teatrale
PerIncantamento,
da lei fondato nel 2003. In poesia ha pubblicato la raccolta Nenie
dell’aria (Cremona
2006) e Di terra e di
luogo (sei testi, in
«Strenna dell’ADAFA per l’anno 2006», XLVI, Cremona 2007).
25/4/2015
Le signorine di Concarneau Traduzione di Laura Fausin Guarino
Adelphi Edizioni
Narrativa romanzo
Le conseguenze di un affetto dispotico Jules Guérec è uno scapolo di quarant’anni che vive, da quando è nato, in una cittadina della costa bretone nella casa ereditata dai genitori in compagnia di due sorelle nubili, più anziane di lui, (una terza sorella, sposata tardi, sta altrove); Céline e Marthe – così si chiamano le due sorelle zitelle - si prendono cura di lui come una madre, ma con un accentuato dispotismo, tanto che lui non può spendere nulla senza rendere conto a loro, lui che è proprietario di due pescherecci e fra non molto di un altro in costruzione. È per questo motivo che, tornando in auto da una riunione sindacale in un’altra città, si arrovella per giustificare un’uscita di 50 Franchi, compenso per una prestazione sessuale di una prostituta. È già arrivato quasi casa, quando, complice il buio e anche il fatto che è poco pratico nella guida, investe un bambino e, anziché fermarsi per soccorrerlo, si allontana dal luogo dell’incidente. Inizia così un romanzo breve (136 pagine) di Georges Simenon, che non è né un giallo, né un noir, e che invece si traduce in una fine analisi psicologica dell’affetto possessivo. Jules Guérec è cresciuto in una casa in cui le sorelle hanno tutto pianificato, dove è coccolato, ma anche redarguito come se, anziché essere un uomo maturo, fosse solo un bimbo. È una sorta di prigione dorata (i Guèrec sono gente danarosa) a cui lui invano cercherà di sottrarsi, dando una svolta alla sua vita a seguito proprio di quell’incidente per il quale il bambino investito, dapprima ferito, poi finirà per morire. Se c’è un destino sfortunato che ha colpito la madre del piccolo, c’è un altro destino, senz’altro dorato, ma anche ineluttabile che opprime Jules. Incapace do essere completamente maturo la sua ribellione sarà un gesto sterile, sarà una fuga da casa più che per il fermo desiderio di cambiare radicalmente la propria vita, per una specie di protesta con cui cerca inconsciamente di richiamare un amore ancor più protettivo. E infatti la pecorella tornerà all’ovile, docile verso le padrone disposte ad accoglierlo benevolmente, così che il menage a tre possa proseguire, non importa se con reciproca soddisfazione, perché quel che conta è che la famiglia risulti unita e senza cambiamenti. Poi Marthe morirà e resteranno quindi solo in due, ma dato che c’è sempre il pericolo che anche Céline possa venire a mancare, la vita di Jules proseguirà monotona, ma anche nella trepidazione che ciò accada, sotto la minaccia di trovarsi un giorno solo e vecchio, senza più una protezione. Le signorine di Concarneau è un’opera in cui Georges Simenon tende bene a evidenziare i pericoli del troppo affetto, quell’incapacità di comprendere che legami troppo stretti non portano mai bene e che l’educazione impartita da genitori o sorelle più anziane, quando troppo rigida e tesa a sollevare l’allievo da ogni responsabilità, si traduce inevitabilmente in una carenza di maturità, facendogli mancare esperienza e libertà, indispensabili per diventare adulto a tutti gli effetti. Come al solito lo stile di Simenon stupisce per incisività, l’ambientazione della piccola cittadina bretone sul mare è tale che sembra di vederla, l’analisi psicologica dei personaggi è quanto di meglio si possa trovare. Se poi si aggiunge che la lettura è particolarmente gradevole, ci sono tutte le ragioni per consigliare questo libro.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
22/4/2015
Alle spalle di
Trieste
Bompiani Editore Luci e ombre Ho sempre stimato Fulvio Tomizza per le sue indubbie qualità di narratore, anche se la tematica ricorrente è sempre la sua terra d’origine, quell’Istria territorio di confine in cui si incontrano diverse nazionalità, a volte in pacifica coesistenza, altre invece fonti di attriti che appaiono insanabili. Peraltro, come sempre accade in un autore abbastanza prolifico, si alternano prove sicuramente riuscite, e al riguardo non si può fare a meno di ricordare lo stupendo La miglior vita, ad altre decisamente sotto tono. Nel complesso, comunque, ci si trova di fronte a uno scrittore più che eccellente , a una penna che ci ha lasciato opere che sicuramente non cadranno nell’oblio. Del Tomizza saggista non avevo conoscenza e pertanto mi sono accostato con curiosità a Alle spalle di Trieste, un libro che raccoglie numerosi articoli redatti nel corso di diversi anni e relativi appunto a quel territorio che si sviluppa dietro questa città, ultimo nostro porto a Nord sul mare Adriatico. È un ritorno agli antichi temi, a quella terra da cui l’autore è stato costretto a migrare, ma che è rimasta come una spina nel suo cuore. Alcuni potrei definirli di carattere letterario, come quando parla degli scrittori e poeti di questo vasto comprensorio, altri sono di carattere etnografico, oppure sociologico e anche politico, insomma un ampio ventaglio che ritengo che Tomizza abbia inteso proporre per meglio far conoscere agli altri, soprattutto agli italiani, i problemi di questa terra martoriata nei scoli da guerre e invasioni. Tuttavia, se anche l’offerta è ampia, si può notare la presenza di alti e bassi già riscontrabile nella sua produzione di narrativa, un po’ per il lungo arco di tempo nel corso del quale sono stati scritti, un po’ perché come saggista mostra diverse pecche fra le quali, fastidiosa, quella di ricorrere a frequenti digressioni, che gli fanno perdere il filo del discorso principale e che imbarazzano anche il lettore. Si tratta in buona sostanza di luci e di ombre, dove le prime sono poche e le seconde sono decisamente maggiori. Fra l’altro, sono un po’ tanti gli articoli dedicati a Trieste, la sua città di adozione, e in cui lui, abituato agli ampi spazi della campagna, non si deve essere trovato mai bene, perché questo traspare dalle righe, a volte venate da un vero e proprio astio. In contrapposizione c’è uno scritto sulla Mitteleuropa che da solo merita la lettura del libro, una disamina attenta, quasi puntigliosa che è in grado di fornire una visione esatta di questa vasta regione che raggruppava soprattutto quasi tutti i territori di cui era costituito l’impero austro-ungarico e che tanto ha dato alla letteratura; si sofferma giustamente sul collante che teneva unite tante nazionalità, quel senso dello stato comune poi franato miseramente e disgregatosi del tutto con la Grande Guerra. Non posso dire, comunque, che come saggista abbia dato buona prova di sé, però il libro merita ugualmente e ritengo che costituisca un corredo indispensabile per conoscere e comprendere meglio questo grande scrittore.
Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, Umago,
26 gennaio 1935 - Trieste, 21 maggio 1999). Figlio di piccoli
proprietari agricoli, dopo la maturità classica, si trasferì a
Belgrado e a Lubiana, dove iniziò a lavorare occupandosi di teatro e
di cinema. Ma nel 1955, quando l'Istria passò sotto la Jugoslavia, Tomizza,
benché legato visceralmente alla sua terra, si trasferì a Trieste,
dove rimase fino alla morte. Scrittore di frontiera, riscosse ampi
consensi di pubblico e di critica (basti pensare ai numerosi premi
vinti: nel 1965 Selezione Campiello per La quinta stagione,
nel 1969 il Viareggio per L'albero dei sogni, nel 1974, nel
1986 e nel 1992 ancora Selezione Campiello rispettivamente per Dove
tornare, per Gli sposi di via Rossetti e per I rapporti
colpevoli, nel 1977 e nel 1979 lo Strega e quello del Governo
Austriaco per la letteratura Europea per La miglior vita. Ha
pubblicato: Materada (1960), La
ragazza di Petrovia (1963), La
quinta stagione (1965),Il bosco di acacie (1966), L'albero
dei sogni (1969), La torre capovolta (1971), La città
di Miriam (1972), Dove tornare (1974), Trick,
storia di un cane (1975), La miglior vita(1977), L'amicizia (1980), La
finzione di Maria (1981), Il male viene dal Nord (1984), Ieri,
un secolo fa (1985), Gli sposi di via Rossetti (1986), Quando
Dio uscì di chiesa (1987), Poi venne Cernobyl (1989), L'ereditiera
veneziana (1989), Fughe incrociate (1990), I rapporti
colpevoli (1993), L'abate Roys e
il fatto innominabile (1994), Alle spalle di Trieste(1995), Dal
luogo del sequestro (1996), Franziska (1997), Nel
chiaro della notte (1999).
19/4/2015
La paura
Traduzione di Leopoldo Carra
Narrativa romanzo Cui prodest? Cui prodest? Nel caso specifico a chi giova la guerra, ed è solo una delle tante domande a cui l’autore cerca di fornire una risposta. La guerra, questa insensata lotta, quasi sempre mortale, fra uomini di diversi Stati, è quanto di peggio possa esprimere l’homo sapiens, dimostrando così di non essere poi tanto sapiens. E non mi si venga dire che è innata in tutti gli uomini, come invece recita l’infelice aforisma di Filippo Tommaso Marinetti (La guerra sta agli uomini come la maternità sta alle donne), perché è assai facile dimostrare il contrario. L’esperienza di Gabriel Chevallier, maturata nel corso della Prima Guerra Mondiale, in cui fu anche ferito, è riportata integralmente in quest’opera (La paura), ma, benché possa sembrare, e in parte lo è, un romanzo autobiografico, l’autore va ben oltre, spingendosi in una ricerca psicologica, sociologica e antropologia (un po’ come ha fatto Primo Levi con il suo bellissimo I sommersi e i salvati). Ed è così che proprio la paura viene vista in tutte le sue sfaccettature, nelle diverse occasioni e sulla base di esperienze maturate. In guerra si ha paura di essere uccisi dal fuoco nemico o anche da quello amico, si ha paura di morire in modo estremamente doloroso, si teme di finire davanti a un plotone di esecuzione non solo per diserzione, ma anche per piccole cose, che nella vita di pace sarebbero sanzionate al massimo con un’ammenda. Si ha paura anche dei gendarmi, pronti a sospingere a fucilate a un insensato attacco. E dato che questa situazione di acuto timore è sempre presente, ben presto diventa un’angoscia, una costante e devastante presenza. E tutto questo per cosa? Perché uomini che in tempo di pace per lo più sono comparse assoggettate, impossibilitati a mutare il loro stato sociale, devono vivere nel terrore, debbono violare il proprio animo naturalmente pacifico per uccidere dei propri simili? Lo fanno per la patria, almeno ufficialmente, per vendicare un onore offeso, ma queste risposte, giustamente, non sono altro che la vuota retorica che viene inculata alle truppe con la cieca obbedienza, con il progressivo appiattimento della personalità, condizione indispensabile per poter diventare carne da macello. E allora, a chi giova? Ne beneficiano grandi gruppi industriali per arricchirsi ulteriormente, politici che sognano di restare nella storia, come anche ufficiali ambiziosi che, standosene al sicuro, vagheggiano gloria e promozioni. Di tutto ciò chi combatte e muore non vede nulla e il suo premio è solo quello di poter tornare un giorno a casa finalmente in pace, ma distrutto, sia fisicamente che spiritualmente. Sfruttati nei periodi di non belligeranza, sacrificati spesso inutilmente in una guerra, gli uomini normali, le cui ambizioni sono quelle di arrivare a fine mese con il poco salario e di condividere le gioie della famiglia, in un conflitto non devono più solo fornire la mano d’opera, bensì devono donare interamente se stessi. Il pensiero di Chevallier può a volte anche non essere condiviso, ma resta il fatto che lui è riuscito a fornire le uniche logiche risposte a non poche domande. Soprattutto si apprezza il suo pragmatismo che rifugge da soluzioni che spesso sono meramente retoriche, così come risulta particolarmente gradita la sottile ironia che in circostanze particolari accompagna la narrazione. Ciò che soprattutto stupisce però è che riflettendo e anche cercando risposte diverse le sue appaiono le uniche plausibili, frutto quindi un’attenta e approfondita disamina dei problemi. Benchè nella produzione di questo autore l’opera più famosa e fortunata sia Clochemerie , La paura appare di rilevante interesse e valore e si può dire che costituisca un unicum nell’ambito della narrativa sulla Grande Guerra, anche se la sua valenza può essere estesa a qualsiasi conflitto. Lo stile è piacevole, anche se non particolarmente sobrio, e la vita in trincea è descritta con mano felice; alla piacevolezza tuttavia nuoce una certa propensione a dilungarsi, una marcata verbosità e ripetitività che si accompagna alle riflessioni. Questo non è un elemento negativo tale da inficiare l’elevato valore dell’opera, però di fatto impedisce di gridare al capolavoro, di mettere La paura sullo stesso piedistallo di Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. È anche la sua natura ibrida, a metà fra romanzo e saggio, che finisce con l’avere il suo peso, ma ciò non toglie che ci si trovi di fronte a qualche cosa di mai letto prima e che alla fine dei conti ci si senta comunque appagati. Da leggere, ovviamente.
Gabriel Chevallier
(3 maggio 1895 – 6 aprile 1969) ha partecipato alla Prima guerra
mondiale. Finito il conflitto svolge lavori di diverso genere e nel
1925 si dedica alla scrittura; con Clochemerle, pubblicato nel
1934 raggiunge il successo. Del 1930 è La paura, frutto delle
sue esperienze di guerra sul fronte occidentale.
16/4/2015
La volpe e le camelie
L’ora d’oro
editore Il ravvedimento é sempre possibile La volpe e le camelie è l’unico romanzo di Ignazio Silone non ambientato nella Marsica, bensì in Canton Ticino, anche se è accomunato agli altri dal tema della cospirazione politica e dalla presenza di taluni protagonisti che tanto richiamano, per caratteristiche e mentalità, i contadini della Conca del Fucino. È certo il frutto, almeno in parte, di un’esperienza personale, quando l’autore, inviso al regime fascista, fu costretto a riparare in Svizzera e si sa per certo che l’idea di quest’opera maturò nel corso dell’esilio, tanto che in territorio elvetico Silone scrisse una prima bozza, sulla quale negli anni successivi ritornò più volte, ampliandola, dandole corpo, fino ad addivenire alla stesura definitiva verso la fine degli anni ‘50, e infatti la prima edizione, curata da Mondadori, è del 1960. Il romanzo narra della vicenda di Daniele, antifascista del Canton Ticino e della figlia Silvia innamorata di Cefalù, un giovane che si scoprirà spia del regime fascista. Ma il contatto con un uomo integerrimo e amante della libertà, come è Daniele, e la scintilla dell’amore apriranno gli occhi a Cefalù, che preferirà porre fine tragicamente alla sua vita piuttosto che arrivare a quella delazione che avrebbe accusato il padre del’amata. Una vicenda semplice, in fondo, ma la qualità del romanzo non sta tanto nella trama, quanto invece nei suoi sviluppi, nella caratterizzazione dei personaggi e soprattutto in quell’innata capacità di Silone di non vedere l’umanità divisa nettamente fra tutti buoni e tutti cattivi, perché è evidente che ogni essere umano ha in sé i germi del bene e del male e che sta a lui la difficile scelta fra l’uno e l’altro, nonché a provvedere a un eventuale ravvedimento. L’autore sembra volerci dire che gli uomini sono più importanti delle loro idee politiche, che possono anche mutare, e che in fondo le colpe rimangono e che le loro conseguenze sono per forza di cose immutabili, mentre invece i colpevoli possono cambiare. È un modo di pensare di grande rilevanza civile, ma a ben guardare anche perfettamente in sintonia con il messaggio cristiano; in effetti si potrebbe dire non c’è uomo senza colpe e che non ci sono colpe senza uomini. In ciò ritrovo il miglior Silone, quello che mi ha avvinto con romanzi di grande spessore, come Fontamara, Il segreto di Luca, Vino e pane, Il seme sotto la neve e che forse ancor più risalta in un’opera meno conosciuta, ma di notevole rilievo quale L’avventura di un povero cristiano, in cui l’antitesi fra coscienza e potere è esposta in modo semplicemente perfetto. In ogni caso, anche in La volpe e le camelie l’autore ama guardare più l’uomo che gli uomini, l’individuo considerato a sé stante, inevitabilmente imperfetto, una meteora con poca luce che passa e che va, ma un uomo, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, nei cui confronti e anche verso se stesso nutre in fondo un grande rispetto non disgiunto da una vena di pietà. Da leggere, senza alcun dubbio.
Ignazio Silone nasce
a Pescina (Aq) il 1° Maggio 1900 e muore a in Svizzera a Ginevra il
22 agosto del 1978.
12/4/2015
La battaglia Storia di Waterloo di Alessandro Barbero
Editori Laterza Storia
Prima, durante, dopo “Spero di non vedere più un’altra battaglia: questa è stata troppo scioccante. È troppo vedere uomini così valorosi, così degni gli uni degli altri, che si tagliano a pezzi in quel modo.” (Sir Arthur Wellesley, I Duca di Wellington) Come è riportato in tutti i testi scolastici la battaglia di Waterloo, combattuta il 18 giugno 1815 fra le truppe francesi e quelle inglesi e dei loro alleati prussiani, si concluse con la sconfitta dei primi e sancì la definitiva uscita di scena di Napoleone Bonaparte, condannato a una sorta di esilio-prigione nella sperduta isola di Sant’Elena. La vittoria, che dapprima sembrava arridere a l’Armée du Nord, fini invece per essere ottenuta dai suoi avversari grazie all’improvvisa comparsa sul campo di battaglia dell’esercito prussiano. Di questo grande e sanguinoso evento bellico parla lo storico Alessandro Barbero in La battaglia Storia di Waterloo. Come è sua abitudine nel ricercare la maggior completezza d’informazione scrive del prima, del durante e del dopo, fornendo tutti i possibili dati per meglio comprendere il significato di questo scontro. E lo fa con pazienza certosina, elencando per esempio le forze in campo, suddivise per stati partecipanti, il loro armamento, le loro divise, la struttura logistica, le tecniche di battaglia a cui erano addestrati, non trascurando le figure dei comandati in capo, come Napoleone Bonaparte per i francesi, il duca di Wellington per gli inglesi e il feldmaresciallo von Blucher per i prussiani. Per quanto Barbero cerchi di essere chiaro e snello, così tante notizie propedeutiche, per quanto utili, ogni tanto costringono il lettore a concedersi un po’ di riposo, frastornato dalla mole di dati e di informazioni che gli vengono sottoposti, ma dove lo storico piemontese da il meglio di sé è nella descrizione vera e propria dello volgimento della battaglia, forse qui più da narratore che da saggista, anche se si ritrae la convinzione che in ogni caso si sia attenuto rigorosamente a quanto effettivamente avvenne, sulla base di un numero considerevole di fonti. Entra così in gioco una spiccata creatività che ci porta a vedere gli scontri in una serie di lunghe sequenze come se si trattasse di una pellicola cinematografica, e sembra quasi di udire il rullo dei tamburi, gli spari dei fucilieri, il nitrito dei cavallo morenti, il rumore delle cannonate che i due avversari si scambiarono senza risparmio. Questa è la parte indubbiamente migliore di un saggio che si colora di romanzo storico, che avvince e convince, anche se sovente ci si perde sul terreno fra le posizioni degli opposti schieramenti in un territorio che ci è sconosciuto e che le poche cartine disponibili aiutano poco a identificare. Ci sono scene così ben descritte che si ha proprio l’impressione di essere presenti agli scontri, di vedere le formazioni inglesi che in quadrato resistono all’assalto dei Corazzieri, la famosa e letale cavalleria francese, quasi si odono gli strepiti dei fanti che vanno all’attacco al grido di “Viva l’imperatore” e perfino il rantolo dei moribondi risuona nelle orecchie; il fumo degli scoppi irrita le narici e pare di essere travolti da orde di soldati esasperati e disperati che pensano solo a scannarsi. In tutta sincerità sono dell’opinione che l’autore abbia visto “Waterloo”, il famoso film di Sergej Bondarciuk uscito nel 1970, una pellicola di grande pregio con Rod Steiger nei panni di Napoleone e Christopher Plummer che impersona il Duca di Wellington. Come è più che logico, leggendo questo libro viene naturale chiedersi il perché della sconfitta di Napoleone che alla vigilia della battaglia era considerato il favorito alla vittoria; i motivi sono più d’uno, come sempre in questi casi, anche perché gli errori e le deficienze sono proprie di entrambi i contendenti. Non si può imputare al fatto che il giorno e la notte prima fosse piovuto abbondantemente e che pertanto il terreno fosse d’ostacolo alle manovre, soprattutto a quelle dell’artiglieria, poiché questo dato interessava entrambi gli schieramenti; né si possono imputare colpe di scarsa combattività e di inadeguata preparazione dei francesi, perché all’epoca il loro esercito era il migliore in assoluto; d’altra parte non si può nemmeno considerare la strategia di Wellington come geniale, perché era l’unica che gli era possibile, cioè resistere a oltranza fino all’arrivo dei prussiani; lasciando da parte la sfortuna, che in questi casi ha un’incidenza relativa, l’errore maggiore è stato proprio di Napoleone che ha sottovalutato la possibilità che l’esercito prussiano, alla cui caccia si era messo da due giorni il maresciallo Grouchy, potesse comparire sul campo di battaglia; tuttavia, il calcolo dell’imperatore non era del tutto infondato, perché contava che, se fossero arrivati i prussiani, alle loro calcagna ci sarebbe stata appunto l’armata inseguitrice, che però si era messa a cercare in tutt’altra direzione. Si sa come andò a finire: l’esercito di von Blucher, dopo una marcia forzata, arrivò giusto in tempo per dare una mazzata ai francesi, mentre Grouchy non giunse mai a Waterloo, impegnato di continuo in confusi combattimenti con la retroguardia prussiana. Napoleone aveva perso non solo una battaglia, ma anche il trono; già tuttavia era un uomo stanco e finito e i famosi cento giorni ora possono apparire come l’estremo tentativo di un grande protagonista della storia di opporsi al suo declino, ma in questi casi il risultato è sempre negativo, perché chi è stato tanto in alto e quasi sempre vittorioso non può portarsi appresso i fantasmi delle sconfitte, soprattutto quello della tragica disfatta della sua grande armata nel corso della campagna di Russia. Quel sole splendente che gli aveva arriso ad Austerlitz non era che un lontano ricordo, sotto il cielo grigio del Belgio e nel buio di chi sa che non avrà più futuro. La battaglia Storia di Waterloo è un libro da leggere e rileggere, non solo perché è di notevole interesse, ma anche perché è bellissimo.
Alessandro Barbero
insegna Storia medievale presso l’Università del Piemonte Orientale,
sede di Vercelli. Studioso di prestigio, noto al largo pubblico, ha
pubblicato molti volumi. Bella
vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo è
il primo dei suoi romanzi di successo (Premio Strega 1996, tradotto
in sette lingue), al quale altri sono seguiti, tutti editi da
Mondadori. Per Laterza è autore di opere più volte ristampate, alcune
delle quali tradotte nelle principali lingue.
9/4/2015
Affondi ed emersioni Prefazione di Giuliano Ladolfi
Giuliano Ladolfi Editore
Poesia Sensazioni ed emozioni Mi sono sempre chiesto quali sono i motivi per i quali uno scrive poesie. Non certo il successo di vendite, perché, tranne rari casi, di denaro ne arriva proprio poco; forse il poeta intende comunicare con una platea a priori invisibile, nella quale si spera che ci sia qualcuno in sintonia con l’autore; credo, tuttavia, e lo dico per esperienza personale, che il poeta voglia aprire il proprio animo, più che per farlo vedere ad altri, per sapere qualcosa di più di se stesso. E forse Gianna Cavaretta, che ha scritto questa bella raccolta intitolata Affondi ed emersioni, ora è in grado di conoscersi meglio, anche se, poesia dopo poesia, scoprirà inevitabilmente che c’è ancora tanto da esplorare. Di solito, il comune lettore, e quindi non l’appassionato di poesia, si accosta incerto alla lettura, timoroso di non riuscire a comprenderne il senso, ma questo non è proprio il caso di Affondi ed emersioni, il cui ermetismo appare velato e in ogni caso senza che comporti particolari difficoltà nell’interpretazione. Sono versi che, benché sciolti, presentano una loro autonoma armonia che ne rende particolarmente gradevole la lettura (Nella casa dei gelsi rosa / in fondo tazze i grani mielati / cedevano ai cucchiai, / l’erba cresceva / nelle pieghe dei grembiuli quadrettati. /). È una visione idilliaca, in una successione di cromatismi che compongono un’immagine rasserenante. Ma non c’è spazio solo per ritratti gioiosi, perché la vita riserva anche dolori (Parla di te l’immagine di gesso / fissata ad amuleto / sulla parete grezza della casa / e i lacerati addobbi / di finti tulipani, / labbra in un vuoto senza scopo / come la mia bocca allora / si nutriva attaccata al seno / sul bianco della tua camicia.). Il ricordo è il frutto di un lutto omologato, assimilato, tanto che i versi sono percorsi solo da un sottile filo di mestizia, nella consapevolezza che anche questo evento è nel corso delle cose, perché così è la vita. Pur se non impostata su un’unica tematica questa raccolta è suddivisa in sezioni; si tratta, più che di argomenti, di stati d’animo, in cui si riesce a catturare quell’attimo creativo che sovente cerca di sfuggire e vi riesce, se non si è accorti a coglierlo subito e a imprimerlo nella mente. L’impressione che ho ricavato è che, nonostante la poetessa introduca alcune parti con versi di Rainer Maria Rilke, che di certo non fu il poeta della gioia, in realtà in lei alberghi un animo sì sensibile, ma non portato a una tristezza esistenziale; come ho scritto prima c’è più una consapevole mestizia, e solo in alcune poesie, poiché tende più che altro a illuminare di viva luce le sensazioni e le emozioni che così naturalmente avverte (I richiami del cuore ravvivano / suoni di futi / nostalgie d’insolite gioie / nel grigio dei giorni / come tra cumuli di neve, / lo spuntare di crochi / e morbidi soffioni. / Colori e suoni riordinati / sull’arcuato piano dell’amore,). Per concludere si tratta di una raccolta di eccellente fattura, ben comprensibile e quindi ne consiglio la lettura. Gianna Cavarretta vive a Prato. Maestra d’Arte, si è sempre occupata di pittura e poesia. Ha ottenuto riconoscimenti in ambedue i settori. Sue opere sono presenti su cataloghi e pubblicazioni di carattere antologico. Si sono occupati della sua poesia critici e riviste letterarie di vario genere; molte sue poesie sono state interpretate con tecniche pittoriche da alcune tra le migliori pittrici pratesi. Nel 2000, ha
pubblicato con la Florence Art Edizioni (Firenze), il libro di
poesie: Amare
dissolvenze e Percorsi
ascendenti, e nel 2011, sempre con la Florence Art Edizioni
Firenze, la raccolta di poesie Fragili
Splendori (sottotitolo: Preludio
alla vita in quattro tempi). Entrambe le pubblicazioni hanno
ottenuto premi e menzioni di merito.
7/4/2015 Marinai
perduti
7/4/2015
Se la
casa è vuota
Longanesi Editore Infanzia tradita I primi anni di vita sono cruciali per ogni infante, perché in quel periodo si viene ad avviare la formazione della personalità, a cui contribuiscono in modo determinante i genitori con l’educazione e la cura dei piccoli; però non è che l’inizio e anno dopo anno, fino più o meno alla maturità, si sviluppa quello che sarà l’uomo di domani, con i suoi pregi e con i suoi difetti, in parte innati, in parte dovuti alle attenzioni e agli insegnamenti ricevuti. E’ quindi evidente che la famiglia riveste un ruolo primario tanto che nel nostro diritto ci sono tutta una serie di norme a tutela del minore. Non è certo facile per un genitore educare, ma è un dovere a cui dovrebbe di buon grado assoggettarsi in quanto il futuro del figlio e/o o della figlia dipende molto dalla passione, dall’entusiasmo, dall’esempio con cui si allevano e, a parte i casi particolari di individui che nascono con determinate caratteristiche che li rendono insensibili a qualsiasi forma di istruzione, è certo che l’uomo di domani è anche il frutto di questa quotidiana e attenta attività. Il troppo amore o il troppo poco amore, il cattivo esempio finiscono così con l’incidere profondamente questa personalità in formazione, con reazioni a volte anche violente che il genitore per lo più si rifiuta di comprendere. Questo tema della famiglia e dell’allevamento dei figli deve essere particolarmente sentito da Isabella Bossi Fedrigotti, tanto che ha pensato di scrivere un libro, in pratica sei storie di bambini che, per un motivo o per l’altro, non hanno avuto un’infanzia equilibrata e felice, al punto da marcare indelebilmente le loro vite. In verità le vicende sono sette, perché all’inizio c’è anche quella personale dell’autrice, una sorta di confessione, il tentativo di liberarsi da un peso che trascinava fin dalla più tenera età. Sono storie varie e a un certo punto è logico chiedersi se siano vere, e ciò è logico, tanto che il libro presenta un ultimo capitoletto intitolato La solitudine dei nostri figli in cui l’autrice ci fornisce la risposta, laddove dice “ Vengono, come la maggioranza delle mie storie, dalla realtà, viste, ascoltate, indovinate. Sono tutte quante, compresa la prima, rigorosamente inventate dal vero, nel senso che pur essendo reali sono rielaborate dalla fantasia come è inevitabile che sia per un’opera di narrativa, tanto che nessun bambino o ex bambino riuscirebbe a riconoscersi in uno di questi personaggi e forse nemmeno io nel racconto dell’introduzione.”. Sta di fatto che la fantasia non ha scalfito realtà in cui non ci sono bimbi seviziati, ma povere creature che diventano o preda ossessiva di genitori che da loro si aspettano ciò che non hanno avuto, o che vengono fatti sentire di peso, come degli incomodi. Sono storie raccontate con mano lieve e tanta tenerezza, come se Isabella Bossi Fedrigotti intendesse in un certo modo dimostrare quel giusto affetto che non hanno avuto. E in questo è veramente brava, perché non ci sono né asetticità, né passione, in un equilibrio raro che l’autrice trova nell’amore per i suoi personaggi. Come sempre la scrittura è piana, mai affaticante, così che la lettura risulta facile e gradevole, anche se rimane dentro una spina nel cuore, pensando a Pietro e alla separazione dei suoi genitori, oppure a Paolina, a cui la vita ha inferto solo ferite. La lettura è ovviamente consigliata, anche se ci si chiede quanti Pietro e Paolina ci siano, quanti bambini si trovino spaesati in una famiglia, quanta sia la sofferenza di queste piccole creature che si porteranno appresso per tutta la vita.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor
Budischowsky (Rizzoli, 2003) e Il primo figlio (Rizzoli,
2008).
20/3/2015
L’ultima alba di guerra di Paul Dowsell
Feltrinelli Editore Narrativa romanzo Non male, ma nemmeno bene La Grande Guerra, di cui ricorre per noi il centenario dal suo inizio, richiama l’attenzione di diversi narratori e fra questi Paul Dowsewll, inglese, scrittore di romanzi per ragazzi. E anche L’ultima alba di guerra, almeno nell’intenzione dell’autore, dovrebbe costituire narrativa per lettori dai 12 anni in su; in effetti, lo stile abbastanza semplice e immediato, la propensione a narrare scontri e battaglie possono essere elementi adatti a un pubblico giovane, anche se, però, per la crudezza di certe immagini, per un certo compiacimento nel dilungarsi nella descrizione di combattimenti che mi sembra eccessivo, é semmai più adatto a degli adulti, tanto più che non c’è una ferma condanna della guerra, come se quello che importava di più era di scrivere un melodrammone con tutte le caratteristiche invece di certe serie televisive di produzione sudamericana. L’idea originale era in sé buona: tre giovani soldati, un americano, un inglese e un tedesco nell’ultimo giorno di guerra, tre destini ben distinti che a un certo punto, per una serie di circostanze, si incrociano e così da nemici diventano amici, ma la sorte sarà benigna solo per uno di loro. Quello che è mancato veramente a questo libro è stata la capacità di sviluppare l’idea, o meglio di svilupparla in modo adeguato, non restando in superficie, ma cercando di approfondire un po’. È un peccato perché ne è uscita un’opera di discreta confezione, ma che appare troppo in linea con l’obiettivo di dare al lettore ciò che chiede, senza indurlo a riflettere; inoltre la paura, naturale, che dovrebbero avere i tre è di maniera, sa di qualcosa di già visto, con tante immagini che scorrono spesso leziose, senza che sorga anche il minimo pathos, come certe pellicole di guerra adatte solo a svagare per un po’. Dowsell non ha certo la stoffa del grande romanziere, di lui non resterà traccia in campo letterario, è solo un corretto artigiano della penna che ha avuto per le mani, inaspettatamente, un’eccellente idea, che ha sviluppato però con le sue non eccelse capacità, così che l’intuizione originaria è stata sprecata, ricalcando tanti schemi convenzionali in cui prima dell’ultima pagina già si comprende come andrà a a finire. Comunque, direi che è un libro che si lascia leggere, che consente un po’ di svago senza che sia necessaria una particolare attenzione, perché non induce certo a riflessioni; è inutile chiedergli di più, perché i suoi limiti lo impediscono.
Paul Dowswell ha lavorato a
lungo nell’editoria prima di diventare scrittore. Per Bloomsbury ha
pubblicato una trilogia storica ambientata nell'Inghilterra
dell'Ottocento. Feltrinelli “Kids” ha pubblicato Ausländer(2010), Il
ragazzo di Berlino (2012), L’ultima
alba di guerra (2013) e Tra le mura del Cremlino (2014).
15/3/2015
Il destino dei Malou
Adelphi Edizioni
Narrativa romanzo Le tante verità
*«Mio padre era un uomo disonesto?» Eugène Malou, imprenditore edile in rovina, si uccide con un colpo di pistola sulla scalinata che conduce alla villa del conte Adrien d’Estier, proprio davanti alla porta da cui era appena uscito. Con questo suicidio, indubbiamente d’effetto, si inizia poco a poco a conoscere chi fosse il morto, ma non attraverso degli sprazzi del passato rievocati da lui stesso, bensì con racconti di chi lo conosceva, e tutto questo perché il figlio Alain, l’unico che più gli somiglia, vuole conoscere chi fosse effettivamente suo padre. I fatti della sua vita, rievocati da diverse persone, sono sempre gli stessi, ma ciò che cambia è il giudizio, perché, per esempio, la depravata figlia Corine lo disprezza, mentre due suoi dipendenti, Foucret e Bourgues, lo stimano molto. Si tratta della molteplicità dei giudizi di fronte alla stessa domanda: chi era Eugène Malou? Nulla di nuovo in campo letterario, tanto che è evidente che Simenon si è messo nella scia di Pirandello. Eppure questo romanzo, pur a fronte di una discutibile morale, presenta non pochi pregi autonomi. Il fatto che Eugène Malou fosse figlio di una donna conosciuta come pazza e che si offriva a tutti gli uomini e di un padre quasi analfabeta che si nutriva di corvi e di bisce, la sua lotta per emergere dal fango in cui rischiava di soffocare, sfruttando i difetti peculiari di una società borghese (avidità, corruzione, completa amoralità) di per sé costituiscono un atto d’accusa senza se e senza ma di un ceto che nel tempo ha preso sempre più piede. Malou odiava questa gente, ma se ne serviva per i suoi piani ambiziosi, per un’affermazione sociale ed economica che andava a fasi alterne, con momenti in cui il denaro abbondava ed altri in cui proprio mancava, ma lui faceva di tutto per procurarselo, a qualsiasi costo per soddisfare le esigenze di una famiglia, in cui la moglie e la figlia erano delle scialacquatrici, mentre Alain viveva senza porsi domande e soprattutto senza porle al padre. Gli alti e bassi erano frequenti, tanto è vero che al momento del suicidio tutti i suoi beni, personali e aziendali, erano pignorati. Che uomo è quello che nei periodi buoni offre ai camerieri mance favolose e negli altri pessimi non è nemmeno in grado di pagare il suo personale di servizio? È Malou forse un sognatore? Anche, ma soprattutto è un avventuriero, un uomo destinato a una perenne lotta con la società in cui vive, che sfrutta e da cui viene sfruttato, mai domo, mai talmente in rovina da non avere la forza di cercare di rimettersi in piedi, pronto, se necessario, a servirsi anche dei molti nemici, ma ce n’è uno contro cui nulla si può fare, contro cui è inutile combattere e al quale non c’è possibilità di sfuggire. Emerge così la figura di un intrallazzatore che ai giorni nostri sarebbe in carrozza, ferocemente critico nei confronti di quel mondo in cui legami, sotterfugi e ferocia non consentono amicizie e infatti Eugène Malou è un uomo profondamente solo, con una famiglia che non pensa ad altro che a sfruttarlo, ma non è di certo un modello da imitare e invece il giovane Alain, suggestionato dalla visione positiva che ha ritratto sulla base dei racconti di Foucret e Borgues alla fine, fra lo scegliere se accettare un lascito di valore del padre o mettersi in cammino, partendo da zero, per farsi avanti nella vita, finirà per optare per la seconda alternativa, perché in fondo di tutta la famiglia lui è l’unico Malou al cento per cento, lui e solo lui intende sgomitare per avere un posto al sole. Di più non ci è dato di sapere, perché Simenon si ferma a questa scelta, ma è possibile ritenere che in futuro ci sarà il nome dei Malou osannato e vituperato, grazie al degno successore del defunto Eugène. L’aspetto che meno mi convince è proprio questa immagine, tutto sommato positiva, che Simenon offre dell’imprenditore suicida, in contrapposizione alle feroci critiche a una società borghese fatta di pescicani che si divorano fra di loro, forte con i deboli e debole con i forti. Vada per le accuse a questo ceto e che mi sento di condividere, ma secondo me Eugène Malou non è soggetto da prendere a esempio, è in fondo un manigoldo che ha solo fatto in tutta la vita quanto riteneva necessario per emergere. La descrizione dei protagonisti, l’ambientazione, come al solito sono perfetti e lo stile della scrittura, scorrevole e senza tanti fronzoli, è quel che ci si aspetta da Simenon, in un romanzo che si legge con piacere, che invita a riflettere e che nell’incalzare degli eventi conquista e affascina.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller aJeanPauhlan, da Faulkner a
Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per
esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
6/3/2015
La battaglia di Luzzara (15 agosto 1702) La fine dei Gonzaga e la sofferenza della gente reggiana e mantovana di Armando Rati
Presentazione di Giuseppe Montecchio
Sometti Editoriale Storia militare
La guerra di successione spagnola in Italia Il 1° novembre del 1700 venne a mancare Carlo II di Spagna, senza lasciare eredi diretti, così che prima di spirare aveva disposto per testamento che a succedergli dovesse essere il duca Filippo d’Angiò, nipote del re di Francia Luigi XIV. Le grandi potenze europee già da tempo avevano brigato per poter mettere mani sull’immenso territorio europeo, africano e americano della Spagna, vantando tutti i reali di queste gradi di parentela con Carlo II. Se del testamento gioì Luigi XIV, il famoso “Re Sole”, non si può dire la stessa cosa per gli altri pretendenti che uniti in una Grande Alleanza che comprendeva l’Inghilterra, l’Austria e gli altri stati tedeschi del Sacro Romano Impero sostennero la candidatura di Carlo d’Austria. Si arrivò così a una guerra, iniziata nel 1701 e terminata nel 1714, che vide sul fronte opposto i sostenitori di Filippo d’Angiò, e cioè la Spagna, la Francia e la Baviera. Benchè il teatro principale di questo conflitto siano stati i Paesi Bassi, un altro scenario di furiose battaglie fu l’Italia settentrionale, in cui la Spagna era presente con il Ducato di Milano. Il libro di Alessandro Rati parla appunto della guerra che insanguinò il Piemonte, la Lombardia, parte dell’Emilia e del Trentino, con numerosi scontri, in cui il più importante fu quello di Luzzara, avvenuto il 15 agosto 1702. La vittoria fu reclamata da entrambe le parti, ma a ben guardare il mancato arretramento degli Imperiali dalle loro posizioni e il fallimento del tentativo di liberare Mantova, passata tradendo in campo nemico, dall’assedio degli imperiali stessi, ebbero conseguenze tali sul seguito sul conflitto che si può ragionevolmente dire che da allora i sostenitori dell’Angiò iniziarono una parabola discendente che li vide poi definitivamente perdenti. Infatti, le sorti generali della guerra arrisero alla Grande Alleanza e determinarono, nel mutamento generale degli equilibri, anche la scomparsa di antichi principati, fra i quali il Ducato di Mantova. In questa battaglia si fronteggiarono 36.000 uomini dell’Armata franco-spagnola, comandati dal duca di Vendome e dal re Filippo V di Spagna (era questo nome che assunse Filippo d’Angiò salendo al trono) e 25.000 imperiali condotti da quel genio militare che fu Eugenio di Savoia. Le perdite furono ingenti da entrambe le parti (2.500 i franco-spagnoli e 4.000 gli imperiali). Armando Rati è particolarmente abile nel descrivere gli antefatti, le fasi, gli scontri di questa campagna d’Italia, e se ovviamente predominano gli eserciti e i loro comandanti, non viene tralasciata la descrizione delle conseguenze sulla popolazione civile, depredata delle poche cose che aveva, privata del cibo, che veniva requisito per l’alimentazione dei soldati di entrambe le parti. Ma, oltre a questo, c’erano i saccheggi, le violenze, soprattutto sulle donne, frutto di strutture militari, in cui i professionisti, cioè coloro che servivano solo la loro nazione erano relativamente pochi, mentre abbondavano i mercenari e i delinquenti, questi ultimi arruolatisi per sfuggire alle loro pene. È una lettura facile e piacevole, tipica non dei saggi storici, ma dei romanzi storici, pur lasciando poco spazio alla creatività, che avrebbe nuociuto alla ricerca della verità. Emerge così un grandioso quadro di un’Italia la cui frammentarietà degli stati componenti le impedisce di essere protagonista, ma la rende soggetto passivo, teatro di battaglie per interessi altrui, quasi una colonia dell’uno o dell’altro contendente, ma siamo solo nel XVIII secolo, e ancora non esiste la benché minima idea o aspirazione di giungere a una unificazione, che come noto avverrà molto più tardi, nella seconda metà del secolo successivo. Il libro è corredato da alcune illustrazioni (si tratta di stampe dell’epoca) ove vengono riportate soprattutto le posizioni di entrambi gli schieramenti, prezioso aiuto per ancor meglio comprendere gli svolgimenti degli scontri e in particolare di quello di Luzzara. Per quanto sopra la lettura è indubbiamente consigliata, ricordando ancora una volta come la stessa risulti particolarmente piacevole.
Armando Rati è
un generale dell’esercito originario di Acquanegra sul
Chiese in provincia di Mantova. Laureato in pedagogia, a indirizzo
storico, ormai congedato, si occupa di storia, prevalentemente
militare. Ha così pubblicato numerosi saggi, fra i quali1918: la
fine della Grande Guerra, 4° Reggimento artiglieria contraerei
1926-2003,Caporetto, I bersaglieri nel Risorgimento
(1848-1870), L'80° Fanteria - La lunga storia eroica di un
Reggimento mantovano diventata leggenda , La fulgida epopea
della Divisione Pasubio, Giacomo Desenzani un
generale castiglionese nella Grande Guerra, tutti editi da Sometti.
28/2/2015
Il bufalo e il bambino
di Ettore Masina
Poesia La vita è cosìDopo aver letto questa raccolta di poesie di Ettore Masina credo poter dire che l’autore, nel cogliere spunti e riflessioni sorte in occasione dei suoi viaggi in un mondo in cui tutto è controsenso, in cui miseria e ricchezza sono le facce della stessa moneta e dove ha cercato le verità nascoste, quasi sempre celate da verità imposte, ha in effetti voluto tratteggiare un unico grande percorso, quello della sua vita. Conosco Masina da abbastanza tempo per essere pressoché certo che questo suo ultimo lavoro non è stato motivato dalla necessità di far udire ancora la sua voce per sentirsi lui stesso, ormai avanti con gli anni, ancora vitale, bensì il suo scopo è più intimo e personale, è abbracciare quel culto della memoria che in una persona non più giovane finisce inevitabilmente per sostituirsi ai progetti per l’avvenire. Nel ricordare il passato si finisce con il rivivere un’esistenza, è la base indispensabile per fare bilanci e per riconoscere a se stessi il significato di tutto un procedere negli anni. Credo che il rendiconto finale possa essere stato più che soddisfacente, che quello spirito di giustizia che l’ha sempre animato non sia mai venuto meno, nonostante che oggi l’ingiustizia regni sovrana come da sempre. L’importante è aver tentato, avere la coscienza a posto e se non c’è stato risultato ci si può anche rammaricare, ma in ogni caso è stato bello aver provato. Masina non è certo un poeta classico, è uno che cerca di badare soprattutto al sodo, al messaggio che intende comunicare e pur tuttavia le sue poesie non sono scarne sequele di versi, ma sono anche permeate da una certa ricercatezza del linguaggio, dalla scelta di immagini appropriate, e da una apprezzabile levità, il che ne rende la lettura agevole e senz’altro piacevole. Grosso modo l’opera è costituita da 5 sillogi, ognuna delle quali ovviamente caratterizzata da liriche con la medesima tematica, circostanza ancora più evidente in quella intitolata E l’anima sbocciò, costituita da una sola poesia dallo stesso titolo. Non mi sembra giusto non soffermarmi su alcune poesie, almeno su quelle che più mi sono piaciute ed ecco allora che da Il bufalo e il bambino riporto i versi di Vecchi 2. Sarò forse per l’età, perché di certo non sono giovane, ma ho riscontrato in questa quel tocco di genio creativo che permette di esprimere tanto in poco. “Il vento ha portato via il cappello del vecchio, / lo insegue il vecchio a piccoli passi veloci. / Ride il bambino che lo crede ubriaco. / La vecchia moglie prega / che al suo uomo il vento / non porti via il pensiero.”. C’è tutto il ciclo vitale in questi pochi versi, con l’anziano, che nel suo viale del tramonto, rischia di perdere la ragione e con il bimbo, che ride della situazione, inconsapevole che un giorno anche lui finirà con il rincorrere un cappello; sembra poco e invece è tanto, è una sintesi mirabile che nella sua cruda realtà non addolora, ma che delinea con serenità il corso della vita. La forza di Qui, a Gaza (da Cartoline illustrate) sta tutta invece nell’accostamento fra due periodi diversi, fra quello che vide Maria fermarsi là per allattare Gesù mentre era in fuga da Erode verso l’Egitto, con tutto un contorno da idillio agreste proprio di chi, ovunque va, porta il bene e la pace, e la dura realtà di un territorio sempre infestato dalla guerra, con i bambini che sembrano vittime predestinate; la chiusa è una di quelle che non si dimenticano: “…/ Oggi i bambini a Gaza muoiono di ferite, / di fame, di paure, di macerie infinite. / Shemà, Israel, Shemà: / Erode è ancora qua. “ Non sono poche le poesie interessanti di questa raccolta e sarebbe improbo parlare di tutte, ma di una in particolare intendo effettuare qualche approfondimento, magari una nota, una riflessione: mi riferisco a La morte giocosa (da Attese e paura); infatti colpisce per il tono conviviale con cui parla della morte, figurata in modo non drammatico, come quella che è, cioè un fatto del tutto naturale, come la nascita. Ora in una persona in là con gli anni è cosa normale avere spesso presente la morte, che si pensa dietro l’angolo, ma parlarne con questi toni, se è anche vero che può essere un metodo scaramantico, non è certo frequente, è anche sintomo di un uomo che nel complesso è soddisfatto della sua vita e che accetta con serenità la sua fine terrena. Particolare e apprezzabile anche qui è la chiusa, che, per certi toni, mi fa venir in mente quella bellissima poesia di Nazim Hikmet che si intitola il mio funerale. “./ La banda musicale / del mio funerale /(suonatemi l’Internazionale!) / già si è messa in cammino, / scende per vie senza fretta, /b grancassa e bombardino / l’addio per un vecchio bambino, / con l’abito scuro, / dall’ombra dipinto sul muro.” È quasi una festa, un ritorno da dove si è partiti, è ancora una volta la consapevolezza che a tutto c’è un termine, e che questa è la vita. E quando arrivato all’ultimo verso ho chiuso il libro, ho avvertito dentro di me quella serenità che accompagna Ettore Masina. Piano piano si è insinuata nel mio animo e ancora ne gioisco, e questo non è certamente poco, anzi è tanto, è un qualche cosa di indefinibile e al tempo stesso tangibile, un’emozione ben impressa nella mia personale biblioteca dei ricordi. Il bufalo e il bambino è quindi senz’altro da leggere e da meditare; ne sarete piacevolmente sorpresi e alla fine gioirete della grande serenità che riesce a infondere.
Ettore
Masina (Breno,
1928), giornalista e scrittore, una delle voci più importanti del
cattolicesimo critico italiano, ha seguito come vaticanista del
quotidiano "Il Giorno" il Concilio Vaticano II e nel 1964 ha fondato
con il prete operaio Paul Gauthier
l'associazione
di solidarietà internazionale "Rete Radiè Resch"
(dal nome di una bambina palestinese morta di stenti nella sua casa
fatiscente). Dopo aver lavorato al Tg2, dal 1983 al 1992 è stato
deputato nel gruppo della Sinistra indipendente e nella X legislatura
è stato presidente del Comitato permanente per i diritti umani. Tra i
suoi saggi: Il Dio in
ginocchio (Rusconi, 1982), Il
califfo ci manda a dire,
(Rusconi, 1983), Un inverno
al Sud. Cile, Vietnam, Sudafrica, Palestina(Marietti,
1992), L'airone di
Orbetello. Storia e storie di un cattocomunista
(Rubbettino,
2005). Tra i romanzi, Il
ferro e il miele (Rusconi,
1983), Comprare un santo (Camunia,
1994), Il Vincere (San
Paolo, 1994).
25/2/2015
La tripla vita di Michele Sparacino
Bur Biblioteca Universale Rizzoli Nella scia di Pirandello Mi corre l’obbligo di fare una premessa, doverosa soprattutto per chi intendesse acquistare questo libro: la pubblicazione consta di due parti, la prima di sole 44 pagine è costituita dal racconto La tripla vita di Michele Sparacino, la seconda, con le restanti 46 pagine è un’intervista di Francesco Piccolo ad Andrea Camilleri. Si tratta di una strana scelta editoriale, tanto più che nella conversazione i riferimenti all’opera che la precede sono assai limitati, mentre invece è possibile avere altre notizie, fra le quali il modus operandi dell’autore nello scrivere i suoi romanzi, assai schematico, quasi geometrico. Questa parte può interessare fino a un certo punto e ha il sapore di un espediente per raggiungere un numero di pagine idoneo a una stampa, insomma a farne un libro da poter immettere sul mercato. Ciò premesso, per quanto come detto il racconto non sia lungo, pur tuttavia presenta indubbie valenze tali da ritenerlo meritevole di lettura per le riflessioni a cui esso porta. È strano il destino di Michele Sparacino, nato alla mezzanotte tra il 3 e il 4 gennaio del 1898, da famiglia poverissima, con un padre ubriacone e sempliciotto che ha già un bel problema all’anagrafe nel denunciarne la nascita. Sarà il 3 o il 4 gennaio? Risolve il tutto l’impiegato, provocando, però, involontariamente, tutta una serie di conseguenze che non toccano la famiglia del pargolo, ma che si manifestano in sommosse e tumulti, eventi eclatanti che attirano l’attenzione di un giornalista che per farsi bello inventa il Masaniello di turno, attribuendogli per un caso del tutto fortuito il nome di Michele Sparacino. Da allora il vero Michele Sparacino proverà sulla propria pelle cosa voglia dire essere scambiato per un facinoroso, tanto che a militare verrà considerato prima un disfattista, poi connivente con il nemico (siamo nel corso della Grande Guerra) e infine, poiché scompare durante la ritirata di Caporetto, anche un disertore. Il destino però gli ha riservato una sorpresa, lui che in effetti, al di là della nomea immeritata, è sempre stato uno sconosciuto, diventerà ignoto in assoluto, con onori e gloria, quali spettano a chi riposa nell’Altare della Patria. Si tratta solo di un racconto, ma le finalità di Camilleri non sono tanto quelle di imbastire una storia che si legge con molto piacere, ma vanno ben oltre. In fondo avrebbe potuto intitolarlo le tre vite di Michele Sparacino, ma in tal caso sarebbe venuto meno al suo intento, poiché in effetti la vita di Michele Sparacino è una sola, mentre sono altre e più quelle che gli uomini gli attribuiscono scambiandolo per altra persona e questo nel solco tracciato da un altro grande siciliano, Luigi Pirandello. E tutto questo per un’invenzione giornalistica, il che dimostra come la stampa possa condizionare esistenze, a cui si aggiunge, inevitabile, la visione che ognuno di noi ha di un altro. Così, se Michele Sparacino è stato visto come un capitano di popolo, poi come un soldato con i più gravi difetti per un militare (e che non aveva), cioè disfattista, connivente con il nemico, disertore, anche da morto il suo corpo ha un’altra vita. Era facile cadere in contraddizioni, perdere il filo del discorso, rendere inverosimile la vicenda, ma Camilleri ha saputo procedere con sicurezza, non disdegnando anche di darci un’immagine dell’autentico Michele Sparacino: un po’ ingenuo e un po’ furbo, schiacciato tuttavia da chi comanda, un ritratto che si potrebbe estendere tranquillamente alla quasi totalità di noi italiani. Quindi di carne al fuoco ne ha messo tanta, sia pure in poche pagine, e da abile scrittore quale è non l’ha mai bruciata, anzi ha saputo confezionare un racconto di eccellente qualità e che è indubbiamente meritevole di essere letto.
Andrea Camilleri (Porto
Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e
sceneggiatore. Ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il
volume, I teatri stabili in Italia (1898-1918). Il suo
primo romanzo, Il corso delle cose, del 1978, è stato
trasmesso in tre puntate dalla TV col titolo La mano sugli occhi.
Con questa casa editrice ha pubblicato: La strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992), La bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca(1997), La concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il re di Girgenti (2001), La
presa di Macallè (2003), Privo di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza Musumeci(2007), Il
casellante (2008), Il sonaglio (2009), La rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010, anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie diVigàta (2011), La setta degli
angeli(2011), La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014); e inoltre i romanzi con protagonista il
commissario Salvo Montalbano: La forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il giro di boa (2003), La pazienza
del ragno (2004), La luna di carta (2005), La vampa
d'agosto (2006),Le ali della sfinge (2006), La pista di
sabbia (2007), Il campo del vasaio (2008), L'età del
dubbio(2008), La danza del gabbiano (2009), La caccia
al tesoro (2010), Il sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi (2011), Una lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un covo di vipere (2013), La piramide di fango (2014).
21/2/2015 Gente in
cammino 16/2/2015
9 agosto 378 il giorno dei barbari di Alessandro Barbero
Editori Laterza Storia
La fine dell’Antichità e l’inizio del Medioevo La storia mi è sempre piaciuta, perché la conoscenza del passato può aiutare a comprendere molti fatti del presente e addirittura a prevederne altri che potrebbero avvenire in futuro. È per questo motivo che, benché non sia di certo un appassionato di programmi televisivi, quando mi è possibile non mi lascio sfuggire quelli proposti da Rai Storia. E appunto guardando alcuni di questi, cime quello sulle Crociate, mi sono imbattuto in un professore universitario piemontese, Alessandro Barbero, che mi ha stupito per la semplicità con cui è capace di raccontare grandi avvenimenti storici, non disgiunta da una sana ironia che finisce inevitabilmente per attrarre il telespettatore. Da lì e reperire presso la biblioteca del mio paese un suo libro il passo è stato breve e la mia scelta è caduta su 9 Agosto 378 Il giorno dei barbari. Non è un caso se ho optato per questo titolo, ma, così a memoria, ricordo che nei miei studi scolastici la fine dell’impero romano e con esso dell’antichità, con avvio al medioevo, era liquidata in poche pagine, tanto che quasi all’improvviso lo studente apprendeva della divisione dell’impero romano in due entità: quello d’occidente e quello d’oriente; nulla i libri riportavano sul perché di questa divisione e i miei insegnanti nulla aggiungevano, poi cominciavano le invasioni dei barbari, degli Unni, dei Goti, degli Ostrogoti, un susseguirsi di guerre deleterie esposte in in paio di paginette. Era quindi logico il mio desiderio di approfondire, di colmare quelle incolpevoli lacune scolastiche che creavano nella mia mente una situazione confusa, un succedersi di eventi di cui non riuscivo a trovare il filo, come se si fosse trattato di fatti con correlati, ma del tutto autonomi. Devo dire che questo bel saggio di Barbero è pienamente venuto incontro alle mie esigenze, e ciò seguendo un discorso razionale, lasciando ben poco spazio alla fantasia, in modo semplice e accattivante, così che la lettura, oltre che particolarmente istruttiva, mi è risultata facile, per nulla greve, anzi di una particolare e appagante gradevolezza. Insomma si può dire che il professor Barbero scrive come parla in televisione e mi auguro che sia altrettanto chiaro, completo e piacevole quando insegna. C’è da chiedersi perché è importante questa data, che cosa è accaduto il 9 agosto 378, un giorno tale da restare memorabile. Ebbene si svolse la battaglia di Adrianopoli, città sita nella provincia romana della Tracia, che corrispondeva all’attuale Turchia europea. Lo scontro vide contrapposti da un lato l’imperatore dell’Impero romano d’oriente Valente con il suo ben addestrato esercito e dall’altro Fritigerno con i suoi Goti. L’esito fu fatale ai romani, che vennero pressoché annientati e fra essi anche Valente. Barbero, nel prologo al suo libro, tiene a precisare come questa battaglia comunque non sia famosa come quelle di Waterloo e di Stalingrado, anche se il suo esito finì con il segnare, come opinione anche di altri storici, la fine dell’Antichità e l’inizio del Medioevo. L’autore è molto bravo nel delineare gli antefatti, ponendo in luce le trasformazioni intervenute nell’impero romano, le diversità esistenti fra la parte occidentale e quella orientale dello stesso, la diffusione della religione cristiana fra i barbari, quella religione che era già quella ufficiale nell’impero, ed è altrettanto capace di tratteggiare le conseguenze di questa sconfitta, cioè quella caduta inarrestabile di Roma, al cui tonfo si evidenziò quel periodo da non pochi considerato oscuro, ma che pure aveva anche dei valori non indifferenti, e che viene chiamato Medioevo. Credo di poter dire di essere sostanzialmente in accordo con il pensiero di Barbero, tranne in un elemento non certo da poco: la decadenza. Secondo l’autore l’impero non era certamente in condizioni salde e floride, ma non poteva essere considerato in condizioni di collassare gradualmente. Al riguardo, tuttavia, Barbero cita, dando prova di molta obiettività, in quanto di opinione contraria alla sua, il Gibbon, storico inglese che ha scritto un’opera di grande valore (Declino e caduta dell’impero romano) in base alla quale l’impero, alla vigilia delle famose invasioni barbariche, era un’entità in profonda decadenza. Personalmente sto con Gibbon, perché già da diverso tempo Roma era minata profondamente nella sua struttura da tutta una serie di problemi, alcuni dei quali peraltro evidenziati anche da Barbero, e che la facevano apparire sì come un colosso, ma dai piedi d’argilla. Queste erano le cause: secoli di conquiste e poi la decisione di fermarsi, perché i confini, troppo ampliati, erano difficili da difendere; la penuria nell’esercito di autentici romani che faceva sì che annoverasse nei suoi ranghi soprattutto truppe barbare; un flusso migratorio dalle zone poco civilizzate, agevolato sia per rimpolpare i corpi militari, sia per disporre di mano d’opera a basso costo; l’incertezza del potere, con imperatori che si succedevano con troppa rapidità, imposti dai loro stessi soldati; la diffusione del cristianesimo, che sminuiva la figura dell’imperatore, non più divino, e che cercava di allentare la schiavitù; la corruzione sempre presente a ogni livello; il vizio di mettere nei posti di responsabilità persone solo fedeli, ma spesso incapaci; la crisi economica, con un’inflazione crescente. Messe tutte insieme collaborarono alla disgregazione dell’impero e la battaglia di Adrianopoli è solo il fatto che di colpo mette alla luce una fragilità a lungo nascosta. Ed è strano come la storia si ripeta: spostiamoci di circa 1.600 anni e possiamo rilevare come parte di queste cause sia presente anche oggi, nel nostro Stato, augurandoci che non vi sia un’altra Adrianopoli e che quell’atmosfera da basso impero che si respira venga alla fine fugata. Questo riscontro è un’ulteriore prova di come la conoscenza del passato possa spiegare il presente. Corredato da un ampio elenco bibliografico, il saggio di Barbero è ampiamente meritevole di essere letto e, sempre per restare in epoca romana, è una lettura talmente piacevole che mi sento di dire che anche per questo, come iper pochi altri, vale la locuzione latina jucunde docet.
Alessandro Barbero
insegna Storia medievale presso l’Università del Piemonte Orientale,
sede di Vercelli. Studioso di prestigio, noto al largo pubblico, ha
pubblicato molti volumi. Bella
vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo è
il primo dei suoi romanzi di successo (Premio Strega 1996, tradotto
in sette lingue), al quale altri sono seguiti, tutti editi da
Mondadori. Per Laterza è autore di opere più volte ristampate, alcune
delle quali tradotte nelle principali lingue.
14/2/2015
Betty di Georges Simenon traduzione di Gabriella Luzzani
Adelphi Edizioni Storia di una
disadattata Georges Simenon è certamente un narratore di qualità, capace come pochi di delineare perfettamente ambientazioni, di ricreare atmosfere, di scendere in profondità nella psiche dei suoi personaggi e Betty è una di questi, una donna incapace di affrontare la realtà, spesso cruda, se non crudele, della società in cui vive. Già come ci viene presentata, in preda ai fumi dell’alcol, con gli abiti di qualità, ma sgualciti, le calze con le smagliature, smarrita, in preda a uno stato confusionale e soprattutto disperata. È un essere che si lascia trasportare, inerte, dagli eventi, come se avesse i piedi su questo mondo e la testa forse in un altro. Fa tenerezza per questa sua fragilità, ma anche repulsione, per quella sua incapacità di sapersi coscientemente relazionare. Insomma una che c’è, ma che anche non c’è, un personaggio quasi dalla doppia identità: apatica e rassegnata alla sua incapacità di amare, ma anche tesa alla ricerca di un amore, quell’amore che forse potrebbe salvarla, senza però che ci sia la convinzione in lei che possa essere la soluzione di tutti i suoi problemi. La potremmo definire una disadattata, una incoerente, una donna che non riesce a trovare una precisa identità e un ruolo nella società che le consenta di esserne consapevole parte. Si tratta evidentemente di un personaggio al limite, ma che serve egregiamente a Simenon per addentrarsi nella psicologia femminile, a volte tortuosa e complessa. Considerato il carattere dell’autore, i suoi turbinosi rapporti con l’altro sesso, la sua violenza anche nei confronti dello stesso, non mi stupisce più di tanto che abbia ideato un personaggio come Betty, che ripeto è al limite, per quanto, sia pure con caratteristiche meno esasperate, non sia difficile trovare donne che riescono a mostrare, nel medesimo tempo, due facce della stessa medaglia. È indubbio che Simenon qui sia riuscito a esprimere il suo virtuosismo ai massimi livelli, ma pur tenendo conto di questo elemento positivo, il romanzo in sé, per quanto di grande successo, mostra alcuni limiti, come per esempio una non impeccabile realizzazione delle atmosfere a cui lo scrittore belga ci ha sempre abituato e anche gli eccessi caratteriali in altre opere sono stati delineati meglio; inoltre la trama è tortuosamente avvitata su se stessa, tanto che la lettura ne risente . È esclusivamente per questi motivi che, sebbene sia dell’opinione che l’opera abbia una sua non trascurabile valenza, comunque non mi sembra in linea con altre che rasentano la perfezione, come, tanto per citarne una, Il piccolo libraio di Archangelsk. Aggiungo che qui è troppo presente l’autore, così che il personaggio che viene proposto e costruito appare come in controluce, laddove la fonte luminosa è identificabile chiaramente proprio in Simenon. Quindi per me è un ottimo romanzo, ma non un capolavoro.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a JeanPauhlan, da Faulkner a
Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
30/1/2015
Una
spina nel cuore Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. Il mistero dell’animo femminile *“Non è che bene. È tutto bene, che rende felici tutti e non fa male ad anima viva.” Da qualche minuto sentivo una punta acuminata che mi penetrava nel petto. “Ma lei” chiesi “non sente una spina nel cuore?” “Una spina? No, non sento nessuna spina. Anzi, il cuore mi si allarga” rispose. Trasse un profondo respiro e spalancò le braccia come se volesse accogliere sul suo cuore il mondo intero.* Piero Chiara, il cantore dei piccoli mondi, di quei paesi un tempo così caratteristici e ora quasi del tutto spersonalizzati da un progresso che porta solo sogni di ricchezza, è indubbiamente uno dei miei autori preferiti e ho letto quasi tutte le sue opere, per lo più di eccellente livello e qualcuna forse da considerare un capolavoro. Potrei dire che mi mancava solo Una spina nel cuore, tenuta per ultima chissà per quale arcano motivo, ma credo ne sia valsa la pena, perché accomiatarsi da un narratore che si apprezza così tanto è sempre un po’ malinconico, temendo anche che proprio l’ultimo libro sia quello meno riuscito. E invece posso congedarmi da lui con la soddisfazione di aver visto nel giusto, di averlo sempre considerato uno dei più grandi scrittori italiani e questo libro ne è un’ulteriore conferma. C’è sempre la vita di paese, con il lago, con il bar Metropole dove soggiornano i bighelloni giocando a carte o a biliardo, più che altro per ingannare il tempo, e immancabile c’è anche una storia di corna, o meglio una storia d’amore di una delicatezza incredibile, quasi che Chiara, probabilmente a fronte di un’esperienza personale non andata a buon fine, nel cercare di svelare la psicologia femminile volesse invece mettere a nudo, scoprire quella maschile. Caterina, la protagonista, è una ragazza che poco a poco svela la sua vita, come nel caso delle matrioske, perchè sollevato un velo di verità ci si accorge che sotto ce n’è un altro, che nella sua storia è preda e anche predatrice, che in fondo è un essere indifeso e succube, pronta a donarsi senza un’autentica passione. E lui, il protagonista maschile, che rispecchia per certi versi l’autore – e infatti parla sempre in prima persona – è colui che la perde e che solo allora tenta di capire, cerca di conoscere quella donna, per lui divenuta un’abitudine e che ora che se n’è andata ha finito con il lasciare un vuoto di cui continua a struggersi. Arriverà, per vie traverse, a conoscere la verità, scoprirà anche l’ultimo velo nel triste finale che lo vede desolatamente solo. Ci sono tanti personaggi, delineati alla perfezione, come il Dr. Trigona, il medico del paese, l’ostetrica Adelaide Biotti, il mostruoso e sfortunato Tibiletti, il Dionisotti, il signore prepotente, quasi un Don Rodrigo che somiglia tanto a Mussolini, il vissuto oste Sberzi e perfino il parroco, il saggio Don Galimberti. Si muovono tutti con un sincronismo perfetto, non sono semplici comparse, ma rivendicano una partecipazione attiva che impreziosisce il romanzo. Chiara ha saputo misurare gesti e parole, senza mai ricorrere all’enfasi, con un ritmo blando, quasi stanco, proprio come quello che scandiva la vita di un paese negli anni ’30. È sortito così un capolavoro, uno di quei romanzi che inizia piano piano, poi ti prende senza che ti accorga e s’infila dentro come una serpe, scava nell’animo per rinchiudervisi, si ficca nel cuore come una spina e finisce così che te lo porti sempre appresso, che ogni tanto ti torna in mente, ricordandolo con vero piacere, quel piacere che hai provato nel corso di tutta la sua lettura. Imperdibile. Piero Chiara nacque a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i più amati e popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi, quasi cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo, conterraneo e grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie che Chiara amava raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori, 1962), che segna il suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara scrisse con eccezionale prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.
E’ stato autore particolarmente fecondo e fra le sue numerose
pubblicazioni figurano Il piatto piange (1962), La
spartizione (1964), Il balordo (1967), L’uovo al
cianuro e altre storie (1969), I giovedì della signora Giulia (1970), Il
pretore di Cuvio (1973), La stanza del Vescovo (1976), Il
vero Casanova (1977), Il cappotto di Astrakan (1978), Una
spina nel cuore (1979), Vedrò Singapore? (1981), Il
capostazione di Casalino e altri 15 racconti(1986).
27/1/2015
La Grande Guerra di Mario Isnenghi
Giunti Editore Saggistica storica
Alcuni aspetti della Grande Guerra Ciò che mi ha stimolato maggiormente a leggere questo libro è stato il numero (157) veramente esiguo delle pagine, perché mi sono chiesto come uno storico potesse parlare brevemente della prima guerra mondiale, immaginando che si trattasse di un sunto per sommi capi. E invece mi sono sbagliato perché Isnenghi, pur seguendo l’ordine cronologico del conflitto dal 1914 al 1918 ha inteso privilegiare aspetti a cui normalmente viene riservata una trattazione abbastanza sintetica. In particolare ha suddiviso l’opera in cinque capitoli: 1 - Dalla pace alla guerra, vale a dire il periodo in cui cominciarono a presentarsi le prime avvisaglie di una guerra che nessuno dei contendenti desiderava ardentemente, ma che fece ben poco per scongiurarla; 2 - La guerra moderna, cio è quella caratteristica che la differenziò da quelle del XIX secolo, con massiccia presenza di nuove armi, con il preponderante peso dell’industria e con il coinvolgimento diretto delle popolazioni; 3 - Il paese e il fronte, con l’introduzione di una massiccia propaganda, l’inizio di una nuova classe operaia, all’epoca costituita per lo più da donne, essendo gli uomini arruolati; 4 - Il terribile 1917, e non solo per la nostra rovinosa disfatta di Caporetto, ma anche per sanguinose battaglie divampate sul fronte occidentale; peraltro l’anno è cruciale e importante anche per la rivoluzione russa e l’armistizio siglato da questo paese con la Germania e con l’Austria, nonché per l’ingresso nell’Intesa di quella grande potenza economica e militare che sono gli Stati Uniti; 5 - L’anno della pace, una pace che, anziché porre rimedio ai motivi che avevano scatenato il conflitto, getta tuttavia le basi per un nuovo scontro, che avverrà, come è noto, nel 1939. Questi capitoli tematici sono svolti abbastanza bene, senza tuttavia andare molto a fondo, così che si ricava l’impressione che l’autore li abbia voluti considerare linee guida per successive opere, che comunque a oggi non mi risultano pubblicate. L’interesse non manca perché in fondo si parla di fatti, di motivi che, pur sembrando del tutto pertinenti e forse dominanti in un conflitto gigantesco come quello, sono stati spesso trascurati o comunque ben poco trattati da altri storici. Ma se questo è l’aspetto positivo del libro non posso fare a meno di evidenziare il tono accademico che finisce con il rendere un po’ faticosa la lettura; del resto l’asetticità dell’autore, pregevole in uno studioso della materia, è un po’ eccessiva e non avrebbe guastato un po’ più di partecipazione che, fra l’altro, avrebbe contribuito ad avvincere maggiormente il lettore. Comunque l’opera resta sicuramente interessante e in fin dei conti è un utile mezzo per un approccio allo studio della Grande Guerra, che non sia basato sulle poche pagine presenti nei libri degli studenti delle scuole superiori, e in tal senso mi sento di consigliarne la lettura.
Mario Isnenghi è nato a Venezia nel 1938 e ha insegnato
Storia Contemporanea all’Università Caì Foscari di Venezia. E’ autore
di numerosi libri di storia, fra in quali I vinti di Caporetto
nella letteratura di guerra (Marsilio, 1967), Il mito della
Grande Guerra. Da Marinetti a Malaparte (Laterza, 1970), Le
guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi. 1848 – 1945
(Mondadori, 1989), La grande guerra (Giunti, 1993),
L’Italia del fascio (Giunti, 1996), La tragedia necessaria. Da
Caporetto all’otto settembre (Il Mulino, 1999), Garibaldi fu
ferito. Storia e mito di un rivoluzionario disciplinato
(Donzelli, 2007), Garibaldi fu ferito. Il mito, le favole
(Donzelli, 2010), Ritorni di fiamma. Storie italiane
(Feltrinelli, 2014)
24/1/2015
Recensione a “Azan e la spada di Dityan” di Maristella Angeli.
“La luce è vita, è speranza, è tocco divino che illumina le menti”.
Così Maristella
Angeli scrive alla fine del suo romanzo, e se, letta all’inizio,
questa frase potrà lasciarci perplessi, dopo che avremo finito di
leggere il libro, ne apprezzeremo senz’altro il senso.
18/1/2015
Il mio Delta e dintorni di Colomba Di Pasquale Prefazione di Vivian Lamarque
Fara Editore
Poesia
Benché questo libro ricomprenda due raccolte di poesie (Il mio Delta e Dintorni) il tema comune è costituito dalla relazione fra l’autrice e la natura; più esplicito nella prima, appare invece da sfondo portante nella seconda, evidenziando però ancora una volta l’afflato, intenso, esistente fra chi scrive e il mondo di cui è parte. Non mi nascondo che la tematica non è nuova e per certi aspetti può richiamare il De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro. Tuttavia, l’impostazione espositiva, la malinconia che permea tutti i versi, quella propria di chi nell’osservare con occhi attenti la natura s’incanta e si commuove, imprimono una personalizzazione a due raccolte che non è possibile non apprezzare per raffinatezza, equilibrio e armonia. Nella prima silloge è ben evidenziato l’amore che la poetessa ha per la foce del Po, quell’ampia superficie a delta in cui tutto sembra rimasto tale da millenni, come ben espresso nella lirica che dà il titolo al libro (Il mio Delta e dintorni): “Per quanto tu possa sperare / lo svasso continuerà la sua ricerca / e per quanto tu possa sperare / il marangone si scalderà al sommo del ramo / e per quanto tu possa sperare / l’airone bianco continuerà la sua pesca miracolosa / e per quanto tu possa sperare / la Natura continuerà ad essere sé stessa / senza sosta.”. Si tratta di una serie di immagini vive di abitatori di questa zona umida e in generale di altre zone umide della pianura padana, tanto che non è infrequente incontrarli nel Parco Naturale del Mincio. E in quelle occasioni ho provato le stesse emozioni, orgoglioso, come Colomba Di Pasquale, di essere parte di questo sistema perfetto e al tempo stesso consapevole della mia caducità, del mio infinitesimale tempo rapportato a quello infinito della natura, quella stessa natura che altri uomini vogliono distruggere per tornaconto personale, dimenticando che essendone parte finiranno invece con il distruggere loro stessi. Che poi sia comune fra me e l’autrice questo senso di precarietà rispetto all’eternità del mondo trova conferma ulteriore in un’altra bella poesia (L’imbarcazione), ben esplicitato nella chiusa:” …/ La vita alfine è una corsa / più o meno lenta verso la fine. / La carcassa dell’imbarcazione lo grida.”. Ma non c’è solo questo, c’è anche una lirica del tutto particolare, una di quelle che per originalità e completezza non è possibile dimenticare; infatti non avrei mai certamente pensato a una sorta di ringraziamento a chi ha consentito di conoscere, di comprendere il vero senso della natura e così si spiega l’Ode alle guide ambientali ( Se non ci fossero state loro / non avrei dato retta all’allodola e al cannareccione / non avrei evitato di calpestare il fiore di lino / e il campanellino estivo / non avrei osservato meglio il tronco di nidi / del salice / non avrei capito l’importanza del colpo d’ali / non avrei percepito la vicinanza terrena tra / me e il resto da me.). Come in Lucrezio Caro, Colomba è alla continua ricerca dell’infinito e sapendo che il nostro tempo è breve fissa su carta le emozioni ed è anche nella seconda raccolta che ciò viene ben esplicitato, laddove in Giorni scrive:” …/ Temo sempre perdere per sempre / questi ricordi misti a piccole morti. / Perché non tornano quei giorni così splendenti / così innamorati della vita, / non tornano?”. E a proposito di questa seconda parte si tratta di Dintorni molto allungati rispetto al delta del Po, sono poesie che nascono da sensazioni provate nel corso di viaggi, anche oltre i nostri confini, come nel caso di Argentina. In ogni caso sono versi belli, piacevoli da leggere, per nulla difficoltosi da comprendere, alcuni anche di intenso misticismo, come in Camaldoli (…/ L’aria rigida della foresta chiudeva il cielo / come una stretta al cuore e al fiato / necessaria per restare ancora nel monastero / prima di affrontare l’eremo / e i suoi ospiti nelle celle inaccessibili, / spogliati di loro stessi / come pulli / come quelli che vidi / giorni dopo nel nido della cicogna di Bando. / Sarà questa la purezza dell’inizio e della fine? / Sarà questa mi dico l’essenza della vita?) Da leggere, senz’altro.
Colomba Di Pasquale
è nata nel 1968 a Lilla in Francia. Di origini abruzzesi, insegna
diritto ed economia in due istituti tecnici di Ravenna. Risiede a
Recanati. Con Del Monte Editore ha pubblicato Viaggio
tra le parole nel
2006 e con Nicola Calabria Editore Una
vita altrove nel
2007. Nel 2008 pubblica con Fara
Il resto a voce e
viene inserita nell’antologia fariana
Il silenzio della poesia con
la silloge Dei silenzi (e degli
ascolti). Nel 2010 presso Genesi Editore ha pubblicato
Dulcamara con prefazione di Vivian Lamarque. È presente in
diverse antologie letterarie e ha conseguito numerosi riconoscimenti
sia per la poesia edita che inedita.
14/1/2015
Il mondo senza sonno di Stefan Zweig Skira Edizioni Narrativa racconti
“Più breve è ora il sonno del mondo più lunghe le notti e più lunghi i giorni. In ogni paese della sconfinata Europa, in ogni città, via, casa, stanza, il respiro quieto e sopito è più corto, agitato come in un’unica notte d’estate afosa e soffocante…” La guerra, ossessivamente presente ove anche non si combatte, fa da sfondo alle vicende narrate in questi quattro racconti, ognuno dei quali, per certi versi, è capace di rappresentare le emozioni e le tensioni di chi, direttamente o indirettamente, vi è coinvolto. Il conflitto in questione è il primo grande scontro mondiale del secolo scorso, quello che solo in parte vide coinvolte le popolazioni belligeranti e che comunque rappresentò un salto stratosferico nell’orrore, quell’orrore che poi verrà amplificato da lì a pochi anni nella seconda guerra mondiale. Zweig, scrittore austriaco, poi naturalizzato inglese, è capace di interpretare angosce e dilemmi non tanto di soldati al fronte, ma di chi invece sta nelle retrovie, lontano dai tiri dei cannoni, ma che comunque, vuoi per l’aver dei familiari sotto le armi, vuoi per tenere ossessivamente presente la tragica realtà che su tutto incombe opprimente, finisce con l’essere preda di una tensione angosciosa che prepotente emerge dalle righe. Se nel primo brano (Il mondo senza sonno) che dà il titolo all’intero libro le pulsioni, gli incubi, per non parlare della serpeggiante paura occupa il tempo degli abitanti delle nazioni belligeranti, nel secondo e nel terzo si scende nei particolari, in singoli casi che, per la loro logica ripetitività, finiscono con l’essere il disarmante quadro di un mondo che ha preso a girare alla rovescia. Dalla genuina sofferenza del soldato russo disertore (Episodio sul lago di Ginevra), strappato già al suo mondo immobile e arcaico e catapultato in una realtà per lui incomprensibile, al dilemma del pittore (L’obbligo), ospite in Svizzera, fra l’obbedire alla chiamata alle armi e opporsi così a un omicidio legalizzato, sono affrontate tematiche non precipue di quel conflitto, ma di tutte le guerre. L’uomo militare non è più tale, è un essere indistinto in una massa, quasi una mandria avviata al macello, in preda alle sue paure e anche al suo senso di repulsione – almeno nella maggior parte dei casi – per la violenza, ma è anche quell’essere talmente imperfetto dall’avere una memoria corta, da ritornare sui campi di battaglia, una volta intervenuta la pace, per visitare con viaggi ben organizzati i luoghi dell’orrore (Ypres), senza pietà, ma solo con una abnorme curiosità di poter calcare la terra sotto cui giacciono tante vittime di guerra. Non c’è scoramento, c’è solo spazio più che per un pellegrinaggio in memoria, per una gita turistica. Zweig sembra dirci che, nonostante tanti buoni propositi, non è cambiato nulla e che quindi gli orrori di uno scontro si possono ripresentare, come in effetti é. L’autore si dimostra particolarmente abile nel descrivere l’angoscia derivante dall’oppressione di un evento che cambia radicalmente il modo di vivere di ogni essere umano, che profonde a piene mani incertezze, che toglie ogni possibilità di predisporre progetti, apparendo l’esistenza più che mai appesa a un filo sottile che di giorno in giorno tende ad allungarsi fino al punto di rottura. Non è la paura per una malattia, che in fin dei conti può essere attribuita al fato, ma è il timore di un domani senza speranze, è anche la sfiducia in un sistema, in una società i cui capi non esitano a metterne il gioco il futuro per spesso incomprensibili motivi. Si tratta di un libro interessante, a cui nuoce solo la tipica grevità degli scrittori mitteleuropei della prima metà del secolo scorso, ma è indubbia la validità del messaggio portato, è palpabile il senso di sgomento, tutte qualità che mi inducono a consigliarne la lettura. Stefan Zweig
(1881-1942), scrittore, giornalista, drammaturgo e poeta austriaco
naturalizzato britannico, è̀ stato uno degli scrittori più̀ noti del
Novecento: tra i suoi titoli più famosi ricordiamo Il mondo di
ieri. Ricordi di un europeo (Mondadori, 1994), La
novella degli scacchi (Garzanti, 2004), Magellano (BUR,
2006), Paura (Adelphi, 2011). In fuga dalle leggi razziali, si
esiliò in Brasile nel 1940 e vi si suicidò, insieme alla seconda
moglie, nel 1942. Di lui Skira ha pubblicato Il candelabro sepolto
(2013).
6/1/2015
Ritorno sul Don di Mario Rigoni Stern Edizioni Einaudi
Il ricordo è sempre presente Si tratta di otto racconti ambientati durante la seconda guerra mondiale, di cui l’ultimo, Ritorno sul Don dà il titolo all’intera opera. Ancora una volta ho potuto constatare le straordinarie capacità di questo narratore e pertanto il lettore non potrà che apprezzare i toni caldi, ma pacati, le atmosfere perfettamente riprodotte e l’abilità nel far sì che i suoi ricordi non abbiano valore solo per lui, ma per tutti. Si alternano mirabilmente le visioni della steppa russa e dei verdi prati dall’altipiano di Asiago, con descrizioni paesaggistiche mai fini a se stesse, ma indispensabili per poter vedere con la propria fantasia i papaveri rossi nell’oro del frumento o il verde dei boschi di montagna, immagini di una dolce natura che stridono con i fragori e gli orrori di una guerra. Dal massacro di Nella steppa di Kotovoskij all’alpino che ritrova il padre creduto disperso nella prima guerra mondiale di In un villaggio sepolto nella balca, dagli ebrei costretti a un rigoroso confino in La segheria abbandonata alla vicenda di un uomo che, dopo aver combattuto nella Grande guerra, si trova sotto le armi anche nella seconda (Bepi, un richiamato del ’13), dallo struggente Un ragazzo delle nostre contrade e dal difficile periodo a casa dopo la fine del conflitto (La scure) a Ritorno sul Don, non viene mai meno la grande umanità di Mario Rigoni Stern, che ama la giustizia, ma non la vendetta, e che comunque riesce a vivere in pace con tutti e soprattutto con se stesso. Sono tutti belli questi racconti, ma Ritorno sul Don é a dir poco superlativo per la capacità dell’autore di esprimere gli stati d’animo, per quel continuo riaffiorare di ricordi, quasi sempre tragici, senza tuttavia indulgere alla facile commozione. Così come in un altro suo libro (Aspettando l’alba) aveva anche scritto di un suo viaggio, con i familiari, nel lager che lo vide prigioniero dei tedeschi, in Ritorno sul don c’è il resoconto di un suo pellegrinaggio, con la moglie, lungo la via della tragica ritirata di Russia. I contrasti fra la dolcezza del paesaggio attuale e e la piattezza di distese sconfinate di neve percorse da una torma di straccioni e di affamati, la discrasia fra la pace di oggi, che ti consente di viaggiare insieme all’ex nemico in perfetta armonia, e l’angoscia e l’orrore di un esercito in rotta che cerca la salvezza lasciandosi dietro una scia di morti sono tutti quadri di incomparabile bellezza. Stern riesce nel difficile compito di rendere partecipe il lettore al passato e al presente, senza affaticarlo, anzi entusiasmandolo. È tanta la grandezza di quest’autore, per natura invece umile, che il passato che fa rivivere ci sembra familiare, quasi che anche noi vivessimo quei ricordi come fossero nostri. Ritorno sul Don è uno di quei libri che, una volta letti, non si riescono a dimenticare.
Mario Rigoni Stern (Asiago
1921-2008) ha esordito nel 1953 con Il
sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia (ultima
edizione «Super ET» 2008), uno dei libri più significativi del
dopoguerra. Sempre presso Einaudi, ha poi pubblicato: Il
bosco degli urogalli(1962), Quota
Albania (1971), Ritorno
sul Don (1973), Storia
di Tönle (1978, Premio Campiello), Uomini,
boschi e api (1980), L'anno
della vittoria (1985), Amore
di confine (1986), Il
libro degli animali (1990),
Arboreto salvatico (1991), Le
stagioni di Giacomo (1995), Sentieri
sotto la neve (1998), Inverni
lontani (1999 e 2009), Tra
due guerre (2000),L'ultima
partita a carte (2002
e 2009), Aspettando
l'alba e altri racconti (2004), I
racconti di guerra (2006)
e Stagioni («L'Arcipelago
Einaudi» 2006, «Super ET» 2008 e «Numeri Primi» 2012). Il suo ultimo
libro, pubblicato postumo nel 2008, è la sceneggiatura del Sergente
nella neve, scritta con Ermanno Olmi.
4/1/2015
Nel buio che precede l’alba di Joseph Boyden Traduzione di Paola
Bertante Narrativa romanzo Il male che c’è in noi È il 1919 e la prima guerra mondiale è finita da poco. Niska, una vecchia indiana Cree attende il treno in una cittadina canadese che porta un reduce, Elijah, il migliore amico di suo nipote Xavier, da lei cresciuto come un figlio, e che purtroppo è morto in combattimento, come comunicato in un telegramma. Il convoglio arriva, scendono in tanti e per ultimo un uomo, che sembra un vecchio, malandato e privo di una gamba. Ma non è Elijah, bensi Xavier, profondamente ferito non solo nella carne, ma anche nello spirito. Sta a lei, che è come una sciamana, riportarlo alla vita in un lungo viaggio di ritorno in canoa su acque spumeggianti e fra foreste incontaminate. Lungo il percorso Niska gli parla, gli racconta la sua vita di quasi ultima indiana che non si è lasciata conquistare dal mondo dei visi pallidi; lui, estremamente sofferente, ascolta in silenzio e a sua volta rievoca, per lo più mentalmente, la sua amicizia con Elijah, gli anni di guerra, l’orrore che ha visto e il terribile segreto che nasconde.. Scritto dal canadese Joseph Boyden, le cui origini sono scozzesi e irlandesi, mescolate tuttavia con quelle dei nativi Ojtbwe, Nel buio che precede l’alba è un romanzo di grande approfondimento psicologico che non manca di avventura e della capacità di mettere bene in rilievo quanto la guerra possa cambiare gli uomini e portarne alla luce la loro autentica personalità. In un continuo alternarsi di vita primitiva, con paesaggi stupendi, e scene di battaglia, su terreni sconvolti dalle bombe, coperti di cadaveri, tesse una trama che è convincente e che inevitabilmente finisce con l’attrarre il lettore, disposto a perdonargli la non trascurabile lunghezza del testo. Fra riti pagani e avventure piano piano si entra in sintonia con Xavier, si comprende il rifiuto alla violenza che lo coglie verso la fine del conflitto, ma soprattutto attira quel segreto che lui porta dentro e che lentamente gli toglie la forza e la vita; opportunamente verrà svelato alla fine, anche se nel frattempo, da tanti elementi e fatti, ci si può forse arrivare da soli. E’ un libro strano, perché non è un’opera contro la guerra, ma sulla guerra, non è un romanzo edificante, ma è anzi un atto di accusa al sistema di vita occidentale che, nel suo desiderio di potenza, fa emergere negli uomini il loro lato peggiore, da cui pochi si salvano se non con il pentimento e il rimorso. È lunga e dolorosa la redenzione di Xavier, come il suo viaggio di ritorno a un mondo apparentemente primitivo in cui però primeggiano valori che l’uomo bianco sembra aver dimenticato. I protagonisti sono sostanzialmente tre: Elijah e Xavier, descritti benissimo con una psicologia estremamente fine, e soprattutto la vecchia Niska, una zia che tutti desidereremmo avere, emblema di un mondo in cui essere umano e natura si integrano perfettamente, donna coraggiosa e intelligente, capace di amare un nipote come fosse il figlio che non ha mai avuto. Può sembrare forse esagerato, ma non sono infrequenti i brani che potrei definire di prosa poetica, e non si tratta solo di quelli in cui fa da sfondo il paesaggio dei grandi fiumi e delle immense foreste, ma anche di quelli che nel funebre tempo della guerra riescono a cogliere il segno, se anche minimo, di una normalità e in cui si riaffaccia una natura che intende rivendicare i valori primigeni dell’umanità, come alcuni fiori o una rondine che accudisce i suoi piccoli, una speranza per un futuro diverso e migliore. Nel buio che precede l’alba è un ottimo romanzo e quindi ne consiglio la lettura.
Joseph Boyden, quarant'anni, è
cresciuto fra Toronto e la Georgian Bay (Canada) in una famiglia le
cui radici irlandesi e scozzesi si mescolano a quelle dei nativi
Ojibwe. Laureato alla York University di Toronto, ha insegnato ai
ragazzi delle riserve e dal 1992 è titolare della cattedra di
scrittura creativa all'Università di New Orleans. Il suo esordio
narrativo Nel buio che precede l'alba è stato uno dei romanzi
più contesi nel panorama editoriale mondiale. Bestseller N. 1
assoluto in Canada, dove è stato proclamato uno dei 5 migliori libri
dell'anno, è finalista al Governor's General Literary Award, il
massimo premio letterario canadese.
1/1/2015
Quando si pensa con i piedi e un cane ti taglia la strada di Luisito Bianchi
L’Ancora del Mediterraneo
Narrativa romanzo
Doreàn, ovvero gratuitamente Ci sono libri che apparentemente sembrano piccole storie, ma che, qualora letti con la dovuta attenzione, rivelano qualità insospettabili, messaggi che vanno ben oltre l’esile trama che funge solo da supporto per raggiungere l’obiettivo. È questo il caso di Quando si pensa con i piedi e un cane ti taglia la strada, un volumetto in cui Luisito Bianchi, l’autore del celebre La messa dell’uomo disarmato, ancora una volta ritorna sul tema a lui caro, su quella gratuità a cui si è uniformato nel corso di tutta la vita, perché se si vuole cambiare il mondo, questo cambiamento deve prima avvenire in noi stessi. Ripeto che la vicenda è esile nell’incontro con un cane non affamato che si affeziona da subito a Luisito, gli dona incondizionatamente il proprio amore ricevendone altrettanto. E poiché anche questi simpatici animali devono avere un nome, per lui viene scelto Doreàn, un avverbio greco che tradotto significa gratuitamente. Senza un tornaconto immediato la bestiola offre il suo amore, chiedendo solo in cambio, a gratis, altrettanto. Se Dio ci ha dato questa terra, i suoi frutti, vivere per appropriarsene a danno degli altri, rinchiuderci nel nostro egoismo che misura tutto in termini monetari, anche i contatti con i nostri simili, è venir mento ai principi cristiani, nonostante ci si possa professare credenti. E Don Luisito Bianchi ha improntato tutta la sua vita a questo principio della gratuità, rifiutando lo stipendio da insegnante di religione, lavorando come prete operaio in un’industria chimica, vivendo in ristrettezze in un mondo che non riesce a comprendere altro che i valori monetari. In questo modo è stato un prete scomodo, critico nei confronti di una Chiesa che ha sempre professato la sua sete di potenza, proteso a condividere l’esistenza delle classi più disagiate, testimonianza sì di una fede, ma soprattutto di una coerenza mai venuta meno. Ho potuto verificare ciò più volte nel corso dei non infrequenti colloqui telefonici che abbiamo avuto e l’unica cosa di cui mi pento è di aver rimandato, più volte, un nostro incontro a Viboldone nell’illusione che per questo c’era ancora quel tempo che poi non c’è stato. Anche la nostra corrispondenza epistolare rivela un uomo dalla straordinaria grandiosa umiltà, la stessa che possiamo trovare in un altro illustre personaggio del secolo scorso, cio è Gandhi. Nel suo libro Don Luisito, nel ripercorrere una vita, ritorna tambureggiante sul tema della gratuità senza esaltare il suo percorso, tanto che quella coerenza, decisa a tutto al punto da renderlo inviso a non pochi comandanti della Chiesa, appare per lui un fatto del tutto normale, come normale è mangiare, dormire e respirare, e in queste pagine si respira un’aria buona, leggera, da alta montagna, quasi che lui, pur sempre fra noi, fosse immerso in quella profonda serenità propria solo di chi è consapevole di procedere sulla strada giusta. Da leggere senz’altro.
Luisito Bianchi è
nato a Vescovato nel 1927 ed è morto nel 2012. Sacerdote dal 1950, é
stato insegnante e traduttore ma anche operaio, benzinaio e
inserviente d’ospedale. Negli ultimi anni di vita ha svolto la
funzione di cappellano presso il monastero di Viboldone (Milano).
Ha pubblicato:Salariati (1968), Gratuità
tra cronaca e storia (1982), Dittico vescovatino (2001), Simon
mago (2002), La
messa dell’uomo disarmato (2003),
Dialogo sulla gratuità (2004)
e Monologo
partigiano (20049,
Come un atomo sulla bilancia (2005), I
miei amici - Diari (2008), Quando si pensa con i piedi e un
cane ti taglia la strada (2010), Le quattro stagioni di un
vecchio lunario (2010), Il seminarista (2013).
|
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Poetare.it © 2002