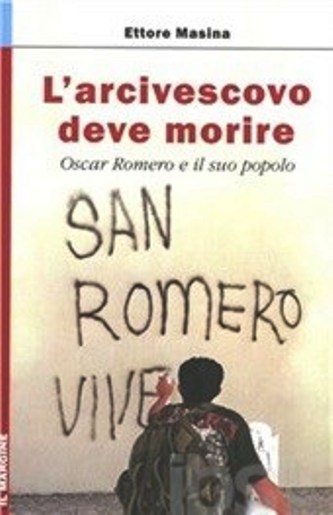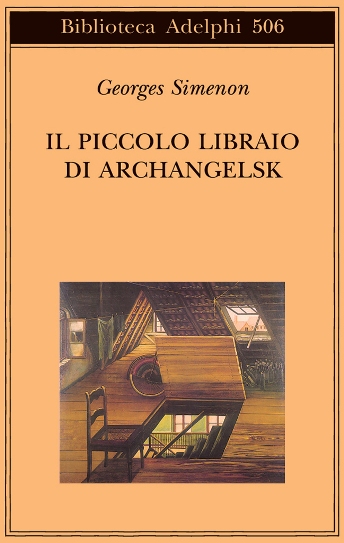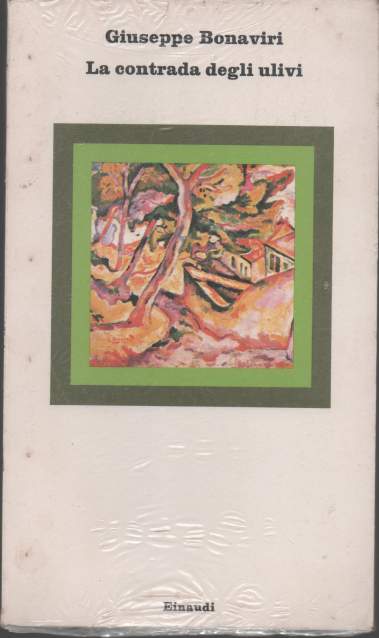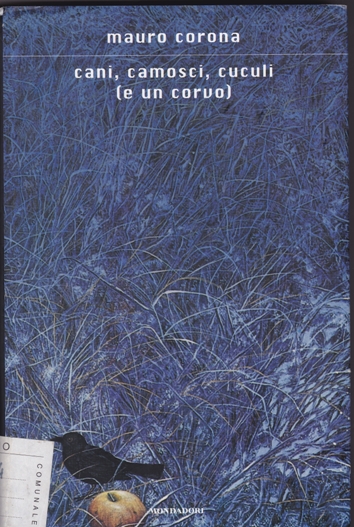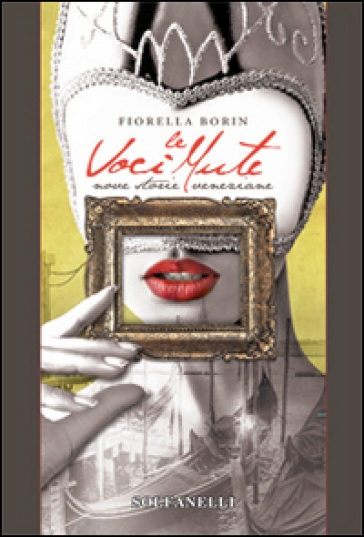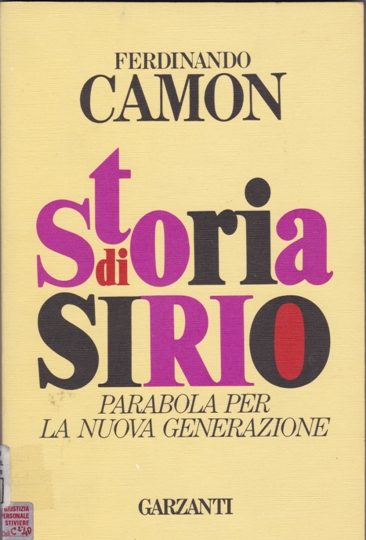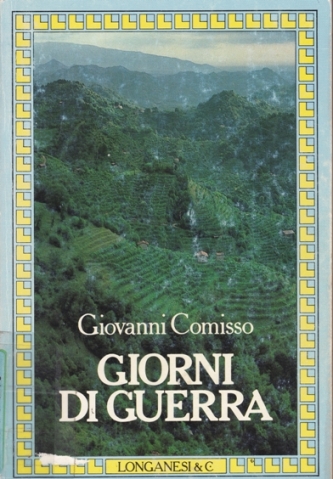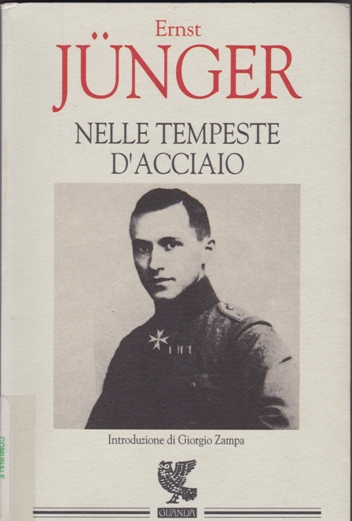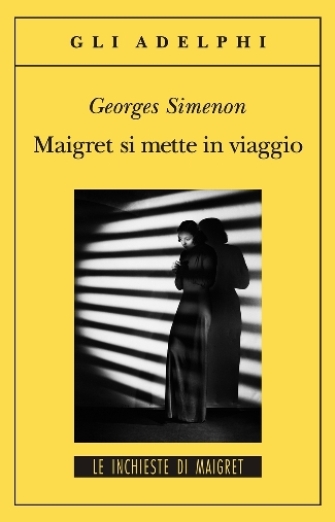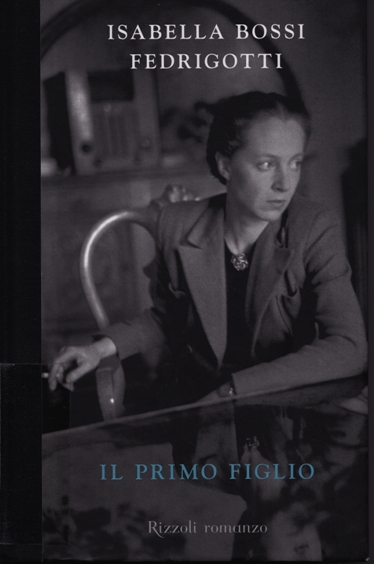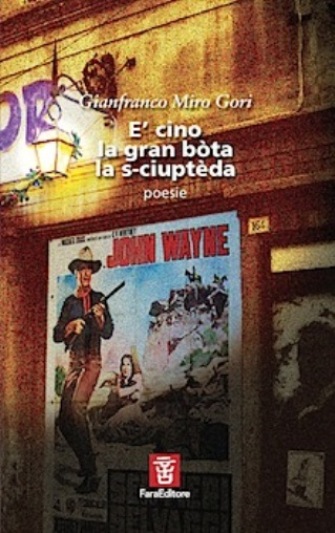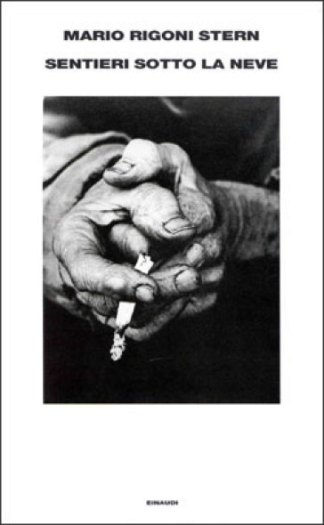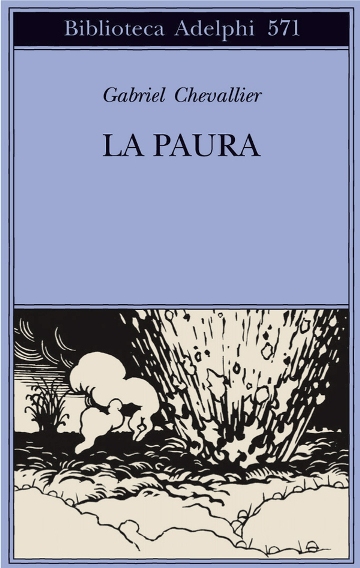2014
![]()
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Commenti Poesie consigliate La Giostra della satira Concorsi La Sorgente delle poesie
|
Questa pagina raccoglie le recensioni di romanzi, libri di racconti, volumi di poesia e di altro genere letterario (libri di saggi, viaggi, teatro, ecc.), film. |
Recensioni 2012
Recensioni 2013
Recensioni 2014 (Gennaio-Settembre)
|
28/12/2014
Magazzino vita di Isabella Bossi Fedrigotti Edizioni Longanesi
Gli oggetti sollecitano il ricordo “ Era passatempo per noi sorelle, più o meno confinate fra casa e giardino, guardare dall’alto la stradina, giusto un poco più animata di oggi, con viavai di biciclette, di qualche carro di buoi, di donne con le borse, di vecchi che lenti trascinavano i piedi sul selciato di porfido. Più che vedere era interessante sentire: voci, chiacchiere, risate, battibecchi e bestemmie, risse di ubriachi la sera che salivano fino alle nostre finestre come attraverso un megafono, per via della stradina così stretta, delle case dirimpetto così vicine alla nostra. Saliva per noi la vita da quella smorta via semideserta, vita che non conoscevamo e della quale a tutti i costi volevamo apprendere il più possibile.” La vecchia casa nobiliare si è lentamente spopolata, è entrata in una fase di decadenza come la dinastia che l’abitava, e ora non restano che i segni del passato che Isabella Bossi Fedrigotti evidenzia descrivendoci gli ambienti dell’antica magione e riscoprendo dagli oggetti, dai mobili, da vecchi vestiti ormai non più indossabili le storie di chi lì ha vissuto, lei compresa. Normalmente, o comunque quasi sempre, questo tema viene svolto in modo decisamente prolisso e sovente anche piuttosto greve, ma l’autrice riesce a fornire nuovamente un bell’esercizio di stile, rendendo la lettura più che gratificante. Così ci accompagna, quasi tenendoci per mano, in una visita, dal pianterreno alla soffitta, facendoci da guida, offrendoci alla vista ciò che si cela sotto la polvere di secoli e, attraverso oggetti e vestiario, veniamo a conoscere le storie dei suoi abitatori, una dinastia di campagna, non particolarmente ricca, ma nemmeno povera, che ha fatto di quella immensa casa un simbolo del prestigio, ma anche un rifugio dalle novità di ogni tempo. L’atmosfera è rarefatta, i passi, i piccoli screzi sono brevi e controllati, insomma si entra in un mondo ai più sconosciuto e che tutto sommato non ci induce a invidiare una nobiltà ristretta volontariamente fra quelle mura, tesa a conservare un particolare modo di vivere che cerca di mantenere immutato nel tempo. Isabella Bossi Fedrigotti, pur nell’affetto che mostra per i suoi familiari, in particolare gli avi più prossimi, tiene a prendere le distanze, ricordando la ferrea disciplina a cui era sottoposta, l’incapacità, imposta, di essere come gli altri comuni mortali, in un tempo che avrebbe dovuto essere fermo e sempre uguale. Non è un caso quindi se fra la parentela le sue simpatie vanno ad Alfonsina e Giuseppe, i reietti e, a loro modo, i ribelli della famiglia, incapaci di sostenere una vita noiosa, in cui tutto era programmato in un calendario senza variazioni. Ormai magazzino dei più svariati oggetti, anche di quelli inutili o inutilizzabili, la dimora è diventata una sorta di museo dei ricordi, un magazzino di vite passate le cui tracce possono essere individuate grazie a un tavolo, oppure a un abito dismesso e nella migliore delle ipotesi in uno dei tanti ritratti. L’autrice, nel ripercorrere le storie dei suoi familiari, porta alla luce un mondo, un modo di vivere che è stato e che mai più ritornerà, ma non c’è rimpianto, non regna la malinconia, grazie alla consapevolezza che non è più tempo di nobili, o meglio non è più tempo del modo di vivere di una nobiltà prigioniera del suo stesso titolo; di un’epoca e di un rango un giorno forse si perderà traccia, ma è giusto sapere com’era e cos’era e Magazzino vita ci fornisce le risposte in modo sorprendentemente piacevole ed efficace. Da leggere, senza il minimo dubbio.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor
Budischowsky (Rizzoli, 2003) e Il primo figlio (Rizzoli,
2008).
20/12/2014
Vita di Gabriele D’Annunzio di Piero Chiara Mondadori Editore
Il Vate Di biografie di Gabriele D’Annunzio, personaggio assai noto, soprattutto per la sua vita fuori da qualsiasi canone, ne sono state scritte innumerevoli, ma a me interessava soprattutto quella di Pero Chiara, scrittore fra i miei preferiti. Il motivo? Considerata la propensione dell’autore luinese a narrare, nel contesto delle piccole realtà, di avventure spesso boccaccesche, ho pensato, non a torto, che un protagonista della storia come D’Annunzio dovesse anche essere visto sotto l’aspetto che forse più l’ha caratterizzato, cioè quell’insaziabile appetito sessuale che ha contraddistinto tutta la sua vita. Non crediate, però, che il libro indugi solo sulle numerose avventure galanti del Vate, perché invece fornisce anche un quadro puntuale ed esauriente di uomo che fece di se stesso un vero e proprio mito. Se 447 pagine sembrano tante, sono invece appena sufficienti per una biografia di un personaggio poliedrico come D’Annunzio, e comunque prescindono da una disamina della sua arte letteraria, che non era nelle intenzioni di Chiara e per la quale si limita di tanto in tanto a degli incisi, quasi sempre non benevoli, o riferendo degli insuccessi di rappresentazioni teatrali, o accennando al vizietto che aveva di scopiazzare. Ne desumo, pertanto, che il D’Annunzio letterato non fosse particolarmente apprezzato dal biografo, e del resto, al riguardo, la critica non è concorde, passando dall’esaltazione alla stroncatura. Credo, tuttavia, che la vita del poeta, narratore e drammaturgo pescarese possa influire non poco sul giudizio delle sue opere, in cui sovente si riflettono alcune delle tante esperienze vissute. Ciò premesso, posso dire che giunto, non con fatica, ma anzi con piacere all’ultima pagina, il lavoro di Chiara è riuscito assai bene e fa emergere la figura, per certi versi straordinaria, di un uomo che fece di se stesso un mito. E pensare che era un tipo volubile, gran bugiardo, spendaccione oltre misura e sempre inseguito dai creditori (vizio di famiglia questo), del tutto amorale, ossessionato dal rapporto sessuale al punto che, in tarda età, per poterlo praticare dovette ricorrere a sostanze stimolanti come la cocaina. Ma D’Annunzio è anche l’uomo un po’ anarcoide, nazionalista, ma non fascista, che si gettò nella prima guerra mondiale con un entusiasmo, mai scemato, che lo portava a sfidare la morte con atti eroici; al riguardo, non si trattò solo del volo su Vienna o della beffa di Buccari, ma anche di ripetute azioni sul fronte che, se magari non arrecavano danni consistenti al nemico, avevano però il pregio di galvanizzare i nostri soldati. Fu anche ferito (perse un occhio), ma non in episodio bellico, bensì in uno sfortunato atterraggio del suo aereo. Da questa sua partecipazione al conflitto trasse ulteriori fama e onori, con promozioni, medaglie d’argento e anche una d’oro, e altri riconoscimenti degli alleati, tutte cose a cui teneva in modo particolare, essendo un gran vanitoso, tanto che mi è sorto il dubbio che certe imprese fossero motivate unicamente dal desiderio di gettare ulteriore benzina sul fuoco del mito. Poi, come in ogni essere umano, poiché la vita è una parabola, dopo il vertice raggiunto con la questione fiumana, assai ben delineata da Chiara, iniziò la fase discendente, il ritiro a Gardone nella bella villa, i continui foraggiamenti di Mussolini, che lo temeva, vedendo in lui un possibile avversario, e infine l’inesorabile e malinconico declino, chiuso nella sua prigione adorata, come sempre attorniato da una corte di donne, ma sempre più l’ombra di se stesso, fino alla morte, che avvertiva vicina, avvenuta a seguito di un aneurisma cerebrale. Ma il Mito non doveva finire ed ecco allora il suo desiderio, puntualmente realizzato, di far diventare la sua dimora (il Vittoriale) un museo mausoleo, ancor oggi meta di numerosi turisti e curiosi. Vita di Gariele D’Annunzio è un buon libro, scritto in modo scorrevole, mai greve, punteggiato qua e là dall’ironia dell’autore che, pur tuttavia, accompagna le ultime pagine con un sincero senso di pietà, poiché con il degrado fisico dovuto all’età il SuperUomo D’Annunzio diventa l’uomo che se forse non teme la morte, avverte ogni giorno l’approssimarsi della fine, l’ineluttabilità di un destino comune a tutti gli esseri viventi. Corredato dall’indicazione di tutte le fonti l’opera di Chiara assume una valenza storica che riesce anche a farci meglio comprendere quel periodo di fine ‘800 e di inizi ‘900 in cui una vecchia struttura sociale credeva di allontanare da sé lo spettro della sua imminente scomparsa gettandosi nel più ampio appagamento dei sensi e che la Grande Guerra spazzerà via. Il miglior rappresentante di questo stile di vita non poteva che essere D’Annunzio, un uomo che al termine dei suoi giorni non deve aver potuto nemmeno pensare che la sua esistenza fosse stata fatta solo di monotonia. Ha amato tanto, anche troppo, ma negli ultimi anni era sostanzialmente solo, come probabilmente solo aveva condotto la sua vita, fatta solo di passioni sfrenate e di soddisfazioni carnali, senza la tranquilla presenza di un autentico affetto. Da leggere. Piero Chiara nacque a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i più amati e popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi, quasi cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo, conterraneo e grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie che Chiara amava raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori, 1962), che segna il suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara scrisse con eccezionale prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.
E’ stato autore particolarmente fecondo e fra le sue numerose
pubblicazioni figurano Il piatto piange (1962), La
spartizione (1964), Il balordo (1967), L’uovo al
cianuro e altre storie (1969), I giovedì della signora Giulia (1970), Il
pretore di Cuvio (1973), La stanza del Vescovo (1976), Il
vero Casanova (1977), Il cappotto di Astrakan (1978), Una
spina nel cuore (1979), Vedrò Singapore? (1981), Il
capostazione di Casalino e altri 15 racconti(1986).
16/12/2014 
Porte aperte
Edizioni Adelphi
Narrativa romanzo Il grande impegno civile di Sciascia “ La realtà è che chi uccide non è il legislatore ma il giudice, non è il provvedimento legislativo ma il provvedimento giurisdizionale. Onde il processo si pone con una sua totale autonomia di fronte alla legge e al comando, un’autonomia nella quale e per la quale il comando, come atto arbitrario di imperio, si dissolve, e imponendosi tanto al comandato quanto a colui che ha formulato il comando trova, al di fuori di ogni contenuto rivoluzionario, il suo <<momento eterno>>.” (Salvatore Satta, Soliloqui e colloqui di un giurista) Verso la fine degli anni trenta (e quindi in pieno regime fascista) a Palermo fu commesso un crimine efferato (un uomo uccise la moglie, il suo datore di lavoro che l’aveva licenziato e l’impiegato che lo aveva sostituito). Il colpevole, individuato dagli investigatori, fu assicurato alla giustizia. La vicenda, accaduta realmente, rappresentò l’occasione per Leonardo Sciascia per imbastire nel 1987 un romanzo storico volto a condannare, senza mezzi termini e senza dubbi, la pena di morte. Sì, perché il colpevole, che per il suo carattere non era individuo capace di suscitare simpatie, né di impietosire, era destinato inevitabilmente ad essere condannato alla pena capitale mediante fucilazione, poiché la pena di morte era stata reintrodotta nella legislazione dal Ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco. Non bastasse questo, in un regime che, vantandosi, affermava che gli italiani potevano dormire sonni tranquilli a porte aperte (da qui il titolo dell’opera), non si poteva tollerare che qualcuno contraddicesse con i fatti la pretesa quiete tanto sbandierata. Quindi sembrava già deciso tutto e il processo non avrebbe dovuto che essere una mera formalità, ma ci fu un giudice che intese procedere secondo coscienza e che pertanto né tollerò pressioni autoritarie, né riuscì ad accettare che potesse esistere un diritto legale di sopprimere un essere umano. Certo, nel libro c’è una chiara condanna del fascismo e della sua violenza innata, ma sarebbe riduttivo dire che Sciascia si è limitato a stigmatizzare un regime, perché la sua denuncia, e da qui il suo grande impegno civile, sta proprio in quella possibilità che ha un tribunale di privare della vita un imputato, atto più che ingiusto in quanto la pena è prevista da una legge, immorale e inumano, immorale perché si attribuisce un potere eccessivo a chi giudica (decidere fra vita e la morte), inumano poiché togliere la vita a un nostro simile non solo non risolve il problema della delinquenza come statisticamente dimostrato, ma impedisce anche che il reo possa prendere coscienza dell’enormità del suo reato e che con il rimorso si accompagni il pentimento, e quindi la redenzione. Questo giudice, un piccolo giudice a latere esistito veramente, non volle tradire la sua coscienza e trovando anche un alleato in un giurato popolare, un agricoltore bibliofilo (di grande rilievo ed effetto il loro dialogo), arrivò a comminare una sentenza di reclusione a vita, ben sapendo che in appello sarebbe stata assai probabilmente ribaltata e trasformata in pena di morte. Come uomo, tuttavia, rimase in pace con se stesso, non ebbe contrasti e lacerazioni nella sua coscienza, non si lasciò condizionare, anche se poi il suo comportamento ebbe effetti negativi per la sua carriera. Ma al di là della bellezza del romanzo, del profondo messaggio che lancia, della capacità di Sciascia di avvincere e di pungolare, ciò che mi sembra sia di particolare pregio è quella necessità espressa affinché ogni essere umano, nelle sue decisioni, debba sempre regolarsi secondo coscienza, mantenendo ben viva quella luce di umanità che ci distingue dalle bestie, e ciò anche se avrà un costo, che non sarà mai così alto e lancinante come invece nel caso in cui si agisca contro il proprio intimo sentire. Dal romanzo è stato tratto un film di grande successo diretto da Gianni Amelio e interpretato da Gian Maria Volonté, un eccellente trasposizione di un’opera narrativa non certo facile, ma che non può che lasciare un segno indelebile dentro il lettore.
Leonardo Sciascia (Racalmuto,
8 gennaio 1921 – Palermo, 20 novembre 1989). E’ stato autore di saggi
e romanzi, fra cui: Le
parrocchie di Regalpietra (Laterza,
1956), Il
giorno della civetta (Einaudi,
1961), Il consiglio
d’Egitto (Einaudi,
1963), A ciascuno il
suo(Einaudi, 1966), Il
contesto (Einaudi,
1971), Atti relativi
alla morte di Raymond Roussel(Esse Editrice, 1971), Todo modo (Einaudi,
1974), La scomparsa di Majorana (Einaudi,
1975), I pugnalatori (Einaudi,
1976), Candido, ovvero
Un sogno fatto in Sicilia (Einaudi,
1977), L’affaire Moro (Sellerio,
1978), Il teatro della
memoria (Einaudi,
1981), La sentenza
memorabile (Sellerio,
1982), Il cavaliere e
la morte (Adelphi,
1988), Una
storia semplice (Adelphi,
1989).
14/12/2014
L'arcivescovo deve morire di Ettore Masina Prefazione di Leonardo Boff
Edizioni Il Margine
Storia biografia Fede e giustizia Oscar Arnulfo Romero y Galdàmez (Ciudad Barrios, 15 agosto 1917 – San Salvador, 24 marzo 1980). In queste due date, come per tutti gli esseri umani, è ricompreso il percorso terreno di questo sacerdote, di famiglia povera, ma non misera, avviato al seminario dall’alcade del suo paese natale, in quanto sin da bambino dimostrava una concreta vocazione religiosa. E in effetti fu allievo attento, studioso e coscienzioso, tanto da meritare l’accesso alla Pontificia Università Gregoriana, conseguendo il baccellierato in Teologia. Ritornato al suo paese, svolse il suo ministero sacerdotale con autentica passione, facendosi benvolere dalla popolazione, costituita quasi esclusivamente da contadini analfabeti e miseri, che lo apprezzavano per la sua innata umiltà. Benché conservatore, legato quindi a una visione della Chiesa come istituzione chiusa, avulsa dalla realtà dei fedeli, sarà proprio questa vicinanza con una classe disperatamente povera, vessata da pochi grandi latifondisti, sempre pronti a far reprimere nel sangue qualsiasi moto di protesta, che cambierà profondamente l’uomo, capace di comprendere che un religioso non deve vivere nella stretta osservanza delle norme della Chiesa, ma deve essere il Cristo di tutti gli uomini e in particolare di quelli più sfortunati. È così che si accostò alla teoria della liberazione con cui si affermano come prioritari i valori di emancipazione sociale e politica che figurano nel messaggio cristiano. Fu una vera e propria trasformazione e Oscar Romero, anche per effetto delle continue violenze degli squadroni della morte, che tolsero la vita a persone e a collaboratori a lui particolarmente cari, diventato arcivescovo di San Salvador, cominciò a denunciare pubblicamente i misfatti che insanguinavano il paese, venendo meno alla tradizionale accondiscendenza della sua carica con le famiglie che detenevano il potere. Le sue omelie, trasmesse dalla radio diocesana, furono ascoltate anche all’estero, pur se non apprezzate dal Vaticano. Non sostenuto da Paolo VI e nemmeno dal suo successore Giovanni Paolo II divenne così sicuro bersaglio dei latifondisti; tuttavia, lui continuò a predicare, a invocare la pace e la giustizia, consapevole, come il Cristo, che la sua fine era prossima. Infatti, il 24 marzo 1980, mentre stava celebrando la Messa nella cappella dell’Ospedale della Divina Provvidenza, in cui viveva in un piccolo locale dalla sua nomina ad arcivescovo, un sicario lo uccise con un solo colpo di pistola. Se ne andò da questo mondo povero come aveva sempre vissuto, per non essere diverso dai suoi amati poveri. Come non infrequente nella storia della Chiesa, un personaggio scomodo da vivo diventa estremamente utile da morto e fu così che nel 1997 venne avviata la causa di beatificazione, ancora non conclusa, perché stranamente ferma per anni, ma sollecitata ora fermamente da papa Francesco. Io ho riassunto in poche righe una vita, più che altro per informare chi legge di che si tratta, ma la storia di questo uomo debole di salute, gracile, ma dalla volontà ferrea, riveniente da una fede ben salda, è narrata in modo magistrale in questo libro da Ettore Masina. La sua è una scrittura piana, non enfatica ma vibrante, precisa senza essere pignola, circostanziata nel raccontare gli accadimenti senza che tuttavia sfoci, anche appena, nello schema di un verbale. E tutto appare in crescendo, mettendo in luce quegli eventi che sono indispensabili per comprendere il personaggio. Ne esce così una splendida biografia che ha la forza e la bellezza del romanzo senza esserlo, che porta a una lettura veramente appassionante, al punto che ho ritratto, sovente, l’impressione di trovarmi al fianco di Romero, davanti a una folla di disperati campesinos che chiedono solo di vivere e che nonostante tutto vanno avanti grazie alla loro fede religiosa. Chiedono, tuttavia, a quell’uomo che li ascolta un po’ di giustizia e lui parla a loro con le parole di Cristo, con quel messaggio di pace e di serenità che oggi ha più di duemila anni e che da sempre troppi non vogliono udire. Leggetelo, perché è un’esperienza indimenticabile.
Ettore Masina
(Breno,
1928), giornalista e scrittore, una delle voci più importanti del
cattolicesimo critico italiano, ha seguito come vaticanista del
quotidiano "Il Giorno" il Concilio Vaticano II e nel 1964 ha fondato
con il prete operaio Paul Gauthier l'associazione di solidarietà
internazionale "Rete Radiè Resch" (dal nome di una bambina
palestinese morta di stenti nella sua casa fatiscente). Dopo aver
lavorato al Tg2, dal 1983 al 1992 è stato deputato nel gruppo della
Sinistra indipendente e nella X legislatura è stato presidente del
Comitato permanente per i diritti umani. Tra i suoi saggi: Il
Dio in ginocchio (Rusconi,
1982), Il califfo ci
manda a dire, (Rusconi, 1983), Un
inverno al Sud. Cile, Vietnam, Sudafrica, Palestina(Marietti,
1992), L'airone di
Orbetello. Storia e storie di un cattocomunista(Rubbettino,
2005). Tra i romanzi, Il
ferro e il miele (Rusconi,
1983), Comprare un
santo (Camunia, 1994), Il
Vincere (San Paolo,
1994).
11/12/2014
Porte aperte di Leonardo Sciascia
Edizioni Adelphi
Narrativa romanzo Il grande impegno civile di Sciascia “ La realtà è che chi uccide non è il legislatore ma il giudice, non è il provvedimento legislativo ma il provvedimento giurisdizionale. Onde il processo si pone con una sua totale autonomia di fronte alla legge e al comando, un’autonomia nella quale e per la quale il comando, come atto arbitrario di imperio, si dissolve, e imponendosi tanto al comandato quanto a colui che ha formulato il comando trova, al di fuori di ogni contenuto rivoluzionario, il suo <<momento eterno>>.” (Salvatore Satta, Soliloqui e colloqui di un giurista) Verso la fine degli anni trenta (e quindi in pieno regime fascista) a Palermo fu commesso un crimine efferato (un uomo uccise la moglie, il suo datore di lavoro che l’aveva licenziato e l’impiegato che lo aveva sostituito). Il colpevole, individuato dagli investigatori, fu assicurato alla giustizia. La vicenda, accaduta realmente, rappresentò l’occasione per Leonardo Sciascia per imbastire nel 1987 un romanzo storico volto a condannare, senza mezzi termini e senza dubbi, la pena di morte. Sì, perché il colpevole, che per il suo carattere non era individuo capace di suscitare simpatie, né di impietosire, era destinato inevitabilmente ad essere condannato alla pena capitale mediante fucilazione, poiché la pena di morte era stata reintrodotta nella legislazione dal Ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco. Non bastasse questo, in un regime che, vantandosi, affermava che gli italiani potevano dormire sonni tranquilli a porte aperte (da qui il titolo dell’opera), non si poteva tollerare che qualcuno contraddicesse con i fatti la pretesa quiete tanto sbandierata. Quindi sembrava già deciso tutto e il processo non avrebbe dovuto che essere una mera formalità, ma ci fu un giudice che intese procedere secondo coscienza e che pertanto né tollerò pressioni autoritarie, né riuscì ad accettare che potesse esistere un diritto legale di sopprimere un essere umano. Certo, nel libro c’è una chiara condanna del fascismo e della sua violenza innata, ma sarebbe riduttivo dire che Sciascia si è limitato a stigmatizzare un regime, perché la sua denuncia, e da qui il suo grande impegno civile, sta proprio in quella possibilità che ha un tribunale di privare della vita un imputato, atto più che ingiusto in quanto la pena è prevista da una legge, immorale e inumano, immorale perché si attribuisce un potere eccessivo a chi giudica (decidere fra vita e la morte), inumano poiché togliere la vita a un nostro simile non solo non risolve il problema della delinquenza come statisticamente dimostrato, ma impedisce anche che il reo possa prendere coscienza dell’enormità del suo reato e che con il rimorso si accompagni il pentimento, e quindi la redenzione. Questo giudice, un piccolo giudice a latere esistito veramente, non volle tradire la sua coscienza e trovando anche un alleato in un giurato popolare, un agricoltore bibliofilo (di grande rilievo ed effetto il loro dialogo), arrivò a comminare una sentenza di reclusione a vita, ben sapendo che in appello sarebbe stata assai probabilmente ribaltata e trasformata in pena di morte. Come uomo, tuttavia, rimase in pace con se stesso, non ebbe contrasti e lacerazioni nella sua coscienza, non si lasciò condizionare, anche se poi il suo comportamento ebbe effetti negativi per la sua carriera. Ma al di là della bellezza del romanzo, del profondo messaggio che lancia, della capacità di Sciascia di avvincere e di pungolare, ciò che mi sembra sia di particolare pregio è quella necessità espressa affinché ogni essere umano, nelle sue decisioni, debba sempre regolarsi secondo coscienza, mantenendo ben viva quella luce di umanità che ci distingue dalle bestie, e ciò anche se avrà un costo, che non sarà mai così alto e lancinante come invece nel caso in cui si agisca contro il proprio intimo sentire. Dal romanzo è stato tratto un film di grande successo diretto da Gianni Amelio e interpretato da Gian Maria Volonté, un eccellente trasposizione di un’opera narrativa non certo facile, ma che non può che lasciare un segno indelebile dentro il lettore.
Leonardo Sciascia (Racalmuto,
8 gennaio 1921 – Palermo, 20 novembre 1989). E’ stato autore di saggi
e romanzi, fra cui: Le
parrocchie di Regalpietra (Laterza,
1956), Il
giorno della civetta (Einaudi,
1961), Il consiglio
d’Egitto (Einaudi,
1963), A ciascuno il
suo(Einaudi, 1966), Il
contesto (Einaudi,
1971), Atti relativi
alla morte di Raymond Roussel(Esse Editrice, 1971), Todo modo (Einaudi,
1974), La scomparsa di Majorana (Einaudi,
1975), I pugnalatori (Einaudi,
1976), Candido, ovvero
Un sogno fatto in Sicilia (Einaudi,
1977), L’affaire Moro (Sellerio,
1978), Il teatro della
memoria (Einaudi,
1981), La sentenza
memorabile (Sellerio,
1982), Il cavaliere e
la morte (Adelphi,
1988), Una
storia semplice (Adelphi,
1989).
7/12/2014
Derubati di sovranità. La guerra delle élite contro i cittadini di Gianluca Ferrara
Edizioni Il punto d’Incontro Saggistica politica-economica
Ritorniamo uomini liberi! La crisi sembra senza fine, non c’è giorno che una fabbrica non chiuda mettendo sul lastrico centinaia di lavoratori, e alle difficoltà economiche si aggiungono anche quelle atmosferiche, con piogge di tipo monsonico, cioè vere e proprie cascate d’acqua che dilagano ovunque portando morte e distruzione. Come la prima, come quell’economia che pare il cane che si mangia la coda, anche il tempo non è una fatalità, ma è il frutto della sistematica azione dell’uomo che sta depredando il pianeta. Cosa c’è dietro questo scenario apocalittico, chi sono i principali colpevoli di tali sfortune? Questo libro di Gianluca Ferrara fornisce le risposte e, guardate bene, non si tratta di ipotesi campate in aria, ma è il risultato di un approfondito studio di carattere economico e sociologico basato esclusivamente su dati ufficiali. Tuttavia, temo che non possa essere creduto, visto che è un guscio di verità in un mare in tempesta di menzogne, propinateci da anni in modo subdolo e ossessivo, grazie soprattutto alla televisione, che ha la straordinaria capacità, con l’immagine, di far credere reale ciò che non é. Siamo stati indotti a consumare sempre di più, perché se è giusto consumare, altra cosa è essere condizionati a credere che l’acquisto di un bene ci possa portare alla tanto agognata felicità, che nel caso specifico si elide nel brevissimo periodo in cui pagato l’oggetto ci si trova per le mani non il rimedio del nostro quotidiano malanno, ma un nuovo ossessivo bisogno perché incalzati da una nuova chimera. Si è arrivati al punto che non si produce più in base ai bisogni, ma che si creano di continuo nuovi bisogni onde proporre subito di che soddisfarli. In questo girone perverso, ideato e alimentato da pochi individui che da soli si spartiscono la quasi totale ricchezza del mondo, finiamo con l’essere loro inconsapevoli complici, alla ricerca continua di nuovi guadagni da bruciare nel nulla, come dei drogati, privi di qualsiasi volontà. E allora crediamo a tutto, alla panzanata che il nostro colossale debito pubblico è stato causato dal nostro modo di vivere ben superiore alle nostre possibilità, il che non è vero, perché noi ci siamo quasi distrutti per poter comprare ciò che è così indispensabile, che hanno tutti e che pertanto non averlo finirebbe con l’emarginarci. Abbiamo anche creduto che con la globalizzazione, con i nuovi investimenti ci sarebbe stato più lavoro, e invece questo è diminuito; ci siamo illusi con la moneta unica di essere come i tedeschi (loro invece non si sono illusi, sono rimasti i tedeschi di prima, ma con ben più soldi in tasca). Per fortuna però che ancora c’è la democrazia, ma quale democrazia? Quella che quando vai a votare a chiunque tu dia il tuo consenso puoi star sicuro che non cambierà niente, che la situazione sarà già tanto se non peggiora? Ed è forse democrazia quella che acquista a spizzichi gli F35 e non ha i soldi per i disabili, o quella che grazie a un Presidente della Repubblica che lo sta diventando a vita ha messo dapprima a capo del governo un non eletto, come poi ha fatto anche per l’attuale? Se la democrazia è questa quasi quasi preferisco la dittatura perché là, volente o nolente, il capo diventa l’unico responsabile di ogni azione, senza quei giochini e quei balletti che ci tocca vedere ogni giorno. Così, senza accorgerci siamo stati derubati della sovranità, perché chi sta al governo è lì su mandato di noi tutti e a noi deve rispondere del suo operato, e a nessun altro. In questo schema societario mondiale se al vertice ci sono i cosiddetti poteri oscuri - ma poi così oscuri non sono, perché mi chiedo come mai ogni anno questi signori dell’elitario Club Bildenberg si riuniscono a porte chiuse e nulla trapela – i politici sono un gradino più sotto, sono i vassalli, poi giù giù in fondo ci siamo noi, i sudditi, i servi della gleba. L’analisi di Ferrara è spietata, incide nelle nostre errate convinzioni come il bisturi tagliente di un chirurgo, e devo dire che non fa piacere scoprire che quello che forse per atavico istinto temevamo non è un’ipotesi, ma un fatto concreto. Subito ci si pone una domanda: c’è rimedio? Se c’è voluta la rivoluzione industriale in poco più di due secoli per ridurci così, se abbiamo lasciato che impunemente prendesse il sopravvento il neoliberismo economico, che vede lo stato come un nemico, salvo poi ricorrere ad esso nel caso che certe speculazioni vadano male (ma chi paga siamo sempre noi), la soluzione c’è, anche se non percorribile in tempi brevi. Se è vero che occorrerà riconquistare le sovranità nazionali, monetarie e alimentari, quello che è più necessario è recuperare la sovranità dell’uomo, cioè noi dobbiamo diventare artefici del nostro destino, noi dobbiamo credere in noi e non in ciò che ci viene propinato, dobbiamo vedere con i nostri occhi, dobbiamo arrivare a capire che la ricchezza esiste perché c’è la povertà degli altri, che le disuguaglianze sono solo foriere di sventure, che la vita, questo breve percorso dall’alba al tramonto è da fare insieme, senza ostacolarci, e che essa può essere infinitamente bella e serena anche se non si riesce a comprare l’ultimo modello di iPad oppure una Ferrari. Già il prendere coscienza del nostro stato è un buon inizio e grazie a questo bellissimo saggio di Gianluca Ferrara è ora maggiormente possibile.
Gianluca Ferrara laureato
in Scienze Politiche è un saggista noto per la sua analisi dei
fenomeni politici e degli scenari economico-sociali, ha scritto per
diverse riviste e quotidiani nazionali come Il Manifesto e L’Adista.
Ai suoi libri hanno partecipato: Andrea Gallo, Alex Zanotelli, Beppe
Grillo, Vandana Shiva e Paul Connett.
4/12/2014
Il piccolo libraio di Archangelsk di Georges Simenon Traduzione di Massimo Romano
Adelphi Edizioni
Narrativa romanzo
Un autentico capolavoro Jonas Milk è un piccolo commerciante di libri usati che ha il negozio, con annessa abitazione, sulla piazza del mercato di una piccola città francese. Nato ad Archangelsk in Russia, già da infante, in concomitanza con la rivoluzione, ha dovuto abbandonare il suo paese con i genitori, mentre le sorelle sono rimaste ospiti di una zia. La famigliola, approdata in Francia, riesce a rifarsi una vita, poiché il padre mette su una bottega di pescheria proprio in quella piazza del mercato. Jonas ha studiato, è istruito, ma è sempre timoroso di non apparire troppo umile e quando muoiono i genitori, non subentra nella loro attività, ma rileva un negozio di libri, conducendo una vita modesta, ma dignitosa, da scapolo, fino a quando gli viene praticamente buttata fra le braccia Gina, molto più giovane di lui, figlia di altri negozianti del Vieux Marché (così si chiama la piazza del mercato). La ragazza, esuberante e ninfomane, è nota per concedersi a tanti uomini, Jonas lo sa, ma la sposa egualmente, soprattutto per togliere il grigiore dalla sua esistenza e per cercare di proteggerla. Lui, che è riuscito a essere parte di una piccola realtà, nonostante sia di origini straniere e per di più ebreo (ma si convertirà in occasione del matrimonio, non per vocazione, in quanto non credente, ma affinchè la cerimonia di nozze avvenga in chiesa). In seguito la vita continua abbastanza nella normalità, fino a quando un giorno Gina sparisce. Jonas prova inquietudine e vergogna per essere stato lasciato dalla moglie, tanto più che ha portato con sé i francobolli più preziosi e di rilevante valore della sua collezione di filatelico. Invece di formalizzare la scomparsa con una denuncia alla polizia, quando al vecchio mercato gli chiedono dove sia Gina inventa un’innocente bugia. Dice che è andata a Bourges, ma più passano i giorni, più la gente s’informa se è ritornata, quella piccola menzogna si rivela una bomba a orologeria, poiché negli altri si insinua il sospetto che lui abbia eliminato la consorte. E così puntuale arriva la polizia e mi fermo qui con la vicenda, perché, pur limitandomi a dire che non è né un romanzo giallo, né un noir, che prevedono quanto meno la presenza di un delitto o comunque di un grave reato, lo sviluppo vi terrà incollati al libro come forse non vi è mai capitato. Se nella prima parte Simenon ha privilegiato l’atmosfera, l’ambiente, la storia di questo Jonas, nella seconda, in un crescendo entusiasmante, ci mostra con una fine analisi psicologica, ma anche sociologica, l’inferno in cui può cadere un innocente, colpevole solo di essere uno straniero e per di più ebreo. Non c’è però solo questo, perché piano piano si compone il ritratto di questo piccolo libraio, che ha fatto dell’umiltà il fine della sua stessa esistenza, un uomo strappato alle sue origini, senza più famiglia, che ha creduto di ritrovarne una allargata costituta dai negozianti del vecchio mercato, poi una vera e propria con il matrimonio. Jonas è un uomo disperatamente solo che credeva di aver trovato in quella piazza la sua nuova patria, di essere diventato come loro, i negozianti, di aver raggiunto quella tranquillità che ha solo chi è parte integrante di una comunità. E invece di colpo crolla ogni sicurezza, dalla freddezza improvvisa degli altri si passa alle accuse, a voci fatte circolare e prive di fondamento; il peggio però deve ancora venire e lo proverà quando, tramite la polizia, verrà a sapere che Gina, che lui intendeva proteggere, invece aveva paura di lui. E’, come si suol dire, il colpo di grazia e per Jonas il mondo e la vita non avranno più senso. Che Simenon sia un grande scrittore penso non ci siano dubbi, ma in questo libro è riuscito a cogliere e a rappresentare un dramma che finisce con lo stritolare, oltre che il personaggio principale, anche il lettore. La sua disperazione diventa anche la nostra, il suo successivo disinteresse alla vita porta chi legge a un senso di angoscia, gli fa immaginare cosa gli accadrebbe se tutte le sue certezze crollassero di colpo, se improvvisamente dovessimo trovarci soli, circondati da gente che prima credevamo amica, ora divenuta ostile, se perfino in famiglia venissimo a sapere che la moglie ha recitato una parte, senza sentimenti, anzi con un livore latente. Ho letto tanti libri di Simenon, tutti belli, ma questo ha qualche cosa di più, ha le caratteristiche del grande capolavoro. Non mi pare che sia necessario aggiungere altro.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a JeanPauhlan, da Faulkner a
Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
1/12/2014
La contrada degli ulivi di Giuseppe Bonaviri Edizioni Einaudi
Narrativa racconti
Un racconto di straordinaria bellezza “…Pensava alla neve che lei aveva visto soltanto una volta, lassù, a Camùti, ed era caduta in tante foglioline bianche e si era posta sugli ulivi e sui sassi delle trazzere. Ma subito si era disfatta ed era rimasto un brillio d’acqua sulle cose. Non poteva capire come quella neve potesse accumularsi in colline alte e uguali e le pareva di vedere Luigi Cappellano in tutta quella neve camminare e affondare e gridare, senza che nessuno lo andasse a salvare….” Scritto dopo Il sarto della strada lunga, il romanzo che è stato l’opera prima di Giuseppe Bonaviri, La contrada degli ulivi è un racconto lungo di straordinaria bellezza, per certi versi forse uno dei migliori lavori dell’autore siciliano. La vita della gente legata alla terra vi è descritta mirabilmente, con quell’eternità di tempo propria della civiltà contadina, in cui tutto appare ed è immutabile. Si tratta di poveri esseri ancorati al terreno, da cui traggono il minimo indispensabile per sopravvivere, in una condizione di costante precarietà che già Giovanni Verga bene aveva evidenziato in alcune delle sue novelle e che ritroviamo anche In una terra chiamata Alentejo del grande José Saramago. In ogni caso lo scritto di Bonaviri si differenzia dalle opere di questi due autori per la tendenza - che poi nei suoi lavori successivi si evidenzierà meglio – a un senso dolcemente cosmico, in base al quale è la natura stessa a diventare protagonista, e non solo gli uomini, che ne sono solo una parte. In La contrada degli ulivi il dialogo fra esseri umani e le cose ha una caratteristica di sporadicità, appare come un tentativo, peraltro già riuscito, di dare un senso comune a tutto ciò che esiste, che è presente, uomini, animali, vegetali e perfino i sassi. La narrazione procede come sotto l’incubo di una sempre possibile tragedia, in una vita che più che dare pare togliere, e in questo contesto si innestano tante piccole storie che danno la misura dell’ingrato destino dell’uomo, schiavo di quella terra, su cui si rompe le ossa e che poi finirà con il riprenderselo. Non è certo una visione ottimistica, però guai a pensare che Bonaviri intendesse ridurre l’esistenza a una materialità di semplice nascita, tribolazione e morte, perché in fondo all’uomo è riservata l’ancora di salvezza dell’amore, quasi a dire che l’esistenza si può riassumere in nient’altro che l’amore. E così Rosa, che si è innamorata ricambiata di Luigi, una relazione fatta solo di sguardi, di emozioni, di palpitazioni, quando lui, partito militare per la guerra non farà più ritorno dalla steppa russa, continuerà a sopravvivere nel ricordo di quel sentimento, che nemmeno la durezza del lavoro, le disgrazie, le miserie e la fame potranno scalfire. Se Il sarto della strada lunga mi è piaciuto tanto, questo racconto per me è ancor più bello e arrivato all’ultima pagina sono stato preso da un pathos da cui non è certo facile liberarsi, e questo sebbene Bonaviri non faccia nulla per muovere a una facile commozione, con una scrittura piana, con descrizioni di asprezze, ma anche con brevi parentesi di struggente poesia, cercando non solo il brutto della vita, ma anche quel poco per cui vale la pena di vivere. La contrada degli ulivi è, a mio avviso, un autentico capolavoro.
Giuseppe Bonaviri,
nato nel 1924 a Mineo, in provincia di Catania, è scomparso nel 2009.
Primo di cinque figli di un sarto, Bonaviri ha vissuto per anni a
Frosinone dove ha esercitato la professione di medico. Fra le sue
opere più note L’incominciamento, Il dottor Bilob , Il
vicolo blu , L’incredibile storia di un cranio , Il
sarto della stradalunga , La divina foresta e Notti
sull’altura.
28/11/2014
Andreas Hofer a Mantova in catene… di Roberto Sarzi
Editoriale
Sometti
Saggio storico Il Garibaldi tirolese Credo che, se anche poco realmente conosciuto, di Andreas Hofer molti abbiamo sentito parlare, soprattutto in Tirolo dove da oltre duecento anni è oggetto di vera e propria venerazione. Per certi aspetti ha rappresentato per quelle popolazioni quello che è stato per noi Garibaldi, cioè il guerriero che si è battuto per l’indipendenza. Si è trattato di un eroe carismatico che nella sua azione ha saputo riunire in una impari lotta contro gli occupanti francesi e bavaresi la gente di quella regione, che andava da alcuni chilometri a nord di Innsbruck fino a Rovereto, ricomprendendo a Est anche l’Ampezzano. Non era dotato di grandi capacità militari, ma grazie alla sua indubbia ascendenza sulle truppe costituite non da soldati di professione, ma da popolani (i cosiddetti Schutzen) e con l’aiuto di un luogotenente assai valido come tattico e stratega riuscì, con una condotta di guerra tipica della guerriglia, a tenere in scacco il nemico, riportando anche alcune clamorose vittorie, a differenza dell’esercito austriaco, più volte sconfitto, e che prese una vera e propria batosta a Wagram. La pace di Schonbrunn mise a tacere definitivamente l’Austria, che non solo dovette rinunciare al Tirolo, ma che ingenerò nel suo sovrano un senso di rispettoso timore verso Napoleone, tale da indurlo a togliere ogni sostegno ad Andreas Hofer. Questi, ormai prigioniero del suo stesso mito, non rinunciò a combattere, ma con esiti questa volta disastrosi, tanto da costringerlo a rifugiarsi in montagna in una malga. Lì, grazie al tradimento di un tirolese, fu catturato e portato a Mantova in catene, dove subì un processo il cui esito fatale era già stato deciso da Napoleone e che si concluse con la condanna a morte, nonostante che i mantovani avessero cercato con una colletta di liberarlo e che comunque gli furono vicini, in quanto ostili a un regime francese vessatorio. Il 20 febbraio 1810, a Porta Giulia, Andreas Hofer fu fucilato; si comportò, prima di morire, in modo dignitoso, senza mostrare né rimpianti, né odio, come era sempre vissuto e sostenuto da quella fede religiosa che non era mai venuta meno. Da allora, ogni anno, in quella ricorrenza, scendono a Mantova centinaia di Schutzen dal Nord Tirolo, dal Sud Tirolo, dal Trentino e dall’Ampezzano. Vestiti nei loro caratteristici costumi, con gli schioppi e la banda, commemorano il loro eroe, unitamente alle autorità cittadine e ai tanti mantovani ai quali, di generazione in generazione, è stata tramandata la vicenda di un uomo che si immolò per la libertà del suo popolo. Roberto Sarzi, attento osservatore e che conosco dagli anni dell’Università, ha scritto di questa vita straordinaria, scremando le fantasie del mito e consegnando alle stampe il ritratto di un uomo che nulla desiderava per sé, ma che tutto faceva per la sua patria. È ripercorsa questa breve esistenza (morì a 43 anni) con mano sicura, sulla base di una documentazione più che attendibile e nel modo più asettico possibile. Ciò nonostante si avverte, soprattutto verso la fine, una punta di commozione, del tutto naturale peraltro, perché nel momento in cui Andreas Hofer cade sotto il piombo francese termina la cruda e dura realtà dei fatti e nasce il mito, a cui, per chi ama la libertà, è impossibile sottrarsi. Corredato da numerose fotografie e da un puntuale elenco delle fonti, Andreas Hofer a Mantova in catene… è di uno di quei libri che non dovrebbero mai mancare in una biblioteca personale, sia per l’indubbia valenza storica, sia per conoscere un protagonista a cui vi sentirete sicuramente vicini.
Roberto Sarzi,
mantovano, dopo un passato da diplomatico, è ora in pensione.
Laureato in lingue e letterature straniere è un appassionato di
storia.
25/11/2014
Cani, camosci, cuculi (e un corvo) di Mauro Corona
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. La strada giusta Leggere un libro scritto da Mauro Corona è sempre un’esperienza esaltante perché come ben pochi autori riesce a mostrarci la vita nella sua spesso cruda realtà, indicandoci nel contempo, senza imporcelo, il senso da dare alla stessa. La sua è una scrittura semplice, piana, ma di straordinaria efficacia e ha il dono dell’immediatezza, poiché chi legge resta avvinto da subito, dalle prime righe. È il caso anche di questa raccolta di racconti intitolata Cani, camosci, cuculi (e un corvo), un bell’assortimento di animali in cui però predominano i primi, gli inseparabili amici dell’uomo che tuttavia, a volte, hanno da temere i rispettivi padroni, dovendo patire gli sfoghi di uomini abbrutiti dalla vita e dall’alcol. Eppure i fidati “quattro zampe” restano protagonisti indiscussi, con il loro istinto che li porta a prevedere la caduta di una valanga, o con il disamore per il padrone che li ha feriti nell’aspetto relazionale, al punto di cercare la morte. Su tutto domina la natura, incombono le montagne del luogo natio dell’autore, in una serie di visioni a volte bucoliche, a volte drammatiche, ma non c’è da meravigliarsi, perché Corona è veramente bravo nel descriverci la realtà del mondo di cui siamo parte e che a volte può sembrare amico e altre nemico. È indubbiamente presente il risultato di un animo poetico che ha la capacità di incantarsi ed incantare di fronte a un’alba o a un tramonto, ma c’è anche la consapevolezza che è ormai indispensabile ritrovare quel rapporto con la natura che la società attuale sembra aver smarrito, ingannata dalla falsa chimera di un benessere che si intende misurare solo in guadagni di denaro. Il rispetto per il mondo che ci circonda, per gli animali che lo abitano è tale che Corona si lascia affascinare perfino dalla danza delle vipere, bestiole utili, che ci mordono solo se calpestate. In questo concetto sembra quasi volerci dire che se esistono questi serpenti un motivo ci deve essere e loro, come tutte le bestie, non sono né buone, né cattive, non hanno la possibilità di avvalersi del libero arbitrio, insomma sono semplicemente così, a differenza di non pochi uomini che possono celare un’indole feroce, pronta a venire allo scoperto magari anche solo per arricchirsi un po’ di più. Devo ammettere che il messaggio di Corona è uno di quelli che affascinano, ma che non ha, a differenza di molti altri, l’inconcretezza dell’utopia, e che invece é realizzabile, basta che lo vogliamo ed è proprio lui, l’autore, che con la sua esistenza e i suoi scritti, ne è la dimostrazione vivente. Da leggere, pertanto, anzi mi permetto di consigliarne l’adozione fra i testi scolastici, affinché i giovani possano comprendere quanto non hanno capito tanti adulti che vivono in un’avvilente rincorsa dietro al nulla.
Mauro Corona è
nato a Erto (Pordenone) nel 1950.
23/11/2014 Cristina Bove - Metà del silenzio - E-book Editore PiBuk - Collana Diamante - 2014 Prefazione
Il silenzio, talvolta, è un gravitare
di parole il cui suono è quello di una lingua universale. Parole che
nascono a fior di labbra e lì si fermano, o nel cavo dell’anima dove
vengono tenute in gran fermento, ma senza osare debordare. Attraverso
le parole non dette, il silenzio assume tanta forza da ergersi a
sentinella della torre più alta della Vita. Ed è allora che proietta
la sua ombra su ogni cosa di cui vorrebbe dire e invece tace.
Questa ricchezza, che appare già alla
prima scorsa dell’Indice, si sostanzializza poi nelle diverse poesie,
attraversate da una musicalità e un’armonia che guidano il lettore
nella comprensione pressoché immediata, se non del senso profondo,
almeno dell’atmosfera incarnata nella forma. Un’altra peculiarità da sottolineare consiste nell’uso di un lessico che si differenzia non solo dall’uso comune (il che è normale per un “vero” poeta), ma dallo stesso uso che ne fanno altri poeti: è come se la Bove fosse distante una o più dimensioni nell’uso del linguaggio, rispetto alla maniera più comune di poetare; è come se il “nutrimento” linguistico- lessicale fosse stato da lei metabolizzato e poi re-inventato in un modo del tutto imprevedibile, in particolare negli accostamenti di termini che nelle sue mani non diventano soltanto metafore prima impensate ed impensabili, forbite ed originali, ma anche semplicemente (sic!) espressioni vive, mobili, che si leggono come se si stesse assistendo ad una rappresentazione teatrale, in modo che appaiono le scene descritte come nell’atto stesso in cui si svolgono.
Le poesie che fanno parte di questa
raccolta spaziano su un’ampia gamma di temi, com’è buona consuetudine
dell’autrice, così dando modo al lettore di ritrovarsi almeno in
alcune delle situazioni o dei vissuti che ne costituiscono l’oggetto.
- Parole inferte, a significare quanto le parole possano fare male, ferire, quando sono pronunciate con una sorta di astio, sempre ingiustificato, a mio parere, quando l’altro/a è un familiare; - Donna chissà…, in cui si avverte un forte desiderio di rispetto per la donna, non solo nei momenti in cui le si fa vivere (meglio, “si vive insieme”!) “l’ansimo di un’ora resa insolita” con “un guizzo di vita”; tutto questo, infatti, si cancella di colpo se poi le si trafigge persino l’ombra; - Donne, che enumera la diversità delle mansioni a cui le donne ottemperano per l’utilità della famiglia, poi ripagate da coloro da cui ci si aspetterebbe il massimo rispetto e almeno un po’ d’affetto (compresa la società più ampia), con inganni, e altre azioni non degne di alcun essere umano; - Il burqa occidentale, a significare che la condizione femminile non è ancora risolta neppure nel civilizzato (?) mondo occidentale; - Figlie della solitudine, donne che hanno per compagnia solo il proprio silenzio carico di profonde emozioni, accumulate già dalla fanciullezza, spesso in ambienti che avrebbero dovuto incoraggiare, difendere, sostenere la fragilità insita per natura in ogni essere umano e tanto più in una bambina; - o, ancora, Alfa privativo, dove le donne sono viste come appartenenti all’altra parte della vita; esse lasciano in secondo piano, (meglio, annullano…!) il proprio autentico sentire per poter maggiormente soddisfare il partner, ma sono rese oggetto in mani che “devastano” proprio mentre le si accoglie; e la civiltà? non ha voce per queste abiezioni umane: “la terra non ripaga le sue amazzoni / e nei giardini i pomi delle esperidi / restano appesi ai rami”.
Molte sono anche le poesie d’amore, in
cui questo sentimento viene presentato con i suoi alti e bassi, come
avviene in modo naturale nella vita di ognuno: Cristina segue
istintivamente i moti dell’animo che le permettono di alternare il
sogno, il desiderio, la paura di entrare in una storia nuova che pare
se-ducente, il rimpianto per le parole d’amore mai sentite, la
nostalgia per i momenti felici trascorsi e il ricordo che torna a
farsi vivo come a voler sottolineare, a volte, la distanza tra il
passato ricco di emozioni positive e il presente arido, intriso di
solitudine esistenziale, e altre volte come a voler supplire alla
mancanza di quelle atmosfere piacevoli dei tempi andati, addolcendo
così i momenti di abbattimento presenti. Non mancano le poesie un po’ giocose, che sembrano punteggiare la raccolta per allentare un po’ la tensione provocata da certe invettive sociali che pure sono presenti: una per tutte, Mix, dove risaltano in modo netto e fin troppo significativo alcune espressioni che sembrano non avere niente a che fare con le altre, ma dove l’elenco delle cose da “mixare” viene a chiarire alla fine il suo scopo; e allora le “parentesi quadre” inducono ad una sorta di pausa riflessiva momentanea, un “imperativo categorico” sta per un volersi imporre, senza possibilità di ripensamenti, almeno un margine di riflessione che faccia, da sola, da “cartina al tornasole” e finalmente evidenzi con chiarezza la situazione presente; e poi il silenzio, evidenziato dal “cauterio” e dal “chiudere a filo bocca”, per finire con quel “clic su my heart” e sentirne il suono onomatopeico “splash” che da solo spiega quale triste effetto hanno prodotto le condizioni di quella confusione di vita alla quale non ci si riesce ad adattare; molte delle espressioni usate (apparentemente giustapposizioni non legate da alcuna logica discorsiva) trovano la loro corretta collocazione non solo in riferimento al titolo della poesia, ma soprattutto nel denotare come si voglia pensare ad altro per meglio sopportare la propria sofferenza e come, per questo motivo, ci si immerge in situazioni mediatiche, ad esempio seguendo l’andamento della Borsa delle azioni, i matrimoni speciali o altro che possa far parte della quotidianità e da cui ci si possa sentire emotivamente distanziati. A volte, Cristina sorprende con poesie il cui contenuto viene molto rafforzato dalla struttura grafica: ad esempio, la poesia Myrmeleontidae è scritta in forma di calligramma ed evoca l’habitat della formicaleone, avvalendosi della originalissima metafora dell'imbuto-voragine-abisso, resa visibile dalla stessa grafica dei versi. Questi i versi cardine:
"allunga arpia la mano come gli
aztechi a depredarti il cuore e danza Il tutto per rapportare all’esperienza umana la vita delle myrmeleontidae: la tana e il loro cibarsi di insetti corrisponderebbe così all’abisso scavato tra le persone quando depredano anime.
Ci sarebbe ancora molto altro da dire
per presentare in modo completo questa ricca e interessante silloge
poetica, ma mi limiterò a concludere sottolineando come Cristina
abbia una grande capacità di captare minimi segnali, non solo dalla
vita delle persone direttamente o indirettamente conosciute, ma anche
dalla presenza di oggetti e cose che potrebbero sembrare
insignificanti e che lei invece riempie di vita e senso, soprattutto
in analogia con la propria o altrui esperienza.
Le voci mute
Copertina di Vincenzo Bosica
Narrativa racconti Dare voce a chi non l’ha Leggo la narrativa di Fiorella Borin da un po’ di tempo e ogni volta noto un progressivo costante miglioramento, una maggiore accuratezza nel ricreare l’ambiente e nel sondare i personaggi, così che pubblicazione dopo pubblicazione la scrittrice veneziana ha ormai raggiunto un particolare ed elevato livello di eccellenza. Per lei il romanzo e il racconto storico non devono essere fini a se stessi, ma nel rappresentare un’epoca è necessario che i valori e i difetti abbiano una portata più universale, quasi a testimoniare che l’evoluzione della specie è stata più un fatto tecnologico che una reale e radicata maturazione. Quindi, quando si dice che la storia si ripete, non si sbaglia, perché l’essere umano, nei suoi comportamenti, è rimasto sostanzialmente invariato e l’ingiustizia e la disuguaglianza c’erano un tempo come ci sono anche oggi. In questa nuova raccolta di racconti (nove per la precisione) intitolata Le Voci Mute, tutte storie ambientate a Venezia nel XVI secolo, l’autrice dà voce a chi non l’ha, a sconosciuti personaggi della vita di ogni giorno che, senza che lo sappiano, anche loro fanno la storia, che non è solo il frutto delle decisioni e delle azioni dei potenti, ma anche di tutti gli uomini, in particolare gli umili, i diseredati, coloro che urlano muti il loro dolore di vivere. Sono trame convincenti, con protagonisti dipinti con precisione, grazie anche a un’analisi psicologica attenta, che non resta in superficie, ma va a fondo, e così, pur se frutto di creatività, assumono la parvenza di personaggi reali, che si muovono sul palcoscenico di una Serenissima ricostruita fedelmente (e al riguardo opportuna è stata la scelta di riportare in calce la bibliografia utilizzata), attori che prendono vita dalla penna della narratrice e che li vedono impegnati nelle più svariate vicende. Così è infatti per La strazzona, una figura femminile che non si dimentica facilmente; percorso da una venatura gialla risalta Miserere; il vecchio Gerolamo, poi, è di una simpatia unica e questo carceriere umano lo si trova in Mir i dobro e in La sciarpa azzurra, due brani diversi, ma che sono di notevole interesse, anche per sapere come veniva amministrata la giustizia all’epoca; un tocco di grazia rende splendente Persona per hora secreta, un dramma che tocca un potente e una del popolo, ma a pagarne le conseguenze è sempre chi non ha potere; in La rabbia dei poveri l’attenzione per questi di Fiorella Borin si traduce in un desiderio di giustizia di fronte al quale non si può certo restare insensibili e che alla luce anche di recenti sentenze ci fa chiaramente capire che nulla è cambiato e che il potente non solo ha sempre ragione, ma può fare ciò che vuole, a meno che i sudditi non trovino nella loro unione la forza per ribellarsi; il tema della donna oggetto, in tutto sottomessa agli uomini, è quello di Ludovica de gatti; la vendetta, servita su un piatto freddo, domina in La congiura degli Olderichi, in una narrazione che sapientemente accompagna a un fatto tragico anche una vena di comicità che evita che la tensione arrivi al parossismo; infine un ragazzo che sogna ad occhi aperti, che si crede furbo al punto dal voler diventare un ciarlatano, nonostante l’ingenuità che lo caratterizza, con una vita che condurrà come in un sogno che morirà all’alba, è il protagonista dell’ultimo racconto, appunto Il ciarlatano, una vicenda che, se talora può provocare un sorriso, tanto è il candore del personaggio principale, si chiude poi con una nota malinconica, un velo di tristezza per queste voci che ritornano definitivamente mute. Da leggere, perché lo merita.
Fiorella Borin,
nata a Venezia nel 1955, laureata in psicologia, si è dedicata per
qualche anno all’insegnamento di scienze umane e storia negli
istituti superiori. Ha collaborato con l’Università di Padova come
cultrice della materia; in seguito ha maturato qualche esperienza in
seno a piccole case editrici e nelle redazioni di riviste letterarie
e di noti settimanali femminili. Da una ventina d’anni si dedica con
passione allo studio della storia di Venezia, prediligendo il XVI
secolo quale cornice per racconti e romanzi, alcuni dei quali già
premiati e pubblicati. Più di trecento suoi piccoli lavori di
narrativa, poesia e saggistica sono presenti in antologie, quotidiani
e riviste; il racconto “La tela di Penelope”, vincitore del concorso
letterario bandito dal mensile “Vera”, è stato pubblicato sul numero
di settembre 1995 con il commento dello scrittore Alberto Bevilacqua,
presidente della Giuria. 18/11/2014
Storia di Sirio Parabola per la nuova generazione di Ferdinando Camon
Garzanti Libri
La speranza non deve morire Non si può certo dire che Ferdinando Camon sia monocorde, che i suoi scritti trattino sempre lo stesso tema e così, dopo aver dato alle stampe i romanzi del Ciclo degli ultimi, per intenderci quelli che parlano della scomparsa della civiltà contadina, ha osservato il mondo che lo circonda, la società che lo occupa, cogliendo, insieme con gli aspetti esteriori più significativi, le carenze di fondo, in un invito a meditare e, soprattutto, a cercare di cambiare le tante troppe storture. E’ il caso questo anche di Storia di Sirio, che sembra un’opera rivolta più all’attuale generazione giovanile, ma che interessa tutti, anche quelli più avanti negli anni, figli di quel dopoguerra che hanno accettato supinamente la civiltà industriale, quella dei consumi, salvo poi lamentarsi sterilmente. Un giovane deve necessariamente maturare attraverso le esperienze e Sirio è un emblema di questo processo, un prodotto tipico in cui la generazione attuale troverà non pochi punti di contatto. Ma finisce con l’essere un atto di accusa anche nei confronti dei genitori, ingabbiati, come i figli, in una struttura piatta che nell’illusione di uno sprazzo di benessere finisce con lo schiavizzare, con il rendere succubi a un sistema capitalistico impietoso che poco dà per togliere invece tanto. In questo quadro Sirio, figlio di un industriale, quindi di un capitalista, con quella voglia di aria nuova che è proprio dei giovani, prima si ribella al padre, avviando una serie di esperienze totali come una vita da sbandato con l’assunto che lavoro equivalga a schiavitù, poi prova l’ebbrezza del primo amore e la delusione che ne deriva quando questo diventa noia, e infine arriva all’autoanalisi interiore, quasi a voler dimostrare che qualsiasi aspirazione di cambiamento è inevitabilmente destinata alla sconfitta se non cambiamo prima noi stessi. Però, se è pur vero come dice Camon che si tratta di una parabola per la nuova generazione, ho colto altri motivi di interesse, forse nemmeno tanto impliciti, che l’uomo, scrittore, insegnante e padre, non può aver messo lì per caso o unicamente a supporto del suo discorso. Camon, legato per nascita alla campagna e a quella civiltà contadina ormai scomparsa, vede nell’imperante capitalismo lo stesso nemico di Marx, ma ciò non vuol dire che lo scrittore padovano sia un comunista, perché la sua aspirazione volge più a una visione cristiana dell’esistenza, un’immagine a lungo costruita che vede ogni uomo padrone di se stesso nell’equilibrio di un mondo non più votato all’autodistruzione e dove ragione e sentimento si fondano in un unico anelito di umanità. In questo senso la sua ostilità per la città, per quella massa di condomini, alveari dove è raro che gli abitanti non solo s’incontrino, ma possano avere almeno un barlume di reciproca conoscenza, è una sua costante, perché rappresenta lo spossessamento dell’indole naturale degli esseri umani a comunicare e la supina accettazione di un ordine costituito in cui pochi dominano tutti gli altri. Questo aspetto è ripreso anche in Storia di Sirio e appare assai efficace, soprattutto quando il moto di rivolta avviene solo nella città, coinvolgendo studenti e operai e lasciando fuori gli abitanti delle campagne che pur in presenza di una civiltà industriale agricola riescono a mantenere ancora una, se pur ridotta, autonomia. La mia impressione è che Storia di Sirio sia sì una parabola per i giovani, ma anche una confessione dell’autore per aver accettato pure lui, come tanti e come me, che si arrivasse a un mondo non a misura d’uomo e credo che in fondo quell’idea dell’autocoscienza sia una speranza che si è sempre portata in cuore, affinché ci possa essere ancora qualcuno che, con energia vitale, propria della generazione giovanile, possa concretizzare ciò che chi, ormai avanti con gli anni, non può più fare. Da leggere e rileggere.
Ferdinando Camon è
nato in provincia di Padova. In una dozzina di romanzi (tutti
pubblicati con Garzanti) ha raccontato la morte della civiltà
contadina (Il quinto stato, La vita eterna, Un
altare per la madre – Premio Strega 1978), il terrorismo (Occidente,Storia
di Sirio), la psicoanalisi (La malattia chiamata uomo, La
donna dei fili), e lo scontro di civiltà, con l'arrivo degli
extracomunitari (La Terra è di tutti). È tradotto in 22 paesi.
Il suo ultimo romanzo è La mia stirpe (2011).
14/11/2014
Mantova città fortezza e le battaglie risorgimentali di Armando Rati
Sometti Editoriale
Storia militare Colline insanguinate Tutti a scuola abbiamo studiato la storia del nostro periodo risorgimentale e ciò per una semplice ragione: dalle guerre combattute in quegli anni uscì un nuovo stato, l’Italia. Al di là del pur gloriosa impresa di Garibaldi e delle sue camicie rosse che con il loro ardimento, ma anche con il concorso determinante del Regno di Piemonte che corruppe a destra e a manca politici e militari del Regno delle Due Sicilie, è innegabile che il teatro principale di tutto il nostro Risorgimento sia stata la Lombardia, soprattutto nella sua parte orientale, dove vennero combattute furiose battaglie. Se ci si chiede come mai le operazioni militari si siano svolte prevalentemente sui colli morenici del Garda e quindi su un terreno poco pianeggiante e sfavorevole al movimento degli eserciti, la spiegazione sta unicamente nel fatto che esisteva una grandiosa linea di difesa, non rigida, ma elastica, costituita dal famoso quadrilatero con le fortificazioni di Peschiera, di Verona, di Mantova e di Nogara, i cui lati molto lunghi potevano peraltro consentire una vigorosa penetrazione, se compiuta con uomini e mezzi in numero adeguato, così da mettere in difficoltà l’intero sistema. Mantova, già in passato, all’epoca dei Gonzaga, era ritenuta imprendibile, ma non lo fu, visto il saccheggio del 18 luglio 1630 a cui fu sottoposta dai lanzichenecchi; inoltre fu conquistata dalle truppe napoleoniche, scacciate poi dagli austriaci. Restò invece inviolata proprio durante le tre guerre d’indipendenza, nonostante l’assedio posto nella prima, ed era da lì e da Verona che partivano le truppe asburgiche per contrastare il nemico che veniva da ovest. Il generale Armando Rati, mantovano di nascita, ha consegnato alle stampe un libro assai interessante in cui descrive gli aspetti militari di battaglie come quelle di Solferino, di San Martino e di Custoza, non tralasciando tuttavia, e senza appesantire la narrazione, gli accadimenti politici forieri delle nostre tre guerre per l’indipendenza. Se il lettore ha timore che movimenti di truppe, orari, caratteristiche degli scontri possano risultare gravosi, preciso da subito che l’autore è riuscito in modo encomiabile a dare, senza esser greve, una visione di queste battaglie, divise quasi sempre in episodi ben precisi, in fatti d’arme che nel loro insieme costituiscono il vero e proprio combattimento, quello che a scuola ci è stato di in volta indicato come le vittorie di Solferino e di San Martino, o come le sconfitte di Custoza, ameno paese del veronese teatro di sanguinose lotte sia nella prima che nella terza guerra d’indipendenza. Pur con il dovuto rigore dello storico, Rati non si ferma a una mera descrizione, ma va oltre, parlando dei prodromi, cioè della preparazione, e delle conseguenze, riuscendo così a far capire come mai nel 1866, benché perdenti a Custoza, ma ancora nel pieno delle forze, peraltro superiori a quelle austriache, non riuscimmo a uscire dal pantano di incertezze con cui avevamo avviato quel conflitto bellico e buon per noi che la Prussia nostra alleata sconfisse gli austriaci, permettendoci di ottenere, sebbene per interposta forza, il Veneto. L’autore, che è uomo d’armi e quindi particolarmente competente, non tira tuttavia le conclusioni, anche perché sono evidenti: la mancanza di un piano ben definito, che mancò anche nella Grande Guerra, portando però a conseguenze molto più tragiche, atteso il numero di militari morti. Come sempre ai nostri soldati non hanno mai fatto difetto il coraggio e l’abnegazione, doti che a volte sono riuscite a supplire alla disorganizzazione dei nostri comandi, in cui approssimazione, eccesso di sicurezza e anche puerile rivalità serpeggiavano, caratteristiche riscontrabili anche nei due grandi conflitti del secolo scorso. In questo libro, inoltre, vi è da rilevate la grande obiettività dell’autore, teso sì ad esaltare il valore dei nostri soldati, ma anche ad evidenziare quello dei nostri nemici, insomma un’opera, che sotto qualsiasi aspetto la si guardi, è senz’altro meritevole di essere letta.
Armando Rati
è un generale dell’esercito originario di Acquanegra sul Chiese in
provincia di Mantova. Laureato in pedagogia, a indirizzo storico,
ormai congedato, si occupa di storia, prevalentemente militare. Ha
così pubblicato numerosi saggi, fra i quali 1918: la fine della
Grande Guerra, 4° ,Reggimento artiglieria contraerei 1926-2003,
Caporetto, I bersaglieri nel Risorgimento (1848-1870),
L'80° Fanteria - La lunga storia eroica
di un Reggimento mantovano diventata leggenda ,
La fulgida epopea della Divisione Pasubio, Giacomo
Desenzani un generale castiglionese nella Grande Guerra, tutti
editi da Sometti.
12/11/2014
Il birraio di Preston di Andrea Camilleri
Sellerio Editore Palermo
Narrativa romanzo
Credo che se avesse potuto leggerlo Leonardo Sciascia ne sarebbe rimasto incantato, così come lo sono stato io. Intendiamoci, ed è una premessa indispensabile, Il birraio di Preston non è il solito romanzo di Camilleri, gradevole, appassionante, con la presenza magari di qualche spunto e di qualche fine civile; è invece molto di più e anche il linguaggio usato, quel siciliano italianizzato, che è una caratteristica dell’autore, è assai più comprensibile che in altre sue opere; la struttura del racconto è inoltre costituita da un alternarsi temporale, un prima, un durante e un dopo, trovata che in genere può disorientare, ma che se ben congegnata finisce con il costituire un ulteriore motivo di piacevolezza. La vicenda è tortuosa, i personaggi sono tanti, ma qui Camilleri è senz’altro riuscito a esprimere il meglio del suo talento, raccontando di un fatto accaduto ben più di un secolo fa, quando l’isola era da poco parte del Regno d’Italia e se qualche spunto è reale, attinto dall’Inchiesta parlamentare sulla Sicilia del 1876, il resto è frutto di pura fantasia creativa. Tutto ruota intorno alla decisione del prefetto toscano di Montelusa di inaugurare il teatro di Vigata con la rappresentazione di un’opera lirica, appunto Il birraio di Preston. E questo è un fatto vero, come i disordini che ne conseguirono, poiché gli abitanti si opposero fermamente a questa decisione, imposta dall’alto e perciò non di loro gradimento, qualunque fosse il valore dell’opera. Come dicevo i personaggi sono tanti e quasi sembrano lottare, sgomitando, per ritagliarsi un angolo di notorietà, dal più umile al più altolocato. Alcuni sono delle vere e proprie macchiette, che Camilleri si diverte a dipingere a suo modo, facendo loro interpretare alcuni passaggi che strappano più di una risata; altri invece sono seri, troppo seri, al punto anch’essi da muovere al riso, come le figure del prefetto e del questore. Camilleri ci narra di questa rappresentazione operistica, dell’incendio del teatro e delle indagini successive e nel parlarci di questi fatti e di questa varia umanità finisce con il descrivere non solo la Sicilia postunitaria, ma anche l’Italia d’oggi, percorsa da interessi segreti che stanno sotto l’apparenza degli eventi, di una realtà ufficiale così dissimile dalla realtà effettiva, in un paese in cui, vigendo un sistema di potere capace di manipolare la verità, può accadere che l’onestà diventi una colpa e che invece la criminalità finisca con l’essere un merito. Quando il travisamento della realtà è imperante ed è pratica comune, non è più possibile discernere il vero dal falso, il galantuomo dal disonesto, in un sistema che spegne sul nascere le speranze, che è auto conservativo, che tutto soffoca, obliando il passato e infinocchiando il presente. Non tutti i personaggi sono così, solo quelli che detengono le leve del potere, i funzionari di stato, i politici e i malavitosi; gli altri possono anche essere onesti e pure eroici, ma per i burattinai che muovono i fili di un’eterna rappresentazione non sono altro che comparse, buone solo a piegare la schiena, ad apparire sul palcoscenico e a rimanervi per il tempo che sarà ritenuto necessario, per poi scomparire, come oggetti usati e inutili che non meritano nemmeno l’attenzione del robivecchi. Tutto era così al tempo dell’incendio del teatro di Vigata, lo fu anche in seguito, lo è oggi e, ahimé, lo sarà anche domani. Il birraio di Preston è un autentico capolavoro.
Andrea Camilleri
(Porto Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e
sceneggiatore. Ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il
volume, I teatri stabili in Italia (1898-1918). Il suo
primo romanzo, Il corso delle cose, del 1978, è stato
trasmesso in tre puntate dalla TV col titolo La mano sugli occhi.
Con questa casa editrice ha pubblicato: La strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992), La bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca(1997), La concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il re di Girgenti (2001), La
presa di Macallè (2003), Privo di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza Musumeci(2007), Il
casellante (2008), Il sonaglio (2009), La rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010, anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie di Vigàta (2011), La setta degli
angeli(2011), La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014); e inoltre i romanzi con protagonista il
commissario Salvo Montalbano: La forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il giro di boa (2003), La pazienza
del ragno (2004), La luna di carta (2005), La vampa
d'agosto (2006),Le ali della sfinge (2006), La pista di
sabbia (2007), Il campo del vasaio (2008), L'età del
dubbio(2008), La danza del gabbiano (2009), La caccia
al tesoro (2010), Il sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi (2011), Una lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un covo di vipere (2013), La piramide di fango (2014).
9/11/2014
Cari saluti di Isabella Bossi Fedrigotti
Rizzoli Edizioni Un altro bell’esercizio di stile Non si può dire certo che lo stile narrativo di Isabella Bossi Fedrigotti sia ripetitivo, perché, come in Di buona famiglia, anche in questo Cari saluti c’è un’invenzione che caratterizza in modo estremamente incisivo la narrazione. Infatti, per raccontare dell’improvvisa scomparsa di un uomo, che di fatto è sparito senza lasciare traccia, la scrittrice trentina fa parlare di lui sei personaggi, con un’impostazione quasi teatrale, attraverso dei veri e propri monologhi. La tecnica è estremamente raffinata e la Fedrigotti ha fatto di tutto per rendere gradevole la lettura, riuscendoci in larga parte. Inoltre, quello che stupisce è la straordinaria capacità di analisi psicologica dei personaggi, dai cui racconti non emerge una verità univoca, bensì la verità come tale ritenuta da ognuno, sulla base delle sue conoscenze, delle esperienze maturate e della propria personalità. E così, sebbene il personaggio principale sia lui, cioè lo scomparso, si viene a delineare un quadro di affetti non solo familiari che poco a poco ci può far comprendere i motivi che hanno indotto l’uomo ad andarsene, senza lasciare traccia, nemmeno un rigo alla famiglia o alla fidanzata. In particolare emerge inquietante l’immagine di una famiglia i cui componenti sembrano lì per caso, fra i quali non corre un vero affetto, governata da una madre possessiva e al tempo stesso sempre incombente, chiusa in un’aridità di sentimenti che spegne ogni desiderio di vita. E’ un vero e proprio inferno in cui i familiari sono contemporaneamente carnefici e vittime, rivelandosi poco a poco nella grettezza, nelle miserie umane che non riescono più a camuffare. Se la narrazione procede come in un giallo, vi è da precisare però che differisce sensibilmente dai romanzi di questo genere; se l’improvvisa immotivata scomparsa di un uomo può dare luogo a una ridda di ipotesi e può costituire motivo di domande personali, di una vera e propria investigazione, qui non s’indaga sul fatti, ma sull’anima dei personaggi. E il protagonista, sempre assente, farà una sua indiretta comparsa alla fine, dove, in un’appendice di sei pagine, sarà fatta luce sul mistero. Per quanto ovvio non fornirò anticipazioni della soluzione, perché verrebbe meno al lettore la tensione, palpabile, che cresce pagina dopo pagina. Credo che non ci sia altro da dire, salvo la raccomandazione di leggere Cari saluti, perché lo merita.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor
Budischowsky (Rizzoli, 2003) e Il primo figlio (Rizzoli,
2008).
5/11/2014
Pascoli e gli animali da cortile di Maria Cristina Solfanelli Presentazione di Vito Moretti
Edizioni Tabula Fati
Saggio letterario L’innocenza innata Che Giovanni Pascoli e la sua poesia rappresentino per me un’autentica passione è fuor di dubbio, tanti sono anche i commenti critici che ho scritto alle sue opere, e che poi meritino un’analisi approfondita le connessioni fra l’autore e i suoi testi è comprovato dai numerosi studi in materia. Fra questi ultimi, anche in ordine di tempo, c’è questo saggio, scritto dalla giovane Maria Cristina Solfanelli, che ha inteso discernere delle relazioni fra il poeta e gli animali da cortile, quelli cioè della campagna da cui lui proveniva e a cui è sempre stato affettuosamente legato. Illuminante il tal senso è un passo dell’opera, laddove l’autrice scrive: “Giovanni Pascoli si avvede assai presto che il suo amore per la natura gli permette di vivere le esperienze più appaganti, se non fondamentali, della sua vita. Lui vede negli animali delle creature perfette da rispettare, da amare e da accudire al pari degli esseri umani; infatti, si relaziona con essi, ci parla di loro e, spesso, prega affinché possano avere un’anima per poterli rivedere un giorno.” Pascoli non ebbe degli ottimi rapporti con gli uomini, troppo egoisti e soprattutto mancanti di quell’innocenza riscontrabile negli animali, sempre sinceramente se stessi. E nelle sue poesie questi innocenti amici sono ricorrenti: L’uccellino del freddo, La capinera, L’usignolo e i suoi rivali, tanto per citarne alcune. Ma pure nella vita del poeta le bestie sono presenti e appunto c’è uno specifico capitolo del saggio intitolato Gli animali di casa Pascoli. Quando il poeta avrà una casa con giardino, gli ospiti saranno molteplici e le cure a loro dedicate particolari e attente. Quando poi ne muore uno, è un lutto familiare. Certo che potrebbe venir da pensare che Pascoli esagerasse un po’, che la sua psiche complessa, segnata dal fatto di aver dovuto diventare improvvisamente adulto alla morte del padre, presentasse delle stranezze e ciò è vero, ma con ogni probabilità si trattava di eccessi nel rapportarsi con il mondo esterno e non che la visione di come avrebbe dovuto essere questo fosse sbagliata. Forse il problema è che il poeta, catapultato in un mondo di adulti, quando ancora era adolescente, non riuscì a maturare quell’esperienza di tutti i ragazzi che li porta a entusiasmi e a delusioni, fortificandone il carattere per giungere alla consapevolezza che il mondo degli uomini è il palcoscenico di un teatro in cui tutti gli attori cercano spesso invano di interpretare se stessi. Ma i veri attori che riescono in questo sono solo gli animali, perché in loro resta sempre l’innocenza originaria. Vi è da dire, inoltre, che l’innocenza innata negli uomini si va perdendo con la crescita, così che già passata la pubertà essa è ormai perduta, ma la visione cosmica di Pascoli di un mondo in perfetto equilibrio fra esseri umani e animali, per quanto chimerica alla luce dell’esperienza, è orientata al raggiungimento di una serenità che ci è sconosciuta, ma che senz’altro porterebbe a una società in cui la felicità è sostanzialmente di casa. Quindi il poeta romagnolo era sì pessimista, ma non credeva a una irrimediabilità dell’egoistico comportamento degli uomini, secondo un pensiero che in fin dei conti possiamo definire cristiano. Forse mi sono lasciato prendere la mano e magari sono andato un po’ fuori tema, ma questo saggio ha avuto anche il pregio di farmi riflettere sul mio poeta preferito, di tentare un quadro d’insieme che senza gli approfondimenti di Maria Cristina Solfanelli probabilmente non avrei nemmeno provato ad avviare. Per conoscere qualcosa di più su questo grande autore questo saggio è quindi in un certo senso indispensabile ed è per questo che ne consiglio vivamente la lettura.
Maria Cristina Solfanelli risiede
a Chieti, dove è nata nel 1991. Ha conseguito, presso l’Ateneo
teatino, la laurea in «Letteratura, filologia e linguistica del mondo
medievale e moderno» e attualmente frequenta, nella stessa
Università, il corso magistrale in «Filologia, linguistica e
tradizioni letterarie».
3/11/2014
Giorni di guerra di Giovanni Comisso
Edizioni Longanesi La guerra come avventura A limitarsi al solo titolo verrebbe da pensare al solito romanzo di guerra, frutto di un’esperienza personale dell’autore. Certo, si tratta di vita vissuta, ma in questo libro il conflitto, il primo dei grandi conflitti, cioè la Grande guerra, viene raccontata in un’ottica del tutto particolare. Non ci sono scontri feroci, bombe che esplodono e che dilaniano corpi, la paura, anzi l’angoscia del fante in trincea che attende l’ora dell’attacco, quella corsa nella terra di nessuno che spesso diventa una fuga dalla vita incontro alla morte. Comisso era giovane all’epoca e per lui, figlio di un’agiata famiglia borghese, quella guerra, più che una tragedia, ha rappresentato un’avventura, un tuffo spensierato in un mondo tutto nuovo, così diverso da quello tranquillo, ma in fin dei conti monotono in cui fino ad allora aveva vissuto. Così ogni cosa diventa una nuova esperienza, così la morte rappresenta solo un’eventualità a cui non pensare. In questo nuovo modo di vivere certo non poco ha influenzato il fatto che il giovane Comisso, prima soldato semplice e poi tenente del Genio, viveva e operava soprattutto nelle retrovie, affacciandosi solo saltuariamente in prima linea e in ogni caso mai direttamente impegnato in scontri armati. Con la spavalderia e l’incoscienza della giovinezza Comisso, più che partecipare alla guerra, pare essere lì come uno spettatore pronto a cogliere gli aspetti positivi della sua posizione privilegiata e in questo senso tutto sfuma, anche il dolore, sicché gli occhi dei feriti che lentamente vengono trasportati nelle retrovie sembrano sprizzare gioia per quell’opportunità di lasciare un inferno per un posto più tranquillo. E se ogni attività viene svolta in modo spensierato ci sono mille occasioni per assaporare questa avventura, con le maschie amicizie, il sorriso e l’incanto delle donne venete, le corse fra i campi, i bagni nudi nel fiume, il sano cameratismo che si viene a instaurare fra superiori e truppa, quasi un gioco che rifugge da ogni senso di morte, tanto che la fucilazione di un disertore farà scappare Comisso al fine di non udire gli spari del plotone di esecuzione. Per l’autore questa guerra non è sinonimo di morte, ma di vita, magari a fare scorpacciate di ciliegie o a rincorrere le lucciole, giochi da bambino che è in corso di diventare adulto. E più grande e più maturo lo diventerà in occasione della ritirata di Caporetto, in quella confusione di gente che scappa, di ordini e contrordini, di famiglie intere in fuga dall’austriaco, fra magazzini saccheggiati e cannoni abbandonati. E’ un brusco ritorno alla realtà, un momento in cui si devono fare delle scelte, in cui occorre essere guida e riferimento per i propri uomini, e non solo compagno di giochi e d’avventure. Così, in uno sfacelo descritto con rara forza ed efficacia, Comisso sembra dare addio alla sua giovinezza, ma ancora non lo sa e se ne accorgerà solo a guerra finita di come quegli anni che sono i più belli sono corsi via, impegnati in un gioco che poco a poco ha mostrato il suo vero volto insanguinato. In questo romanzo, scritto con una freschezza che stupisce, in cui la spontaneità sembra traboccare, se poche sono le scene di tragedia, molte sono quelle in cui l’uomo sembra ritrovarsi con la natura, vista come un rifugio sicuro in cui riposare più la mente che le membra e in queste occasioni l’autore è capace di una prosa poetica mai melensa, anzi quasi sempre affascinante. La guerra è forse proprio un’occasione, un esame di maturità in cui inconsapevolmente si cresce, ma questa evoluzione si accompagna ancora a un cuore bambino, a un mondo di giochi ben diversi da quello in cui ora si trova. E proprio perché è vissuta come un’avventura non le si tributano onori, né la si esalta; Comisso non si è posto il problema se sia giusta o meno, sa solo che c’è e che forse è un’occasione irripetibile per un ultimo gioco prima di diventare adulto. Giorni di guerra è un libro bellissimo, che si legge con estrema facilità e grande piacere, tanto che si non si vorrebbe mai arrivare alla fine.
Giovanni Comisso (Treviso,
1895-1969) combatté come volontario durante la prima guerra mondiale
(che raccontò in Giorni
di guerra) e partecipò all’impresa fiumana. Abbandonata la
carriera legale per dedicarsi al giornalismo, fu a lungo inviato
speciale per importanti quotidiani. Autore eccentrico (ma apprezzato
da critici e scrittori quali Contini, Debenedetti, Gadda, Montale,
Saba e Svevo), dopo i primi libri, Poesie (1916)
e Il porto dell’amore, pervenne a uno stile personale che trovò la
misura più congeniale nei racconti e nelle prose di viaggio o di
memoria – tra le maggiori del Novecento italiano –, in cui la sua
natura istintiva, sorretta da un’acuta sensibilità visiva, esprime
appieno un’esperienza di vita intesa come felice avventura. Tra le
altre sue opere ricordiamo: Gente
di mare (1928, premio
Bagutta), Storia di un
patrimonio (1933), Amori
d’Oriente (1947), Le
mie stagioni (1951), Capricci
italiani (1952, premio
Viareggio), Un gatto
attraversa la strada (1955,
premio Strega), Veneto
felice (postumo,
1984).
30/10/2014 Ho
letto il romanzo "Montedidio" dello
scrittore ERRI DE LUCA in un solo giorno, cosa che non mi
capitava da molti anni. Il racconto era molto scorrevole e mi hanno
incuriosito molto le scene che tratteggiavano con pennellate poetiche
ambienti e modi di fare del Sud di molti anni addietro,di quanto
anch' io ero giovane e vivevo in meridione precisamente a Reggio
Calabria, dove sono nato.
L’isola di Rab 1941 – 1943 di Frediano Sessi
Mondadori Editore
Italiani brava gente? Ritengo doveroso effettuare due premesse e cioè che questo breve romanzo non è stato scritto per gli adulti, bensì per i ragazzi (dai 10 ai 13 anni come indica l’editore); di conseguenza lo stile è abbastanza semplice e anche gli approfondimenti sono limitati, ma ciò non toglie che per l’argomento trattato possa essere letto e apprezzato da individui più maturi. La seconda premessa riguarda un mito (Italiani brava gente) che deve essere rivisto radicalmente, perché se è vero che nella disgraziata campagna di Russia ci comportammo in genere civilmente, tanto da riscuotere anche simpatie nella popolazione locale, su altri teatri di guerra, purtroppo, almeno una parte dei nostri soldati si abbandonò a violenze e a massacri non dissimili da quelli dei militari nazisti. Nella nostra storia, del resto, ci sono analoghi precedenti: dalla eliminazione sistematica della popolazione libica alle stragi con i gas nel corso della guerra in Etiopia, e infine i rastrellamenti, le deportazioni, le esecuzioni sommarie in Slovenia dove il generale Mario Roatta, comandante del nostro esercito nella zona di Lubiana e poi in Croazia, era uno zelante massacratore, mai soddisfatto comunque, al punto da impartire ordini come questo:” Se necessario, non rifuggire da usare crudeltà. Deve essere una pulizia completa. Abbiamo bisogno di internare tutti gli abitanti e mettere le famiglie italiane al loro posto"[8], ‘’(…)l’internamento può essere esteso… sino allo sgombero di intere regioni, come ad esempio la Slovenia. In questo caso si tratterebbe di trasferire, al completo, masse ragguardevoli di popolazione… e di sostituirle in loco con popolazioni italiane’. Ed è di un campo di concentramento che questo libro parla, quello di Arbe, nome italianizzato dell’Isola di Rab, un lager in cui la mortalità era addirittura superiore a quella del tristemente famoso lager di Buchenwald. La vicenda è necessariamente semplice e si sviluppa sull’arrivo ad Arbe del figlio di un ufficiale italiano che si trova là con responsabilità di alto livello nel comparto degli equipaggiamenti e del vettovagliamento. Questo ragazzo, che ha quasi tredici anni, di nome Benito a riprova della fede fascista della famiglia, giunge al campo ancora in costruzione scosso per le scene di violenza a cui si sono abbandonati i militi che lo scortano. Educato alla scuola dell’epoca, permeato dal mito del fascismo, stenta a credere a quello che ha visto, ma con il tempo si accorgerà che non si è trattato di un fenomeno isolato e così piano piano cambia opinione, diventa un antifascista. Quanto al padre, con l’opportunismo tipicamente nostrano, dopo l’8 settembre 1943 sale in montagna con i partigiani. E’ un libro che scuote, ma che è anche piacevole da leggere, lasciando perfino lo spazio per un tenero e platonico amore fra Benito e Sonia, una ragazzina muta internata. Se devo trovare un difetto questo sta forse nel fatto che gli aguzzini sono il comandante del campo e i carabinieri ai suoi ordini, mentre l’altro personale italiano, fra cui i medici, appare caritatevole e pronto ad aiutare gli internati. Nessuno, però, si ribella apertamente, ma qui sta forse il significato del libro: tutti avevano gli stessi ordini, ma c’erano i fin troppo zelanti nell’eseguirli e altri che invece non avevano ancora sepolto la loro coscienza. La discrasia fra chi è solo soldato e fra chi prima è uomo e poi è soldato è quella che salva l’umanità, perché è grazie ai secondi che l’orrore di una guerra può essere mitigato, può portare alla tanto agognata pace. In calce al libro vi è una interessante scheda tecnica di Luciano Tas che riporta cronologicamente in modo sintetico ma esauriente la storia della nostra presenza nei Balcani durante il secondo conflitto mondiale. Non si tratta di opinioni, ma di fatti di cui esistono prove inconfutabili, ed è quanto mai opportuno questo excursus, anche per dimostrare che la creatività espressa nel romanzo parte da basi purtroppo reali. Da leggere, quindi.
Frediano Sessi
vive e lavora a Mantova. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il
ragazzo Celeste (1991),
Ritorno a Berlino (1993), L’ultimo
giorno (1995), Alba
di nebbia (1998), Nome
di battaglia: Diavolo (2000),
Prigionieri della memoria (2006,
due edizioni), Foibe
Rosse (2007, due
edizioni), Il segreto
di Barbiana(2009) e con Carlo Saletti Visitare
Auschwitz (2011, due
edizioni) tutti editi da Marsilio. Sempre per Marsilio ha curato il
saggio di Michel Mazor La
città scomparsa(1992). È autore inoltre dei romanzi per ragazzi
Ultima fermata: Auschwitz (1996), Sotto
il cielo d’Europa (1998)
e Il mio nome è Anne
Frank (2010), editi
da Einaudi, per cui ha curato anche l’edizione italiana definitiva
del Diario di Anne
Frank (1993) e il Dizionario
della Resistenza (2000).
Nel 1999 è stato pubblicato il suo saggio La
vita quotidiana ad Auschwitz (Rizzoli,
tredici edizioni).
27/10/2014
Quaderno di frontiera di Gabriella Bianchi
Fara Editore
Poesia Quando la Poesia è Arte Quaderno di frontiera è l’opera vincitrice assoluta del Concorso Faraexcelsior 2014 organizzato dalla casa editrice Fara di Rimini che si occupa prevalentemente della pubblicazione di opere di poesia. Premetto che spesso sono scettico sulla validità dei testi premiati in questi concorsi, perché troppe volte mi sono trovato in deciso contrasto con le valutazione della giuria, ma in questo caso, pur non conoscendo i lavori degli altri partecipanti, sono rimasto piacevolmente colpito dalla qualità complessiva di questa silloge. In verità le qualità sono più d’una e, prima fra tutte, fatto inconsueto, la straordinaria comprensibilità, frutto di una capacità non comune di tradurre in versi stati emozionali o riflessioni non certo facili. Secondo me questa è la strada che dovrebbe percorrere oggi la poesia, per poter essere apprezzata dai più e infine anche per perpetuarne l’autentica e originaria natura, che nel tempo e soprattutto negli ultimi anni si è svilita in composizioni prosastiche, sovente incomprensibili e che comunque rendono difficoltoso, se non addirittura impossibile, l’approccio del lettore. Che c’è di meglio di versi piani e scorrevoli in una struttura equilibrata e armonica per invogliare chi legge a fare proprio il messaggio del testo? Direi che in questo Gabriella Bianchi ci è riuscita (da Alla madre scomparsa: (Al di là degli elementi consueti / in quale treno sei / in quale traghetto o transatlantico / in quale aereo diretto dove? /…). L’eterna ricerca di un “dopo” è ben espressa, in un senso di solitudine che è proprio di chi ha perso un proprio caro, e nel caso specifico la mamma, che fra tutte e tutti è la più cara. Le tematiche affrontate sono molteplici e spesso possono celarsi sotto versi che magari introducono a una stagione, come in Cerimoniale d’autunno (…/ L’aria profuma di mele rosse, / ma sui panni stesi ad asciugare / il vento lascia lacrime / di genti lontane / sopraffatte dalla sete. / Di loro non resta traccia.) Poesia questa di impegno civile, sofferta e anche lancinante nella chiusa, dove è possibile intendere quel “Di loro non resta traccia” come un qualcosa di talmente lontano di cui la gente non si accorge. Vediamo il dolore che ci tocca da vicino, ma già un metro più in là non ce ne accorgiamo e quindi è ovvio immaginare che i derelitti del pianeta si consumino nel più grave dei nostri peccati: l’indifferenza. E’ impossibile parlare di tutte queste belle poesie, ma di una, che rientra nel mio sentire in modo spiccato, ritengo sia giusto dire un po’ più di due parole; è quella che è mi piaciuta di più, non voglio dire che è la più bella, perché, mi ripeto, sono tutte belle, ma il ricordo di un tempo più a misura d’uomo, contrapposto all’attuale frenesia, è troppo importante per licenziarla magari solo con una frasettina. Ed è per questo che intendo assaporarla, suggere come un nettare ogni verso. Gabriella Bianchi scrive: “Nella mia infanzia c’era solo il treno / e qualche bicicletta arrugginita./” In due soli versi il ritratto di un’epoca, di un’Italia martoriata dalla guerra che faticosamente cercava di tornare a vivere. “Percorrevo sentieri tra gli arbusti / colmi di sputi d’insetti misteriosi.” Per i bambini, per quelli poveri ed erano quasi tutti poveri, i giocattoli erano spesso un miraggio, ma in cambio c’era una natura incontaminata da esplorare. “Le auto in città o sulla via maestra / erano poche. Intorno / era tutto selvatico, / poco o niente si era mosso nelle case / e nei meandri del pensiero umano.” C’era come un tempo fermo, ripetitivo, in un’atmosfera rallentata. “La levatrice interrompeva la quiete / quando spuntava con la sua Lambretta/ anche di notte. / Il resto / era un’isola perduta nel folto / dai cui spiragli si vedeva la città, / ma la città non vedeva noi / e questo ci salvava.” Sì, la nuova era cominciava dalla città, in cui la vita era diversa e non guardava mai alla campagna, considerata quasi un accessorio di poco conto; era ancora lontana l’epoca della folle cementificazione, dei centri urbani che con i loro tentacoli soffocheranno la campagna. “Restavamo innocenti a giocare / sulla strada / tra il fiato delle cantine / e un forte odore di trinciato. / L’aria pungeva lieve / di clorofilla.” L’innocenza non era solo dei bambini, ma di una civiltà, prossima a essere soppiantata, che non conosceva il mito del denaro per il denaro, che si accontentava di quel poco che c’era e poteva inspirare l’aria profumata dei prati, non quei gas venefici che oggi ammorbano e ammalano. Una volta si andava in campagna perché l’aria era più salubre; oggi non è più possibile, perché concimi e anticrittogamici hanno intossicato prima i polmoni e poi il cervello. Era un’epoca dell’innocenza, una sorta di Arcadia di cui ormai pochi possono serbare il ricordo. Leggete questa silloge, perché così leggerete la Poesia, quella con la P maiuscola, quella che scende fino al cuore e rasserena, quella che, quando è così, è Arte.
Gabriella Bianchi è
nata e vive a Perugia.
24/10/2014
Le vite dell'altipiano di Mario Rigoni Stern
Edizioni Einaudi Il senso della vita Mario Rigoni Stern ci ha lasciato nel 2008 e questa raccolta di racconti, sua ultima fatica, ha il sapore di un vero e proprio testamento spirituale. Quel narrare lento e affettuoso, il tema costante della natura e dei rapporti con gli esseri viventi che ne fanno parte, sono un segno indelebile delle straordinarie qualità di questo autore, capace di avvincere senza stancare e di mostrarci, con una semplicità sconcertante, ma anche con una grandezza immensa, il suo concetto della vita, il senso da dare alla stessa, una preziosa indicazione per un mondo migliore, più equo e più umano. Sono tanti i racconti di questa raccolta, suddivisa in tre parti (Storie naturali, Storie di animali e Storie dell’Altipiano) per un totale di ben 602 pagine. Eppure non ci lascia intimorire dal tempo necessario per leggere, anzi è costante il desiderio di portarsi avanti continuamente, immersi idealmente in un bosco di montagna, cullati dal linguaggio caldo e preciso dell’autore. Se la giornata è no, se il lavoro ci ha spossato, se siamo schifati per le ingiustizie di questo mondo, a maggior ragione si deve prendere in mano questo libro, leggere anche un solo racconto e come d’incanto la vita ci sembrerà meno grigia, l’affanno quotidiano sfumerà in un grande senso di serenità. Credetemi, leggere Mario Rigoni Stern è sempre una piacevole esperienza e il bello è che dopo un po’ di pagine si ha la sensazione che lui sia presente davanti a noi, che alla luce di un focolare ci racconti tutti quei fatti, con toni pacati e sommessi. Sembra di averlo sempre conosciuto, l’uomo della porta accanto che non giudica, né condanna, ma che in tutta umiltà parla della sua vita, dei suoi rapporti con gli uomini, con gli animali, con gli alberi e perfino con i fenomeni atmosferici, come la neve. Non ci sono mai astio e odio nella sua voce, c’è solo e sempre quel modo di essere a cui ha sempre improntato la sua esistenza, e senza la pretesa di imporlo agli altri. Anzi, l’impressione è che voglia dirci: “Io vivendo così sono stato bene, non ho nulla da rimproverarmi. Essere in pace con il mondo è esserlo con se stessi, è l’alzarsi un giorno sapendo che quello sarà l’ultimo e non affliggersi, perché non si hanno rimpianti. E l’alba dell’indomani sarà la più radiosa di tutte, perché sarà l’inizio di un’infinita e tanto desiderata pace.”. Da leggere, perché l’ha scritto Mario Rigoni Stern; da leggere perché vi infonderà tanta serenità, da leggere perché è un capolavoro imperdibile.
Mario Rigoni Stern (Asiago
1921-2008) ha esordito nel 1953 con Il
sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia (ultima
edizione «Super ET» 2008), uno dei libri più significativi del
dopoguerra. Sempre presso Einaudi, ha poi pubblicato: Il
bosco degli urogalli(1962), Quota
Albania (1971), Ritorno
sul Don (1973), Storia
di Tönle (1978, Premio Campiello), Uomini,
boschi e api (1980), L'anno
della vittoria (1985), Amore
di confine (1986), Il
libro degli animali (1990),
Arboreto salvatico (1991), Le
stagioni di Giacomo (1995), Sentieri
sotto la neve (1998), Inverni
lontani (1999 e 2009), Tra
due guerre (2000),L'ultima
partita a carte (2002
e 2009), Aspettando
l'alba e altri racconti (2004), I
racconti di guerra (2006)
e Stagioni («L'Arcipelago
Einaudi» 2006, «Super ET» 2008 e «Numeri Primi» 2012). Il suo ultimo
libro, pubblicato postumo nel 2008, è la sceneggiatura del Sergente
nella neve, scritta con Ermanno Olmi.
22/10/2014
Nelle tempeste d’acciaio di Ernst Junger
Introduzione di Giorgio Zampa
Guanda Editore
Narrativa romanzo
Nato per uccidere Giorgio Zampa conclude la sua prefazione a Nelle tempeste d’acciaio con questa frase:” Le tempeste figurano come un masso erratico nella distesa sterminata della letteratura europea.”. E in effetti questo libro ha la grevità di un macigno, uno dei suoi non pochi difetti di cui parlerò più approfonditamente in seguito, poiché ora reputo necessario in via preliminare delineare la figura dell’autore, Ernst Jünger, un tedesco nato a Heidelberg il 29 marzo 1895 e morto a Riedingen il 17 febbraio 1998, cioè a 102 anni compiuti. Cresciuto in una famiglia di agiata borghesia, si arruolò come volontario allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in cui fu ferito 14 volte, ebbe promozioni (l’ultima fu quella a tenente comandante di compagnia) e ottenne la croce di ferro di prima classe, nonché l’ambitissimo e raro ordine Pour le Mèrite. Conclusosi il conflitto, ebbe l’’dea di mettere nero su bianco il suo diario di trincea che venne pubblicato a spese del padre, ottenendo subito uno straordinario successo. Chiaramente nazionalista e di destra non aderì mai tuttavia al partito nazista, ma non mancò di pubblicare un suo scritto contro gli ebrei. Nel corso della seconda guerra mondiale fu ufficiale della Wermacht a Parigi, senza tuttavia farsi notare. A conflitto concluso fu accusato di connivenza con il nazismo, ma come molti altri se la cavò a buon mercato. Continuò l’attività di scrittore, a cui si aggiunse la passione per la filosofia con un’analisi critica della modernità che gli valse, nel 1980, il prestigioso Premio Goethe. Stravagante e sempre portato agli eccessi sperimentò diversi tipi di droghe, dalla cocaina al famigerato LSD, il che però non gli arrecò danni, vista la veneranda età che raggiunse, a dispetto anche del fatto di essere stato sui campi di battaglia di due guerre, il che porta a concludere che si è trattato del classico uomo nato con la camicia. Ma veniamo ora a Nelle tempeste d’acciaio, trasformato da diario di trincea a romanzo autobiografico, 329 pagine esclusivamente di guerra, con descrizioni minuziose delle azioni condotte dall’autore, in cui la morte ha solo una valenza numerica (tot morti loro, tot morti noi), senza che ci sia il benché minimo senso di pietà. È presente la paura, ma più che la paura di morire, il timore così di non riuscire, di non poter continuare a uccidere. Forse come ufficiale sarà stato considerato un esempio per i soldati, ma come uomo rivela una mancanza di sensibilità che non può che urtare la suscettibilità di un lettore non guerrafondaio. C’è uno straordinario compiacimento nel descrivere la battaglia, una morbosità nel parlare delle morti (la testa spiccata dal corpo, oppure il cervello che esce dalla scatola cranico, con il ferito ancora vivo e cosciente) che lascia stupefatti. Junger non era un essere umano, era un automa programmato per ammazzare e stento anche a credere alla gioia dei suoi soldati prima di un attacco, come fossero tornati bambini quando giocavano alla guerra. C’è una differenza abissale con il romanzo di un altro tedesco, Erich Maria Remarque, che in Niente di nuovo sul fronte occidentale ci offre una misura umana degli orrori di un conflitto, ci lascia un messaggio di ferma condanna di ogni guerra; inoltre la stessa stridente discrasia possiamo trovarla in un altro capolavoro, questa volta non di un tedesco, bensì di un italiano, cioè Il sergente nella neve, di Mario Rigoni Stern. In entrambi questi due libri, che dovrebbero costituire materia di studio a scuola, lì ci sono gli uomini che combattono, loro malgrado, per sopravvivere, poveri esseri trascinati in una tragedia che li segnerà per tutta la vita. . Junger non è in verità che inneggi alla guerra, ma nemmeno la condanna e oserei dire che per lui è un fatto privato, la possibilità finalmente offertagli di esaudire quel desiderio che si porta appresso dalla nascita e che è quello dell’inebriante voluttà di essere libero di uccidere. La sua è una lotta continua in cui l’effettivo nemico non è il soldato inglese, oppure quello francese, bensì sé stesso, pronto a misurarsi continuamente e con gioia con la morte, una tenzone che lo inebria con il sottile piacere del rischio e di tutto ciò che è estremo. . Poiché le 329 pagine sono fitte di azioni belliche, con descrizioni di bombardamenti e delle più orribili morti, senza lasciare il minimo spazio a una qualsiasi riflessione che possa rivelare un sentimento nascosto, risultano di una pesantezza incredibile, tanto che viene naturale dopo un po’ o troncare per sempre la lettura o proseguire il più alla svelta possibile per giungere al termine. Certo che chi ama i romanzi che parlano solo della guerra come azioni belliche qui avrà modo di essere soddisfatto, ma questo libro così anomalo per me è un classico esempio di cattiva letteratura, peraltro diseducativa. Non pochi lettori considerano questo romanzo un capolavoro, ma io intendo tenermi fuori dal coro, perché nel giudicare un’opera non ci si può basare solo sullo stile e sulla trama, ma anche sui contenuti e i fini; ora Nelle tempeste d’acciaio non è certo scritto male, riesce forse anche ad avvincere, ma il messaggio che porta è deleterio, perché una bestialità come la guerra non può essere esaltata e quindi il mio giudizio non può essere che negativo; se non fosse così, se non dovessi osservare anche la finalità dell’opera, l’insegnamento che essa comporta, per paradosso dovrei considerare un gran libro anche il Mein Kampf, di Adolfo Hitler. Leggerlo è tuttavia sempre possibile, almeno per vedere quanto ci sia di folle in un uomo nato per uccidere.
Ernst Jünger (Heidelberg,
1895 - Wilflingen, 1998) studiò filosofia e scienze naturali
all'università di Lipsia.
19/10/2014
Maigret si mette in viaggio di Georges Simenon Traduzione di Leopoldo Carra
Edizioni Adelphi Narrativa romanzo
Maigret in difficoltà Maigret è abituato a indagare in ambienti malavitosi o di comuni mortali, quali siamo tutti noi e ovviamente anche lui. Le cose si complicano, e non poco, se occorre venire a capo di un delitto in un mondo riservato a pochi eletti, a grandi uomini di affari, che vivono in una condizione di estrema agiatezza. È su questo terreno sconosciuto che il commissario deve procedere, con piedi di piombo, data la notevole influenza dei personaggi, ai quali è riservata una vita così lontana da quella di tutti gli altri al punto di non riuscire a comprenderla. E’ così che, quando in un lussuoso albergo di Parigi viene ritrovato affogato nella vasca da bagno un magnate inglese, si innesca un meccanismo che porta Maigret a investigare in modo del tutto diverso da quello che gli è abituale, correndo dietro a una contessa che, se probabilmente non è la colpevole, comunque era in stretto contatto con la vittima e potrebbe sapere molte cose. Il commissario prende l’aereo per Nizza, poi il giorno dopo uno per la Svizzera, dove si trattiene poche ore, per poi ritornare sempre in volo a Parigi. Ha parlato con la nobildonna, ma senza che gli si siano schiarite le idee, abbagliato da tante apparenze e frastornato da quel continuo andare. Proprio non sa che fare, ma in una notte trascorsa gironzolando per i locali dell’Hotel teatro dell’omicidio gli viene un’idea, prima sul movente e poi sulla possibile identità dell’assassino. Nel procedere ora sui suoi passi consueti di investigazione Maigret ritrova il suo mondo e se stesso, ritorna a essere il fenomeno che ben conosciamo, al punto da architettare un’ingegnosa trappola per incastrare il colpevole, che vi cadrà inevitabilmente. Se l’intreccio della vicenda puramente poliziesca può apparire un po’ debole e prevedibile (sono riuscito a capire chi è l’assassino già a metà libro), Maigret si mette in viaggio si fa tuttavia apprezzate, oltre che per la tradizionale abilità dell’autore nel sondare la psicologia dei personaggi, soprattutto per la perfezione con cui viene descritto il mondo dei VIP verso i quali Maigret e Simenon non nutrono evidenti simpatie, mostrandoceli con un senso di autentica pietà come prigionieri del loro ruolo, una reclusione senz’altro dorata, ma che non li rende felici. Da leggere.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a JeanPauhlan, da Faulkner a
Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
16/10/2014
Il primo figlio di Isabella Bossi Fedrigotti
Rizzoli Editore Tre donne È innegabile che Isabella Bossi Fedrigotti con la sua scrittura piana, calma, mai enfatica riesca a coinvolgermi grazie alle sue storie, in apparenza semplici, ma che rappresentano un’analisi approfondita di esistenze, in particolare di quel mondo che ancora si vuole considerare a sé stante, sebbene non lo sia, e che molto genericamente definiamo con il termine di universo femminile. Il primo figlio ci accompagna per mano con tre storie di donne, di estrazione sociale, di istruzione e di nazionalità diversa e quindi così dissimili fra loro. Eppure in esse si rispecchia una matrice comune, con quella maternità che è alla base di ogni esistenza e che nei casi specifici le vede, di volta in volta, madri a seguito di una violenza (Teresa), materne come indole naturale, dedizione suprema volta all’allevamento dei bambini (Maria), madre ancora immatura, ma dal sentimento forte e sicuro (Sofia). Sono tre personaggi delineati stupendamente, tre ombre che poco a poco schiariscono per rilucere vivamente nello splendore dei loro affetti, in una narrazione volta non certo a indulgere alla facile commozione, ma che poco a poco porta il lettore a un pathos indescrivibile, proprio quando le loro strade si incontrano, diventando una sola, in un periodo delle loro vite che sarà senz’altro il più bello, quello in cui si sentiranno più realizzate. Poi, con il tempo che passa, con gli anni che pesano, con i bimbi che diventano adulti e lasciano la casa, quel cammino insieme inevitabilmente finirà e ognuna delle tre riprenderà quel percorso che le è sempre stato proprio e che ora si avvia a quell’ultima meta. Ci si emoziona per la condizione di autentica miseria della giovane Teresa, per il dolore di Maria la cui madre, non sana di mente, verrà immolata alla perfezione della razza nazista, per quel senso di vuoto che sempre resterà nell’animo di Sofia per la perdita del primo figlio. Tre donne, tre esseri umani che si sentono vicini, che quasi appaiono, pagina dopo pagina, davanti agli occhi, e a cui si vorrebbe affidare un po’ del proprio destino, braccia materne che ci stringano nella loro protezione dai venti turbinosi della vita. Non credo sia facile, specie nella nostra epoca, leggere libri come questo, in cui, senza rinnegare la naturale funzione materna, si ponga bene in evidenza la necessità che alla donna sia riconosciuta pari dignità, uguaglianza non solo di diritti, ma anche di affetti e di sentimenti. Il primo figlio è uno di quei libri che una volta letti non possono non lasciare un segno indelebile dentro di noi.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor
Budischowsky (Rizzoli, 2003) e Il primo figlio (Rizzoli,
2008).
13/10/2014
Nel legno e nella pietra
di Mauro Corona Un libro che invita a riflettere Novantatre racconti più un epilogo costituiscono questa raccolta dall’emblematico titolo “Nel legno e nella pietra”. Sono quasi tutte prose abbastanza brevi, al massimo di tre pagine e quindi la lettura non risulta impegnativa, anche grazie alla varietà dei temi e allo stile piano dell’autore, con una fluidità e un’efficacia di esposizione che ricorda, pur senza raggiungerla, la straordinaria abilità al riguardo di un altro narratore, pure lui montanaro, e cioè Mario Rigoni Stern. Preciso, inoltre, che per la presenza tangibile di Mauro Corona in ognuno di questi scritti, per i periodi della sua vita che lì si trovano esposti, Nel legno e nella pietra finisce con l’essere una, se pur parziale, autobiografia. Ci sono i rapporti dell’autore con gli animali, con gli uomini, con la natura, le sue imprese alpinistiche, anche sfortunate, i lunghi e duri anni di lavoro alla cava di marmo. Se la brevità è un vantaggio, spiace a volte dover constatare come uno spunto di notevole interesse e che avrebbe meritato una trattazione ben più ampia, materia prima valida magari per un romanzo, qui invece sia ridotto a una sintesi per quanto gradevole. Ciò che tuttavia stupisce è scoprire ancora una volta quanto il Corona descritto sia reale, cioè l’autore si dipinge con pregi e difetti, non lesinando soprattutto questi ultimi, senza autocompiacimento, ma con l’umiltà di chi, sotto una parvenza di semplicità, rivela qualità e soprattutto concretezza di vita forse insospettabili. Quell’uomo, barbuto, con la capigliatura mai in ordine, trasandato nel vestire, è effettivamente così, per sua precisa scelta, secondo uno stile di vita che magari non ci attira, pur destando curiosità, ma che è il frutto di una ricerca del senso dell’esistenza a cui è da tempo approdato. Noi siamo perché altri sono stati prima di noi, e altri ancora saranno dopo; non siamo che un microscopico elemento del creato e quella vita che abbiamo avuto in dono deve essere condotta in armonia con tutto ciò che ci circonda, cioè uomini, animali, alberi, insomma quel complesso di cose animate ed inanimate che costituisce la natura. Inseguire il guadagno, cercare il successo a ogni costo significa sprecare un’occasione, l’unica che ci è stata data. Per certi versi il messaggio di Corona è cristiano, ma può essere visto e compreso anche da un ateo purché si ponga la domanda del perché della sua esistenza. E’ ormai da anni che seguo Mauro Corona, grande scalatore, abile scultore e bravo narratore, in quest’ultimo caso con una produzione di eccellente qualità che ribadisce sempre la necessità di vivere in armonia con la natura, messaggio che condivido pienamente.. Nel legno e nella pietra riconferma le elevate qualità dell’autore, consente una lettura snella e piacevole, introduce ad ampie, profonde e opportune riflessioni; pertanto è più che raccomandabile.
Mauro
Corona è
nato a Erto (Pordenone) nel 1950.
10/10/2014
E’ cino, la gran bota, la s-ciuptèda di Gianfranco Miro Gori Prefazione di Ennio Grassi
Fara Editore
Poesia dialettale con traduzione in italiano a fronte
Una raccolta in vernacolo Il dialetto è un idioma tipicamente locale e fino a non molto tempo fa era utilizzato più frequentemente della lingua italiana. Al riguardo, da un’inchiesta ministeriale del 1910 risultò che oltre la metà degli insegnanti delle elementari ricorreva al dialetto per le lezioni quotidiane. Il fatto fece scalpore, furono presi immediati provvedimenti e in pochi anni il vernacolo venne bandito dagli istituti scolastici. In un paese come il nostro in cui lo spirito unitario è sempre stato carente è comprensibile quindi che sia fatta leva, onde creare una popolazione omogenea, sull’uso di una sola lingua, appunto l’italiano. Poco a poco il dialetto venne confinato a entità ristrette, assumendo a volte le caratteristiche di un linguaggio arcaico che pochi appassionati si ostinavano a mantenere. Come in vernacolo c’erano le prose, si avevano anche le poesie, anzi entrambe le forme espressive esistono ancora oggi (ricordo che fino a pochi anni fa a Mantova c’era un vero e proprio Festival delle commedie dialettali). E se spesso associamo al vernacolo una narrativa o una poesia di limitato spessore, sovente tesa, anche con toni un po’ volgari, a sollecitare la facile risata, non vi è però da dimenticare che ci sono stati poeti dialettali di rilevante valore (Trilussa e Totò, per citarne i più noti). Quindi anche la poesia in vernacolo, purché si tratti di componimenti non banali, ma votati a messaggi non di rado profondi, ha una sua dignità, pur restando un problema di base che è la sua non facile comprensibilità in tutte le zone d’Italia, con l’eccezione dei versi in napoletano e in romanesco, dialetti discretamente conosciuti anche al di fuori delle località d’origine. Affinché tutti potessero comprendere è intervenuto opportunamente l’uso di accompagnare al testo in vernacolo la traduzione in italiano, che però risulta meno efficace di certi linguaggi locali nell’esprimere concetti e situazioni. A questo punto ci si chiederà il perché di questo lungo preambolo e al riguardo si potrà comprendere dal mio commento critico che segue subito. È cino – la gran bòta – la s-ciuptèda è una raccolta di poesie in dialetto romagnolo che Gianfranco Miro Gori, l’autore, ha pubblicato con l’editore Fara di Rimini, quindi perfettamente nella zona del vernacolo utilizzato. Quanto sia importante la traduzione a latere è testimoniato dal fatto che il titolo mi aveva indotto a pensare a un certo Gino, che prende una gran botta e poi una schioppettata. Niente di più sbagliato perché cino sta per Il cinema, la gran bòta per Il gran botto e solo la s-ciuptèda ha un significato comprensibile, cioè la schioppettata. Questa raccolta è articolata in tre tematiche, di cui quella preponderante è il cinema, e non poteva essere altrimenti visto che Gori ha ideato e diretto la Cineteca di Rimini. In effetti, cino è un omaggio al cinematografo, non a quello di oggi che ne vede forse gli ultimi bagliori, ma a quello di ieri, in una sorta di Nuovo Cinema Paradiso e di Amarcord. E’ una rievocazione commossa delle sale di un tempo, fumose, anche chiassose, per quello che all’epoca non era uno spettacolo, ma Lo Spettacolo. E così come i fotogrammi di una pellicola i versi ci raccontano la storia del cinema fino all’amara conclusione che sembra segnare la fine di un mondo (Il cinema è morto, / Il dialetto è morto./ O / ruzzolano entrambi / più o meno / nel vociare della televisione / nel chiacchiericcio di Internet). Insomma è finita un’epoca pionieristica, in cui si ragionava anche con il cuore, ed è trionfante il periodo tecnologico, che, inaridita l’anima, sta anche congestionando la mente. Sì, è una fine, ma questa terra, questo mondo in cui viviamo, com’è nato? Grazie al gran botto, al big bang ha cominciato a formarsi la Terra, si è sviluppata, e anche se non possiamo avere la misura del tempo che è stato necessario, alla fine è quello che ci ritroviamo, noi compresi. Sono originali le poesie che parlano in pratica della creazione e rivelano che l’autore qui ha un chiaro intento didascalico, perché sapere da dove veniamo serve per conoscere dove andremo. Scopi legati alla sua terra e in particolare al suo paese natio San Mauro Pascoli sono all’origine delle ultime due poesie (Il morto ammazzato e L’assassino) e parlano di un fatto vero, dell’omicidio di Ruggero Pascoli, padre del grande poeta Giovanni. Hanno la voce del cantastorie, il sapore di un tempo passato che, ahimé, mai più ritornerà. Nel complesso il libro mi è piaciuto, per quanto sia impossibilitato a esprimere un giudizio compiuto sullo stile, stante la mia modesta conoscenza del dialetto romagnolo che influenza tuttavia solo in minima parte la gradevolezza, poiché ho preferito abbandonarmi alle caratteristiche e simpatiche inflessioni; il contenuto, peraltro, non è da poco, affronta temi, quali la memoria e il mistero della creazione, senza scivolare nel banale o in cose più che risapute, ma con una sua personale visione in cui in più di un’occasione mi sono ritrovato. Quindi, l’invito è a leggerlo, perché ne vale la pena.
Gianfranco Miro Gori,
nato a San Mauro Pascoli (11.8.1951), ha ideato e diretto la Cineteca
del Comune di Rimini ed è stato sindaco di San Mauro Pascoli.
Organizzatore di festival e manifestazioni culturali in patria e
all’estero, ha pubblicato molti saggi (dedicati soprattutto al cinema
ma anche a Giovanni Pascoli e Secondo Casadei), tre raccolte di versi
in dialetto (Strafócc, Chiamami
Città, Rimini 1995; Gnént, Pazzini,Verucchio 1998;Cantèdi, Mobydick,
Faenza 2008) e un romanzo (Senza movente, Mobydick, Faenza
2000). Attualmente è presidente di Sammauroindustria, associazione
culturale da lui progettata.
7/10/2014
Sentieri sotto la neve di Mario Rigoni Stern
Edizioni Einaudi Il culto della memoria “Lassù la montagna è silenziosa e deserta. Lungo la mulattiera che gli austriaci costruirono per giu 9788ngere nei pressi dell’Ortigara, dove un giorno raccolsi la punta ferrata del Bergstock che è qui sulla libreria, ora non passa più nessuno. La neve che in questi giorni è caduta abbondante ha cancellato i sentieri dei pastori, le aie dei carbonai, le trincee della Grande guerra, le avventure dei cacciatori. E sotto quella neve vivono i miei ricordi.” Benché abbia letto pressoché tutto ciò che ha scritto, ogni volta che prendo in mano un suo libro, già dalla prima pagina, resto stupito della straordinaria capacità di comunicare, una dote evidentemente innata che Mario Rigoni Stern ha saputo coltivare arrivando a livelli qualitativi elevatissimi. Riesce a ricreare, con semplicità, atmosfere che spesso ci sono sconosciute, racconta come se fosse lì davanti a te, magari in una casa di montagna appena illuminata dalle vampe del fuoco nel camino, e fuori è tutto bianco di neve e gelido, ma lì, in quell’ambiente, c’è un sano tepore, un profumo di resina che aleggia insieme alle parole, che, pacate, lui pronuncia. Sono storie di guerra, oppure ricordi di anni passati, sono ritratti di personaggi scomparsi da tempo, sono descrizioni della natura nel corso delle stagioni; Rigoni Stern racconta in un fluire di ricordi che piano piano vengono a definire il monumento della memoria, perché se non sappiamo quali sono le nostre radici, come si sono sviluppate, inevitabilmente siamo orfani del presente, incapaci di orientarci in una vita che arriva a sembrarci senza senso. E di queste rimembranze sono intrisi anche questi sedici racconti che riuniti formano una raccolta, molto opportunamente intitolata Sentieri sotto la neve. La frase che ho trascritto in epigrafe è l’ultima di questo libro e ha un significato profondo, riassume ciò che per un grande scrittore deve essere la vita, e cioè raccontare di ciò che è stato, un patrimonio insostituibile da lasciare ai posteri affinché sappiano camminare sull’impervio sentiero dell’esistenza. L’opera è suddivisa in tre parti: la prima è relativa a un periodo di tempo molto remoto, la seconda a uno che è più recente e la terza è il presente. Non c’è un racconto che non sia riuscito, che non sia almeno buono; sono tutti eccellenti, con qualcuno che lo è più di altri. Se incalzante è “Che magro che sei, fratello!”, la storia del ritorno solitario dal lager, struggente è Un pastore di nome Carlo e magico potrei definire Osteria di confine, una ferma condanna di ogni guerra, senza retorica, senza ricorso a luoghi comuni, tanto che forse è quello che ho apprezzato di più. Ma assai riuscito mi è parso anche L’altra mattina sugli sci con Primo Levi, un’immaginaria escursione sulla neve con il grande scrittore torinese già scomparso e che più volte in passato aveva manifestato il desiderio di questa passeggiata alpina, senza che si concretizzasse per svariati motivi. Benché la narrazione sia come al solito semplice, ci sono momenti in cui Stern riesce a imprimerle dei toni sublimi, come nella prosa poetica che si trova in Caprioli. E’ una lettura che coinvolge, è un’esperienza di partecipazione a fatti o avvenimenti a cui ci si abbandona con voluttà, incantati dal pregevole italiano, che molti narratori odierni purtroppo ignorano, soddisfatti ed entusiasti pagina dopo pagina, consapevoli che stiamo nutrendo la nostra anima, che la serenità che lenta ci avvolge non potrà che essere il frutto di tanta bellezza. Ogni ulteriore commento credo sia superfluo.
Mario Rigoni Stern (Asiago
1921-2008) ha esordito nel 1953 con Il
sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia (ultima
edizione «Super ET» 2008), uno dei libri più significativi del
dopoguerra. Sempre presso Einaudi, ha poi pubblicato: Il
bosco degli urogalli(1962), Quota
Albania (1971), Ritorno
sul Don (1973), Storia
di Tönle(1978, Premio Campiello), Uomini,
boschi e api (1980), L'anno
della vittoria (1985), Amore
di con fine (1986), Il
libro degli animali (1990),
Arboreto salvatico (1991), Le
stagioni di Giacomo (1995), Sentieri
sotto la neve (1998), Inverni
lontani (1999 e 2009), Tra
due guerre (2000),L'ultima
partita a carte (2002
e 2009), Aspettando
l'alba e altri racconti(2004), I
racconti di guerra (2006)
e Stagioni («L'Arcipelago
Einaudi» 2006, «Super ET» 2008 e «Numeri Primi» 2012). Il suo ultimo
libro, pubblicato postumo nel 2008, è la sceneggiatura del Sergente
nella neve, scritta con Ermanno Olmi.
3/10/2014
La paura e altri racconti della grande guerra di Federico De Roberto Introduzione di Antonio Di Grado
Edizioni e/o
Narrativa raccolta di racconti
La paura è contagiosa Si avvicina il primo centenario dell’inizio della Grande Guerra e la casa editrice e/o ha inteso procedere a una commemorazione stampando questo volumetto di racconti (in tutto quattro) ambientati nel corso di quel conflitto. Stranamente i narratori italiani ne hanno parlato poco o meglio ancora pochi sono quelli che ne hanno scritto; fra questi figura Federico De Roberto, più conosciuto per il suo capolavoro intitolato I Viceré. Ebbene, da un romanziere come lui, mai mi sarei aspettato la straordinaria capacita nel descrivere il quotidiano di un dramma collettivo quale può essere una guerra. Premetto che il primo dei brani, intitolato La paura e che dà il titolo all’intera opera è un autentico capolavoro e da solo giustifica ampiamente la lettura di questo libro. Gli altri tre, pur essendo validi e di ottima qualità, vi sfigurano, se raffrontati al primo, ma preferisco – e così posso meglio parlare di quest’opera – procedere per gradi con brevi cenni sui racconti, non partendo dal primo, ma anzi lasciandolo per ultimo. Il rifugio è un ritratto della casualità, con un capitano, in missione, costretto dall’inclemenza del tempo a chiedere ospitalità a una famiglia di contadini che poi risulteranno parenti stretti di un soldato appena fucilato per diserzione. Al riguardo intense e convincenti sono le pagine che parlano dell’esecuzione, in cui emerge da parte degli ufficiali del condannato un senso di profonda pietà, a cui non si sottraggono pur consapevoli della necessità del provvedimento per quella disciplina indispensabile in ogni esercito, soprattutto in tempo di guerra. La retata è quello che non ti aspetti, cioè un brano divertente innestato nell’immane tragedia del conflitto. Grazie al protagonista picaresco, un romano che parla solo nel suo dialetto e che per le caratteristiche mi ha fatto venire in mente il grande Alberto Sordi, sembra esserci un attimo di pausa nella tragedia, con situazioni indubbiamente comiche e al riguardo basti pensare che, preso prigioniero, il nostro soldato, eroe a suo modo, accortosi della fame dei suoi carcerieri, li incanta con la descrizione di quanto di buono si mangia nell’esercito italiano, al punto che questi lo liberano e finiscono per consegnarsi ai nostri. L’ultimo voto è un po’ più convenzionale e tratteggia una donna rimasta vedova del marito morto in guerra e stridente appare la discrasia fra la scomparsa eroica dell’uomo, innamoratissimo della moglie, e la capacità di lei di consolarsi ampiamente. La paura nella sua trama è tutto sommato semplice. In un tratto del fronte, da tempo del tutto calmo, c’é una postazione avanzata ed esposta in cui è necessaria la costante presenza di una vedetta che possa osservare se da lì possa venire l’attacco del nemico. In un giorno come tanti e come sempre ogni due ore avviene il cambio, ma ecco che chi monta viene ucciso o comunque ferito gravemente da un cecchino e anche quelli che nell’ordine vanno all’appostamento fanno la stessa fine. L’attesa dei predestinati, il lacerante contrasto intimo dell’ufficiale, combattuto fra il senso del dovere e l’angoscia per la sorte dei suoi uomini, l’implacabile freddezza del cecchino che non si scompone nemmeno di fronte a un bombardamento della nostra artiglieria, le urla strazianti di un ferito segnano queste pagine in un crescendo di tensione che fa sentire il lettore quasi presente, magari pure lui nella fila di quelli che devono andare, con morte pressoché certa, a quel maledetto avamposto. Così la paura serpeggia, si trasmette velocemente come un virus e contagia anche un soldato con la tempra da eroe, portando a una conclusione non liberatrice, ma ancor più angosciante. Qui De Roberto si esprime a livelli elevatissimi e pur tuttavia con semplicità, il che indubbiamente giova alla gradevolezza della lettura, dimostrando ancora una volta le sue capacità di analisi psicologica e facendo di questo racconto un veemente atto d’accusa contro ogni guerra, senza retorica, con la crudele realtà di un fatto forse come tanti, ma estremamente emblematico. La paura e altri racconti della grande guerra è un libro senz’altro meritevole di essere letto.
Federico De Roberto,
nato a Napoli nel 1861, ebbe una prima formazione scientifica alla
quale affiancò presto l'interesse per gli studi classici. Sin dai
primi anni della sua carriera fu impegnato in collaborazioni con
importanti riviste e quotidiani e con alcune case editrici. Autore di
numerosi romanzi e raccolte di novelle e racconti, morì a Catania nel
1927.
|
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Poetare.it © 2002