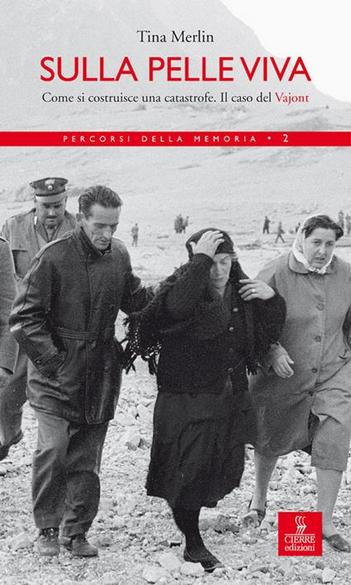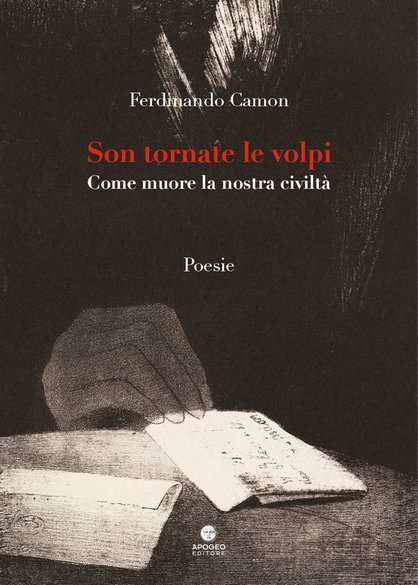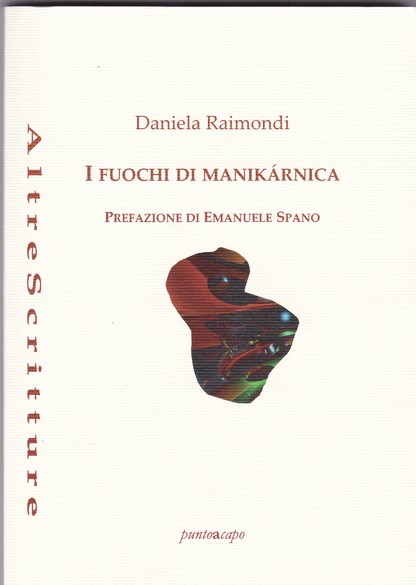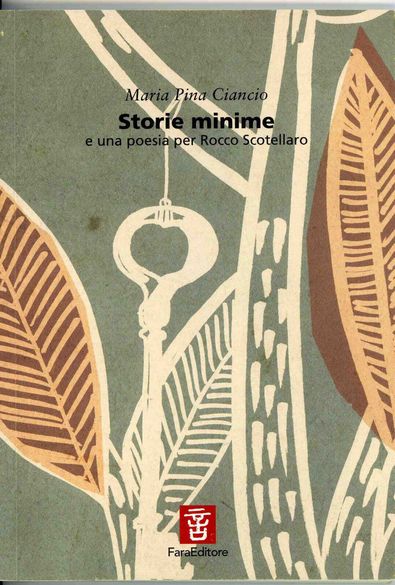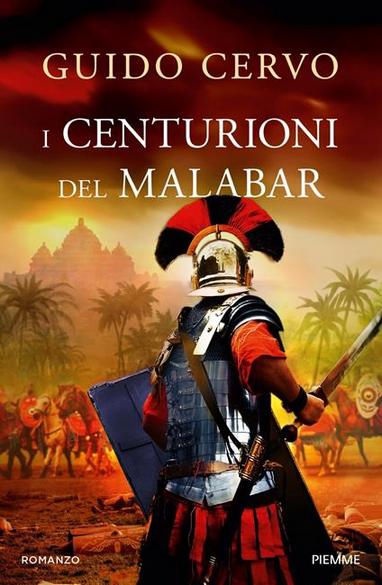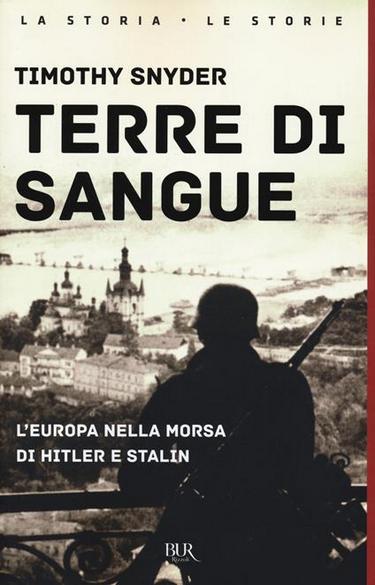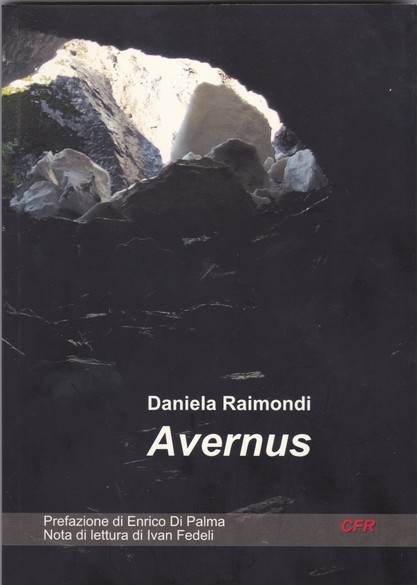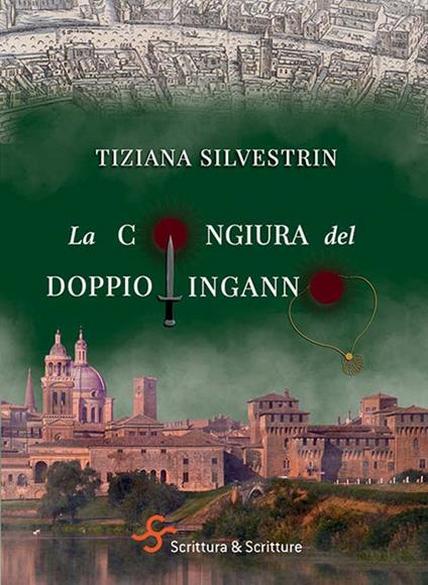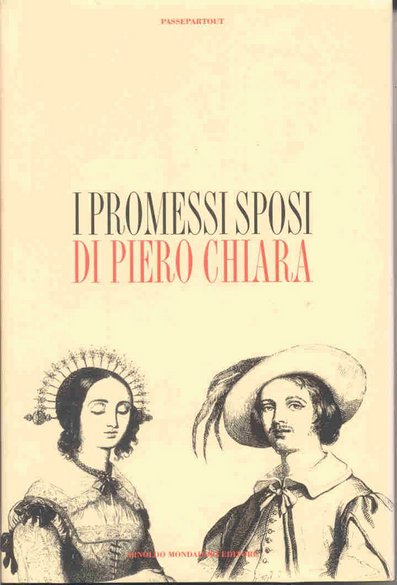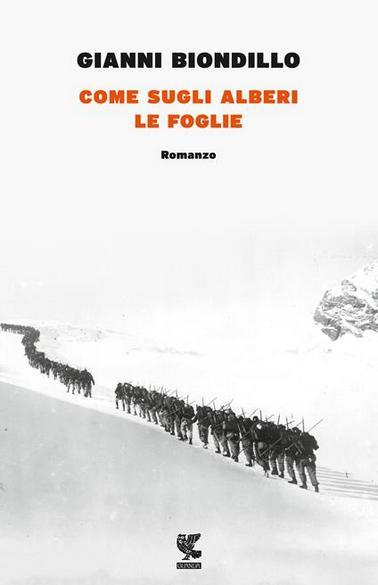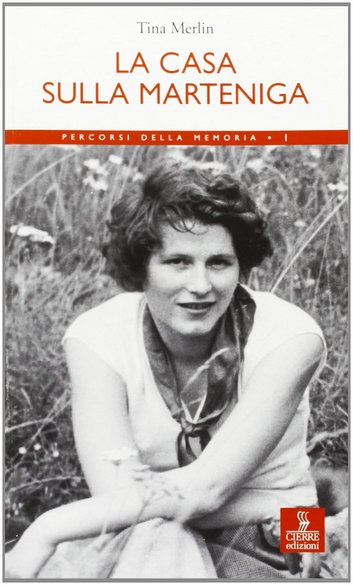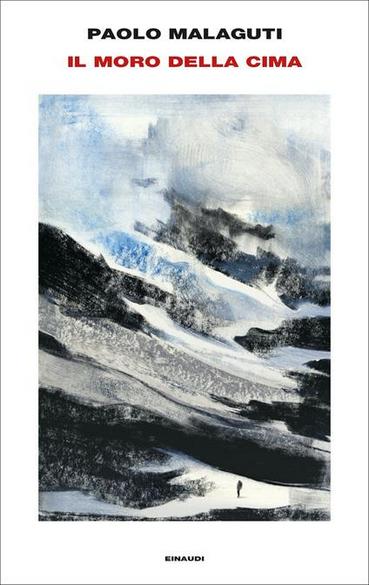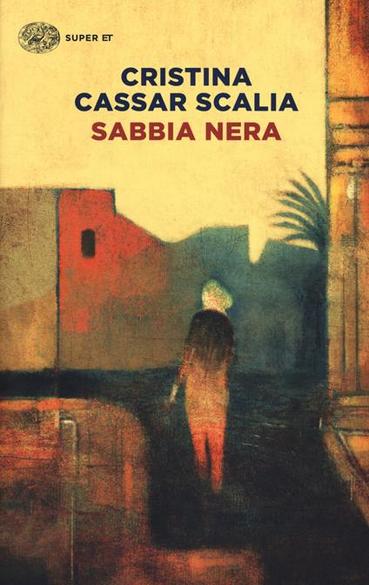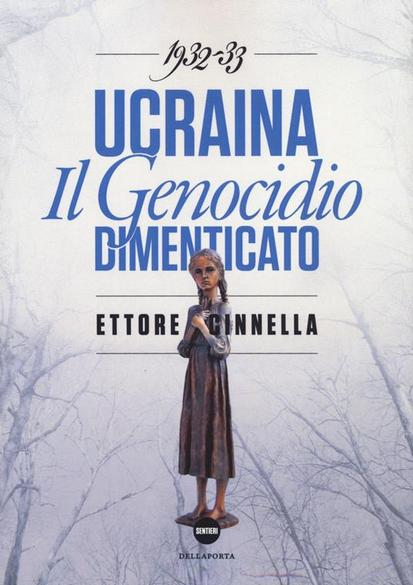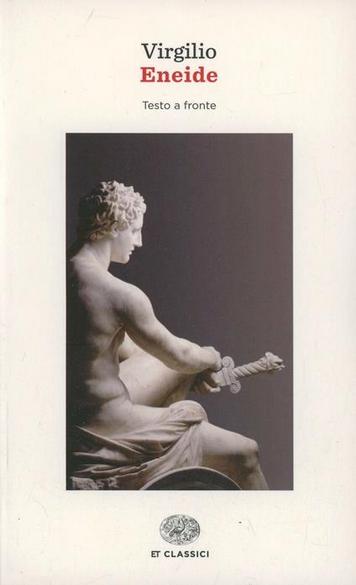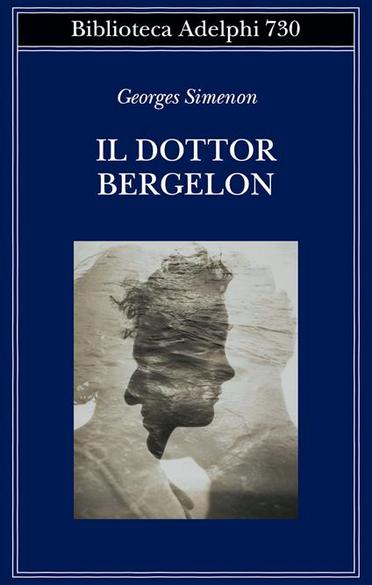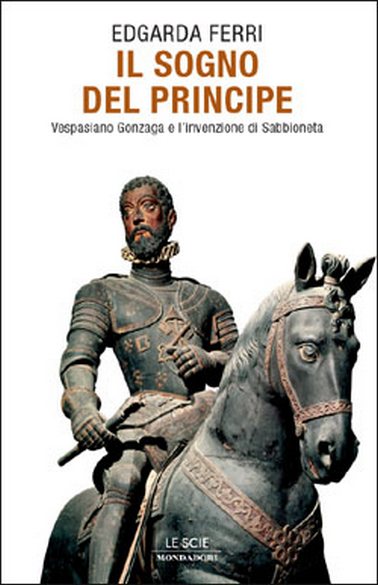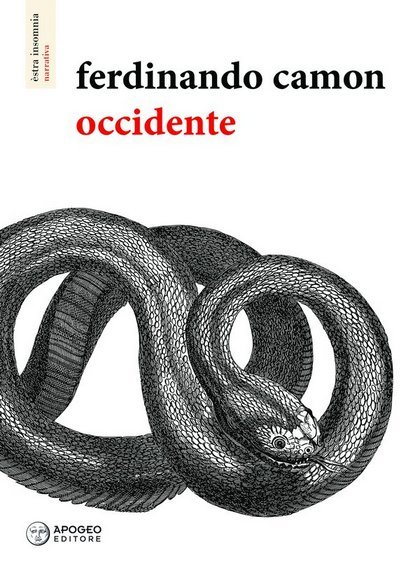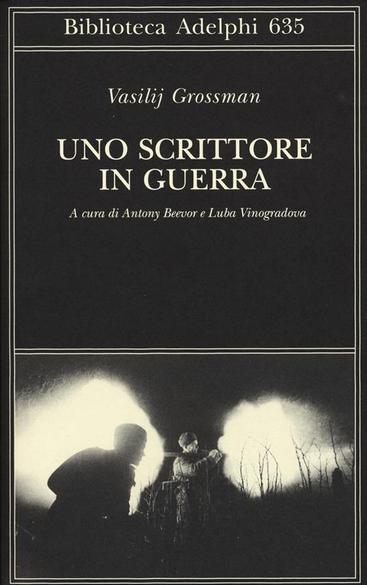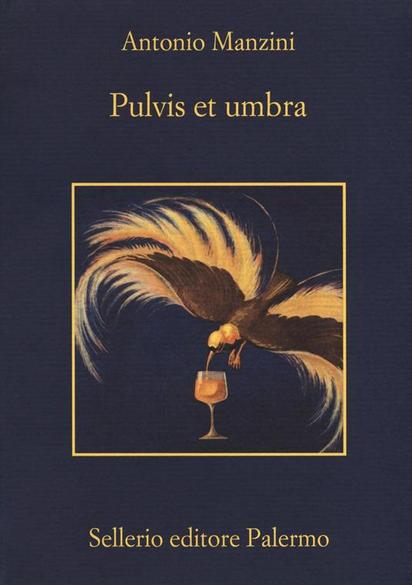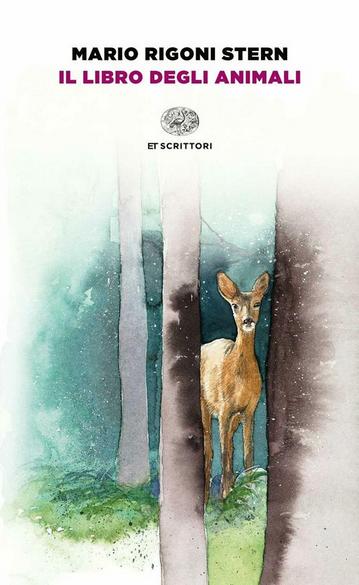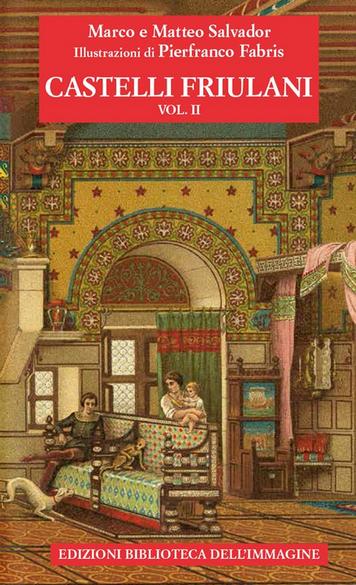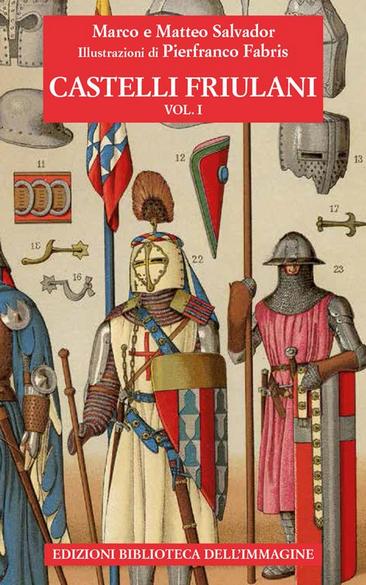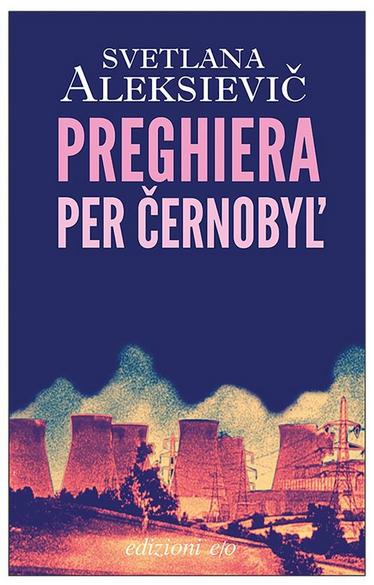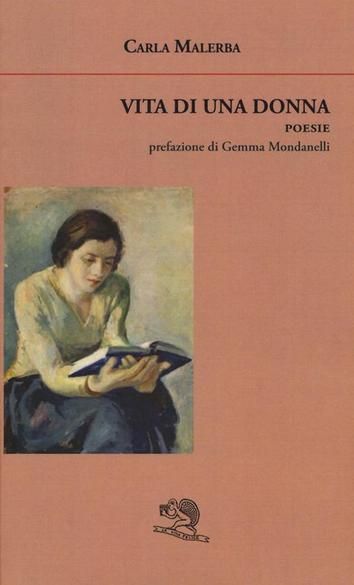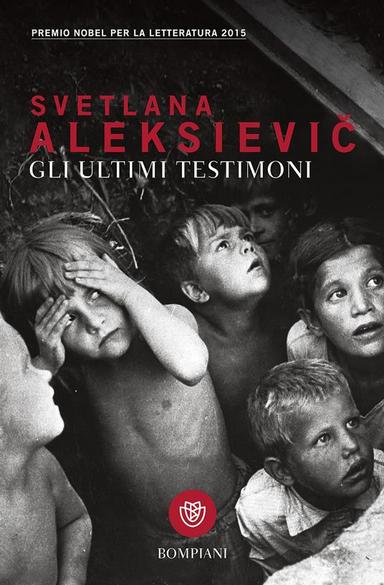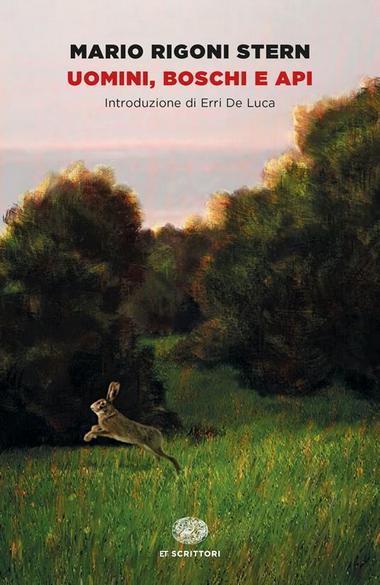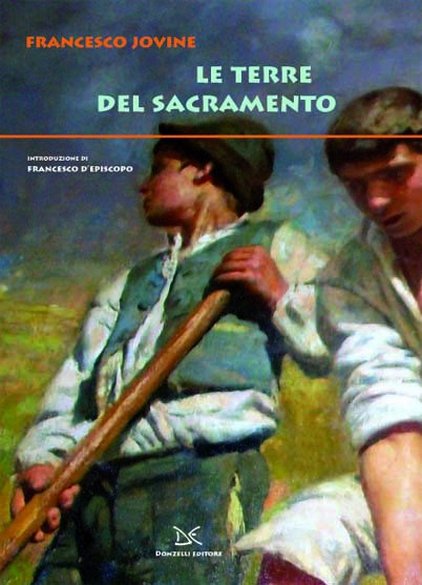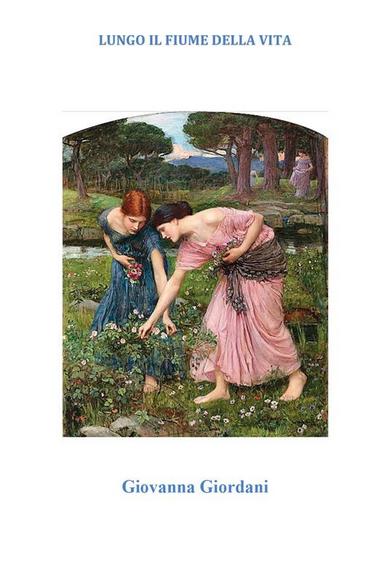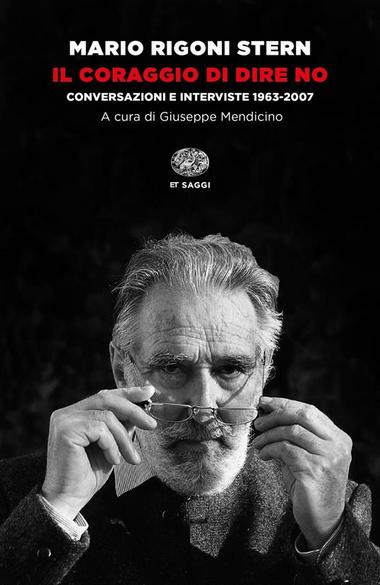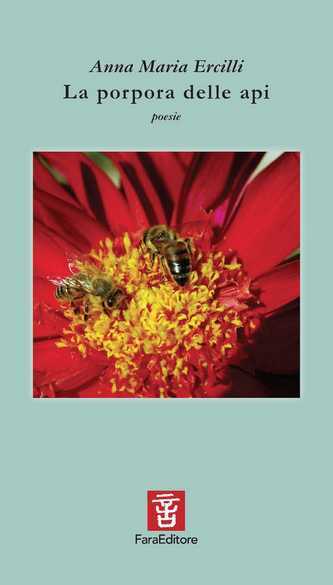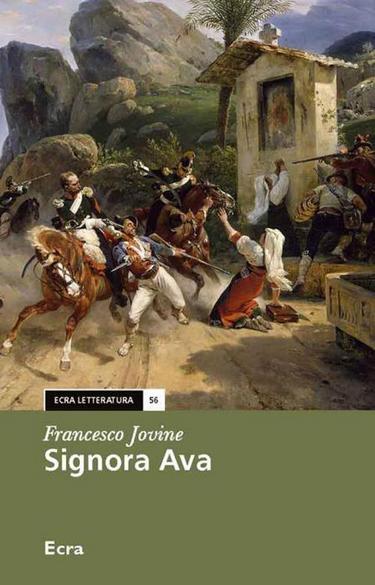|
16 Dicembre
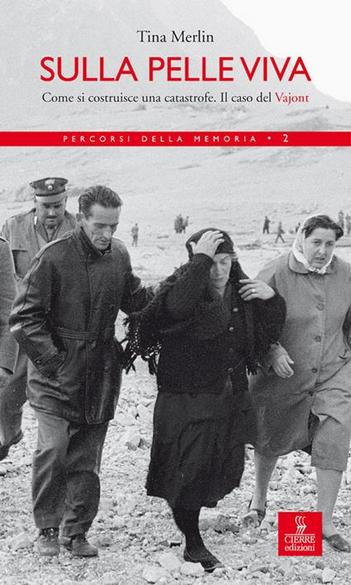
Sulla pelle viva.
Come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont
di Tina
Merlin
Edizioni
Cierre
Storia
Una tragedia annunciata
Alle
22,39 del 9 ottobre 1963 una gigantesca frana di oltre 250 milioni di metri
cubi di terra e rocce scese dal monte Toc nell’invaso realizzato grazie alla
diga del Vajont, sollevando un’onda gigantesca che spazzò via tutto quello che
incontrava nello scendere a valle e che cancellò letteralmente Longarone,
provocando, oltre alle distruzioni, quasi duemila vittime. Fatalità, evento
imprevedibile, negligenza? All’inizio si invocò l’imprevedibilità del fatto,
ma ben presto vennero alla luce decisioni ed eventi antecedenti che smontavano
facilmente questa ipotesi, anche perché la giornalista dell’Unità Tina Merlin
aveva scritto della estrema pericolosità ricollegabile all’edificazione della
diga già a partire dai primi lavori, avviati nel 1957, pur in assenza di una
valutazione geologica di un territorio dalla particolare fragilità tanto che
la montagna che sovrastava i paesi di Erto e di Casso si chiama Toc e toc
indica nel dialetto locale qualcosa di guasto, di avariato. Infatti chi
abitava lì era a conoscenza dell’instabilità di quel monte, già oggetto in
passato di altre frane, e gli unici che sembravano non saperne nulla erano
proprio gli azionisti e dirigenti della SADE Società Adriatica Di Elettricità
che si erano messi in testa di costruire la diga più alta d’Europa in modo da
realizzare un invaso gigantesco. Una perizia geologica in realtà esisteva, ma
era stata predisposta ad arte per consentire di intraprendere un’impresa che
altrimenti non sarebbe stata autorizzata. Purtroppo all’epoca c’era uno
stretto legame di interessi fra il governo e la SADE, di cui beneficiavano
entrambi, così che allegramente venivano saltate tutte le necessarie
procedure, perfino per gli espropri dei terreni che sarebbero stati sommersi.
La Merlin, che appoggiava i moti di protesta delle popolazioni locali, che
temevano, a ragione, per la loro incolumità, fu addirittura accusata di
diffondere notizie false e tendenziose atte turbare l’ordine pubblico, ma il
Tribunale di Milano la assolse. Del resto tutta la zona aveva un equilibrio
instabile, come testimoniato dalla colossale frana di 3 milioni di metri cubi,
staccatasi dai monti Castellin e Spiz il 22 marzo del 1959, precipitata nel
sottostante lago artificiale, provocando un’onda che superò la relativa diga
di almeno 7 metri e fu solo per fortuna che ci fu un’unica vittima, un operaio
che transitava lungo il percorso interessato dallo smottamento e il cui corpo
non fu mai ritrovato. Dato che anche quell’invaso era opera della SADE questa
cominciò a preoccuparsi, tanto più che una perizia geologica non di parte (uno
degli estensori era il figlio del progettista della diga del Vajont) aveva
evidenziato l’esistenza di un pericolo gravissimo, di cui si ebbe una prova
il 4 novembre 1960 quando dal monte Toc si staccò una frana di 800.000 mc, con
caduta nel lago artificiale e conseguente ondata alta una decina di metri. Non
ci furono vittime, ma questo dimostrava che mano a mano che le acque
dell’invaso salivano (si era già a 650 metri) le spinte sui fianchi tendevano
a innescare fratture nel terreno. A questo punto si decise di abbassare il
livello, tanto più che si era evidenziata una lunga crepa nel fianco della
montagna. Tina Merlin, nell’occasione, scrisse un articolo per l’Unità che
riportava fra l’altro queste parole:”Si era dunque
nel giusto quando, raccogliendo le preoccupazioni della popolazione, si
denunciava l'esistenza di un sicuro pericolo costituito dalla formazione del
lago. E il pericolo diventa sempre più incombente. Sul luogo della frana il
terreno continua a cedere, si sente un impressionante rumore di terra e sassi
che continuano a precipitare. E le larghe fenditure sul terreno che
abbracciano una superficie di interi chilometri non possono rendere certo
tranquilli.”.
Si tentò
allora di mettere in sicurezza l’impianto, ma era troppo tardi, perché una
volta che si viene a gravare su un difficile equilibrio è inevitabile che,
prima o poi, se ne paghino le conseguenze. Lo sapevano dunque quelli della
SADE e la possibilità che avvenisse un disastro era notevolissima.
Considerata che era imminente la nazionalizzazione delle imprese di energia
elettrica, con lauti guadagni per queste, dopo aver ridotto il livello del
lago, si aumentò di nuovo, in modo da arrivare al collaudo necessario per la
cessione allo stato, ben sapendo che in questo modo il rischio sarebbe
aumentato in modo massiccio ed è così che si giunse a quella famosa notte del
disastro, nonostante, monitorando la montagna, ci si fosse accorti del
pericolo enormemente incrementato, a cui si cercò di rimediare abbassando di
nuovo il livello. Era però troppo tardi e il resto lo conosciamo.
Il libro
della Merlin è un atto di accusa, chiaro e incontestabile, contro chi per
denaro, e ben sapendo che il suo comportamento poteva provocare vittime, volle
procedere lo stesso, un reato non da omicidio colposo, bensì quasi da omicidio
volontario, ibrido peraltro non contemplato dal nostro codice penale, così che
l’unica accusa fu quella di omicidio colposo. Non vado oltre perché
occorrerebbero chissà quante pagine; mi limito solo a evidenziare il valore di
questo libro. Tina Merlin è brava, perché unisce allo stile giornalistico una
impronta narrativa, grazie alla quale ben si comprende l’atmosfera e si prende
consapevolezza della paura di questi montanari, schiacciati da un potere
insensibile. Le qualità che ho potuto apprezzare nel romanzo La casa sulla
Marteniga qui sono al servizio di un’inchiesta giornalistica su un fatto
drammatico, così che è evidente la tensione in attesa di un evento pressoché
certo. Leggere queste pagine fa male, perché l’avidità di certi uomini non
ammette l’esistenza di sentimenti, in quella che può essere definita un’orgia
del potere.
Da
leggere senz’altro.
Tina Merlin nasce
a Trichiana (Belluno) il 19 agosto 1926 e muore a Belluno il 22 dicembre 1991.
Durante la guerra di liberazione è stata staffetta partigiana. Inizia la sua
attività letteraria scrivendo racconti che vengono pubblicati sulla rivista Noi
donne. Dal 1951 al 1967 è corrispondente locale del quotidiano L’Unità.
Esordisce come scrittrice con Menica (1957),
raccolta di racconti partigiani. Segue da vicino le vicende del Vajont. tentò
di pubblicare un libro sulla vicenda, Sulla Pelle viva. Come si costruisce
una catastrofe. Il caso del Vajont, che tuttavia trovò un editore solo nel
1983.
Renzo Montagnoli
10 Dicembre
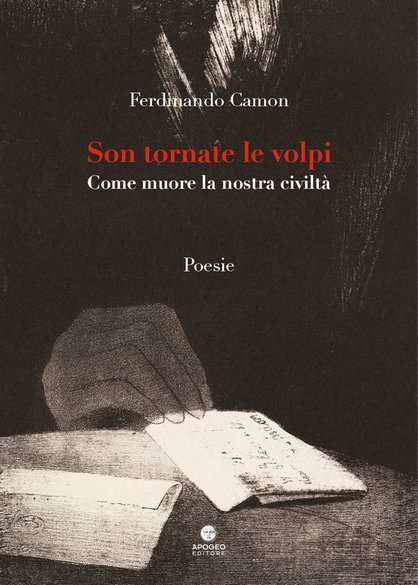
Son tornate le volpi
Come muore la nostra civiltà
di Ferdinando Camon
Apogeo Editore
Poesia
La paura
deve finire
Si fa presto a dire che
l’immigrazione è il nostro tardivo aiuto a popoli in un ancor recente passato
vessati dalle potenze europee, ma questa moltitudine che fra mille difficoltà
e rischi arriva nel nostro paese rappresenta di per sé una bomba orologeria,
perché è inevitabile che si vengano a creare le occasioni per uno scontro di
civiltà, soprattutto quando una di queste è improntata a una religiosità
fanatica e di esclusione delle altre fedi. In un occidente europeo francamente
decadente non sta avvenendo una pacifica integrazione di due concetti di
società, ma piano piano sta prendendo il sopravvento il lato più oscuro e
drammatico di popoli le cui convinzioni religiose, spesso, sono in netto
contratto con le nostre leggi fondanti, scritte nelle costituzioni e
rispecchianti il comune sentire. Ferdinando Camon che già ha scritto,
benissimo, della scomparsa della civiltà contadina si è guardato intorno, ha
osservato, ha tratto conclusioni e così è nato Son tornate le volpi
con sottotitolo Come muore la nostra civiltà, senza paura di
essere qualificato come razzista, perché razzista non è, perché vedere come
stanno le cose non è razzismo, non è cercare di difendere i propri valori
minacciati ogni giorno, non è desiderare di vivere in tranquillità, senza
paura. E lui di paura non ne ha e non ne ha mai avuta, fin dai tempi di
Occidente, quando i terroristi neri l’avevano messo nel mirino. E a
maggior ragione non ne ha ora, quando, nell’esprimere lo sconcerto e i timori
di tanta gente, ha in cuor suo il desiderio che il futuro della propria
discendenza non venga minacciato.
La paura comunque c’è, è la paura di
chi si accorge che l’illegalità è ovunque e che prende il sopravvento (Fa
l’architetto / vive da solo, / e dopo tredici ore / di lavoro / torna nel
cuore / della notte per buttarsi a letto. / Apre la porta come un automa, /
accende la luce e la mano gli trema: / c’è un altro a letto, con la faccia
truce, / dorme pesante, un sonno da coma. /…).
Come è possibile notare non si
tratta di prosa, ma di poesia, il terzo libro di versi frutto dell’arte di
Camon, e allora c’è da chiedersi come mai sia ricorso a questa forma per
partecipare agli altri questo tema così contingente. Credo che stante la
quotidianità di un crescente problema e l’acuirsi di una situazione che da
disagio sta diventando paura l’autore padovano abbia ritenuto, secondo me
giustamente, di comunicare con maggiore immediatezza, e per l’appunto in
proposito non c’è nulla di più efficace della poesia. Del resto, fra le
diverse liriche, ce n’è una che penso ben esprima il concetto; può sembrare un
eccesso, ma non è un caso isolato e appunto per questo nei quotidiani passano
eventi simili dalla prima pagina (quando sono novità) alla terza o alla
quarta; la riporto per intero, si intitola Battaglia primordiale: “Padova,
via Anelli: / a sirene spiegate, frena, balza, / la polizia arriva sulle Alfa
/ con scudi e manganelli, / dalle case escono tribù / di senegalesi e
nigeriani / mezzo nudi, bastoni fra le mani / con movenze di kung-fu; /
i poliziotti suonano le trombe / per fare i duri / dalle finestre rullano i
tamburi / e piovono sassi come bombe. / La gente si ferma incantata: mai visto
/ uno scontro del genere. / Chi vincerà, il prima o il dopo Cristo?”.
Certo la gente prima dimostra
stupore, poi disagio e infine paura, una paura del diverso, tanto che basta
che uno abbia la pelle un po’ scura per diventare un potenziale criminale. Ed
è così che piano piano si passa dalla ideale integrazione alla reale
fagocitazione, perché se scompare la nostra civiltà non saremo più nulla, né
per gli altri, né soprattutto per noi stessi. E di questo non hanno colpa i
magrebini, i fondamentalisti, no, la colpa è solo nostra, di avere abdicato un
po’ per volta ai nostri valori, di esserci spogliati delle nostre tradizioni,
di essere diventati indifferenti a quanto più di sacro e importante abbiamo da
coltivare e difendere: le nostre comuni radici.
E il titolo? E’ quello di una
poesia della raccolta, in cui al ritorno delle volpi, ai danni che provocano,
soprattutto ai pollai, si accompagna la reazione dei contadini, nonostante la
protezione che il governo ha concesso a questi carnivori; sembrerebbe poco
attinente al tema della silloge, ma si può anche interpretare come un invito
all’autotutela nei confronti di certe categorie di immigrati, di quelli
completamente indifferenti alle nostre leggi e che mirerebbero a sovvertire
l’ordine esistente, facilitati da leggi che tendono a proteggere chi entra nel
nostro paese, e ciò indipendentemente dalla sua eventuale pericolosità
sociale.
Leggete queste poesie, questo monito
di un artista che non ha mai avuto paura, ma che sempre si è adoperato perché
fossero eliminati i motivi della paura stessa; la nostra civiltà, benché ormai
sbiadita, non è ancora morta, facciamo sì che possa continuare a vivere.
Ferdinando Camon
Il primo romanzo di Camon uscì in Italia con una appassionata prefazione di
Pier Paolo Pasolini e fu subito tradotto in Francia per interessamento di
Jean-Paul Sartre. Camon si definisce “narratore della crisi”: ha raccontato la
crisi e la morte della civiltà contadina (nei romanzi “Il Quinto Stato”, “La
vita eterna”, “Un altare per la madre”, premio Strega, “Mai visti sole e
luna”, nelle poesie “Liberare l’animale”, premio Viareggio, e “Dal silenzio
delle campagne”), la crisi che si chiamò terrorismo (“Occidente”), la crisi
che porta in analisi (“La malattia chiamata uomo”, “La donna dei fili”, “Il
canto delle balene”) e lo scontro di civiltà, con l’arrivo degli
extracomunitari (“La Terra è di tutti”). “La malattia chiamata uomo” fu
recitata a Parigi al teatro L’Aquarium per 4 anni consecutivi. Il regista
Claude Miller ne ricavò un film. Camon ha lavorato nel primo Centro
Anti-Droga, che aveva sede a Padova, e l’ha raccontato nel libro “La droga
discussa con i ragazzi”. I suoi romanzi più recenti sono “La cavallina, la
ragazza e il diavolo” e “La mia stirpe”. È tradotto in 25 paesi. In Francia,
Gallimard ha tradotto tutte le sue opere in prosa e in versi. Nel 2020 è
uscito il suo “Dialogo sul Comunismo” con Pietro Ingrao, che Ingrao aveva
bloccato per 25 anni. Ed è uscito il pamphlet “A ottant’anni se non muori
t’ammazzano”, contro l’opzione di non curare i malati troppo anziani. Nel 2022
Apogeo ha ripubblicato “Occidente” nella stesura definitiva. Le sue opere sono
pubblicate anche in edizioni per ciechi, in Italia e in Francia. Nel 2016 sono
state raccolte in 16 ebooks e gli è stato assegnato il premio Campiello alla
Carriera. Dal 2021 è in corso la pubblicazione delle sue opere in forma di
audiolibri presso la casa editrice Il Narratore; sono già usciti 4 audiolibri.
Renzo Montagnoli
5 Dicembre
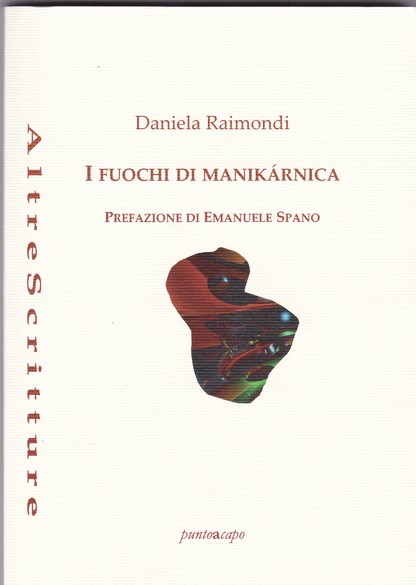
I fuochi di Manikarnica
di
Daniela Raimondi
puntoacapo
edizioni
Poesia
Il viaggio
Manikarnika è uno dei luoghi più antichi di cremazione esistenti in India e si
trova lungo il Gange a Varanasi. E’ quindi spiegato il titolo di questa
raccolta e pertanto c’è da chiedersi che cosa sia I fuochi di
Manikarnica: è forse un libro sulla morte? Anche. E’ magari un libro
sulla vita? E anche è la mia risposta. In realtà I fuochi di Manikarnica
è un’opera sul viaggio, o meglio ancora sui viaggi, ma al di là del fatto che
effettivamente si parla di diverse località, non si tratta solo di percorsi
turistici, perché ci sono viaggi intesi come migrazione, come scoperta. Al
riguardo ci sono alcuni capitoli di cui accennerò in seguito che risultano
piuttosto chiarificatori di ciò che ho appena scritto. Invece il viaggio al
singolare diventa una metafora, quella della vita, un percorso che per ognuno
di noi va dall’alba al tramonto, con tutte le situazioni in cui ci si imbatte,
con tutte le esperienze che si acquisiscono. Ed è proprio a Manikarnica che
esemplarmente c’è il punto in cui si incontrano la nascita e la morte, con
quei poveri corpi che sono affidati alla funzione purificatrice del fuoco.
Così i roghi diventano l’estremo saluto, il passaggio dall’entità solida e
ormai inerte a quella divina, una morte che genera una nascita.
Questo in
India, però, è solo uno dei viaggi della raccolta, perché ci sono anche gli
altri, come per esempio la scoperta dell’America, l’esplorazione avventurosa
di Cristoforo Colombo, e sempre verso l’America ci sono in navigazione i
bastimenti che portano i nostri poveri emigranti, quelli che volentieri
abbiamo dimenticato, quasi fossero una vergogna nazionale, allorché si tratta
di osteggiare gli africani che fra mille insidie e pericoli arrivano via mare
in Italia. Al riguardo, per quei nostri sventurati compatrioti che partivano
per l’ignoto, ci sono versi che non possono lasciare indifferenti, come la
Preghiera dell’addio: “Ce ne andremo un mattino d’inverno / nei piedi
il peso della seta / e nelle mani una valigia vuota. / Cammineremo spinti dal
vento / lasciandoci dietro tre ciglia sul cuscino, / l’odore aspro della terra
e del sudore. / Partiremo soli / l’ultimo sguardo in fondo al giardino, / un
ritratto premuto contro il petto. / Ma ugualmente andremo, dicendo: /
“!Salvaci, Padre / dalla mancanza della felicità, salvaci da tutti i sogni /
che abbiamo lasciato morire. / Togli dalle nostre bocche il tuo pane malato /
e portaci verso cieli più miti, / il corpo a brillare fra i papaveri / e con
il bene dentro.”
E’ una
preghiera che è frutto della disperazione, struggente, un addio alle proprie
radici in quel passo verso l’ignoto.
La
raccolta, come ho accennato, consta di diversi capitoli : Terra promessa
(L’esodo ebraico), America (La scoperta), Emigranti (I nostri), Mare Nostrum
(Immigrati), Circolo Polare Artico (Esplorazioni), Sanskrit (india), I fuochi
di Manikarnica (Riti della cremazione in India), Africa (Corrispondenza con
mia figlia).
Avrei
dovuto parlare di tutte le parti dell’opera, ma mi sono limitato a quelle
delle cremazioni e delle migrazioni, sia per motivi di spazio, sia perché mi
sono particolarmente care; infatti mi trovo in totale sintonia con i loro
contenuti, in quanto uniscono a un tema sempre valido, quello dell’esistenza,
un altro attuale che abbiamo continuamente sotto gli occhi, perché le
migrazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Nessuno può impedire a un
essere umano di poter mettersi in cammino per sfuggire alla fame o alle
guerre, o a entrambe, così che quel percorso intrapreso diventa il viaggio nel
viaggio della vita.
Se i temi
trattati poeticamente sono di particolare interesse non va sottaciuta
l’ecletticità dell’autore, capace di spaziare da tematiche religiose ad altre
civili, con una capacità di attrazione che finisce con il coinvolgere il
lettore. E’ così che si ritrae l’impressione di essere a New York, a Ellis
Island, in attesa dello sbarco di quei miseri in cerca di un futuro migliore
ed è sempre così che si finisce con l’essere partecipi dei riti in riva al
Gange, affascinati dai contrasti di una terra che è patria dello spirito e
ristoro dell’anima.
Da
leggere, lo merita.
Daniela Raimondi è
nata in provincia di Mantova e ha trascorso la maggior parte della sua vita in
Inghilterra. Ora si divide tra Londra e la Sardegna.
Ha pubblicato dieci libri
di poesia che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali. Suoi
racconti sono presenti in antologie e riviste letterarie. La
casa sull’argine,
edito da Nord, è il suo primo e, al momento, unico romanzo.
Renzo Montagnoli
28 Novembre

Mario Rigoni Stern.
Un ritratto
di
Giuseppe Mendicino
Laterza
Editori
Biografia
La
biografia
E’
notorio che Giuseppe Mendicino è il maggior conoscitore delle opere di Mario
Rigoni Stern, una conoscenza che si è estesa anche all’autore, grazie alle
frequentazioni avute, a quei contatti personali che sono più esplicativi di
qualsiasi testo, perché spesso è guardandosi negli occhi che si può capire
meglio e avere la possibilità di chiedere eventuali chiarimenti.
Di
conseguenza chi avrebbe potuto scrivere una biografia, anzi la biografia,
perché questa è ormai un riferimento con cui confrontarsi quando si vuol
parlare di Rigoni Stern, meglio di Giuseppe Mendicino? Nessuno, perché con la
scomparsa del narratore di Asiago non c’è più da tempo l’opportunità di un
colloquio franco e diretto con colui che è oggetto del lavoro.
Qualcuno
potrà obiettare che non è difficile scrivere della vita di Rigoni Stern visto
che quasi tutte le sue opere parlano della sua esistenza, dalla nascita ad
Asiago fino all’ultimo periodo prima della dipartita. E anche quelle che
sembrano estranee a questa regola – mi riferisco a Storia di Tönle e a
L’anno della vittoria – sono frutto di ricordi di storie raccontate dal
nonno e dai genitori quando Mario era bambino. Sì, non è difficile scrivere la
biografia di questo grande narratore proprio per il motivo che ho appena
esposto e sempre per lo stesso motivo però è difficile, in quanto
raccapezzarsi, dare una continuità temporale logica rappresenta una sfida
visto che Stern non ha avuto, almeno fino alla fine degli anni ‘50, una vita
quieta, perché è passato per una guerra in cui è stato testimone e
protagonista di tanti eventi. E poi, nel parlare di un autore, se dire della
sua vita ha un senso, visto che la sua produzione la ricalca, è anche
indispensabile porre l’accento sulle sue caratteristiche di uomo, che in
questo caso si riflettono completamente nel Rigoni narratore. Da ciò risalta
l’amore per la natura, la consapevolezza di esserne un umile parte e proprio
per questo il profondo rispetto per la stessa. Per Mario Rigoni Stern non
esistono alberi, ma gli alberi, cioè vegetali con proprie caratteristiche che
oserei quasi definire personalità, così come gli animali non sono solo esseri
viventi di rango inferiore, sono creature da amare. E questo amore viscerale
per la natura si riscontra in tutte le sue pagine, anche quelle tragiche, come
nel caso della ritirata in Russia durante la quale, nonostante le difficoltà,
il freddo, la fame, la sofferenza riesce a trovare anche il tempo di ammirare
queste enormi distese di neve, una neve che richiama alla memoria quella del
suo altopiano. Non è che amando vegetali e animali sia però insensibile nei
confronti degli uomini, dei suoi alpini che con sacrificio ha riportato a
baita e di quelli che sono rimasti a dormire un sonno eterno nella steppa.
Credo che per chi non ha mai letto nulla di Rigoni Stern, prima di passare ai
romanzi e alle raccolte di racconti, sia di grande aiuto questa splendida
biografia, perché è come ritrarre un’idea di quello che poi avrà il piacere di
visionare, una sorta di guida che finisce con l’essere un invito ad accostarsi
a questo grandissimo scrittore che ci ha lasciato nel 2008.
Da
ultimo, in ordine cronologico e non di minore importanza, ci sono tre brevi
saggi dell’autore; rappresentano una sintesi di quello che è stato, sia a
livello letterario che personale, Mario Rigoni Stern. Troviamo così L’
Altipiano dei Sette Comuni e altre montagne, un affresco sul rapporto fra
il narratore veneto e le nostre Alpi, Tra Col del Vento e Pian di Leguna,
sulle tracce di Breve vita felice, dove Breve vita felice è un racconto
che fa parte della raccolta Amore di confine, una prosa che riproduce
un fatto veramente accaduto e per certi aspetti struggente, e infine quello
che costituisce un ritratto di rilevante spessore, cioè L’etica civile di
Mario Rigoni Stern, che fa ben comprendere la grandezza di un uomo che
nulla fece per essere grande, perché lo era per sua natura.
Giuseppe Mendicino è
considerato il maggior esperto dello scrittore Mario Rigoni Stern. Con Laterza
ha pubblicato Mario Rigoni Stern. Un ritratto (2021).
Ha redatto la voce Mario Rigoni Stern del Dizionario Biografico degli Italiani
(Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani) ed è autore di Mario Rigoni
Stern. Il coraggio di dire no (Einaudi, 2013), Mario
Rigoni Stern. Vita, guerre, libri (Priuli & Verlucca, 2016), Portfolio
alpino (Priuli & Verlucca, 2018) e Nuto Revelli.
Vita, guerre, libri (Priuli & Verlucca, 2019). È socio accademico del
GISM (Gruppo italiano scrittori di montagna) e collabora con le riviste «Doppiozero»
e «Meridiani Montagne».
Renzo Montagnoli
21 Novembre
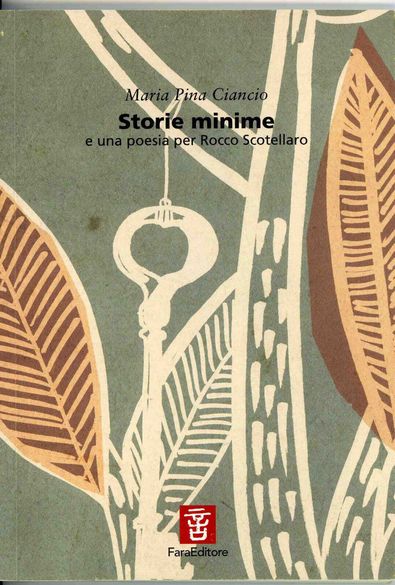
Storie minime
e una poesia per Rocco Scotellaro
di Maria
Pina Ciancio
Fara
Editore
poesia
Un canto
per il Sud
Le storie
delle proprie origini mi hanno sempre incantato, con le descrizioni di paesini
che stanno legati alla terra con la forza della disperazione perché poco a
poco si spopolano, avari, prima ancora che di vita, di lavoro. Si trovano
soprattutto nel Sud, un meridione che nella sua sventura di essere madre
ingrata dei figli mantiene la sua dignità e che così bene ha cantato nella sua
pur breve vita Rocco Scotellaro. Più recentemente mi hanno affascinato i versi
di Vincenzo D’Alessio, un caro amico purtroppo già scomparso. Ed ecco che
allora si spiega il mio interessamento per questa raccolta di Maria Pina
Ciancio, poetessa nata in Svizzera, ma poi ritornata nei luoghi delle sue
radici, in Lucania.
Anche lei
canta la disperazione di chi è costretto ad andare, dell’emigrante che, povero
fra i poveri, si mette su un treno sperando in un futuro migliore, con tutto
il dolore che può provare chi è costretto a lasciare la sua terra (Evaporano
i sogni e dentro i sogni / la storia di mio padre / quella di valigie di
cartone cotte al sole / trascinate a mani strette / dentro vagoni neri di
carrubi / e sguardi claudicanti aggrappati al finestrino / …). Sono versi
quasi sussurrati, nonostante la passione che l’autore riesce a stento a
contenere; non ci sono toni enfatici, c’è una malinconia di fondo che stringe
piano piano la gola come un cappio e che impedisce alla voce di uscire, di
gridare trasformando il dolore in rabbia per una sorte che è una condanna
originaria.
Ritrovo
in questi versi lo struggente amore per le sue genti di Rocco Scotellaro, il
poeta sindacalista verrebbe da definirlo certamente non sbagliando, ma prima
di tutto acuto osservatore di una realtà immutabile che sembra senza tempo. In
questo migrare, che porta i corpi lontano, ma con le anime che cercano di non
disancorarsi da quel piccolo mondo ingrato in cui si è cresciuti, si nota
implacabile lo spaesamento ( Lo spaesamento, ecco
cos’è: / un tempo in cui le mani non sanno più/ se stringersi a pugno / o
fermarsi / distendersi a ramo sul cuscino). E’ così che si va con la
lacerazione dentro, mentre c’è chi resta, straziato dalla rassegnazione, in un
palcoscenico i cui attori recitano la commedia della vita con i loro
tradizionali riti, legati ad antichi valori, in cui ritrovano, nel dolore di
vivere, il coraggio per vivere.
E’ indubbio l’amore di Maria Pina Ciancio per la sua terra, i versi delle sue
poesie sono palpitanti, sgorgano dritti dal cuore, si fanno immagine e
atmosfera, rivelano la ricchezza di un sentimento inalienabile.
In questo quadro mi pare logica una poesia dedicata a Rocco Scotellaro, di cui
ebbi a scrivere, recensendo Tutte le poesie 1940 – 1953, il suo tratto
distintivo e cioè che “ Mai fu più intensa una così breve vita” . Lo
scopo è di renderne il ricordo imperituro e con la memoria del poeta i suoi
palpitanti versi, il suo amore per questa terra, per gli uomini che la
calpestano e che rimangono nonostante tutto, per quelli che la lasciano con il
desiderio di ritornavi già quando partono.
(…/
Se non ti
addormenti figlio posso raccontarti la storia di un poeta che morì a
trent’anni e che a venti era già giovane Sindaco di paese con il cuore rosso e
l’anima di un padre. / …).
Nella semplicità che caratterizza tutta la silloge in questi pochi versi c’è
tutta la vita di Rocco Scotellaro e più avanti c’è la speranza, mai sopita, di
un mondo nuovo, più giusto, più equo, perché la Lucania, il Sud non resti
sempre così (.../ Ascolta figlio e impara l’amore e le preghiere / non
straziarmi per dimenticanza il cuore / perché vedi, Rocco è tuo fratello
grande / e ogni giorno è sempre nuova l’alba).
La
raccolta ha collezionato diversi premi, ultimo, recentissimo, il primo premio
Poesia minimalista Polverini 2022 e credo che siano tutti più che meritati. Da
parte mia non posso che caldeggiarne la lettura.
Maria Pina Ciancio di
origine lucana è nata a Winterthur (CH) nel 1965. Trascorre la sua infanzia
tra la Svizzera e il Sud dell’Italia, dove attualmente vive coniugando la
passione per l’insegnamento a quella per la poesia e la scrittura. Viaggia fin
da quand’era giovanissima alla scoperta dei luoghi interiori e
dell’appartenenza, quelli solitamente trascurati dai flussi turistici di
massa, in un percorso di riappropriazione della propria identità e delle
proprie radici.
Ha pubblicato testi che spaziano dalla poesia,
alla narrativa, alla saggistica. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo Il
gatto e la falena (Premio Parola di Donna, 2003), La
ragazza con la valigia (Ed. LietoColle, 2008). Suoi scritti e
interventi critici sono ospitati in cataloghi, antologie e riviste di settore.
È presidente dell’Associazione Culturale LucaniArt e su internet cura uno
spazio laboratoriale sul romanzo e la poesia in Basilicata: lucaniart.wordpress.com
Renzo Montagnoli
15 Novembre
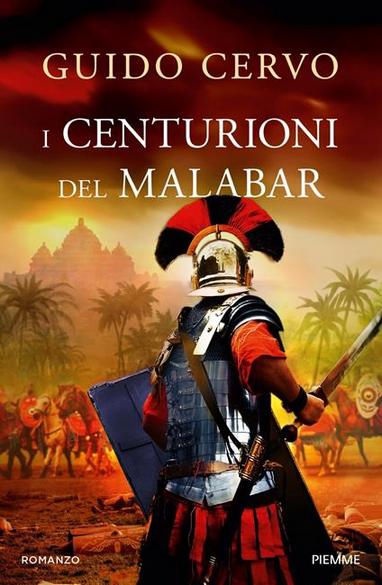
I centurioni del
Malabar
di Guido
Cervo
Edizioni
Piemme
Narrativa
Legionari
romani in India
Ho
cominciato a conoscere come autore Guido Cervo leggendo gli unici due romanzi
che ha scritto sulle due guerre mondiali del secolo scorso (I ponti della
Delizia e Bandiere rosse, aquile nere), poi sono passato alla serie
del Teutone (La croce perduta, La battaglia sul lago ghiacciato
e La setta dei mantelli neri) e stranamente per ultima la serie con cui
il narratore bergamasco ha esordito in campo letterario, quella del Legato
romano (Il legato romano, Il generale di Diocleziano, La
legione invincibile e L’onore di Roma). Ci si chiederà il perché di
questo preambolo e la risposta è molto semplice, perché serve a inquadrare
artisticamente Guido Cervo, uno scrittore che di sicuro si può apprezzare per
il rigore storico su cui innesta la sua creatività, perché in ogni suo romanzo
ci sono, fra gli altri, personaggi esistiti veramente e anche fatti almeno in
parte storicamente accertati. A completare il quadro c’è anche una notevole
capacità di avvincere il lettore, non disgiunta da un uso della lingua
italiana più che corretto. Tutti i suoi lavori mi sono piaciuti e più o meno
tutti mi hanno dato l’identico elevato livello di soddisfazione, insomma per
farla breve Guido Cervo è uno di quegli autori le cui opere si possono
acquistare a scatola chiusa. Questa fiducia trova un’ulteriore conferma in
I Centurioni del Malabar, che all’inizio può lasciare perplesso il
lettore scoprendo che si tratta di una spedizione romana in India. Dico subito
che con ogni probabilità la missione del Tribuno e Legato Imperiale Marco
Terenzio Massimo, con i suoi cinquecento classari (fanti di marina), per
aiutare Nedunj Cheliyan, maharajah di Madurai, è frutto di pura invenzione,
anche se il sovrano indiano è esistito veramente, ma che contatti commerciali
fra Roma e l’Asia meridionale ci siano stati è comprovato, così come si ha
notizie di viaggi di ambasciatori da quei lontani paese alla Caput mundi e
viceversa, e questo aiuta non poco a immergersi nella fantasia della vicenda,
perché in pratica non è tutto campato in aria. Peraltro, in questa trama di
guerre, di intrighi di corte, di battaglie descritte magistralmente, oserei
dire cinematograficamente, ci si avventura nella giungla intricata, nel caldo
umido di quei territori, nelle piogge monsoniche, nei colori esotici
dell’abbigliamento; sono tutte caratteristiche ambientali proprie
dell’India, ma hanno fatto emergere le mie reminiscenze dei romanzi di Emilio
Salgari, con elefanti combattenti, tigri divoratrici di uomini, terribili
serpenti velenosi, un invito al piacere dell’avventura. Le pagine scorrono
veloci, si vive la vicenda, ci si emoziona per i pericoli che gravano sulla
bella Satyavati, consorte del maharajah, si trepida durante la battaglia
finale per la sorte dei legionari, si arriva in crescendo all’ultima pagina e
si chiude soddisfatti il libro. Da leggere, non c’è dubbio.
Guido Cervo
(Bergamo, 19 febbraio 1952) vive e lavora a Bergamo,
dove ha svolto la professione di docente di Diritto ed Economia presso
l'istituto superiore "Maironi da Ponte". I suoi romanzi, tutti pubblicati da
Piemme, sono il frutto di ricerche storiche approfondite, che contribuiscono
alla ricostruzione di affascinanti ambientazioni e scenari, teatro di eventi
riguardanti importanti personaggi storici, cui si intrecciano trame nate dalla
fantasia dell'autore. Attualmente risultano pubblicate le seguenti opere: Il
legato romano (2002), La legione invincibile (2003), L’onore di Roma (2004),
Il centurione di Augusto (2005), Il segno di Attila (2005), Le mura di
Adrianopoli (2006), L’aquila sul Nilo (2007), I ponti della Delizia (2009), La
croce perduta (2010), La battaglia sul lago ghiacciato ( 2011), La setta dei
mantelli neri (2013), Bandiere rosse, aquile nere (2016), Il generale di
Diocleziano (2020).
Renzo Montagnoli
9 Novembre
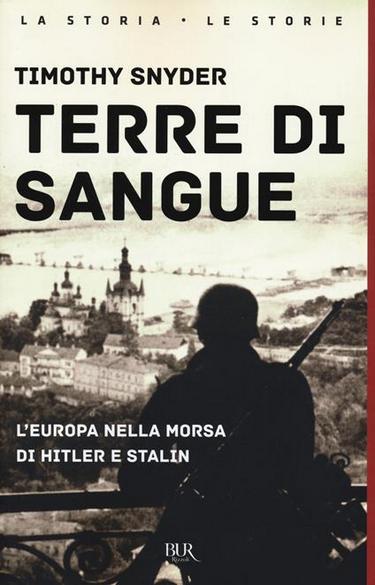
Terre di sangue.
L'Europa nella morsa di Hitler e Stalin
di
Timothy Snyder
Rizzoli
Saggistica storica
Un buon saggio storico
Leggi una
pagina, ne leggi un’altra e cominci a sentire una fitta dentro, come se tutto
il tuo corpo si ribellasse, come se tutto il tuo essere non potesse sopportare
quell’orrore che lì è stampato, che è frutto del lavoro di uno storico
americano, ma che non è invenzione, è solo drammaticamente vero.
Le terre
di sangue sono esistite veramente, non con questo nome, perché si tratta di
territori dell’Europa centro-orientale, fra cui l’Ucraina, la Bielorussia, la
Polonia, gli stati baltici, dove fra il 1940 e il 1943 sono divampate le
scellerate politiche sanguinarie di Hitler e di Stalin, sono le zone nelle
quali questi due regimi dittatoriali hanno maggiormente sfogato la loro innata
malvagità contro dissidenti, ma soprattutto contro inermi popolazioni. A
questo bagno di sangue aveva dato inizio già negli anni 1932 – 1933 Stalin
affamando i contadini ucraini che si opponevano alla forzata
collettivizzazione dell’agricoltura; in questo caso non dovette nemmeno
spendere per le munizioni, perché fra gli abitanti dell’Ucraina, privi di ogni
sostegno alimentare, ci fu un numero altissimo di vittime, non esattamente
quantificabili, ma che studi condotti con raziocinio fanno ascendere
all’incirca a quattro milioni. In pratica morirono di inedia intere famiglie,
uomini, donne e bambini, molti impazzirono e non furono rari i casi di
cannibalismo. Con l’Holodomor, così gli ucraini chiamarono questo genocidio,
si aprì quella mattanza che fece scomparire in quelle zone ben più di dieci
milioni di persone, come per esempio gli ufficiali polacchi assassinati dai
Sovietici, i corpi dei quali furono ritrovati nelle fosse di Katyn. Da quel
1932 iniziò un flusso e riflusso di sangue che accompagnava le avanzate e le
ritirate di tedeschi e russi. Lo studio di Snyder è stato condotto bene, non
si può non apprezzare la sua meticolosità, la sua completezza che
restituiscono un senso di angoscia nel leggere degli eventi, del numero delle
vittime, della ferocia di belve assetate. L’autore è riuscito a dimostrare
come i due regimi totalitari, quello nazista e quello sovietico, abbiano
compiuto la stessa tipologia di reati, peraltro nello stesso periodo e negli
stessi luoghi, comportando così un numero di vittime assai superiore a quello
che sarebbe risultato se invece avessero proceduto singolarmente e in epoche
diverse. Se lo scopo del libro è stato raggiunto, occorre tuttavia tener conto
di alcuni elementi non proprio positivi, fra i quali, soprattutto, la grevità
dell’esposizione che rischia di travolgere il lettore e la mancanza di
indispensabili approfondimenti per fatti di rilevante importanza, quali per
esempio la firma del famoso patto Molotov-Ribentropp, oppure la decisione di
Hitler di accelerare lo sterminio degli ebrei nel momento in cui capì che non
avrebbe potuto vincere la guerra con L’Unione Sovietica.
Nel
complesso direi che Terre di sangue è un buon saggio e porta
avanti una tesi innovativa foriera di possibili ulteriori approfondimenti; non
posso però considerarla un’opera fondamentale per i motivi che ho sopra
esposto, restando comunque un contributo non trascurabile per conoscere i
fatti di una determinata epoca.
Timothy David Snyder,
nato il 18 agosto 1969, è uno storico, scrittore e accademico specializzato
nella storia dell'Europa orientale e delll' Olocausto.
Tra i suoi libri, Il
principe rosso (Rizzoli, 2009), Terre
di sangue. L'Europa nella morsa di Hitler e Stalin (Rizzoli,
2011), Novecento. Il secolo degli intellettuali e
della politica (Laterza, 2012), Terra
nera. L'Olocausto fra storia e presente (Rizzoli,
2015) e Venti Lezioni (Rizzoli,
2017), La paura e la ragione. Il collasso della
democrazia in Russia, Europa e America (Rizzoli
2018).
Renzo Montagnoli
3 Novembre
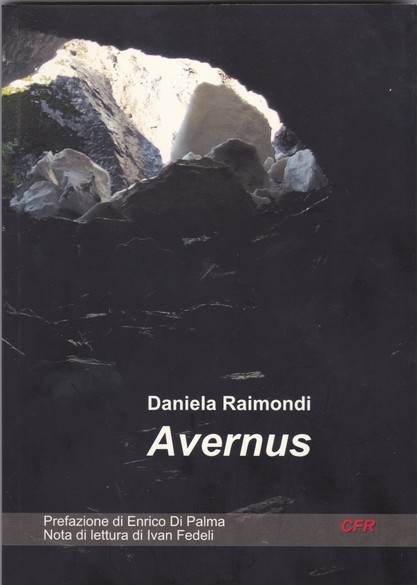
Avernus
di
Daniela Raimondi
Prefazione di Enrico Di Palma
Nota di
lettura di Ivan Fedeli
CFR
Edizioni
Poesia
Il prima
e il dopo
Il titolo
di questa silloge fa pensare immediatamente al regno degli Inferi, proprio
della mitologia latina, ma è una supposizione errata, perché non si parla di
un viaggio nell’oltretomba; secondo me il vero significato è quello di
inferno, l’inferno che deve passare in vita una persona la cui morte è
annunciata e quella persona è il padre della poetessa. E’ così che abbiamo un
diario in versi dell’ultimo periodo su questa terra di un essere umano, con le
sensazioni, il timore l’angoscia di chi è presente e lo assiste, vale a dire
Daniela Raimondi e gli altri familiari stretti. E’ una forma originale di
raccontare, scandita dagli eventi, dalle fasi, fino al momento fatale, ma c’è
anche il dopo, c’è quel ripensare a chi ci ha lasciato nella lenta
attenuazione del dolore per la scomparsa di una persona cara.
Il vero
lutto non fu la sua morte. Non fu nemmeno la sua / assenza. Fu sapere che la
sua vita finiva: vivere i giorni del corpo / malato, condividere l’agonia.
/...
E’ questa
parte della prima poesia di questa raccolta e credo non ci sia bisogno di
spiegazioni, anche perché molti di noi hanno vissuto questi periodi
angoscianti, attoniti per l’impossibilità di porre rimedio e per poter lenire
le sofferenze. Daniela Raimondi l’ha provato con il padre, io con mia madre.
Dalla scoperta della malattia alla morte i versi scandiscono questa fase
(.../ “Cos’ha, Dottore?” / Mi ha detto del tumore. L’impossibilità di operare
o di curare. / “Quanto tempo gli resta?” - La mia voce era ferma. 7 “Bisognerà
fare altri esami, ancora non sappiamo.” - Ha risposto. / Me lo ha detto a
occhi bassi. Sapevo che mentiva.) (.../ Passo la notte seduta accanto a te nel
Reparto Geriatria. / Sento le battaglie di chi lotta per raggiungere la fine:
/ l’eco dei lamenti, il pianto di un vecchio, i passi di un’infermiera. /
Un malato bestemmia. / Un telefono squilla. /…) (.../ C’era un letto. /
Disteso nel bianco il corpo di uno scon0sciuto. / Un involucro di carne. / Il
faraone con le mani incrociate sul petto. / Immobile. / …).
Non tutto
finisce con la morte, anzi comincia per chi resta. Nell’inconscio tentativo di
assimilare il dolore ciò che si nota è quello che non c’é, è l’assenza, ma si
deve tornare a vivere (Poi è tornata la calma, la fame, la noia. / Si è
dovuto vivere. Si è dovuto tornare a camminare nel mondo. / Dimenticare la
nebbia. Muoversi di nuovo insieme ai vivi, ai cani, / le formiche, i motorini
rossi).
Se nel
periodo dell’agonia il dolore di chi assiste impotente è angoscia senza fine,
dopo c’è la sofferenza per l’assenza e per la memoria dei giorni dei giorni
di attesa per un evento irrimediabile; sono segni incisi nell’anima che con la
quotidianità si cerca di celare, ma sono lì, sempre pronti a uscire, a
reclamare la tua attenzione, e così basta una data, un ricordo, un’immagine e,
benché non più così violento, riaffiora il dolore.
Si cerca
di porre rimedio pensando ai momenti che furono lieti, ma molto più spesso
prepotenti ritornano le ore d’angoscia, l’impossibilità di portare un concreto
aiuto, le menzogne anche che sono state necessarie per cercare di dare un po’
di sollievo al malato.
Il
ricordo è uno sfogo, ma anche la condanna di chi resta.
Daniela Raimondi è nata in provincia di
Mantova e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Inghilterra. Ora si
divide tra Londra e la Sardegna.
Ha pubblicato dieci libri di poesia che hanno ottenuto importanti
riconoscimenti nazionali. Suoi racconti sono presenti in antologie e riviste
letterarie. La casa sull’argine, edito da Nord, è il suo primo e, al
momento, unico romanzo
Renzo Montagnoli
28 Ottobre

Viva Migliavacca!
e altri 12 racconti
di Piero
Chiara
Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A.
Narrativa
Una piacevole raccolta
Piero
Chiara, se non scrisse molti romanzi, tuttavia diede alle stampe parecchi
racconti, dimostrando così che la prosa breve gli era particolarmente gradita.
E’ anche questo il caso di Viva Migliavacca! e altri 12 racconti,
tredici piccole perle, molto variegate. Si va dal primo racconto, Con
quel naso, una storia boccacesca, con un risvolto malinconico,
all’ultimo, Viva Migliavacca!, che è sostanzialmente una parodia
di un capitalismo estremizzato, in cui l’uomo che si fa da sé, accumula
ricchezze e potere, si illude di poter disporre della propria vita e del suo
destino. Fra gli altri ne troviamo in cui è presente una nota satirica,
talvolta dolente, come in Il martire che prende spunto
dall’omicidio non per motivi politici di un giovane fascista, che il regime fa
diventare un martire, con il padre costretto a piangerlo solo in privato,
perché nelle cerimonie pubbliche deve continuare a ricordarlo senza lacrime;
ci sono però anche quelli in cui predomina una malinconia di fondo per i fatti
della vita che sembrano congiurare contro chi ne ha tratto sofferenza, come
nel caso di E’ tornato Gaudenzio, il ritorno a casa di un reduce
dalla prigionia in Germania, dove si ritrova in un natio paese così diverso da
prima, beneficato in verità dal signor Gino, un imprenditore la cui generosità
non è senza tornaconto e che, fra l’altro, è diventato l’amante della moglie.
In genere
i racconti sono tutti azzeccati, anche se ovviamente ce ne sono di diversa
qualità – ma comunque sempre di buon livello – e poi c’è quello in cui Chiara
eccelle ed è Un colpo di fucile, per il quale desidero spendere
qualche parola in più. Infatti la creatività che vi è profusa ha quasi
dell’incredibile; la vicenda è intricata, il personaggio chiave, Giacinto
Rimoldi, soprannominato il “Cudegoma” per via della sua sagoma elefantesca e
dell’eccessiva grossezza dei suoi quarti posteriori, è uno di quelli che non
si possono dimenticare, un uomo veramente “tuttofare”.
Insomma,
questi tredici racconti riflettono le caratteristiche del loro autore ormai
maturo come tale e come uomo, con i sentimenti attenuati, un velo di
malinconia che consente un certo distacco (non troppo, però) nel narrare le
vicende e un apparente continua ricerca dei risvolti delle storie, come se
fossero un divenire continuo a cui appassionarsi al pari del lettore ansioso
di sapere come andrà a finire.
Piero Chiara nacque a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i
più amati e popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi,
quasi cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo,
conterraneo e grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie
che Chiara amava raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori,
1962), che segna il suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara
scrisse con eccezionale prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.
E' stato autore particolarmente fecondo e fra le sue numerose pubblicazioni
figurano Il piatto piange (1962), La spartizione (1964), Il
balordo (1967), L'uovo al cianuro e altre storie (1969), I
giovedì della signora Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La
stanza del Vescovo (1976), Il vero Casanova (1977), Il cappotto
di Astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Vedò Singapore? (1981), Il
capostazione di Casalino e altri 15 racconti (1986).
Renzo Montagnoli
23 Ottobre

Enchiridion celeste
poesie
di Alessandro Ramberti
Fara Editore
Poesia
Non arrendersi mai
Il primo
problema che ho dovuto affrontare nel leggere questa raccolta è stato il
titolo, per me del tutto incomprensibile. Qualcuno potrà dire che è una parola
greca, ma a suo tempo purtroppo ho studiato solo il latino, e non anche il
greco. E allora mi sono dato alle ricerche, in Internet, e così ho appreso che
è un manuale ed è anche il titolo di uno scritto di filosofia e di etica
stoica dello scrittore greco-romano Arriano. E quel celeste perché c’è? Il
manuale potrebbe essere di qualsiasi colore, ma perché proprio celeste? Ci
penserò, perché può darsi che nel corso di lettura arrivi la risposta.
Si diceva
del manuale e di che si tratti si capisce abbastanza facilmente, in pratica
sono consigli su come accettare con serenità i dubbi e i timori che sono
insiti nella strada della vita che percorriamo. Senza con questo fornire un
modo di comportamento, anche perché tanti, anzi troppi sarebbero i casi, verso
dopo verso, pur apprezzando l’opera, ho in me quel tarlo che reclama, dapprima
lieve, e poi a viva voce, il motivo di quel celeste. Quasi a indispettirmi
devo arrivare quasi in fondo per scoprirlo, perché dopo una prima parte
intitolata “Idilli” ne viene una seconda, che nemmeno a farlo apposta
l’autore ha classificato come “Piccolo manuale per abbracciare il cielo”.
Devo tuttavia riconoscere che, considerando il notorio spirito religioso di
Alessandro Ramberti, avrei dovuto capire subito, ma allora come avrei potuto
leggere anche con l’interesse di chi sta cercando una risposta le poesie che
compongono la raccolta? Non avrei potuto forse apprezzare nella giusta misura
“Nel bosco” ( Un tuono mi richiama / risalgo dal torpore / mi aggrappo a
delle immagini / la luna sul sentiero / il rumore dei sassi / un niente di
respiro.) che non sono solo versi con cui si descrive un aspetto della
natura, ma sono il risvolto intimistico di una visione che va oltre la realtà,
una sensazione di un’immagine che si vede più con il cuore che con gli occhi.
C’è
sempre nell’uomo quell’ansia di correre, di fuggir via non si sa da cosa, di
leggere a raffica le poesie, di trovarsi poi all’ultima sera con in mano solo
un pizzico di fredda cenere, è in fondo un passar via per non affrontare i
dubbi e i timori della vita, e invece c’è sempre una via di fuga e siamo noi a
doverla cercare, un percorso che non è senz’altro facile, ma che ci fortifica,
ci rende uomini, dà un senso a un’esistenza che da grigia può diventar
celeste.
Da
leggere, non c’è dubbio.
Alessandro Ramberti
(Santarcangelo di Romagna, 1960) laureato in Lingue orientali a Venezia,
master (UCLA) e dottorato (Roma Tre) in Linguistica, ha pubblicato in prosa: Racconti
su un chicco di riso (Pisa,
Tacchi 1991) e La
simmetria imperfetta con lo pseudonimo di Johan Haukur Johansson (2022). Con la poesia Il
saio di Francesco ha
vinto il Pennino d’oro al Concorso Enrico Zorzi 2017. Le più recenti raccolte
di versi sono: Vecchio
e nuovo (2019), Faglia (2020) e Medèla (2021).
Renzo Montagnoli
16 Ottobre
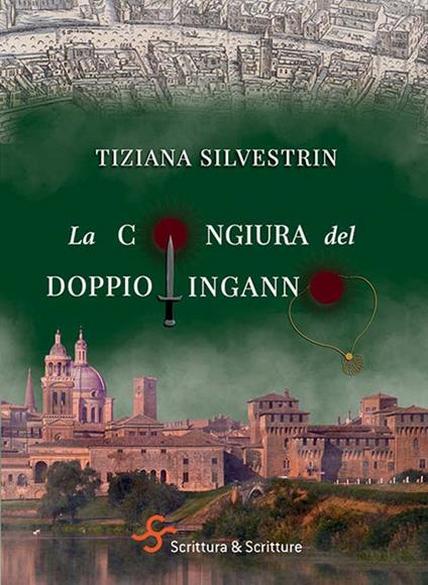
La congiura del doppio
inganno
di
Tiziana Silvestrin
Scrittura
& Scritture Edizioni
Narrativa
Fra Mantova
e Venezia
Era da un
po’ di tempo che non avevo l’occasione di incontrarmi con Biagio dell’Orso,
per l’esattezza dalla fine dell’inverno del 2019 quando ho avuto il piacere di
leggere La profezia dei Gonzaga, quinto episodio con protagonista il
capitano di giustizia più affascinante della storia italiana del Cinquecento.
Poi c’è stato un periodo di silenzio e probabilmente anche il Covid ha avuto
il suo peso, ma finalmente quest’anno ha fatto la sua comparsa nelle librerie
il sesto episodio, un intricato giallo frutto, come i precedenti, della
fantasiosa penna di Tiziana Silvestrin. Dopo quasi quattro anni dall’ultima
lettura devo dire che mi sono accostato con emozione a La congiura del
doppio inganno, a testimonianza che a tanto è arrivata la capacità
dell’autore di fidelizzare i suoi lettori. Del resto il protagonista
principale e quelli che possiamo definire coprotagonisti, vale a dire la bella
Rosa, fidanzata di Biagio, e il dottor Donati, consigliere del Duca di
Mantova, sono stati già in origine ben delineati con pochi e sicuri tratti di
penna e a ogni episodio c’è un piccolo tratteggio, a beneficio di chi per la
prima volta si accosta a questa fortunata serie di gialli storici.
Questa
volta il thriller è particolarmente intricato perché il capitano di giustizia
indaga sull’uccisione di due sorelle, avvenuta a Mantova in due giorni diversi
anche se molto vicini. Purtroppo, per proteggere Rosa dalla vendetta di alcuni
sicari che Biagio ha perseguito, si preferisce allontanarla da Mantova
mandandola a Venezia nella sua locanda, seguita a breve dal fidanzato che ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico di capitano di giustizia, con suo
grande dispiacere tanto più che è ritornato a Mantova, con la raccomandazione
di un ministro dell’imperatore, l’ex podestà, un pessimo individuo con cui
esiste un conto in sospeso. Anche a Venezia ci sono dei misteriosi omicidi,
gente accoltellata, senza che si sia potuto scorgere l’assassino che lascia
sul luogo del delitto una berretta gialla, copricapo distintivo degli ebrei.
Antonio Mocenigo, Signore della Notte, che svolge un incarico affine a quello
di capitano di giustizia, non sapendo più che pesci pigliare e avuto notizia
che a Venezia c’è un famoso ex investigatore, cioè Biagio dell’Orso, chiede il
suo aiuto. E da lì si dipana una vicenda di grande tensione e particolarmente
avvincente di cui non dico nulla per non guastare il piacere di chi leggerà.
Mi sembra
logico invece anticipare che le indagini di Mantova e Venezia assicureranno i
colpevoli alla giustizia, dopo una serie di colpi di scena particolarmente
azzeccati.
Mi è
piaciuto anche questo episodio, però quando arriva l’ultima riga mi prende
sempre un senso di sconforto, perché temo che non ci possano esserne di
ulteriori, ma poi mi dico che la formula è così ben oliata e che la creatività
di Tiziana Silvestrin è così ben sperimentata che è impossibile non possa
esserci un seguito; è quel che spero ed è anche la raccomandazione che faccio
all’autore.
Tiziana Silvestrin vive
e lavora a Mantova. Entrata a far parte di una compagnia di teatro amatoriale,
inizia a scrivere commedie. Alla passione per la recitazione e per la lettura,
si aggiunge la curiosità per la storia. Quando, con un racconto, vince un
premio letterario, le viene il sospetto che forse può mettere a frutto le sue
ricerche per scrivere gialli storici. Così, mescolando fantasia, storia,
personaggi reali e non, ha scritto I leoni d’Europa (2009), Le righe
nere della vendetta (2011), Un sicario alla corte dei Gonzaga
(2014), Il sigillo di Enrico IV (2017) e La profezia dei Gonzaga
(2018). Tutti pubblicati da Scrittura & Scritture.
Renzo Montagnoli
11 Ottobre

Il medico di campagna
di Honoré
de Balzac
Traduzione di Andrea Zanzotto
Introduzione di Ferdinando Camon
Edizioni
Garzanti
Narrativa
Un mondo ideale
Se le
aspirazioni politiche di Balzac furono deludenti, tanto che non riuscì a farsi
eleggere deputato, miglior fortuna - se non dopo un periodo abbastanza lungo
di magra - ebbe il suo desiderio di diventare uno scrittore di successo; al
riguardo non è difficile vedere un nesso logico fra la mancata carriera
politica e un romanzo scritto nel 1833, Il medico di campagna.
In questo libro profuse tutte le sue idee di una amministrazione pubblica
perfetta immaginando un paese montano, nei pressi di Grenoble, in cui grazie
alle intuizioni e alle scelte del dottor Benassis, medico, nonché sindaco del
villaggio, la popolazione da uno stato di indigenza passa a uno di prosperità,
non solo materiale. Che il sanitario sia una specie di benefattore è
indubbio, tanto più che viene da un’esperienza parigina tutt’altro che
edificabile, per non dire riprovevole, ma l’uomo desidera riscattarsi e vi
riesce pienamente, come ha modo di constatare un vecchio soldato, il
comandante Genestas, giunto fin lì per farsi curare per malanni non ben
precisati. E’ un mondo nuovo quello fondato da Benassis, basato sulla fede e
sul lavoro, in pratica sul cattolicesimo e sul capitalismo. Quest’ultimo è
indispensabile per avviare le prime attività che consentono l’avvio di un
timido benessere e poi una crescente diffusione della ricchezza ed è allora
che diventa importante la religione, per temperare la spinta dei nuovi
investimenti, per finalizzarla a scopi più elevati di quello che può essere il
risultato economico del singolo, volgendola invece a portare in palmo di mano
un interesse collettivo. Per fa questo occorre una forza morale e questa viene
data dalla fede, da un sentimento comune di appartenenza. Verrebbe da pensare
al famoso motto: tutti per uno, uno per tutti. Si tratta di una bellissima
idea su cui fantasticare, ma idea resta, inapplicabile tale e quale è stata
concepita. Del resto di ipotesi di comune esistenza ne fiorirono parecchie nel
XIX secolo: senza andare a scomodare Marx, il cui pensiero economico e
filosofico può apparire vicino a quello di Balzac, ma che invece ne è
lontanissimo, mi viene in mente il Cristo dell’Amiata, Davide Lazzaretti,
fondatore di una comunità con caratteri propri di un socialismo mistico,
senz’altro utopistico, guarda caso sorta nella seconda metà del 1800,
esperienza conclusasi tragicamente, con l’uccisione dello stesso Lazzaretti, e
lo scioglimento di quella che potrebbe essere definita, come nel caso anche
del villaggio del romanzo di Balzac, una Comune.
Se però
si è ben consapevoli dell’impossibilità di trasformare una società secondo lo
spirito del dottor Benassis e quindi si dà per certo che tale idea sia del
tutto utopica, resta valido il concetto secondo il quale chi amministra una
comunità lo deve fare nell’esclusivo interesse della stessa, svolgendo, più
che un incarico, una missione, concetto che ahimè cozza con la realtà del
nostro paese, in cui i politici costituiscono una casta che si autoalimenta
rappresentando, anziché i cittadini elettori, solo gli eletti.
Il medico
di campagna
finisce così con il diventare un esempio di quello che dovrebbe essere il
buongoverno, con l’aiuto di felici descrizioni dell’ambiente e di proficue
conversazioni che fanno dimenticare lo stile inevitabilmente un po’ datato, ma
comunque mai greve, un’opera insomma che mette in luce altre caratteristiche
di Balzac, un autore che dopo quasi due secoli è sicuramente ancora
apprezzabile.
Honoré de Balzac
(Tours, 20 maggio 1799 – Parigi, 18 agosto 1850), nacque in una famiglia della
media borghesia e solo dal 1830 aggiunse il «de» al suo cognome; suo padre,
che era stato segretario del consiglio del re durante l’Ancien Régime, fu poi
capo della sussistenza della 22a divisione militare di Tours; la madre
proveniva da una famiglia di commercianti. Dal 1807 al 1813 studiò come
interno nel Collège de Vendôme. Quando la famiglia si trasferì a Parigi,
iniziò gli studi di giurisprudenza e seguì alla Sorbona i corsi di Cousin,
Guizot, Villemain.
Nel 1819 i genitori gli concessero un periodo di
prova per saggiare la sua vocazione letteraria. In una mansarda del quartiere
della Bastiglia, in rue Lesdiguières, scrisse le sue prime opere, una tragedia
in versi, Cromwell, e un romanzo filosofico, Sténie.
L’insuccesso lo spinse a cercare nel giornalismo e nella letteratura spicciola
un mezzo per assicurarsi l’indipendenza.
Dal 1821 al 1829, pubblicò, da solo o in
collaborazione e sotto vari pseudonimi, opere narrative spesso ispirate al
«romanzo nero» inglese, e un gran numero di saggi e articoli. Oltre che
giornalista, fu anche editore e tipografo, ma senza successo e si ritrovò, a
trent’anni coperto di debiti.
Fu allora che pubblicò un romanzo storico sulla
ribellione della Vandea, Gli Sciuani (Les Chouans, 1829),
che ottenne un discreto successo; a esso seguì quasi subito il saggio La
fisiologia del matrimonio (La physiologie du mariage,
1830), che fece scandalo e rese noto lo scrittore presso il grande pubblico.
Pubblicò le novelle che compongono le Scene della
vita privata (Scènes de la vie privée, 1830),
poi La pelle di zigrino (La peau de chagrin,
1831), Il colonnello Chabert (Le colonel Chabert,
1832), Il curato di Tours (Le curé de Tours, 1832), Louis
Lambert (L’histoire intellectuelle de Louis Lambert,
1832), Il medico di campagna (Le médecin de
campagne, 1833), La
ricerca dell’assoluto (La recherche de l’absolu, 1834), Le
sollazzevoli istorie (Contes drolatiques,
1832-37).
Degli stessi anni sono Eugénie
Grandet (1833) e Papà
Goriot (Le père Goriot, 1834), le sue due
opere più famose e forse più perfette.
Fu allora che Balzac concepì l’idea, destinata a
sfociare nella Commedia umana (La Comédie Humaine),
di fondere tutti i suoi romanzi in un’opera unica, facendo riapparire in nuove
vicende gli stessi personaggi delle opere precedenti e organizzando i vari
romanzi e racconti in modo da presentarli come parti autonome, ma
complementari, di un quadro d’insieme.
Nel 1833 ebbe inizio, con uno scambio di lettere,
la sua relazione con una ricchissima nobildonna polacca Eve (Eveline) Háska,
che lo scrittore sposò solo dopo molti anni. Le lettere che egli le scrisse
sono il documento più completo sulla sua vita, descrivendo le rovinose imprese
economiche dello scrittore e la sua straordinaria volontà.
Nel 1841 firmò il contratto per la grande edizione
delle sue opere narrative, illustrata da pittori come Gavarni, Meissonnier,
Daumier, per la quale ben quattro editori si erano consorziati e alla quale
egli premise il famoso Avant-propos del
1842.
Dopo questa data, continuò a produrre (ricordiamo
fra l’altro I contadini, Les paysans,
del 1844, e il ciclo I parenti poveri, Les parents
pauvres, del 1846-47), ma il fisico dello
scrittore era logorato, il suo morale era minato dai continui rifiuti dell’Académie
française e dall’ostilità di critici e giornalisti invidiosi del suo successo.
Nel 1850 sposò la Háska, ma lo scrittore non sopravvisse che qualche mese alle
nozze. Morì a Parigi, nella casa lussuosamente arredata di rue Fortunée (ora
rue Balzac), la sera del 18 agosto.
Fonte: parzialmente tratta dall'Enciclopedia
della Letteratura Garzanti
Renzo Montagnoli
4 Ottobre
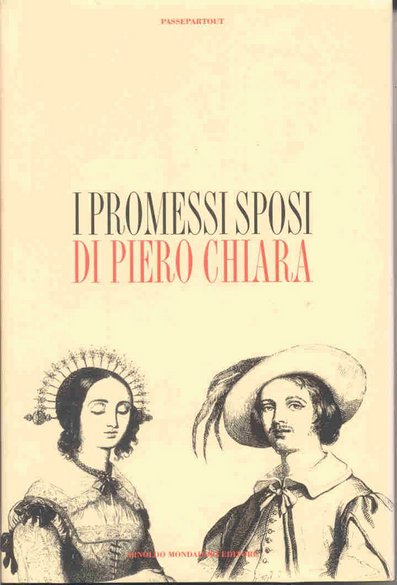
I promessi sposi di Piero Chiara
di Piero
Chiara
Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A.
Narrativa
Lucia, la porcellina
Nel
rileggere per l’ennesima volta I promessi sposi mi sono chiesto se
Alessandro Manzoni, anziché essere nato nel XIX secolo avesse visto la luce
nel XX, come avrebbe scritto la sua opera più famosa, e non mi riferisco tanto
all’aspetto linguistico, a quella ricerca del perfezionismo nell’italiano,
bensì allo svolgimento della trama. E’ indubbio che all’epoca vigeva una certa
morale che giudicava sconveniente tutto quanto riguardasse l’aspetto sessuale,
circostanza acuità dal cattolicesimo francamente bigotto di Manzoni. La
risposta sembrerebbe impossibile, ma c’è chi ha provveduto a riscrivere il
celebre romanzo secondo i canoni e l’etica del secolo successivo con lo scopo
di stilare una sceneggiatura per un film che poi non si fece. E infatti questa
aggiornata versione dei Promessi sposi ha tutti gli aspetti di una
bozza necessaria per poter pensare di trarne una pellicola. Mi sembra giusto
chiedersi chi è stato che ha osato così tanto, chi è stato questo dissacratore
nato? Questa volta la risposta non dovrebbe essere difficile, perché il
Pierino autore di questa specie di parodia, e Pierino lo era come registrato
all’anagrafe, è quel grande scrittore, cantore della provincia, che risponde
al nome di Piero Chiara. E poiché la trama originaria imbastita dal Manzoni è
quella di un amore quasi platonico fra due giovani popolani, contrastato dalla
libidine feroce di un signorotto, si buon ben immaginare quanta sia stata
materia su cui lavorare, tanto che avrebbe potuto essere fonte di ispirazione
per un poeta licenzioso come Pietro Aretino.
Ciò che
nel romanzo di Manzoni può essere intuito, soprattutto con il senso etico
attuale, Chiara mette in chiaro e mi scuso per il gioco di parole, ma sta di
fatto che sentimenti, emozioni, comportamenti sono espliciti, senza per questo
modificare la personalità dei personaggi manzoniani. Infatti, Don Abbondio è
il pavido che ben conosciamo, ma con dei sani appetiti sessuali che vengono
placati da Perpetua, una donna florida e con un seno abbondante; Lucia non è
la giovane pudica e timorata di Dio che conosciamo, anzi è molto appariscente,
tanto da irretire Don Rodrigo e soprattutto da risvegliare le insane voglie di
Fra Cristoforo e dell’innominato, che risponde al nome di Bernardino Visconti
e che si scoprirà impotente. La fanciulla, tutt’altro che ingenua, è come un
ape che svolazza di qua e di là, turbando i sensi degli uomini, fra i quali il
povero Renzo, che non si chiama più Tramaglino, ma Brambilla, e che sarà la
vera vittima, colui che resterà con il cerino in mano e costretto a una
forzata astinenza. La pulzella approfitterà della peste e della morte della
padrona della casa dove è ospitata per impalmare il ricco vedovo, un nobile
spagnolo da cui avrà un figlio, fra Cristoforo e don Rodrigo saranno stroncati
dal morbo e Renzo...Renzo che si era messo nei guai come presunto sobillatore
dei tumulti del pane si ricongiungerà con la sua ex promessa sposa, trovando
occupazione da lei come umile cocchiere. Insomma si tratta di una parodia
godereccia, ideale per trascorrere allegramente alcune ore ed è inutile
pretendere di più. Poi il film, che doveva essere diretto da Marco Vicario non
si fece, e allora Piero Chiara, memore che non doveva essere buttato via
nulla, soprattutto se ottenuto con il sudore della fronte, adattò la
sceneggiatura, facendola diventare un romanzo. E fece bene.
Piero Chiara nacque
a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i più amati e
popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi, quasi
cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo, conterraneo e
grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie che Chiara amava
raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori, 1962), che segna il
suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara scrisse con eccezionale
prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.
E' stato autore particolarmente fecondo e fra le sue numerose pubblicazioni
figurano Il piatto piange (1962), La spartizione (1964), Il
balordo (1967), L'uovo al cianuro e altre storie (1969), I
giovedì della signora Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La
stanza del Vescovo (1976), Il vero Casanova (1977), Il cappotto
di Astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Vedò Singapore? (1981), Il
capostazione di Casalino e altri 15 racconti (1986).
Renzo Montagnoli
26 Settembre
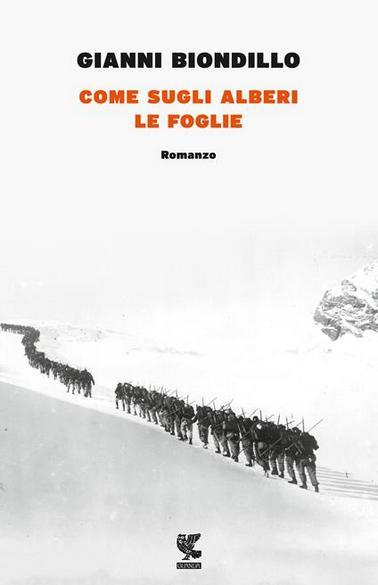
Come sugli alberi le foglie
di Gianni
Biondillo
Guanda
Editore
Narrativa
La dura realtà della guerra
Gli anni
corrono veloci e del passato, soprattutto quello che non ci ha visto presenti,
spesso e volentieri abbiamo solo alcuni cenni, i più importanti, i più
significativi. Proprio per questo credo che pochi sapranno che cosa sia stato
il futurismo, un movimento d’avanguardia letterario, artistico, culturale e
musicale nato in Italia nel primi anni del secolo scorso (il Manifesto
Futurista è del 1909), con cui si esaltava la tecnica, con una fiducia
illimitata nel progresso, considerando decadute le vecchie ideologie,
sbeffeggiate con l’epiteto “passatiste”; inoltre era presente e forte
l’esaltazione del dinamismo, dello spirito guerriero, e della guerra,
considerata purificatrice. E infatti fra gli accesi sostenitori della Grande
Guerra ci furono appunto i futuristi. Filippo Tommaso Marinetti, Umberto
Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, Luigi Russolo furono i
firmatari del manifesto e ad essi successivamente si aggiunsero altri, fra i
quali Antonio Sant’Elia, architetto, a cui si deve un manifesto futurista
dell’architettura e che, nella sua pur breve vita, ideò una miriade di
progetti avveniristici.
Non è
probabilmente un caso se Come sugli alberi le foglie, un romanzo
storico che richiama una celebre poesia di Ungaretti, sia stato scritto da
Gianni Biondillo, giallista di buon livello, ma anche di professione
architetto.
All’inizio della lettura ho avuto l’impressione che l’autore avesse come scopo
solo il tema del futurismo, ma mi sono dovuto ricredere, perché questa
piacevole opera è soprattutto contro la guerra; eppure sappiamo che Tommaso
Filippo Marinetti e gli altri non si sono limitati a discorsi veementi che
incitavano a intraprendere un conflitto con l’Austria, ma si sono arruolati in
massa, coerenti con la loro idea. Tuttavia le sofferenze sui campi di
battaglia, la disumanità che riduceva gli uomini a carne da cannone, la
“bella morte” che si dimostrava tutt’altro che bella, incisero profondamente
sullo spirito di questi interventisti, che comunque si batterono con coraggio,
meritando anche medaglie al valore. Si accorsero però soprattutto dell’estrema
incertezza della vita, quella stessa incertezza che fece scrivere a Ungaretti
“Soldati” (Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie).
Fra tutti
i personaggi spicca, perché è quasi sempre presente, Antonio Sant’Elia,
l’architetto, una figura che diventa il protagonista principale e che cadrà in
combattimento il 10 ottobre 1916 durante un assalto nei pressi di quota 85 di
Monfalcone, vicino al cimitero in corso di costruzione per i caduti della
Brigata Arezzo, l’ultimo dei suoi tanti progetti. Nelle linee generali il
romanzo rispecchia la storia, con un ritmo che a volte rallenta, e altre
accelera, come nel caso della cattura e conseguente esecuzione di Cesare
Battisti e di Damiano Chiesa. Inoltre è anche opportunamente inserita nella
trama una relazione amorosa che riguarda Antonio Sant’Elia, un sentimento
naturale e descritto quasi pudicamente con una vena di poesia che non solo non
guasta, ma apporta altri valori all’opera.
Come
sugli alberi le foglie
mi è piaciuto, si legge facilmente, è uno di quei libri che, senza diventare
un capolavoro, si avvicina all’eccellenza e lo fa con semplicità, in punta di
piedi, senza ricorso a stereotipi e alla non infrequente retorica che invece
si incontra sovente in molte opere in cui è presente la guerra.
Gianni Biondillo
(Milano, 3 febbraio 1966). Architetto e saggista scrive per il cinema e per la televisione. Fa
parte della redazione di Nazione Indiana. Ha pubblicato per l'Universale di
Architettura diretta da Bruno Zevi, Carlo Levi e
Elio Vittorini. Scritti di architettura (1997)
e Giovanni Michelucci. Brani di città aperti a
tutti (1999).
Nel 2001 ha pubblicato, per Unicopli: Pasolini.
Il corpo della città, con un'introduzione
di Vincenzo Consolo.
Il suo primo romanzo, nel 2004 per i tipi di
Guanda, è Per cosa si uccide, "un
tributo di riconoscenza dello scrittore verso la propria città, che viene
descritta in tutte le sue molteplici sfaccettature".
Sempre per Guanda sono usciti Con
la morte nel cuore (2005), Per
sempre giovane (2006), Il
giovane sbirro (2007) e nel 2008 la
raccolta di saggi Metropoli per principianti,
il saggio Manuale di sopravvivenza del padre
contemporaneo, scritto a quattro mani con
Severino Colombo, oltre all'antologia di racconti erotici al maschile da lui
curata, Pene d'amore.
Del 2014 il racconto lungo Nelle
mani di Dio. Un'indagine dell'ispettore Ferraro (Guanda).
Nel 2015 ha pubblicato L'incanto delle
sirene. Un'indagine dell'ispettore Ferraro, nel
2016 Il giovane sbirro e Come
sugli alberi le foglie, e nel 2018 Il
sapore del sangue sempre con Guanda.
Renzo Montagnoli
17 Settembre
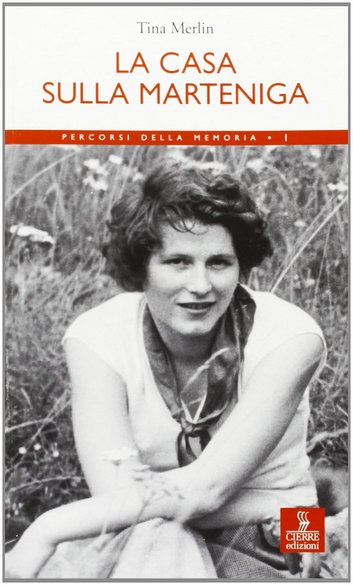
La casa sulla Marteniga
di Tina Merlin
Cierre Edizioni
Narrativa
Una
lettura sorprendentemente piacevole
Ai
giovani, ma anche a non pochi della mia età, il nome Tina Merlin non dice
niente ed è già tanto, se in un tentativo di dimostrare il loro grado di
conoscenza la confondono con la senatrice socialista Lina Merlin che nel 1958
ebbe il merito di promuovere la legge che abolì la regolamentazione della
prostituzione, con conseguente chiusure della case di tolleranza e che
introdusse anche i reati di sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione.
Se Lina
Merlin fu indubbiamente una donna battagliera, volta a eliminare il degrado
del suo sesso, Tina Merlin va invece giustamente ricordata per la lunga
battaglia che condusse per portare alla luce la verità sulla costruzione della
diga del Vajont, e questo ben prima della nota tragedia avvenuta il 9 ottobre
1963. Di orientamento politico di sinistra (era iscritta al Partito Comunista)
di professione faceva la giornalista per l’Unità, ma amava anche scrivere,
oltre agli articoli, saggistica e narrativa, come nel caso di La casa
sulla Marteniga.
La
lettura di questo libro è stata determinata dalla mia curiosità di sapere come
scrivesse Tina Merlin e diciamo che non avevo grandi aspettative, perché ero
convinto che fosse una semplice cronaca di quella che è stata la vita
dell’autore fino alla fine della seconda guerra mondiale. Pagina dopo pagina
ho dovuto invece riscontrare con vero piacere che mi sbagliavo, perché
La casa sulla Marteniga mi ha rivelato una scrittrice di grande
valore, capace di narrare della propria vita con sincerità, in modo semplice
ma efficace, e di sondare l’animo umano con una capacità senz’altro
invidiabile. Un altro pregio è dato dal fatto che, nonostante la militanza
politica, questa non si avverte mai, senza dimenticare che, seppur bocciata in
quinta elementare, per poi abbandonare la scuola e andare subito a servizio
presso famiglie milanesi, ha uno stile gradevole e fa un uso corretto della
lingua italiana, qualità che impreziosiscono ancor più quest’opera, pubblicata
solo dopo la sua morte. La casa sulla Marteniga piacque tanto a
Mario Rigoni Stern, che ne curò una breve presentazione, e se si considerano i
temi di cui scrisse l’autore asiaghese è del tutto comprensibile; infatti in
Tina Merlin ritroviamo lo stesso stupore per la natura, le riflessioni sui
fatti del mondo - in particolare nei colloqui con la madre alla fine di ogni
capitolo -, tutti argomenti cari a Rigoni Stern.
In queste
pagine non c’è altro che la vita, dura e all’apparenza senza speranza di un
ceto povero, come quello contadino, in un’epoca in cui ancora esisteva quella
civiltà contadina di cui tanto ha ben narrato Ferdinando Camon. La Marteniga è
un torrente che bagna parte dei confini della piccola proprietà dei Merlin ed
è come una linea di confine che divide i poveri del contado dagli agiati del
vicino paese, una barriera che Tina vuole superare per rivendicare la sua
dignità di essere umano alla ricerca della realizzazione di un mondo più
giusto e più equo. Un cambiamento non sarà tuttavia possibile fino a quando
impererà il fascismo; sarà la guerra, grazie soprattutto alla Resistenza, che
darà una svolta a questa umanità fino ad allora senza speranza. La Merlin vi
parteciperà assai giovane come staffetta, un servizio umile, ma indispensabile
e pericoloso. E anche qui nella narrazione non ci sono eroi, ci sono solo
esseri umani in cerca di riscatto. Ci furono tanti morti fra i partigiani e
fra questi anche il fratello, gente caduta combattendo per un mondo nuovo che,
però, finita la guerra piano piano ritornò a essere quello delle ingiustizie
sociali, della prevaricazione del più forte sul più debole. Tina Merlin
accenna appena e malinconicamente a questa delusione, ma non si considera
vinta, perché la speranza in lei è ancora viva e forte.
Da
leggere, merita senz’altro.
Tina Merlin nasce a Trichiana
(Belluno) il 19 agosto 1926 e muore a Belluno il 22 dicembre 1991. Durante la
guerra di liberazione è stata staffetta partigiana. Inizia la sua attività
letteraria scrivendo racconti che vengono pubblicati sulla rivista Noi
donne. Dal 1951 al 1967 è corrispondente locale del quotidiano L’Unità.
Esordisce come scrittrice con Menica (1957),
raccolta di racconti partigiani. Segue da vicino le vicende del Vajont. tentò
di pubblicare un libro sulla vicenda, Sulla Pelle viva. Come si costruisce
una catastrofe. Il caso del Vajont, che tuttavia trovò un editore solo nel
1983.
Renzo Montagnoli
12 Settembre

Ragazzi di zinco
di
Svetlana Aleksievič
Edizioni e/o
Narrativa
Un libro imperdibile
Dopo aver
letto Gli ultimi testimoni (i ricordi degli allora bambini di quella
che fu per loro la seconda guerra mondiale) e Preghiera per Cernobyl’
(la ricostruzione non tanto degli avvenimenti, ma dei sentimenti della
popolazione vittima della tragedia causata dall’esplosione del reattore numero
quattro) ho messo mano, anzi ho messo gli occhi su Ragazzi di zinco,
un ennesimo dramma provocato dalla guerra condotta in Afganistan dall’Unione
Sovietica, che costò ai russi dell’epoca 26.000 morti e circa 54.000 feriti su
un totale di 130.000 effettivi, senza dimenticare le vittime dell’alleato
esercito della repubblica democratica dell’Afganistan (18.000 morti) e quelle
civili, il cui computo è assai difficile, ma che si possono fare ascendere a
una forbice fra 600 mila e 2 milioni. Come è noto in questo conflitto l’Unione
Sovietica si dissanguò e di fatto le conseguenze furono la caduta del
comunismo. Anche per Ragazzi di zinco la
Aleksievič usa la tecnica positivamente sperimentata
di fare raccontare questa guerra dai militari che vi hanno combattuto, dalle
loro madri, dalle loro mogli; ne risulta così una narrazione corale che ha il
potere dell’autenticità e che ben riesce a descrivere un dramma che coinvolge
il lettore, lo rende spettatore sgomento e attonito di efferatezze, di stragi,
di dolore, di un inferno in terra che nessuna fantasia può immaginare. Ci sono
soldati usciti di senno, altri invalidi privi di gambe e braccia, altri ancora
che hanno superato il confine che separa l’essere umano dalla bestia e che
sono diventati incapaci di condurre un’esistenza normale in quel mondo che
avevano lasciato andando in guerra e che ora non riconoscono più.
Per i morti parlano le madri, le vedove che hanno visto rientrare i loro cari
dentro casse di zinco, acclamati dal partito come eroi di una guerra inutile e
solo di potenza, avviata per nascondere la tragica realtà di un regime
morente. In Afganistan ai soldati russi manca tutto, non ci sono bende,
cerotti, siringhe, sono mandati allo sbaraglio senza un calcolo strategico di
ampio respiro e privi di un supporto tattico, una storia che si ripete, si
potrebbe dire, viste le attuali carenze dimostrate nel corso dell’attuale
conflitto con l’Ucraina, ma quello di mandare insensatamente al macello le
proprie truppe sembra una costante dei russi, come già visto nel corso della
Grande Guerra e della seconda guerra mondiale. L’elemento umano è
disumanizzato, gli si fa credere dapprima che è inviato magari a Taskent e poi
da là lo si sposta a Kabul, gli si dice di una guerra patriottica, che è
invece è nazionalista, lo si arruola con la falsa promessa di andare in
Afganistan per costruire scuole, ospedali, infrastrutture civili. E’ un
copione quindi che si ripete: così sotto lo zar, poi sotto la falce e il
martello e ora sotto Putin.
Come per i precedenti da me letti, di cui ho brevemente accennato, il libro
della Aleksievič scava profondamente l’animo di chi legge, perché non si può
restare insensibili davanti all’orrore e alla sofferenza, aspetti comuni alle
due parti in lotta, ma soprattutto all’inerme popolazione civile.
La visione dell’autore va tuttavia oltre l’evento, perché nella sua ottica il
rilievo è per l’essere umano, capace di essere carnefice, ma anche vittima,
quel che si direbbe un controsenso, ma che è proprio della nostra specie da
quando si è affacciata sulla Terra.
Arrivato all’ultima pagina, il sentimento di orrore che mi aveva preso con le
prime interviste poco a poco si è trasformato in pietà, in pietà per quei
soldati, per quei civili, ma anche in pietà per noi stessi, per uomini e donne
di questo XXI secolo, per l’incapacità non tanto di opporci alla guerra, ma di
saper coltivare e difendere la pace.
Ragazzi di zinco è un libro imperdibile.
Svetlana Aleksievič
è nata in Ucraina nel 1948 da padre bielorusso e madre ucraina. Giornalista e
scrittrice, è nota soprattutto per essere stata cronista per i connazionali
dei principali eventi dell’Unione Sovietica nella seconda metà del XX secolo.
Fortemente critica nei confronti del regime dittatoriale in Bielorussia, è
stata perseguitata dal presidente Aleksandr Lukašenko e la sua opera è stata
bandita dal paese. Dopo dodici anni all’estero è tornata a Minsk, ma nel
settembre del 2020 è stata costretta a fuggire in Germania. Per i suoi libri,
tradotti in più di quaranta lingue, ha ricevuto il Premio Nobel per la
Letteratura nel 2015.
Renzo Montagnoli
6 Settembre

Il fiore gelido
di
Alessandro Damiani
Edit –
Fiume
Poesia
Un uomo, la poesia
E’ ben
strana la vita, perché il destino (se così vogliamo chiamarlo) ci impone delle
scelte che ci allontano dagli obiettivi che avevamo ben radicati nella mente
ed è stato così anche per Alessandro Damiani, aspirante guerrigliero che nel
lontano 1949 arrivò in Jugoslavia per unirsi ai combattenti comunisti della
guerra civile in Grecia, ma che poi per i giochi di potere che di continuo
tesseva Stalin dovette rinunciare, per fermarsi definitivamente nello stato
retto da Tito. Probabilmente fu un bene, perché forse come partigiano
dell’Esercito Democratico Greco non sarebbe stato molto valido e invece come
civile dedito alla letteratura e al giornalismo seppe dare il meglio di sé.
Eclettico, tanto che scrisse articoli, saggi, commedie, romanzi e poesie, fu
un faro per la Comunità Italiana di quel paese, di cui ha cercato di
salvaguardare lo spirito e la cultura. Già l’avevo conosciuto leggendo un suo
romanzo Ed ebbero la luna, un ibrido fra narrativa e saggistica
storica, ma nulla mi era noto della sua attività poetica, fino a quando suo
figlio Sandro mi ha parlato di Il fiore gelido, una corposa
raccolta di liriche.
Sono
sincero e confesso che quando mi trovo davanti a una silloge costituita da
molte poesie ho un timore reverenziale nei confronti della stessa, al punto
che rinvio di continuo l’inizio della lettura, poi però mi decido, perché
nasce in me un obbligo morale nei confronti di chi ha scritto questi versi.
Complice soprattutto il caldo torrido ho preso in mano il libro solo al primo
accenno di rinfrescamento, titubante in verità, intimorito da quelle poesie
che a prima vista mi sono sembrate di grande lunghezza. Ma non è la dimensione
ciò che conta, perché quel che caratterizza e dona valore a un’opera sono i
contenuti e la forma e in questo caso ci sono entrambi. Premetto che la
raccolta non è monotematica, ci sono diversi argomenti, direi uno sguardo,
disincantato, su come va il mondo, con una visione che, nonostante la
formazione politica, si può considerare nel complesso oggettiva. Così troviamo
grandi temi, come la guerra e la pace, ma anche aspetti più semplici,
osservazioni di costume, dediche ad altri poeti (Pasolini) e anche
dissertazioni sulla poesia, sul suo senso, sull’opportunità che resista,
nonostante ogni tentativo di relegarla in soffitta. Non c’è una malinconia di
fondo, anzi ho ravvisato un’ironia, benefica, anche nel caso degli Epicedi,
pescando dalla tradizione greca dei canti funebri, una sorta di pre-epigrafi
in cui si rivela tutta la filosofia dell’autore nei confronti dei grandi temi
dell’esistenza. E per finire c’è una sezione che, nonostante il nome (Post
scriptum) non è qualcosa che è venuto in mente a opera conclusa, perché in
effetti è la fine e il fine dell’opera stessa, una confessione, o anche un
testamento, comunque un lascito, questo sì malinconico come può esserlo un
commiato in cui si ripresenta tutta la propria esistenza; inoltre c’è l’amara
constatazione che il tempo sta per finire, con un mesto rimpianto per gli
inevitabili errori che non si possono più correggere e che si vorrebbe non
aver mai commesso. E’ forse la parte che mi è piaciuta di più, che avverto più
in sintonia con ciò che provo in questa ultima stagione, tanto che il
gradimento si è unito a una incontrollabile commozione. Ci sono altre
tematiche, ma non vado oltre, sia per ragioni di spazio che di tempo
(meriterebbero tutte un discorso approfondito, e in tal caso occorrerebbe
scrivere un corposo saggio), ma farei un torto all’autore se mi dovessi
fermare qui, perché è d’obbligo evidenziare lo stile, anche se magari solo con
un cenno. Uomo del secolo trascorso, così fecondo di rinnovamenti poetici,
Alessandro Damiani parte da una base classica e costruisce sulla stessa -
grazie al frutto degli studi effettuati e con influssi magari di Leopardi,
Pascoli, pure di Ungaretti, ma nei contemporanei soprattutto di Montale – una
sua ben precisa poetica, una costruzione armonica personale che dona ritmo ed
equilibrio a liriche anche di consistente lunghezza. Del resto tutto quello
che siamo culturalmente è frutto del pensiero di chi ci ha preceduto e che
abbiamo studiato; Damiani non è diverso, ma è riuscito a darsi uno stile che è
una sintesi di voci e correnti non solo dello scorso secolo, ma anche
precedenti. Talora ho addirittura riscontrato un accenno petrarchesco con
delle sfumature e dei rimandi che, secondo me, ricordano anche Guido
Cavalcanti. Non c’è nulla invece di D’Annunzio, perché l’autore non ama
sprecare parole, parole che devono essere un mezzo e non un fine, e proprio
per questo D’Annunzio viene escluso. E così è tutto un fiorire, non casuale,
di novenari e soprattutto di settenari, formula questa certamente non facile,
ma di grande effetto. La rima? La rima non è ricercata, meglio le assonanze,
le rime eventualmente interne, insomma la parola è certamente il mezzo, ma non
è per niente trascurata, anzi…
Giunto al
termine della lettura, invero appagante, credo che Alessandro Damiani nella
sua poliedricità sia riuscito a privilegiare la poesia, una poesia forse non
semplice, ma certamente di notevole qualità, sia per contenuti che per stile.
Alessandro Damiani (Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, 26 agosto 1928 – Fiume, 17
ottobre 2015) è stato un giornalista e scrittore della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia. Gli esordi giornalistici del Damiani risalgono al 1946
quando, diciottenne, collabora con Umanità
Nova,
l'organo dell'Anarchia italiana.
Arriva in Jugoslavia nell'estate del 1948 con
un gruppo di giovani volontari italiani, coll'intento di unirsi alla
guerriglia comunista nella guerra
civile greca,
appoggiata dalla Jugoslavia di Tito.
A seguito della rottura tra Tito e Stalin, la Jugoslavia chiude però i confini con tutto l'est europeo e
toglie il proprio appoggio all'DSE (Esercito
Democratico Greco), guidato dal comandante Vafiadis: quest'ultimo venne
arrestato a Mosca, ed il suo posto venne preso del generale Zachariadis. La
maggior parte delle migliaia di giovani volontari confluiti da ogni parte
d'Europa ritorna quindi nei rispettivi Paesi, salvo un'aliquota di essi che
venne perseguitata dai titoisti jugoslavi.
Alcune centinaia divengono invece dei sostenitori del dittatore e rimangono in
Jugoslavia. Vi rimane pure il ventenne Damiani, che si stabilisce a Fiume e nel 1948,
entra nella compagnia di prosa del Dramma
Italiano[1],
dove conosce Piero
Rismondo, all'epoca direttore e
regista del complesso teatrale ed in seguito tornato in Austria, da dove era fuggito durante la guerra.
Nel 1950 Damiani
sposa Olga Stancich (nata Stančić, nel 1916, nella Fiume ungherese), già
cantante e doppiatrice di Marlene Dietrich. Nel 1957,
deluso dall'esperienza jugoslava, fa ritorno in Italia.
Dopo nove anni trascorsi
nel mondo del giornalismo[2],
questa volta deluso dall'Italia se ne torna definitivamente in Jugoslavia
coll'intento di contribuire alla salvaguardia del patrimonio
linguistico-culturale italiano nell'area istro-quarnerina. Abbraccia le
posizioni di Eros
Sequi,
secondo cui - a fronte delle pressioni nazionaliste panslave, sostituitesi ben
presto nella Jugoslavia di Tito, agli ideali del socialismo, ed in assenza di
adeguate attenzioni da parte dell'Italia - "bisogna salvare il salvabile", per
evitare che del retaggio italiano nell'area non rimangano che vaghi ricordi.
Redattore del periodico Panorama e
del quotidiano La
Voce del Popolo, insegnerà giornalismo
alla Facoltà di Italianistica di Pola dell'Ateneo fiumano e alla Scuola media
superiore italiana di Fiume. Collabora con Tv-Capodistria e col mensile
fondato da Pietro Calamandrei, "Il Ponte", di Firenze.
Pubblica saggi e libri sulla cultura italiana dell'Istria e di Fiume, romanzi,
commedie, varie antologie di poesie.
Gran parte dei suoi lavori sono tradotti in croato ed alcuni anche in sloveno.
1^ Il
Sandro Damiani che negli anni Novanta/Duemila sarà direttore della compagnia è
suo figlio.
2^ Tra gli altri, collaborerà con Il
Pensiero Nazionale diretto da Stanis
Ruinas.
Fonte Wikipedia
Renzo Montagnoli
1 Settembre
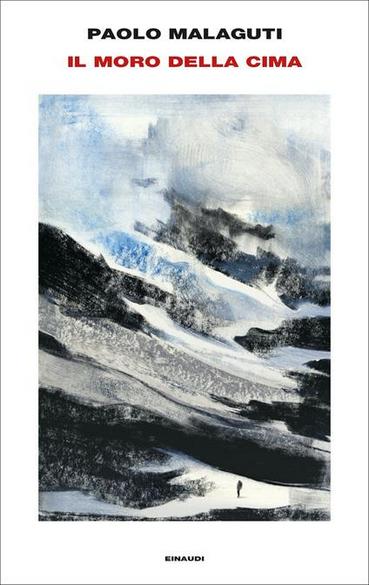
Il Moro della cima
di Paolo Malaguti
Edizioni Einaudi
Narrativa
Un romanzo rasserenante
Ho letto ormai diversi libri scritti da Paolo Malaguti, un autore che alcune
volte mi ha convinto, come nel caso di Prima dell’alba e di Sul
Grappa dopo la vittoria, a mio avviso due autentici capolavori, e altre
invece mi ha lasciato perplesso e mi riferisco in particolare a La reliquia
di Costantinopoli e a I mercanti di stampe proibite; i primi due si
svolgono durante la Grande Guerra e nei giorni immediatamente successivi, gli
altri in epoche ben antecedenti. Forte di questa constatazione ho deciso di
leggere anche Il Moro della cima, visto che la trama si sviluppa
soprattutto durante il primo conflitto mondiale; brevemente è una biografia
molto romanzata di un personaggio esistito veramente, tale Agostino Faccin,
che tutti chiamano “il Moro” e la cui grande aspirazione è di salire di quota,
di percorrere quelle montagne che svettano vicino a casa e in particolare una,
la Grapa, l’odierno Grappa, per la quale ha una particolare e intensa
venerazione. Vorrebbe che rimanesse sempre così, come era da tempo
immemorabile, ma nell’economia della Grande Guerra la Grapa può diventare un
forte baluardo atto a frenare e a impedire l’avanzata nemica ed ecco allora
che vengono realizzate strade, scavate gallerie e trincee, insomma uno
sconvolgimento di quel mondo che il Moro ritiene perfetto e in cui si sente
realizzato. Sarà costretto dai militari ad andarsene, a scendere al piano, ma
quando quella carneficina finisce ritornerà sulla cima e di fronte allo
sconquasso provocato dalla guerra cercherà, in base alle sue possibilità, di
rendere onore alla sacralità della montagna. Grosso modo la trama è quella a
cui ho appena accennato e di per sé è interessante perché sono continui gli
squarci storici e pure l’atmosfera di dolore e di morte è ben resa. Ho
l’impressione, tuttavia, che la figura del Moro sia un po’ troppo caricata,
cioè che l’autore abbia calcato un po’ la mano, anche se di personaggi così se
ne possono trovare, uomini fieri, indipendenti, tesi continuamente a
rivendicare e a difendere la loro personalità; la mia è una sensazione, che
può anche essere sbagliata, e del resto il romanzo si fa ben valere per altri
aspetti, per niente secondari, come anche il profondo rispetto per natura e
soprattutto per la sua montagna, quella Grapa che Agostino sognava fin da
bambino. E’ questa sorta d’amore che dona lustro all’opera, sono le
descrizioni di un mondo eternamente incantato e che solo l’avidità dell’uomo
può corrompere, sono le pagine in cui la prosa è soffusa da un alone di
poesia, come nel caso della morte del cane che gli ha fatto a lungo compagnia
quando il Moro gestiva il rifugio sulla cima, senza dimenticare che la
tragedia della guerra con i suoi mutilati e i suoi morti viene anteposta ai
risultati delle battaglie, un chiaro intento pacifista che non può essere che
lodevole, perché rifugge dalla facile retorica. Aggiungo anche che la
scrittura, priva di ampollosità, non poco contribuisce al piacere della
lettura che mi ha deliziato in questi giorni di intenso caldo estivo, dandomi
un ristoro dell’anima, perché pagina dopo pagina si avverte nel proprio intimo
il sorgere di una gradevole dolcezza che allontana i brutti pensieri e che
poco a poco conduce a quello stato di beatitudine che è proprio della
serenità. Credo proprio che Il Moro della cima rientri fra i
romanzi di Malaguti che mi hanno convinto e pertanto invito a leggerlo, perché
lo merita.
Paolo Malaguti
è nato a Monselice (Padova) nel 1978. Attualmente vive ad Asolo e lavora come
docente di Lettere a Bassano del Grappa. Con Neri Pozza ha pubblicato La
reliquia di Costantinopoli (2015), finalista al Premio Strega 2016. Tra
le sue opere Nuovo sillabario veneto (BEAT,
2016), Prima dell'alba (Neri Pozza, 2017) e L'
ultimo carnevale (Solferino, 2019).
Renzo Montagnoli
8 Agosto
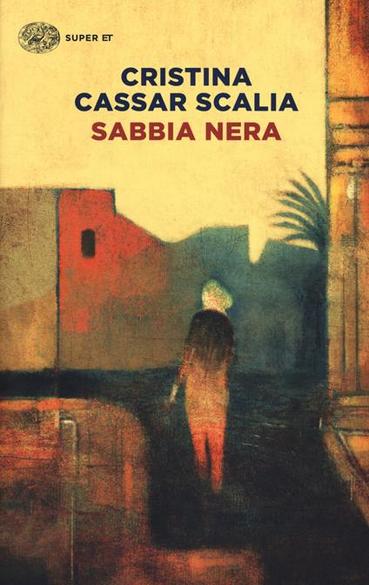
Sabbia nera
di
Cristina Cassar Scalia
Edizioni
Einaudi
Narrativa
Un romanzo giallo particolarmente
avvincente
Può
sembrar facile scrivere un romanzo giallo, che si basa soprattutto su una
trama secolare, vale a dire un delitto, la ricerca del colpevole da parte
dell’autorità giudiziaria e infine la chiusura delle indagini con la scoperta
del reo, ma non è così, proprio perché una trama obbligata richiede, per
attirare il lettore, un’originalità, dei personaggi ben disegnati e uno stile
particolarmente scorrevole. Per Cristina Cassar Scalia, di professione
oftalmologo, cioè oculista, l’impegno profuso per scrivere Sabbia nera
deve essere stato notevole, poiché è riuscita a dare al suo lavoro una
struttura equilibrata, una vicenda di una originalità particolare (il casuale
rinvenimento di una mummia di una donna ammazzata mezzo secolo prima), un
vicequestore (Giovanna Guarrasi, detta Vanina, a cui dona vita con
caratteristiche sue peculiari, non solo fisiche, in corso d’opera), i
collaboratori dello stesso, validi e che suscitano immediata simpatia, fra i
quali particolarmente riuscita è la figura di Biagio Patanè (un anziano ex
commissario occasionalmente coinvolto), una soluzione del caso che avviene
dopo un susseguirsi di colpi di scena caratterizzati da una loro logicità,
l’ambientazione a Catania e in una villa sotto l’Etna in eruzione e che
ricopre tutto di cenere nera, donde il titolo azzeccato.
Sinceramente, prima di leggere ero scettico sulla possibilità che il romanzo
potesse interessarmi in modo particolare, ma mi sono dovuto ricredere già
dalle prime pagine, tanto che è cresciuta in me l’ansia di non staccare gli
occhi dal volume fino a quando le indagini non si fossero concluse, uno stato
d’animo che non sperimentavo da diverso tempo. A ciò ha contribuito in modo
determinante lo stile, con una fluidità della scrittura e un ritmo mai
eccessivo, ma costante, che non poco ha contribuito affinché fossi avvinto da
questa trama che vede un duplice delitto commesso addirittura mezzo secolo fa,
il che rende particolarmente difficili le indagini, anche perché eventuali
testimoni in buona parte hanno finito con il passare a miglior vita. Proprio
per questa discrepanza temporale l’autore avrebbe potuto cadere in una
narrazione caratterizzata da una discontinuità dovuta a non improbabili
flashback, che invece ha giustamente preferito evitare restando nel tempo
presente, ma riuscendo a dare un’idea convincente di quello accaduto una
cinquantina di anni prima.
Ne è
uscito un romanzo capace di attrarre considerevolmente e di far trascorrere
con piacere alcune ore di una amena lettura, il che non è proprio poco.
Cristina Cassar Scalia
(1977) è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive e lavora a Catania. Ha
raggiunto il successo con i romanzi Sabbia
nera (2018), La
logica della lampara (2019), La
Salita dei Saponari (2020), L’uomo
del porto (2021)
e Il
talento del cappellano (2021)
– tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero – che hanno come protagonista il
vicequestore Vanina Guarrasi; da questi libri, venduti anche all’estero, è in
progetto la realizzazione di una serie tv. Con Giancarlo De Cataldo e Maurizio
de Giovanni ha scritto il romanzo a sei mani Tre
passi per un delitto (Einaudi
Stile Libero 2020).
Renzo Montagnoli
1 Agosto

La banalità del male.
Eichmann a Gerusalemme
di Hannah Arendt
Feltrinelli Editore
Saggistica
Quando il male non è
avvertito come tale
Adolf Eichmann, Obersturmbannfuhrer delle SS, l’organizzatore dei convogli
ferroviari con cui gli ebrei erano trasportati nei campi di detenzione e di
sterminio, non era in sé l’incarnazione del male, ma era un uomo normalissimo,
magari mediocre e di poca sostanza, ma dedito al suo lavoro, del tutto
incapace di porsi delle domande sulla legittimità morale dei propri atti, un
ragioniere dello sterminio, senza coscienza, insomma non colui che ama
compiere atti efferati, ma la rappresentazione della banalità del male.
Catturato da un commando israeliano l’11 maggio 1960 in Argentina, dove viveva
sotto falso nome, Eichmann fu trasferito, non senza difficoltà, in Israele per
essere sottoposto a processo. Date le circostanze e nonostante che fosse
passato più di un decennio dal processo di Norimberga il procedimento
giudiziario ebbe enorme risonanza, con la partecipazione di giornalisti di
quasi tutto il mondo e fra questi Hannah Arendt, ebrea tedesca sfuggita alle
persecuzioni emigrando per tempo. Presente a tutte le udienze scrisse per il
suo giornale (New Yorker) molti articoli, approfondendo le problematiche
giuridiche, politiche e soprattutto morali che non erano solo attinenti il
giudizio in corso, ma che erano alla base della figura dell’imputato e in
generale di tutta la struttura nazista.
Ne emerge un quadro allucinante, perché i nazisti non sono considerati
l’incarnazione dei peggiori istinti dell’uomo, ma degli individui qualunque,
mediocri, in fondo anonimi, poco consapevoli o addirittura inconsapevoli
dell’aspetto morale degli atti compiuti, ma inseriti in modo perfetto in un
meccanismo del tutto infernale. In pratica chiunque, o comunque una persona
del tutto normale, può diventare un aguzzino spietato se diventa parte di un
apparato politico o anche poliziesco che lo stimola ad agire senza pensare.
Ecco, il nazismo aveva reso i suoi cittadini del tutto incapaci di pensare, di
porsi delle domande sulla moralità di ciò che essi facevano.
Il libro non piacque agli ebrei, volti a una demonizzazione di Hitler e del
nazismo, anche perché la banalità del male non è stata una prerogativa solo
della Germania nazista, ma potrebbe ripresentarsi in altri paesi, anche con
ideologie diverse.
Il saggio, che è filosofico, ben rappresenta il concetto introdotto dalla
Arendt, ma credo che più delle mie parole si pensi a una cosa semplicissima, e
cioè che sarebbe stato lecito supporre che sparito il nazismo non dovesse più
esistere il male istituzionalizzato, ma purtroppo non è stato così, e vi sono
chiari esempi di non pochi totalitarismi in cui questa banalità si ripresenta,
e, solo per citarne alcuni, il periodo dei khmer rossi in Cambogia, oppure la
rivoluzione culturale cinese, ma purtroppo ce ne sono altri e altri ancora ne
verranno.
Si rimane, più che sconcertati, scossi nel venire a sapere che “quel male”,
quello con la Croce uncinata, che speravamo fosse l’ultimo e l’unico possa
avere dei seguiti, cioè che possa ripetersi questa banalità del male,
perché avevamo sempre considerati delle eccezioni anche i casi successivi, ma
quando questi non sono più rari vuol dire che il male che è in noi potrebbe
emergere prepotente e, istituzionalizzato, diventare lo scopo della nostra
vita.
Da leggere, indubbiamente.
Hannah Arendt
(Hannover, 14 ottobre 1906 – New York, 4 dicembre 1975), filosofa tedesca.
Formatasi nelle università di Marburgo, Friburgo e Heidelberg, ebbe come
maestri Heidegger, R. Bultmann e K. Jaspers.
Di origini ebraiche, nel 1933 emigrò in Francia, per poi trasferirsi negli
Stati Uniti nel 1940.
I suoi principali interessi si sono orientati sull’agire politico, inteso come
dimensione pubblica dell’esistenza umana.
In "Le origini del totalitarismo" (1951), la Arendt ricostruisce il processo
storico
che ha condotto alle dittature europee e alla seconda guerra mondiale; i
momenti decisivi di tale processo (antisemitismo, imperialismo e
trasformazione plebiscitaria delle democrazie) sono interpretati come effetti
di una complessiva de-politicizzazione della cultura moderna.
"Vita activa" (1958) propone l’e1aborazione in termini filosofici del
contrasto tra un tipo di comunità politica - la polis greca al tempn di
Pericle - e la decadenza dell’agire politico nel pensiero occidentale.
Benché nella contrapposizione tra Grecia e modernità si avvertano influssi
heideggeriani, la Arendt rifiuta l’esito anti-mondano dell’ultima filosofia di
Heidegger.
L’agire, per la Arendt, definisce l'essere umano come essere-con-gli-altri:
l'identità umana costituisce nell’intimità della coscienza soggettiva e
neppure nella società (intesa come sfera dei bisogni, del lavoro e della
riproduzione), ma piuttosto nella sfera pubblica.
La Arendt ha delineato quest'antropologia politica in numerosi contributi:
"Sulla rivoluzione" (1963) analizza soprattutto gli esiti perversi delle
rivoluzioni americana e francese, cioè il passaggio dalla libertà pubblica al
dominio della società amministrata e dello Stato
"Passato e futuro" (1961) e altri saggi estendono la critica della modernità a
problemi come la storia, l'autorità e la tradizione; "Ebraismo e modemità"
(1978, postumo), e, soprattutto "Rahel Varnhagen" (1958), biografia di
un'eroina della Berlino romantica, interpretano l'ebraismo moderno come scisso
tra l'aspirazione all'assimilazlone sociale e la fuga nell’interiorità,
aspetto proprio di una più ampia tendenza del moderno alla polarizzazione tra
coscienza soggettiva e sfera sociale.
Favorevole a una cultura ebraica laica e tollerante, la Arendt si è spesso
trovata in contrasto con le comunità ebraiche ortodosse, a partire dal
controverso reportage sul caso Eichmann, "La banalità del male" (1963).
Negli ultimi anni della sua riflessione, ha operato una rivalutazione della
vita contemplativa; in "La vita della mente", opera rimasta incompiuta e
uscita postuma nel 1978, l'esperienza spirituale viene articolata in tre
attività fondamentali: pensare, volere e giudicare
Senza rinunciare al ruolo preminente dell'agire nella definizione
dell’identità umana, la Arendt esprime un certo scetticismo nei confronti
della possibilità di un'esperienza politica autenticamente libertaria nella
società di massa.
Atteggiamento ribadito anche nel ciclo dl lezioni sulla filosofia politica di
Kant (1982, postumo)in cui la dimensione pubblica dell'esistenza non è più
individuata nell’agire politico, ma nel giudizio, vale a dire nella capacità
di saper osservare lo "spettacolo del mondo".
Tratto dall'enciclopedia Garzanti della Filosofia
Renzo Montagnoli
26 Luglio
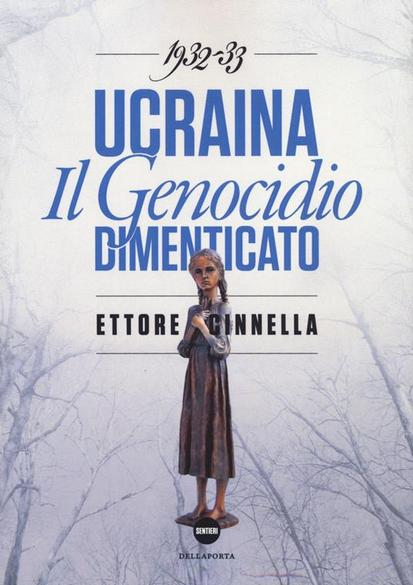
Ucraina. Il genocidio dimenticato (1932-1933)
di Ettore
Cinnella
Della
Porta Editore
Storia
Morire di fame
Molti non
ne saranno nemmeno a conoscenza, altri avranno una vaga idea, altri ancora,
pochi in verità, sanno esattamente di che si è trattato e che cosa rappresenti
l’Holodomor, termine strano che deriva dall’unione di due parole in lingua
ucraina, holod (fame, carestia) e moryty (uccidere, affamare). In pratica con
questo vocabolo si identifica la volontà di far morire di fame, una crudeltà
inaudita, incredibile, eppure verificatasi nell’Unione Sovietica negli anni
1932 e 1933, in particolar modo in Ucraina. Quanti furono i morti? Si tratta
di una cifra difficilmente quantificabile, ma che nel libro Cinnella fa
ascendere a non meno di sei milioni, di cui quattro milioni nella sola
Ucraina, e il resto soprattutto in Kazachistan. Come è possibile però che
così tanta gente sia morta per fame? Ci fu veramente intenzionalità?
Ucraina il Genocidio dimenticato risponde a queste domande. In
particolare i prodromi della tragedia risiedono nella volontà di Stalin di
procedere a tappe forzate nella realizzazione del comunismo e quindi in campo
agricolo nella collettivizzazione delle colture e degli allevamenti. In un
paese in cui i contadini erano passati da poco dalla figura di servi della
gleba propria dell’epoca zarista a quella di piccoli proprietari delle terre
destinate all’agricoltura l’imporre di colpo l’abbandono di questa attività in
proprio per prestare pressoché gratis la stessa in un kolchoz o in un sovkhoz
non poteva che portare a una forte opposizione; fra l’altro proprio negli anni
1932 e 1933 ci fu un minor raccolto e della circostanza trasse profilo il
dittatore georgiano per privare della totalità dei prodotti della terra e
degli allevamenti questi ribelli che in tal modo nulla avevano da mangiare. Il
libro, scritto da uno storico e sulla base di dati inoppugnabili, descrive
questa immensa tragedia, con la gente che, colpita da inedia, lentamente
moriva, oppure, impazzita, si dava al cannibalismo, uccidendo e cucinando i
propri congiunti. Il mondo in parte sapeva, ma nulla fece per portare soccorso
a questi infelici, tanto più che il governo sovietico faceva di tutto per
nascondere questa orrenda verità, mostrando ai rari visitatori stranieri
cittadini sazi e soddisfatti, una vera e propria rappresentazione teatrale.
Poco a poco, decimati dalla fame, persa perfino la volontà di rivendicare
un’entità nazionale, gli agricoltori ucraini si assoggettarono, andando a
lavorare nelle fattorie statali per poco e niente e accontentandosi di vivere
con la casa rurale, un piccolo appezzamento di terreno e qualche animale per
“gentile” concessione del regime sovietico. La storia dimostrerà che mentre i
sovkhoz producevano ben poco, le piccole proprietà portarono sui mercati
rionali prodotti che costavano di più di quelli di stato, ma in quantità e
qualità superiori, tali da permettere di vivere ai cittadini dell’Unione
Sovietica.
Quindi
Cinnella con il libro ci fornisce le risposte ai due quesiti, spiegando
esaurientemente come questa immane tragedia sia potuta avvenire e nel contempo
fornendo le prove dell’intenzionalità, perché se è vero che Stalin nulla fece
per determinare la carestia, al contrario mise in atto una politica di
sequestri dei generi alimentari al fine di concretizzare il piano economico
basato sul passaggio accelerato al collettivismo; avrebbe potuto andare in
soccorso, come gli era stato più volte richiesto, ma ha sempre preferito
immettere sul mercato internazionale la gran parte del più ridotto raccolto
per acquisire da un lato la valuta estera necessaria per acquisire i
macchinari indispensabili per la realizzazione di una forte industria, e
dall’altro per affamare gli agricoltori e renderli umili e disinteressati
lavoratori delle fattorie collettive. Questo è stato l’Holodomor, una strage
di stato e quindi si è trattato di un vero e proprio genocidio.
Sulla base della documentazione emersa dopo il
crollo dell'URSS, il libro ricostruisce quei drammatici avvenimenti e spiega
le motivazioni che spinsero Stalin a prendere decisioni così spietate.
E’ probabilmente da quegli anni di orrore che gli ucraini, tesi a rivendicare
la propria identità nazionale, cominciarono a odiare il potere centrale di
Mosca e per estensione i russi, tanto che all’epoca dell’invasione tedesca,
nella speranza anche di poter così ottenere l’indipendenza, molti diventarono
collaboratori dei nazisti, e non pochi addirittura si arruolarono nelle
famigerate SS. Ciò può anche spiegare lo spirito di resistenza che anima gli
ucraini che si oppongono con tutte le loro forze all’attuale invasione russa.
Del resto le esperienze del passato si manifestano sempre nel presente ed è
per questo anche che si studia la storia, che si è sempre detto che è maestra
di vita, ma, visti i continui errori, c’è da dubitare sulle capacità di
apprendimento degli allievi.
Da
leggere per sapere e comprendere il perché del presente.
Nato a
Miglionico (Matera) nel 1947,
Ettore Cinnella
è stato allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha insegnato molti
anni Storia contemporanea e Storia dell’Europa Orientale all’Università di
Pisa. Dopo il crollo del regime comunista nell’URSS, ha lavorato spesso a
Mosca nell’ex Archivio centrale del partito comunista (oggi Archivio statale
russo di storia politico-sociale, RGASPI). Ha scritto saggi di storia
contemporanea, storia della storiografia, letteratura greca, storia della
Russia e dell’Unione Sovietica. I suoi ultimi libri sono 1905. La vera
rivoluzione russa (2008), Carmine Crocco. Un brigante nella grande
storia (2010 e 2016), 1917. La Russia verso l’abisso (2012),
L’altro Marx (2014), Ucraina 1932-1933. Il genocidio dimenticato
(2015), tutti usciti per i tipi di Della Porta editori.
Renzo Montagnoli
20 Luglio
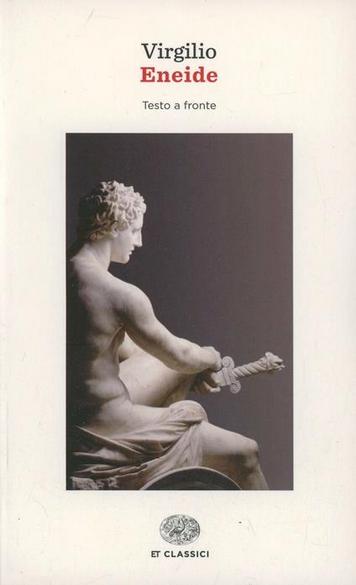
Eneide.
Testo
latino a fronte
di Publio
Virgilio Marone
Edizioni
Einaudi
Poema
Il mito
dell’origine di Roma
Dopo
Bucoliche, prima opera di natura prettamente intimistica, e la successiva
Georgiche, di carattere didascalico, Eneide è l’ultimo e
più importante lavoro di quello che, senza enfasi, può essere definito il più
grande poeta latino. Fu commissionata dall’imperatore Augusto che desiderava
che le origini del suo grande dominio non trovassero riscontro in un popolo di
rozzi bifolchi insediato secoli prima sul Tevere, ma che alla base ci fosse
qualcosa di più importante, di mitico; è per questo scopo che nacque l’Eneide,
un’opera che potrebbe sembrare la naturale continuazione, dal punto di vista
dei perdenti, della famosa Iliade, e che fu scritta in un arco di tempo che va
dal 31 a.C. al 19 a.C.. Con una notevole dose di fantasia Virgilio narra della
fuga da Troia in fiamme di Enea, il figlio di Anchise, del suo peregrinare per
mare in cerca di un nuovo lido in cui approdare fino a giungere alle coste del
Lazio, diventando così di fatto il primo antenato del popolo romano.
Il poema,
piuttosto corposo, si compone di dodici libri, dal primo in cui Enea assiste
alla rovina di Troia e salpa con la sua flotta verso terre ignote, all’ultimo,
in cui Turno, re dei Rutili, viene sconfitto in duello dall’eroe troiano,
rendendo così possibile agli esuli di stabilirsi definitivamente nel Lazio.
Per quanto ovvio, il capostipite di un popolo che diventerà padrone del mondo,
e cioè Enea, progenitore putativo di Augusto, racchiude in sé le più alte
doti, e cioè l’onestà, il coraggio, la giustizia, la lealtà, la pietas (intesa
come devozione nei confronti delle divinità e rispetto degli altri uomini), la
pazienza e un elevato senso civico, dai quali deriva l’esaltazione dei valori
del cittadino romano, che le ripetute guerre fratricide avevano oscurato e che
il primo imperatore si era imposto di far nuovamente trionfare.
L’Eneide,
scritta in esametri dattilici, una metrica complessa, ma capace di rendere più
gradevole l’opera all’ascolto, è stilisticamente perfetta ed esalta, oltre
alle origini di Roma, l’abilità del suo autore, che fa ricorso a diverse
figure retoriche, quali l’allitterazione, capace di aggiungere armonia ad
armonia, e la difficile assonanza, rivelando, sempre che ce ne fosse bisogno,
data la genialità di Virgilio, capacità tecniche ancor oggi ritenute
eccezionali.
Tuttavia
il fato volle che l’opera non potesse essere completata, perché l’autore, di
ritorno da un viaggio in Grecia, giunto al porto di Brindisi, morì
probabilmente per un colpo di sole. La leggenda vuole che, sentendo
l’approssimarsi della fine, abbia raccomandato ai suoi compagni di studi
Plozio Tucca e Vario Rufo di distruggere il manoscritto, ma i due avrebbero
disobbedito, consegnando l’opera all’imperatore. Del resto, per quanto
leggendo l’Eneide ci si accorga che si tratta di un lavoro non ultimato, la
sua bellezza stilistica, la creatività profusa, la profondità di quanto
esposto, tenendo presente la finalità, resta sempre un unicum di
elevatissimo valore, alla pari con l’Iliade e l’Odissea. E di ciò se ne
accorse Augusto, che già aveva avuto occasione di leggerne gran parte in
anteprima, con Virgilio ancora vivente; l’imperatore ne fu talmente
soddisfatto da farla diventare, ufficialmente, il poema nazionale. Era passato
molto tempo da quando il poco ciarliero poeta mantovano si era rivelato con
Bucoliche, riconfermandosi con Georgiche, ma nemmeno lui avrebbe
potuto immaginare che quell’Eneide, a cui aveva dedicato il lavoro di gran
parte della sua vita, l’avrebbe consacrato come il più grande fra i grandi, al
pari del greco Omero, e che, come le opere di quest’ultimo, anche la sua
ultima fatica sarebbe diventata materia di studio nei programmi scolastici.
Da
leggere per chi non la conoscesse, da rileggere per chi l’ha studiata a
scuola, perché l’Eneide è un’esperienza nuova ogni volta, sia la prima che le
successive.
Publio Virgilio Marone (Andes,
15 ottobre 70 a.C – Brindisi, 21 settembre 19 a.C.).
Opere principali: Bucoliche, Georgiche, Eneide
Renzo Montagnoli
14 Luglio
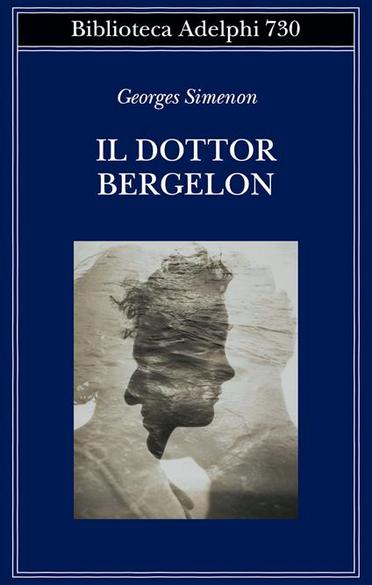
Il dottor Bergelon
di Georges Simenon
Edizioni Adelphi
Narrativa
Un uomo senza qualità
Con Il dottor Bergelon si parte da un caso di malasanità,
provocato dall’assoluta indifferenza di chi dovrebbe salvaguardare una vita e
invece non fa il suo dovere. Che poi il dottor Malin e il dottor Bergelon
nella circostanza siano ubriachi non è di certo un’attenuante, bensì
un’aggravante, perché la deontologia professionale imporrebbe a due medici la
sobrietà e la disponibilità, requisiti che nel caso del parto travagliato di
una giovane donna sono stati talmente assenti, che non solo in nascituro è
morto subito, ma che ha comportato anche il decesso della puerpera. Si dà però
il caso che il vedovo non sia d’accordo sulla giustificazione di comodo circa
l’impossibilità di salvare il bimbo e la madre e che dia inizio a una sottile
vendetta, prendendo soprattutto di mira chi ha meno colpe (il dottor Bergelon),
ma che appare per le sue caratteristiche l’ideale capro espiatorio. Inizia
così per il medico in questione, che già vive un’esistenza grigia, un periodo
di grande difficoltà, fra lettere minatorie e incontri per la strada non
proprio amichevoli. Che fare? La decisione è quella di sparire, di cambiare
vita, magari senza riuscirci, ma almeno per non essere passivo ed esperire
così questo estremo tentativo. La sua sembrerebbe una fuga senza speranza, ma
quasi all’improvviso il vedovo smette di perseguitarlo, dicendogli in un
incontro ravvicinato che ha trovato nuove motivazioni per vivere ed è così che
Bergelon rinuncia alla possibilità di mettersi alla prova ricominciando da
zero, perché torna a casa, dalla moglie e dai figli, e al suo grigiore
quotidiano, in una vicenda in cui domina, per colpa del protagonista, uno
squallore disarmante.
Che Simenon sia capace di aprire l’animo umano, di fare un’analisi psicologica
approfondita è una qualità che non gli fa difetto ed è notoria; questa volta,
però, ha a che fare con un personaggio che è un incompiuto: si è innamorato di
sua moglie senza particolare trasporto, come se fosse una routine giornaliera,
fa il medico di quartiere come un impiegato che timbra il cartellino, ha
un’attrazione per una prostituta che guarda caso è l’amante di Cosson (il
vedovo), ha una relazione occasionale in villeggiatura al mare con una donna
con un figlio, rifiuta a un amico un’offerta di lavoro che gli consentirebbe
di togliersi di dosso quell’abito di mediocrità che da sempre l’accompagna.
Insomma, il dottor Bergelon si lascia trascinare dalla vita, non ha rimorsi e
nemmeno gioie, vegeta, si potrebbe dire, ed è lì l’origine dello squallore.
Descrivere la psicologia di un individuo così è difficile e non è facile
nemmeno per un narratore come Simenon, tanto che riesce solo in parte nello
scopo, un risultato tuttavia che influisce relativamente sulla gradevolezza
della lettura. Non sarà il miglior romanzo di Simenon, o uno dei suoi
migliori, ma resta il fatto che chi legge non può che apprezzare, provando
anche un senso di repulsione per quell’uomo senza qualità che è il dottor
Bergelon.
Georges Simenon (Liegi,
13 febbraio 1903 – Losanna, 4 settembre 1989). Romanziere francese di origine
belga. La sua vastissima produzione (circa 500 romanzi) occupa un posto di
primo piano nella narrativa europea.
Grande importanza ha poi all'interno del genere poliziesco, grazie soprattutto
al celebre personaggio del commissario Maigret.
La tiratura complessiva delle sue opere, tradotte in oltre cinquanta lingue e
pubblicate in più di quaranta paesi, supera i settecento milioni di copie.
Secondo l'Index
Translationum, un database curato dall'UNESCO, Georges Simenon è
il quindicesimo autore più tradotto di sempre.
Grande lettore fin da ragazzo in particolare di Dumas, Dickens, Balzac,
Stendhal, Conrad e Stevenson, e dei classici. Nel 1919 entra come cronista
alla «Gazette de Liège», dove rimane per oltre tre anni firmando con lo
pseudonimo di Georges Sim.
Contemporaneamente collabora con altre riviste e all'età di diciotto anni
pubblica il suo primo romanzo.
Dopo la morte del padre, nel 1922, si trasferisce a Parigi dove inizia a
scrivere utilizzando vari pseudonimi; già nel 1923 collabora con una serie di
riviste pubblicando racconti settimanali: la sua produzione è notevole e
nell'arco di 3 anni scrive oltre 750 racconti. Intraprende poi la strada del
romanzo popolare e tra il 1925 e il 1930 pubblica oltre 170 romanzi sotto vari
pseudonimi e con vari editori: anni di apprendistato prima di dedicarsi a una
letteratura di maggior impegno.
Nel 1929, in una serie di novelle scritte per la rivista «Détective», appare
per la prima volta il personaggio del Commissario Maigret.
Nel 1931, si avvicina al mondo del cinema: Jean Renoir e Jean Tarride
producono i primi due film tratti da sue opere.
Con la prima moglie Régine Renchon, intraprende lunghi viaggi per tutti gli
anni trenta. Nel 1939 nasce il primo figlio, Marc.
Nel 1940 si trasferisce a Fontenay-le-Comte in Vandea: durante la guerra si
occupa dell'assistenza dei rifugiati belgi e intrattiene una lunga
corrispondenza con André Gide. A causa di un'errata diagnosi medica, Simenon
si convince di essere gravemente malato e scrive, come testamento, le sue
memorie, dedicate al figlio Marc e raccolte nel romanzo autobiografico Pedigree.
Accuse di collaborazionismo, poi rivelatesi infondate, lo inducono a
trasferirsi negli Stati Uniti, dove conosce Denyse Ouimet che diventerà sua
seconda moglie e madre di suoi tre figli. Torna in Europa negli anni
Cinquanta, prima in Costa azzurra e poi in Svizzera, a Epalinges nei dintorni
di Losanna.
Nel 1960 presiede la giuria della tredicesima edizione del festival di
Cannes: viene assegnata la Palma d'oro a La
dolce vita di Federico Fellini con cui avrà una lunga e duratura
amicizia. Dopo pochi anni Simenon si separa da Denyse Ouimet.
Nel 1972 lo scrittore annuncia che non avrebbe mai più scritto, e infatti
inizia l'epoca dei dettati: Simenon registra su nastri magnetici le parole che
aveva deciso di non scrivere più. Nel 1978 la figlia Marie-Jo muore suicida.
Nel 1980 Simenon rompe la promessa fatta otto anni prima e scrive di suo pugno
il romanzo autobiografico Memorie
intime, dedicato alla figlia.
Georges Simenon muore a Losanna per un tumore al cervello nel 1989.
Renzo Montagnoli
9 Luglio
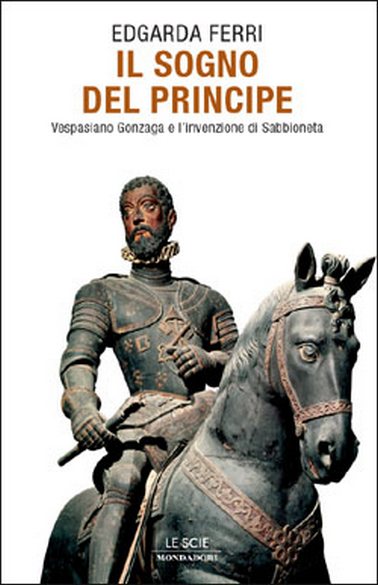
Il sogno del principe.
Vespasiano Gonzaga e l'invenzione di Sabbioneta
di
Edgarda Ferri
Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A.
Storia
biografia
La città ideale
E’ il
mese di febbraio del 1591 e fuori dal palazzo nevica, copiosamente.
Vespasiano Gonzaga, morente, fa un un ultimo sforzo e viene vestito di tutto
punto per dettare al notaio le sue ultime volontà, poi, affranto, si corica,
assistito amorevolmente dalla terza moglie Margherita Gonzaga e a cui si
rivolge con un’ulteriore lascito, cioè il racconto della sua vita. E’ così che
inizia a parlare, a dire tutto, dalla sua nascita a Fondi il 6 dicembre 1531,
primogenito di Isabella Colonna e di Luigi Gonzaga “Rodomonte” fino al suo
ultimo soffio di vita, in un’esistenza tutta dedita a servire il suo Signore
Filippo II di Spagna; del grande monarca fu l’assai fidato consigliere e uomo
d’armi, ripagato da onori e gloria, ma soprattutto con il titolo di Grande di
Spagna e con l’onorificenza del Cavalierato dell’Ordine del Toson d’Oro. Fu un
continuo accorrere alle chiamate del suo re, quasi sempre lontano da casa,
impegnato a costruire fortezze, di cui era un esperto, o a combattere, oppure
ancora ad amministrare grandi territori in qualità di vice re. Il tempo per la
famiglia fu necessariamente poco, eppure riusci a contrarre tre matrimoni, di
cui il primo con Diana Folch de Cardona, che morì nel novembre 1569 in
circostanze poco chiare (con ogni probabilità assassinata da Vespasiano, a cui
erano giunte missive anonime relative a un suo presunto tradimento coniugale,
rivelando un’indole violenta che si sarebbe ancor più manifestata nel 1580
allorché uccise per futili motivi con un calcio all’inguine l’unico figlio
maschio, il quattordicenne Luigi); anche la seconda moglie, Anna Trastamara
d’Aragona, imparentata con il re di Spagna e di salute assai cagionevole,
venne a mancare nel 1567; miglior fortuna ebbe la terza consorte Margherita
Gonzaga, che appunto assistette Vespasiano durante il trapasso, ma che non
riuscì a dargli un figlio (circolarono voci che lei fosse sterile, ma la
verità era che Vespasiano aveva contratto il mal francese, cioè la sifilide,
con tutti i problemi e conseguenze che comporta) . Fra gli onori e la gloria
vi fu anche la nomina, da parte dell’imperatore Massimiliano II d’Asburgo, di
Principe del Sacro Romano Impero, titolo che spettava ai feudatari che
dipendevano direttamente dall’imperatore, il quale già l’aveva gratificato nel
1565 del titolo di Marchese. Completò la sua carriera nobiliare, a chiaro
simbolo del suo prestigio, l’elevazione a ducato del marchesato di Sabbioneta.
Fino a qui è la brillante carriera di un uomo del rinascimento, come non ve ne
furono molti, ma l’importanza di Vespasiano è nell’aver concretizzato un sogno
che possiamo toccare con mano, che è meta di tanti visitatori: la
realizzazione, partendo da un piccolo borgo, di una città rinascimentale
chiamata anche la Piccola Atene. Ai confini occidentali estremi del mantovano,
non lontana dal Po, circondata dalla sua stupenda cinta muraria sorge
Sabbioneta, quell’ideale in cui Vespasiano credette fino in fondo e che lo
sostenne nelle sue lunghe assenze nel corso delle quali trovava il tempo per
progettare la sistemazione architettonica. E mentre lui combatteva in Spagna
contro i moriscos, pietra dopo pietra la meraviglia nasceva, quella che nella
sua mente avrebbe dovuto rappresentare, come in effetti rappresenta, una città
ideale, da stupire il mondo, in cui altri, ma soprattutto lui vivere realmente
un sogno. Qualcuno potrà pensare a un buen retiro, e non sbaglierebbe,
per quanto la definizione sia un po’ riduttiva, perché probabilmente in
Vespasiano allignava la gioia della creazione, il piacere di dire:”questo è
sì mio, ma l’ho realizzato io”.
Edgarda
Ferri è molto brava, scrive delle biografie in cui si ha la sensazione di
essere accanto al personaggio della narrazione, ma forse con “Il sogno
del Principe” si è superata. Si avverte infatti palpabile
l’ammirazione per quest’uomo, per ciò che ha realizzato, per quei tesori di
cultura che ha lasciato e che tutti possono vedere, perché se Mantova vuol
dire Gonzaga e quindi il castello di San Giorgio, il Palazzo Ducale, il
Palazzo Te, Sabbioneta è uno scrigno prezioso che emerge dalle nebbie della
pianura e splende di luce propria.
Da
leggere senza dubbio.
Edgarda Ferri (Mantova,
24 gennaio 1934) vive e lavora a Milano. Scrittrice, saggista, giornalista,
ha pubblicato tra le altre le biografie di Maria Teresa d’Austria, Giovanna la
Pazza, Caterina da Siena, Matilde di Canossa e Piero della Francesca.
Renzo Montagnoli
2 Luglio
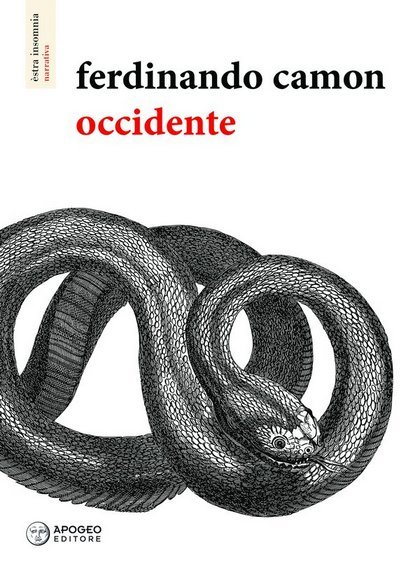
Occidente
di Ferdinando Camon
Apogeo Editore
Narrativa
Perché gli attentati?
Credevo di aver finito anni fa con la lettura di opere di Ferdinando Camon,
anche se in tempi più recenti qualcosa ha pubblicato, romanzi che a definirli
minori può essere eccessivo, ma che se rapportati a La vita eterna
e a Un altare per la madre appaiono quantomeno di minor impegno.
Non ho mancato tuttavia di tributare a essi gli onori che si meritano, perché
in quelle pagine mai viene meno l’impronta dell’autore che sa quel che vuole e
che è capace di renderlo interessante per il lettore. Cosa dicevo? Ah, sì, che
credevo di aver finito di arrovellarmi su nuovi libri di un uomo che, superati
gli ottanta, non dovrebbe avere ancora voglia e spirito per buttarsi a
capofitto in una nuova avventura letteraria, e invece ecco che mi arriva fra
capo e collo Occidente. Il titolo non mi è nuovo – ho pensato,
aggiungendo che probabilmente era una nuova edizione di Occidente. Il
diritto di strage che mi aveva impegnato un po’ prima del Natale del
2009 e per il quale, riflessione dopo riflessione, avevo scritto una
recensione, manco a dirlo, ampiamente positiva. No, mi ha detto Ferdinando, è
lo stesso libro e non lo è, un gioco di parole da mago Zurlì per farmi capire
che non era uguale, soprattutto perché riscritto a mente fredda, non con i
patemi d’animo che avevano accompagnato la stesura dell’altro nei lontani anni
‘70, anni di piombo, quando, per rendersi complicata vita, lo scrittore
padovano aveva iniziato a interessarsi dell’eversione nera, ricavandone
minacce, danneggiamenti, insomma quella che si può definire una vita non
proprio tranquilla. Allora fu un parto indubbiamente sofferto, oggi invece, in
confronto, è stata una passeggiata. Devo dire che la nuova edizione evidenzia
una minor partecipazione emotiva dell’autore, guadagnandone sia in leggibilità
che in comprensione dei propositi alla base del lavoro. Capire la psicologia
di un terrorista non ha solo scopi di curiosità, ma significa conoscere con
chi si ha a che fare, e quindi poter più facilmente arrivare a un’azione di
contrasto. Sono sicuro che se il libro fosse uscito negli Stati Uniti avrebbe
ottenuto il riconoscimento del Premio Pulitzer, e non solo quello pur
importante, ma indubbiamente minore, di giornalista dell’anno. Dopo questa
chiacchierata, che ritengo utile per focalizzare i motivi per i quali Camon ha
deciso di porre mano a un’opera di per sé validissima, penso che forse non
sarebbe sbagliato se ne parlassi ed è quello che adesso farò. Premetto che,
leggendo, si ha l’impressione di entrare in una sorta di limbo, un mondo a sé
stante in cui il terrorista ha una visione dell’esistenza che è completamente
diversa da quella della quasi totalità degli esseri umani, con una ricerca del
razionale per dare inutilmente un senso logico all’irrazionalità; infatti
occorre quasi fare un passo oltre un invisibile ostacolo per cercare di
penetrare nell’assurdità di idee aberranti. In quest’ottica la strage non è
solo una necessità, ma è un diritto ed è grazie a essa che si può pervenire
alla disgregazione del sistema; ne consegue che non può che esistere una
situazione continua e crescente di terrore.
Come è noto il nostro paese anni fa è stato travagliato da un lungo periodo di
attentati, di matrice di estrema destra e di estrema sinistra, che necessita
di una comprensione, per capire il perché, per trovare una giustificazione
logica a un qualche cosa di illogico, per sapere, onde evitare che questi anni
di piombo si possano ancora ripresentare. In questo il libro di Camon è
essenziale, oserei dire indispensabile, anche se è una discesa all'inferno per
cercare di comprendere i motivi di questo orrore e in pratica diventa un
viaggio nell'incubo, nella follia di menti che, prive di senno, hanno con le
loro azioni sconvolto un paese e la vita dei suoi abitanti. Non c'è nulla di
più drammaticamente conclusivo dei concetti espressi da Franco, il capo dei
neri, un individuo che teme la morte, anzi il solo pensiero che un giorno
tutto dovrà finire gli rende impossibile la vita; e allora si fa lui portatore
di morte, indiscriminatamente la esporta verso ignari cittadini, ritraendo il
sottile piacere di liberarsi momentaneamente del suo incubo per trasferirlo ad
altri.
Per far questo si
costruisce anche un'idea che sia lo specchio della coscienza, così da
giustificare il suo odio e il suo crimine. In questo mondo ci sono gli eletti
e lui è uno di questi, mentre tutti gli altri sono comparse inutili, o meglio
sono utili quali vittime sacrificali per la purificazione di un sistema in cui
l'apoteosi è solo il senso di onnipotenza del carnefice, in una convulsione di
egocentrismo che prevede solo la sua esistenza.
E' inutile dire che in
simili individui non esistono né la pietà, né la consapevolezza dei propri
limiti; per loro uccidere diventa così una necessità quale respirare per
vivere e le stragi che pongono in essere non vengono considerate atti
criminosi, trovando giustificazione in una contorta e aberrante filosofia che
non è alla base del loro comportamento, ma è stata adattata appositamente per
fornire una motivazione dello stesso.
In realtà gente come
Franco è il ritratto dell'insoddisfazione per ciò che realmente si è, rispetto
a ciò che si vorrebbe essere, è la figura di frustrati, pavidi e in rotta con
se stessi, ma che trovano sfogo al rancore che li pervade scaricandolo su
altri, del tutto inermi ed incolpevoli, e proprio per questo idonei capri
espiatori.
Camon ci ha fornito un
quadro, un'analisi attenta e apolitica di un movimento, sondando gli aspetti
psicologici dei componenti e mettendo a nudo l'altra verità che è in noi,
quella paura ancestrale che a volte, come nel caso specifico, può portare a
uno stato di follia individuale e collettiva. L'onnipotenza bramata dall'uomo
è quindi il segno manifesto della sua debolezza, l'uccisione di altri, del
tutto innocenti, è rivelatrice di una sete di vendetta per la propria
condizione di immaturità.
Ma il terrorismo è anche
rosso ed ecco allora il narratore che ci parla di Miro che, a differenza di
Franco, non sogna di distruggere una società, ma brama cambiare un sistema, un
fine da raggiungere con qualsiasi mezzo, anche con l'omicidio di coloro che
rappresentano la struttura portante dello stato.
E' una figura in
apparenza solo migliore di quella di Franco, se non altro perché non c'è una
vocazione nichilista, ma anche qui esiste quel diabolico potere - che si
autoalimenta - di poter disporre della vita d'altri, una frenesia che
sconvolge e travolge.
Nel caso di Franco è la
visione dell'individuo che prevale, in quella di Miro invece è quella della
massa, un fiume che avanza e che spezza tutto.
Nel primo si potrebbe
dire che i mezzi sono il fine, nel secondo i mezzi servono a raggiungere il
fine, ma in entrambi è presente un egocentrismo che li porta a considerarsi
superiori a tutti e quindi a decidere anche per gli altri.
Occidente è
un romanzo complesso, ma anche rivelatore, in grado ri rispondere logicamente
al perché di tante illogicità, e proprio per questo assume una valenza
notevole, tale da classificarlo fra le più riuscite opere di Ferdinando Camon.
Ferdinando Camon
é nato nel 1935 in un piccolo paese della campagna veneta. Il suo primo
romanzo, uscito con una prefazione di Pier Paolo Pasolini, è stato subito
tradotto in Francia per interessamento di Jean-Paul Sartre. Nei suoi libri
Camon ha raccontato la crisi e la morte della civiltà contadina (nei romanzi
"Il quinto stato", "La vita eterna", "Un altare per la madre", Premio Strega,
"Mai visti sole e luna", Premio Stazzema, e nelle poesie "Liberare l’animale",
Premio Viareggio, e "Dal silenzio delle campagne"), la crisi che si è nominata
terrorismo ("Occidente"), la crisi che porta in analisi ("La malattia chiamata
uomo", "La donna dei fili", "Il canto delle balene") e lo scontro di civiltà,
con l’arrivo degli extracomunitari ("La Terra è di tutti"). I suoi romanzi più
recenti sono "La cavallina, la ragazza e il diavolo" (2004, Premio Giovanni
Verga) e "La mia stirpe" (2011, Premio Vigevano-Mastronardi). Nel 2019 è
uscito da Ediesse "Tentativo di dialogo sul comunismo", con Pietro Ingrao.
Nello stesso anno Guanda ha pubblicato "Scrivere è più di vivere". Nel 2020
con Apogeo Editore è uscito "A ottant'anni se non muori t'ammazzano". È
tradotto in venticinque paesi. Le sue opere sono pubblicate anche in edizioni
per ciechi, in Italia e in Francia. Nel 2016 gli è stato assegnato il premio
Campiello alla Carriera.
http://www.ferdinandocamon.it/
Renzo Montagnoli
26 Giugno
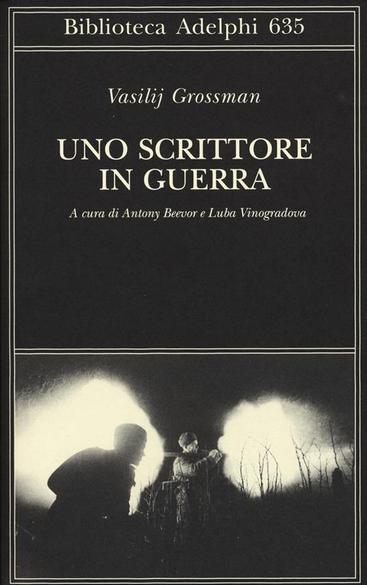
Uno scrittore in guerra (1941-1945)
di
Vasilij Grossman
Edizioni
Adelphi
Storia
La verità, solo la verità
Quando ho
letto Vita e destino, un’opera impegnata e impegnativa sul tema del
bene e del male, ho avuto come una folgorazione, ho avvertito chiaramente che
questo narratore ebreo e di origine ucraina aveva superato quell’invisibile
confine, quasi sempre invalicabile, fra verità oggettiva e verità soggettiva,
quella realtà così difficile da trovare e, soprattutto, da raccontare. Del
resto l’autore si è sempre attenuto scrupolosamente a questo principio: «Chi
scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda, e chi legge ha il
dovere civile di conoscerla, questa verità.» Ed è così che sono nati i suoi
capolavori, che piano piano, ora che è scomparso da tempo, si vanno scoprendo
e vengono portati all’attenzione del mondo dei lettori. E’ anche questo il
caso di Uno scrittore in guerra (1941 – 1945) con cui vengono
narrate, peraltro in presa diretta, i fatti della seconda guerra mondiale sul
fronte orientale. Grossman era inviato speciale di
Krasnaja zvezda
(Stella Rossa), il giornale dell’esercito sovietico, di cui scrisse dalle
prime disastrose fasi che videro la rapida avanzata delle truppe tedesche fino
alla fine del conflitto che lo portò a essere presente in una Berlino
distrutta, una visione apocalittica, la fine ingloriosa della follia nazista.
Dove
c’era un fronte di battaglia Grossman c’era; che si trattasse della sua
Ucraina, di Mosca quasi assediata o di Stalingrado quest’uomo, fuori dai
canoni in tutto (si pensi che non era iscritto al partito comunista),
osservava, intervistava grandi generali e umili soldati, raccoglieva gli
sfoghi e le paure, attraverso la sua penna i soldati sovietici ritrovavano
l’umanità soffocata dalla violenza e anche laddove splendeva l’eroismo - e
per altri trionfava la retorica - lui si limitava a raccontare con un tono
sobrio, senza esaltazioni, solo la guerra, le distruzioni, l’orrore, le
speranze. In questo modo i suoi articoli erano seguiti da un numero via via
crescente di lettori che si identificavano con i personaggi in essi citati,
che vedevano in Grossman uno di loro, non di certo l’esponente del partito che
chiedeva agli altri sacrifici e che poi si prendeva tutti i meriti. La gente
capiva che quell’uomo coraggioso che descriveva con grande efficacia ed
empatia la quotidianità di chi combatteva sapeva parlare con il cuore, sapeva
porgere la verità senza remore e ostacoli. Può apparire incredibile che in un
regime come quello sovietico, soprattutto in epoca staliniana, si potesse
essere pubblicamente sinceri, ma nei posti chiave c’era chi capiva che cosa
volessero i lettori e che questo dovesse essere dato a loro, pur con qualche
taglio di tanto in tanto, per mantenere saldo quel morale, quello spirito
patriottico di cui tanto aveva bisogno un popolo in guerra. Fra l’altro, lo
stile di Grossman è di grande effetto, capace come è di descrivere
poeticamente la bellezza e la serenità della natura, oppure di far piombare
chi legge nell’angoscia più profonda come quando parla del lager di Treblinka,
un’autentica discesa all’inferno.
L’autore,
per i suoi articoli, si serviva delle annotazioni su taccuini, gli stessi che,
opportunamente raccordati e introdotti da una parte propedeutica che tende a
collegare gli uni agli altri, sono stati utilizzati da Antony Beevor e Luba
Vinogradova per scrivere questo libro, un’opera di valore non solo letterario,
ma soprattutto di testimonianza storica di assoluta rilevanza, meritevole
senz’altro di attenta lettura.
Vasilij Grossman (Berdyciv,
12 dicembre 1905 – Mosca, 14 settembre 1964) è stato un giornalista e
scrittore sovietico di origine ebraica.
Diventò ingegnere e dopo essere cresciuto a Ginevra e aver studiato a Kiev,
all'epoca dei piani quinquennali credette talmente nella costruzione dell'
"uomo nuovo" da abbandonare i cantieri minerari del Donbuss, dove lavorava,
per mettersi a raccontare l'epopea dell'Unione Sovietica.
Fu corrispondente di guerra per il quotidiano dell'esercito "Stella
rossa" e seguì il fronte fino alla Germania.
In quel periodo cominciò a comporre una grande opera sulla guerra, incentrata
sulla Battaglia di Stalingrado, e diede alle stampe "Il
popolo è immortale" (1943), esaltazione dei sacrifici sofferti dai
popoli dell'Unione Sovietica durante l'invasione tedesca del 1941.
Tra il 1944 e il 1945 lavorò a un'opera che documentava i crimini di guerra
nazisti nei territori sovietici contro gli ebrei ("Il
libro nero").
Grossman, ebreo sovietico, scrittore e giornalista, conobbe perciò
direttamente le devastazioni della seconda guerra mondiale, la lotta contro i
nazisti, la sconfitta di Hitler quindi l’ascesa di Stalin.
Dopo aver assistito alla campagna antisemita (fra il 1949 e il 1953) si trovò
in dissidio con il regime e cadde in disgrazia.
Così la stesura finale della sua grande opera, Vita e
Destino, venne sequestrata e non avrebbe mai visto la luce se qualcuno
non avesse conservato e fatto pervenire clandestinamente una o due copie a
Losanna, dove fu stampato nel 1980.
Renzo Montagnoli
20 Giugno
BREVI RIFLESSIONI SUL LIBRO
“LA RUSSIA DI PUTIN”
DI ANNA POLITKOVSKAJA

Siamo nel 2022 quindi sono già trascorsi sedici anni dall’assassinio, avvenuto
a Mosca, della giornalista autrice di questo libro. Un assassinio ad oggi
impunito. Raccontare la verità in certi Stati è proibito e si rischia la vita.
Ma chi ama la verità e la libertà di divulgarla sa rischiare anche la vita. Ci
ha lasciato i suoi libri, per fortuna. Prezioso dono.
Fin
dalle prime pagine si può comprendere perché gli argomenti di cui parla la
Politkovskaja non siano stati accolti con favore da qualche potente che,
senza remore, ha deciso di farla tacere per sempre.
Questa è un’opera che non si può leggere tutta d’un fiato in quanto le
citazioni di fatti documentati con le relative date richiedono attenzione e
riflessione particolari. È un testo imbevuto di coraggio e desiderio di urlare
al mondo verità scomode sostituite da deplorevoli menzogne da parte di chi
detiene il potere e lo usa, senza scrupoli di ogni genere, per il proprio
tornaconto.
<Siamo solo un mezzo, per lui. Un mezzo per raggiungere il potere personale.
Per questo dispone di noi come vuole. Può giocare con noi, se ne ha voglia.
Può distruggerci, se lo desidera. Noi non siamo niente. Lui, finito dov’è per
puro caso, è il dio e il re che dobbiamo temere e venerare. La Russia ha già
avuto governanti di questa risma. Ed è finita in tragedia. In un bagno di
sangue. In guerre civili. Io non voglio che accada di nuovo. Per questo ce
l’ho con un tipico čekista sovietico che ascende al trono di Russia incedendo
tronfio sul tappeto rosso del Cremlino>.
Pagina
dopo pagina si percepisce la sofferenza della scrittrice russa nel vedere la
sua gente costretta a subire le più vergognose menzogne senza possibilità di
replica. Perché a subire ingiustizie e menzogne è sempre il cittadino
semplice, che rispetta la legge, paga i tributi allo Stato i cui
rappresentanti, in questo caso, con i loro fedelissimi, hanno raggiunto,
chissà come, un livello di ricchezza da far rivoltare nella tomba i famosi
utopici filosofi Marx ed Engels.
Il
libro della Politkovskaja può essere, a mio parere, anche considerato una
specie di preavviso ai successivi eventi dal 2006 fino ai giorni nostri.
Giorni che sono stati sconvolti dall’inizio di una guerra di aggressione,
voluta dalla Russia di Putin assieme al suo staff, contro uno Stato,
l’Ucraina, che faticosamente aveva raggiunto la democrazia e
l’indipendenza.
Una
guerra che ha colpito il popolo civile indiscriminatamente con distruzione,
morte e atroci sofferenze. Una guerra che certo non ci si aspettava di vedere
in un’Europa moderna e civilizzata. E che certo non lascerà un buon ricordo in
coloro che l’hanno subita, e dalla quale hanno cercato giustamente di
difendersi con ogni mezzo, e in quelli che l’hanno dovuta iniziare in
obbedienza ad ordini superiori. Una guerra, ancora una volta, come tutte le
guerre, vergogna dell’umanità.
Il
coraggio eccezionale di Anna Politkovskaja ci ha lasciato dunque una
testimonianza molto importante riguardo alla vita di quella parte della
popolazione russa che non gode di ricchezza e privilegi. Attraverso le sue
interviste comprendiamo le verità sui comportamenti del potere che, con tutti
i mezzi, cerca di salvaguardare se stesso. Si può solo consigliarne la lettura
così ognuno potrà trarre le proprie conclusioni. Io l’ho apprezzato molto
proprio perché, rendersi conto che c’è ancora qualcuno al mondo che, senza
paura, cerca di contrastare le menzogne e l’arroganza, fa ritrovare la
fiducia nell’umanità degna di questo nome.
E
sono orgogliosa che questo coraggio l’abbia avuto una donna. Perché la forza
della parola non toglie la vita a nessuno, mentre si sa cosa succede con la
forza delle armi…
Ascoltiamola, dunque, questa giornalista amante della giustizia e della
legalità. Magari ci potrà chiarire le idee su come mai qualcuno in Russia, nel
2022 (!) abbia voluto iniziare una guerra assurda ed ignobile che distrugge e
sbrana senza pietà.
-
Giovanna Giordani
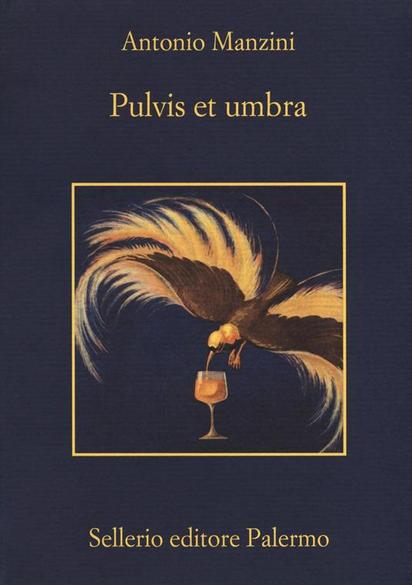
Pulvis et umbra
di
Antonio Manzini
Sellerio
Editore Palermo
Narrativa
Un uomo disperatamente solo
Antonio
Manzini è riuscito indubbiamente a creare un personaggio, perché il
vicequestore Rocco Schiavone ha una sua ben precisa personalità, nel suo campo
è un battitore libero, più propenso ad agire tralasciando le vie gerarchiche e
anche le modalità comuni a tutti i suoi colleghi, magari con un senso della
legge tutto personale, che lo porta anche a commettere qualche reato, ma però
con una grande capacità di risolvere i casi, un pregio che impedisce di fatto
che vengano svolte indagini interne su di lui. Questa sua autonomia, il
modus operandi che gli è proprio, una tristezza di fondo data dalla
prematura scomparsa della moglie lo portano a essere un uomo disperatamente
solo, tradito anche da colleghi e non solo nell’attività professionale, ma
anche negli affetti. Manzini, pur dotato di un’indubbia creatività, alterna
romanzi, con protagonista Rocco Schiavone, di ottimo livello ad altri più
modesti, ma per fortuna questo Puivis et umbra rientra fra i
primi, con due indagini che vengono svolte in parallelo, ad Aosta ove si
ricerca il colpevole dell’omicidio di un transessuale, e a Roma dove in un
campo dei dintorni viene ritrovato il cadavere di un uomo sgozzato, ma con in
tasca un biglietto si cui è riportato il numero del cellulare di Rocco
Schiavone. La trama di entrambi i casi è molto bella, ma lo conclusioni sono
di quelle che lasciano con l’amaro in bocca. Ci sono infatti indagini che non
possono portare a una soluzione, perché entrano poteri dello Stato che
prevaricano il normale corso della giustizia e ce ne sono altre che pur
portando all’arresto del colpevole fanno emergere ipotesi, non campate in
aria, di possibili tradimenti. E al povero Schiavone allora non rimane nulla,
se non la compagnia della sua Lupa e il ricordo, che ogni tanto riaffiora,
della moglie morta, con la quale instaura un dialogo muto che per alcuni
istanti lo fa sentire meno solo. Pulvis et umbra, sì, siamo
tutti polvere e ombra, si vive per arrivare alla morte e questo Rocco
Schiavone riesce a diventare un personaggio che avvince non solo per le sue
abilità investigative, ma anche per il senso della vita, che attraverso di
lui, Antonio Manzini fa emergere. E’ così che le ombre sono i nostri fantasmi,
contro i quali lottiamo, e quando crediamo di averli afferrati ci resta in
mano solo un mucchietto di polvere.
Pulvis et
umbra
è un bel romanzo, che va oltre il genere poliziesco e che merita senz’altro di
essere letto.
Antonio Manzini (Roma,
7 agosto 1964) Attore e sceneggiatore, romano (allievo di Camilleri
all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica), ha esordito nella narrativa con il
racconto scritto in collaborazione con Niccolò Ammaniti per l'antologia Crimini.
Del 2005 il suo primo romanzo, Sangue marcio (Fazi).
Con Einaudi Stile libero ha pubblicato La giostra dei
criceti (2007).
Un suo racconto è uscito nell'antologia Capodanno in
giallo (Sellerio 2012).
Del 2013, sempre per Sellerio, ha pubblicato il romanzo giallo Pista
Nera. Secondo episodio della serie: La costola di
Adamo (Sellerio 2014).
Nel 2015 pubblica Non è stagione (Sellerio), Era
di maggio (Sellerio) e Sull'orlo del precipizio (Sellerio).
Del 2016 è Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (Sellerio).
Altri suoi romanzi pubblicati con Sellerio sono: 7-7-2007 (2016), Pulvis
et umbra (2017), La giostra dei criceti (2017), L'
anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone (2018), Fate
il vostro gioco (2018), Rien ne va plus (2019), Ogni
riferimento è puramente casuale (2019), Gli ultimi
giorni di quiete (2020), Vecchie conoscenze (2021)
e Le ossa parlano (2022).
Renzo Montagnoli
10 Giugno

Storia dei cavalieri templari
di Marco
e Matteo Salvador
Edizioni
Biblioteca dell’Immagine
Narrativa
Quello che è importante sapere
L’Ordine
dei Templari fu fondato nel 1129 dal nobile Ugo de Payns, dietro richiesta di
Bernardo di Chiaravalle e alla fine della prima crociata, con lo scopo di
proteggere i luoghi santi e i pellegrini con l’uso anche delle armi, una vera
e propria novità visto che si trattava di monaci soldati. Fra alterne vicende
furono in auge fino al 1307, quando iniziò un processo a carico degli aderenti
promosso dal re di Francia Filippo IV che intendeva, come effettivamente fece,
incamerare le cospicue ricchezze dell’ordine per rimpinguare le ormai vuote
casse dello Stato; l’ordine fu poi sospeso amministrativamente dal pontefice
Clemente V che agì così, pur consapevole dell’insussistenza delle accuse alla
base del processo, al fine di evitare uno scisma nella chiesa cattolica. Fra
abiure e condanne a morte i confratelli superstiti confluirono in un altro
ordine, quello dei cavalieri Ospitalieri.
Di questi
monaci soldati parla questo libro, uscito nel marzo c.a., quindi dopo la morte
di Marco Salvador avvenuta il 16 febbraio e dispiace ulteriormente sapere che
non ha potuto vederlo pubblicato, tanto più che non si tratta di un’opera
minore, ma di un lavoro di notevole interesse come tutti quelli dell’autore
friulano. Certo che non è facile pensare come un così lungo periodo storico
(circa due secoli), denso di avvenimenti, possa essere raccontato in sole 180
pagine, eppure i Salvador (è coautore il figlio Matteo) ci sono riusciti e
molto bene, grazie a uno stratagemma, vale a dire parlare solo dei fatti
ritenuti più rappresentativi e più importanti. Non solo, ma per introdurre
meglio il discorso il libro inizia con un prologo in cui è descritta la fine
dei tre più importanti rappresentanti dell’ordine, cioè Ugo de Painard, già
ispettore di Francia, che morirà per le torture subite, Goffredo de Gonneville,
a suo tempo precettore di Poitu-Asquitania e il Gran Maestro Giacomo de Molay.
Questi ultimi due periranno invece su un rogo allestito in un’isola della
Senna il 18 marzo 1314. Indi si prosegue con gli albori dell’ordine, il
viaggio del fondatore in occidente per reclutare volontari e trovare
finanziamenti; a seguire l’assedio di Ascalona con la morte del Gran Maestro
Bernard de Tremely, la disfatta di Hattin, con il trionfo dei Saraceni, la
crociata senza gloria di Federico II, la decadenza e la perdita della Terra
Santa a seguito della presa di Acri, le trame ordite da Filippo IV per
impossessarsi delle ingenti ricchezze dell’Ordine, gli ultimi anni del Gran
Maestro prima di finire sul rogo e la politica adottata dal Pontefice Clemente
V per non inimicarsi il re di Francia. Insomma, c’è tutto quello che serve per
conoscere, se non approfonditamente, ma logicamente la storia dei Templari.
Tuttavia gli autori hanno ritenuto di aggiungere un’appendice, soprattutto per
far comprendere l’interesse attuale per quest’Ordine, interesse che in realtà
inizia già nel XVIII secolo, cioè dopo ben quattrocento anni dal suo
scioglimento. Successivamente è tutto un fiorire di romanzi con protagonisti
questi cavalieri, prose che spesso sono opera solo di pura fantasia, ma che
attraggono per l’alone di mistero, probabilmente dovuto alla tragica fine
dell’ordine. Completa il tutto un viaggio pittorico in alcuni dei luoghi in
cui i cavalieri operarono; si tratta di dipinti, molto belli, di David Roberts
realizzati nel 1838 e nel 1839 nel suo lungo viaggio in Terra Santa e in
Egitto.
Storia
dei Cavalieri Templari
si fa
apprezzare anche perché le vicende narrate sono come quelle effettivamente
avvenute, lasciando poco spazio alla creatività, ma con uno stile sobrio che
privilegia l’immediatezza e che pertanto avvince il lettore.
Marco
Salvador ci ha lasciato con un’altra opera di grande valore, la cui lettura
non può che essere vivamente raccomandata.
Marco Salvador
(San
Lorenzo, 10 novembre 1948 – San Lorenzo, 16 febbraio 2022).
La narrativa di Salvador, sia essa di
ambientazione storica sia d'impegno civile, ha una costante: la critica, alle
volte feroce, al potere quando questo è sopraffazione o finalizzato unicamente
a soddisfare personali ambizioni e interessi. Il tutto con una scrittura agile
eppure intrigante sia nella prosa sia nella trame, in grado di non annoiare il
lettore neppure trattando tematiche complesse. Le sue opere hanno ottenuto
ottime critiche, traduzioni in varie lingue e numerosi riconoscimenti. A prova
dell'accuratezza delle ambientazioni e ricostruzioni storiche, gli è stato
assegnato il più prestigioso premio per la divulgazione storica: il Premio
Riccardo Francovich, nel 2013.
Opere
Il Longobardo (Piemme, 2004) con cui ha vinto il "Premio Città di Cuneo per il
primo romanzo", è un romanzo
storico ambientato
nel VII
secolo e
che ha come protagonista il re Rotari prima
della sua salita al trono. ISBN
88-384-8192-X
·La casa del quarto comandamento (Fernandel
2004) narra la storia, i sentimenti e i pensieri di Martino, un settantenne
relegato dal figlio in una casa di riposo. Il romanzo ha avuto due diverse
trasposizioni teatrali e i diritti sono stati acquistati per una fiction RAI. ISBN
88-87433-49-6
·La vendetta del Longobardo (Piemme 2005) è un
secondo romanzo
storico ambientato
nell'VIII
secolo,
che narra le vicende di Evaldo, un franco che
dopo la deposizione dell'ultimo re merovingio Childerico
III ad
opera di Pipino
il Breve,
si rifugerà alla corte longobarda del
re Desiderio.
·L'ultimo longobardo (Piemme 2006) è l'ultimo romanzo storico del trittico
longobardo, ambientato nel periodo detto "pornocratico" quando crolla l'ultimo
dominio longobardo a Benevento, e Marozia regna su Roma e dà origine alla
leggenda della papessa Giovanna.
·Il maestro di giustizia (Fernandel 2007) narra una storia d'amore costretta a
confrontarsi con la "dignità" del dolore e l'eutanasia. ISBN
978-88-87433-87-6
·La palude degli eroi (Piemme 2009), si tratta di un romanzo
storico ambientato
nel XIII secolo e riguarda le vicende della fase finale del dominio di Ezzelino
da Romano e
segue le peripezie di un suo seguace scampato alla disfatta della famiglia Da
Romano.
·L'educazione friulana (Edizioni Biblioteca dell'Immagine 2010), è stato definito un "amarcord
friulano, colmo di ironia e di amore".
·L'erede degli dei (Piemme 2010) [[romanzo storico]] ambientato nel XIV sec.
racconta le vicende di Corrado Da Romano, erede di Ezzelino da Romano e
consigliere di Cangrande
I della Scala.
·Il sentiero dell'onore (Piemme 2012) ultimo capitolo del trittico su Ezzelino da Romano
e i suoi discendenti. Ambientato nel Patriarcato di Aquileia nel corso di un
secolo e mezzo sino agli inizi del XVI secolo.
·Il trono d'oro (Piemme 2013) un affresco sulla grandezza e sullo splendore
dell'Italia meridionale al tempo del principato longobardo di Salerno –
Benevento.
·Processo a Rolandina (Fernandel 2017) la storia vera di un intersessuale condannato
al rogo nella Venezia del XIV secolo. Trasposizione teatrale nel 2021.
·Lapis Lydius, (a cura del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Volturnia
2018) gli intrighi tra monaci Franchi e Longobardi nell'abbazia di S. Vincenzo
al Volturno.
·Una saga Veneziana (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2019). La storia di una
famiglia emigrata a Venezia da Firenze al principio del '300. Una saga nella
quale le vicende personali e famigliari si mescolano a quelle della
Serenissima e fanno rivivere al lettore la quotidianità di nobili, mercanti,
armatori e popolani durante il periodo di massima potenza della città.
·Castelli Friulani (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2020). Due volumi sul
castelli del Friuli e il loro territorio, in collaborazione con Matteo
Salvador e illustrati da Pierfranco Fabris.
·Storia
dei cavalieri templari (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2022), in
collaborazione con Matteo Salvador.
Fonte Wikipedia
Matteo Salvador è Laureato in Economia Aziendale, ma le sue autentiche passioni
sono la storia delle fortificazioni (dai castelli medievali alle strutture
difensive degli ultimi conflitti mondiali), la tutela e la protezione
dell’ambiente soprattutto nella destra del Tagliamento, la fotografia.
Opere:
·Castelli Friulani (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2020). Due volumi sul
castelli del Friuli e il loro territorio, in collaborazione con Marco Salvador
e illustrati da Pierfranco Fabris.
·Storia
dei cavalieri templari (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2022), in
collaborazione con Marco Salvador.
Renzo Montagnoli
5 Giugno
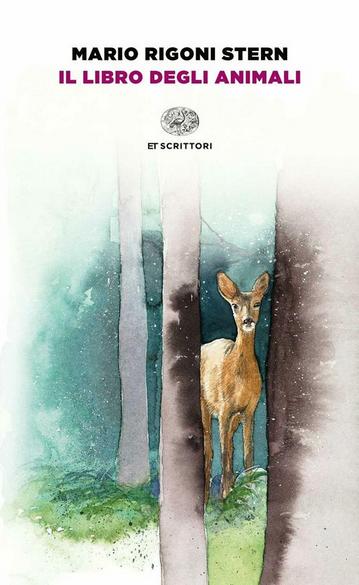
Il libro degli animali
di Mario
Rigoni Stern
Edizioni
Einaudi
Narrativa
Il rispetto per la natura
E’ noto
il profondo amore di Mario Rigoni Stern per la natura, un amore che è dato da
uno scrupoloso rispetto della stessa, in tutte quelle che sono le sue
manifestazioni, dal suo variare nelle stagioni agli animali che ci circondano.
Quello però che è per lui l’attrazione maggiore, il punto di riferimento che
avvince, con i suoi silenzi, con i suoi misteri, con gli esseri che lo
abitano, è il bosco. Con Mario Rigoni Stern gli alberi non sono semplici
vegetali, sono protagonisti dell’esistenza al pari degli uomini, ma quelli che
più di tutti appaiono in sintonia con lui sono gli animali, dai cani ai galli
cedroni, ai caprioli. Nel leggere i racconti di questa raccolta ci si accorge
come un uccello, o un cane, o comunque qualsiasi altra creatura finisca con il
diventare personaggio di sicuro interesse al pari certi uomini. Non ci si può
non emozionare nel leggere di Alba e di Franco, due cani da caccia quasi
leggendari, bravi e intelligenti, oppure del capriolo nato sotto la pioggia
del temporale, fra tuoni e fulmini che hanno temporaneamente allontanato la
madre, ma che la bontà di alcuni taglialegna gli permettono di superare
indenne le difficili prime ore di vita e di seguire poi la genitrice che verrà
a prenderlo quando smette di piovere. Ma ci sono anche storie di api, di
sciami che lo spirito di osservazione di Rigoni Stern, unitamente alla sua
passione per l’apicultura, diventano un vero e proprio trattato di etologia,
interessante, piacevole e facile da leggere. E fra tutte queste storie c’è
anche quella di un bosco che muore per colpa di un parassita, però con la
speranza che possa presto rinascere a nuova vita, una resurrezione che
l’autore, dati i tempi non brevi di crescita, paventa, tristemente, di non
poter vedere.
Questi
racconti, di carattere naturalistico, sono frutti delle attente osservazioni
di Rigoni Stern e fra questi c’è una chicca, poiché uno parla di un gufo delle
nevi, una assoluta rarità per l’altopiano, trattandosi di un volatile il cui
habitat è nell’estremo nord dell’emisfero boreale.
E’ bello
conoscere come l’equilibrio della natura sia perfetto e come possa essere
compromesso solo dall’uomo, incapace di rendersi conto di essere parte della
natura e non superiore alla stessa. Il libro degli animali è un
giusto richiamo ecologico a un approccio attento e rispettoso con il mondo che
ci circonda, di cui tutti dovrebbero tenere conto per la salute dello stesso,
e quindi anche nostra.
Da
leggere, più che un consiglio è una raccomandazione.
Mario Rigoni Stern (Asiago, 1 novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008). Scrittore
italiano. Esordì con Il sergente nella neve (1953),
una delle più notevoli testimonianze letterarie della seconda guerra mondiale,
alla quale l’autore partecipò con gli alpini sul fronte russo. Dopo anni di
silenzio Rrigoni Stern è tornato alla narrativa con i racconti Il
bosco degli urogalli (1962) e i romanzi La guerra
della naia alpina (1967), Quota Albania (1967), Ritorno
sul Don (1973), Storia di Tönle (1978,
premio Campiello), emblematica biografia di un solitario montanaro durante la
grande guerra, uno dei suoi esiti più alti. Successivamente, accanto a nuovi
romanzi, L’anno della vittoria (1985) e Amore
di confine (1986), lo scrittore ha pubblicato diverse opere che
testimoniano di una sua crescente adesione al mondo della natura: Uomini,
boschi e api (1980), Il libro degli animali (1990), Arboreto
selvatico (1991). In Le stagioni di Giacomo (1995,
premio Grinzane) ha raccontato i luoghi d’origine. Nella produzione successiva
tornano i suoi temi dominanti: Sentieri sotto la neve (1998), Tra
due guerre e altre storie (2001), Stagioni (2006),
I racconti di guerra (2006).
(dall'Enciclopedia della Letteratura Garzanti)
Renzo Montagnoli
31 Maggio

Sorgo rosso
di Mo Yan
Edizioni
Einaudi
Narrativa
Quasi un poema epico
Mi corre
l’obbligo di una premessa che ritengo indispensabile, soprattutto per chi ha
conoscenze botaniche limitate come nel mio caso, tanto che non sapevo
assolutamente cosa fosse e come fosse il sorgo. E’ un cereale simile al mais
con un fusto che può arrivare anche a tre metri d’altezza e che in autunno, a
completa maturazione, assume un bel colore rosso. Per quanto possa essere
indicato per l’alimentazione umana e del bestiame nel libro di Mo Yan viene
utilizzato per produrre una bevanda alcolica, una specie di vino.
Ciò
premesso, passo a quest’opera la cui lettura non è certo facile, ma che per
molti versi è possibile definire affascinante. Innanzi tutto il libro è dato
dall’unione di 5 romanzi, ognuno suddiviso in capitoli, e per la precisione e
completezza intitolati, rispettivamente, Sorgo rosso, Vino di sorgo,
Le vie dei cani, Il funerale del sorgo e Pelli di cane.
Sebbene non mi piaccia fornire anticipazioni della trama - nel caso specifico
piuttosto complessa ricorrendo parecchie volte, forse anche troppe, ai
flashback - è tuttavia indispensabile che fornisca alcuni brevi cenni per
comprendere di che si tratta. Si parla dell’epopea, quasi una saga, di una
famiglia di produttori di vino di sorgo in un arco di tempo del secolo scorso
che va dal banditismo degli anni Venti alla tremenda invasione giapponese
degli anni Trenta e Quaranta per arrivare grosso modo al periodo
immediatamente prima della Rivoluzioni culturale. C’è un narratore, che è
l’ultimo discendente di questa famiglia, e che racconta le vicende, vere e
proprie gesta, dei suoi nonni e dei suoi genitori. Ogni tanto torna indietro
nel tempo, in genere con abilità, cioè senza ingenerare fastidio, ma qualche
volta l’autore si è lasciato prendere la mano e allora diventa difficile fare
i necessari raccordi. Comunque è scritto in modo magnifico, alternando
sapientemente, a pagine di notevole violenza, altre in cui la natura provvede
a portare in chi legge un profondo senso di serenità. In particolare ho
trovato una notevole capacità nel descrivere scene di battaglia, quasi come se
davanti ai nostri occhi scorresse un film, ma dove si supera Mo Yan è proprio
nella descrizione della natura, tanto che i campi di sorgo rosso che
ondeggiano al vento, le acque del fiume che scorrono vicino e i tramonti che
paiono pennellate sapienti di un pittore espressionista finiscono con il
diventare un palcoscenico atto a smorzare gli orrori dei combattimenti, fanno
vibrare il cuore del lettore, che, impietrito dalla follia sanguinaria degli
uomini, ritrova il sentiero che lo riconduce a una vita più tranquilla, nella
consapevolezza che noi non siamo altro che ignari attori di quella grande
commedia che è la vita.
Di fronte
alle emozioni che l’opera può suscitare i piccoli aspetti negativi dati da
qualche flashback non raccordato benissimo diventano inezie, tanto è il
piacere di immergersi in una narrazione che stupisce e avvince come poche.
Forse non
è un caso se dall’opera è stato tratto un film, con lo stesso titolo, e con la
regia di Zhāng Yìmóu che si è aggiudicato
L’orso d’oro al Festival di Berlino del 1988, così come non deve stupire che
l’Accademia delle Scienze di Stoccolma abbia conferito a Mo Yan il Nobel per
la letteratura nel 2012.
Il mio
consiglio è di leggerlo senza fretta, di assaporare pagina per pagina il gusto
di un’opera che non ne ha forse l’ambizione, ma che si riallaccia idealmente
ai grandi poemi dell’antichità, con un tono epico in cui si integra benissimo
qualche richiamo al fantastico, tanto che più d’uno ha ritenuto di accostarla
a Cent’anni di solitudine del colombiano Gabriel Garcia Marquez.
Se la
Cina può ancora sembrare un paese molto lontano, nonostante da tempo risulti
più facilmente accessibile, fa piacere che da esso sia arrivato uno scritto
capace di unire gli uomini nel nome della grande letteratura, di quella sempre
valida, cioè senza tempo, a dimostrazione che, se tante cose possono
dividerci, l’arte, soprattutto quando è eccelsa come nel caso di Sorgo
rosso, è sempre in grado di affratellarci.
Mo Yan
(1955, Gaomi), pseudonimo dello
scrittore cinese Guan Moye.
Mo Yan significa, «colui che non vuole parlare» ed è una sorta di risposta
scherzosa alla nonna che lo zittiva sempre.
Fondatore del movimento letterario «Ricerca delle radici», è considerato il
più rilevante scrittore cinese contemporaneo.
Dalla sua scrittura evocativa e potente emerge l’anima senza tempo della
grande civiltà cinese, impregnata di poesia, di violenza, di sentimenti
primigeni.
Mo Yan, originario di Gaomi nella provincia dello Shandong, nasce da una
famiglia numerosa di contadini poveri e, dopo aver terminato i cinque anni
delle scuole elementari, smette di studiare.
In principio porta al pascolo mucche e pecore e i suoi rapporti con questi
animali sono più frequenti di quelli con le persone; prova cosí il gusto della
solitudine, ma acquista una profonda conoscenza della natura. Crescendo,
unendosi agli adulti partecipa alle attività lavorative della comunità.
A diciotto anni va a lavorare in una manifattura di cotone, e facendo capriole
tra le balle si riempie di fili.
Nel febbraio del 1976 abbandona il povero e isolato paese natale per
arruolarsi nell'esercito. Fa il soldato semplice, il caposquadra,
l'istruttore, il segretario e lo scrittore.
Nel 1997, congedatosi dall'esercito, inizia a lavorare per un giornale. Nel
frattempo si è laureato presso la Facoltà di Letteratura dell'Istituto
Artistico dell'Esercito di Liberazione Popolare (1984-1986) e ha ottenuto un
Master in Studi letterari e artistici presso l'Università Normale di Pechino
(1989-1991). Inizia a pubblicare nel 1981.
Fra le sue numerose opere narrative, Einaudi ha finora pubblicato Sorgo
rosso ("grandiosa epopea che, attraverso le vicende e gli amori del
bandito Yu Zhan’ao, ritrae a tutto tondo un popolo e la sua terra, sullo
sfondo dei grandi eventi storici: dal banditismo degli anni Venti
all’occupazione giapponese, fino alle soglie della Rivoluzione culturale"), L'uomo
che allevava i gatti (entrambi del 1997), Grande
seno, fianchi larghi (2002, censurato in patria per la crudezza), Il
supplizio del legno di sandalo (2005, "sconvolgente esplorazione d’ogni
forma dell’agonia condotta attraverso un gioco sottile di stili narrativi,
reinterpretati dall’opera cinese classica, che lascia vibrare l’accordo
dissonante dell’eccesso, teso tra il sublime e il mostruoso") e Le
sei reincarnazioni di Ximen Nao.
Nel 2005 gli è stato assegnato il Premio Nonino.
Delle sue undici novelle si ricordano Felicità, Fiocchi
di cotone, Esplosioni, Il ravanello trasparente. Tra i racconti, Il cane e
l'altalena e Il fiume inaridito, che
Einaudi ha pubblicato nella raccolta di racconti L'uomo
che allevava i gatti (2008).
Ha anche scritto opere teatrali e sceneggiature cinematografiche come Sorgo
rosso, Il sole ha orecchie, Addio mia concubina.
Il film Sorgo rosso (con la regia di Zhang Yìmóu)
è stato premiato con l'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino. Il film Il
sole ha orecchie è stato premiato con l'Orso d'Argento al Festival del
Cinema di Berlino.
Nel 2005 gli è stato assegnato il Premio Nonino per la sua intera opera.
Nel 2012 vince il Premio Nobel per la Letteratura con
la seguente motivazione: "who with hallucinatory realism merges folk tales,
history and the contemporary" (con realismo allucinatorio fonde fiabe
popolari, storia e contemporaneità). Nel 2019 con Einaudi esce I
tredici passi.
Fonti: Archivio storico Einaudi, Enciclopedia
della Letteratura Garzanti
Renzo Montagnoli
26 Maggio

Equilibrio
di Gabriele Oselini
Fara Editore
Poesia
La
serenità della natura
Di questo poeta mantovano avevo già
letto le sillogi Piove (Fara, 2011), La mia casa (Fara, 2014) e
Fiori rossi (Fara, 2018), ritraendone una positiva impressione; in
particolare ho potuto apprezzare le tematiche, connesse alla natura, una
natura di certo reale e non idilliaca, per quanto non manchino note che
richiamano una osmosi fra il mondo circostante e l’intima natura dell’autore,
note che senza giungere a far assumere ai versi un alone mistico pur tuttavia
li nobilitano con una rappresentazione intensa e di chiara efficacia. Anche in
Equilibrio ritroviamo argomenti già affrontati, ma esposti in
modo diverso, frutto di più attente osservazioni e di intuizioni più felici (
Memoria - lenti passi cadenzati / e brezza odorosa / sui campi coltivati /
rosso tramonto / sulla spianata / d’argento / un morbido / grigio nebbia /
sfuma anche la memoria ); è appena il caso di far rilevare che a questa
atmosfera quasi rarefatta molto contribuiscono aspetti della natura tipici
della zona di residenza dell’autore, con i campi coltivati e la felice chiusa
finale che accompagna il grigio della nebbia alla memoria che si impigrisce e
viene lentamente meno. Questa immersione nella natura è sempre presente e in
alcuni casi diventa prevalente, tanto da fornire con poche e sapienti
pennellate un quadro d’insieme che non è solo visione, ma è anche atmosfera,
come in Primavera ( Incanto / sonoro / nell’aria / musicata / dagli
uccelli / brillano / i campanili / nascosti a tratti / da brutti edifici / ma
rami / in fiore / di ogni colore / profumano / tenaci / l’aria / della
primavera). E ogni osservazione del mondo circostante determina sensazioni
ed emozioni che Oselini puntualmente riporta ed esterna con i suoi versi. E’
tanto più apprezzabile questa sua capacità di comunicare quanto prova perché
lo fa con semplicità e pertanto il risultato è di particolare efficacia. Del
resto la vita di paese, il Po, fiume imponente e silenzioso che scorre vicino,
i campi coltivati, i filari di pioppi, i colori dell’alba e del tramonto si
riflettono puntualmente nell’autore, determinano gli slanci di creatività,
fanno sì che tutta la sua produzione presenti un filo conduttore che non viene
mai meno. Oselini vede con gli occhi, ma soprattutto con il cuore e riesce a
cogliere quella magia della natura che l’uomo del XXI secolo sembra aver
dimenticato per rincorrere un fatuo benessere (sulla riva del fiume fra
salici e fruscii nembi d’uccelli neri si specchiano nell’acqua grigia l’onda
leggera risucchia nella sabbia avvolgente e sinuosa orme di piedi nudi una
frasca nasconde i pudici sguardi di due giovani amanti ). E’ una
scena incantata che compone un quadro d’insieme in cui, in un mondo quasi
primigenio, l’uomo sembra ritrovare le passioni, gli affetti, con quei pudici
sguardi di due innamorati nascosti da una frasca. Non credo che debba
aggiungere altro, se non l’invito a leggere questa raccolta che, come le altre
dello stesso autore, è capace di infondere un grande senso di serenità.
Gabriele Oselini
(1953) è nato e risiede a Viadana (MN).
Ha conosciuto negli anni ’70 Daniele Ponchiroli, caporedattore della casa
editrice Einaudi, col quale ha intessuto un rapporto di profonda amicizia e
dal quale ha ricevuto numerosi stimoli culturali e umani.
Ha partecipato a diversi concorsi nazionali di poesia. È stato segnalato alla
III edizione del concorso Pubblica con noi di Fara Editore, con cui ha
pubblicato (2005) una selezione di versi all’interno di Antologia
pubblica,
e successivamente le sillogi Specchio (2006), Finito (2008), Piove (2011), La
mia casa (2014)
e Fiori
rossi (
2018). Ha collaborato con l’editore Afro Somenzari di Fuoco
fuochino.
È stato premiato al VII Concorso di poesia Roberto
Fertonani di
Rivarolo Mantovano (2017)
Renzo Montagnoli
21 Maggio
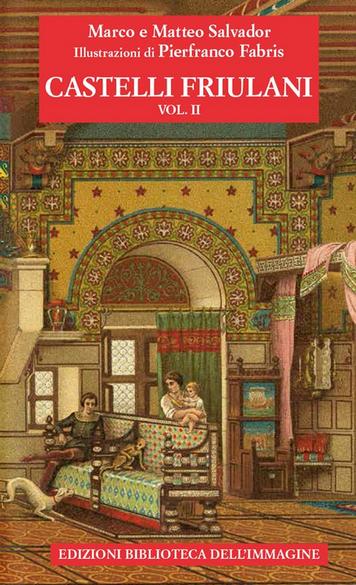
Castelli friulani.
Vol. II
di Marco
Salvador e Matteo Salvador
Illustrazioni di Pierfranco Fabris
Edizioni
Biblioteca dell’immagine
Storia
Sicuramente interessante
Dato il
numero di certo non trascurabile dei castelli friulani per parlarne di tutti è
stato necessario un secondo volume che comprende i rimanenti, vale a dire
quelli di Caneva, Cordovado, Pinzano, Polcenigo,
Porcia, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Toppo, Torre, Valvasone e Zoppola.
Come per il precedente l’esposizione ha carattere preminentemente storico, ma
non trascura anche le indispensabili indicazioni per i visitatori, diventando
così una guida concisa, ma completa. Se queste antiche fortezze potessero
parlare avrebbero da raccontare tante storie, ma poiché sono impossibilitate
per fortuna ci hanno pensato Marco e Matteo Salvador a parlarci di personaggi,
di eventi e anche di leggende, che sempre si accompagnano a queste antiche
vestigia. Sono vicende di dame, di cavalieri, di guerre e anche boccacesche,
come quella che riporto per intero di seguito: “Dopo aver abitato per
alcuni anni a Valvasone, i discendenti di Giovanni Francesco si stabilirono a
Pordenone con un'ottima posizione sociale e una discreta ricchezza. Ciò fino
al 1560, con un Francesco il cui padre aveva sperperato tutto lasciandogli
solo cinquanta ducati. Egli allora si trasferì a Cormons dove le cose gli
andarono di male in peggio. Perciò accolse l'oscena proposta, ma ben pagata
sotto forma di dote, del nobile Giacomo de Casali di Udine: sposarne la figlia
Francesca già ingravidata dal canonico Nicolò de Cassinis, a sua volta figlio
illegittimo del canonico Leonardo e di una monaca di S. Nicolò di Udine, suor
Soave. Francesca, definita dai più gentili come 'donna impudica', partorì da
li a poco una figlia cui fu dato il nome di Leonarda; ma anche a far nascere
la seconda figlia, Costanza, ci pensò il canonico Cassinis così come il terzo
ed unico figlio maschio, Enea, nato quando il povero Francesco era già morto.
Enea, a sua volta, scoperto dal padre naturale Nicolò de Cassinis a svuotargli
il forziere, fu da questi assassinato a pugnalate nel 1546. Allora il
boccaccesco canonico venne rinchiuso nella prigione di Gradisca dove tentò il
suicidio. Trasportato a Cividale, morì poco dopo assistito dalla sua amante
Francesca. “.
Potrei
dire che ce n’è per tutti i gusti, ma soprattutto che è una cavalcata in un
mondo che non c’è più e che ai nostri occhi appare affascinante, ma che
all’epoca doveva essere piuttosto tenebroso. In ogni caso di tratta di una
lettura che accresce culturalmente e che è veramente piacevole, due
caratteristiche che rendono questo secondo volume, come il primo del resto,
particolarmente interessante.
Da ultimo
un cenno doveroso alle riuscite illustrazioni di Pierfranco Fabris, capaci di
mostrare i castelli ammantati da un fascino che sa di magico e di antico.
Marco Salvador
(San Lorenzo, 10 novembre 1948 – San Lorenzo, 16 febbraio 2022).
La narrativa di Salvador, sia essa di
ambientazione storica sia d'impegno civile, ha una costante: la critica, alle
volte feroce, al potere quando questo è sopraffazione o finalizzato unicamente
a soddisfare personali ambizioni e interessi. Il tutto con una scrittura agile
eppure intrigante sia nella prosa sia nella trame, in grado di non annoiare il
lettore neppure trattando tematiche complesse. Le sue opere hanno ottenuto
ottime critiche, traduzioni in varie lingue e numerosi riconoscimenti. A prova
dell'accuratezza delle ambientazioni e ricostruzioni storiche, gli è stato
assegnato il più prestigioso premio per la divulgazione storica: il Premio
Riccardo Francovich, nel 20131.
Opere
Il Longobardo (Piemme,
2004) con cui ha vinto il "Premio Città di Cuneo per il primo romanzo", è un romanzo
storico ambientato
nel VII
secolo e
che ha come protagonista il re Rotari prima
della sua salita al trono. ISBN
88-384-8192-X
·La casa del quarto comandamento (Fernandel
2004) narra la storia, i sentimenti e i pensieri di Martino, un settantenne
relegato dal figlio in una casa di riposo. Il romanzo ha avuto due diverse
trasposizioni teatrali e i diritti sono stati acquistati per una fiction RAI. ISBN
88-87433-49-6
·La vendetta del Longobardo (Piemme 2005) è un
secondo romanzo
storico ambientato
nell'VIII
secolo,
che narra le vicende di Evaldo, un franco che
dopo la deposizione dell'ultimo re merovingio Childerico
III ad
opera di Pipino
il Breve,
si rifugerà alla corte longobarda del
re Desiderio.
·L'ultimo longobardo (Piemme 2006) è l'ultimo romanzo storico del trittico
longobardo, ambientato nel periodo detto "pornocratico" quando crolla l'ultimo
dominio longobardo a Benevento, e Marozia regna su Roma e dà origine alla
leggenda della papessa Giovanna.
·Il maestro di giustizia (Fernandel 2007) narra una storia d'amore costretta a
confrontarsi con la "dignità" del dolore e l'eutanasia. ISBN
978-88-87433-87-6
·La palude degli eroi (Piemme 2009), si tratta di un romanzo
storico ambientato
nel XIII secolo e riguarda le vicende della fase finale del dominio di Ezzelino
da Romano e
segue le peripezie di un suo seguace scampato alla disfatta della famiglia Da
Romano.
·L'educazione friulana (Edizioni Biblioteca dell'Immagine 2010), è stato definito un "amarcord
friulano, colmo di ironia e di amore".
·L'erede degli dei (Piemme 2010) [[romanzo storico]] ambientato nel XIV sec.
racconta le vicende di Corrado Da Romano, erede di Ezzelino da Romano e
consigliere di Cangrande
I della Scala.
·Il sentiero dell'onore (Piemme 2012) ultimo capitolo del trittico su Ezzelino da Romano
e i suoi discendenti. Ambientato nel Patriarcato di Aquileia nel corso di un
secolo e mezzo sino agli inizi del XVI secolo.
·Il trono d'oro (Piemme 2013) un affresco sulla grandezza e sullo splendore
dell'Italia meridionale al tempo del principato longobardo di Salerno –
Benevento.
·Processo a Rolandina (Fernandel 2017) la storia vera di un intersessuale condannato
al rogo nella Venezia del XIV secolo. Trasposizione teatrale nel 2021.
·Lapis Lydius, (a cura del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Volturnia
2018) gli intrighi tra monaci Franchi e Longobardi nell'abbazia di S. Vincenzo
al Volturno.
·Una saga Veneziana (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2019). La storia di una
famiglia emigrata a Venezia da Firenze al principio del '300. Una saga nella
quale le vicende personali e famigliari si mescolano a quelle della
Serenissima e fanno rivivere al lettore la quotidianità di nobili, mercanti,
armatori e popolani durante il periodo di massima potenza della città.
·Castelli Friulani (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2020). Due volumi sul
castelli del Friuli e il loro territorio, in collaborazione con Matteo
Salvador e illustrati da Pierfranco Fabris.
·Storia
dei cavalieri templari (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2022), in
collaborazione con Matteo Salvador.
Fonte Wikipedia
Matteo Salvador è Laureato in Economia Aziendale, ma le sue autentiche passioni
sono la storia delle fortificazioni (dai castelli medievali alle strutture
difensive degli ultimi conflitti mondiali), la tutela e la protezione
dell’ambiente soprattutto nella destra del Tagliamento, la fotografia.
Opere:
·Castelli Friulani (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2020). Due volumi sul
castelli del Friuli e il loro territorio, in collaborazione con Marco Salvador
e illustrati da Pierfranco Fabris.
·Storia
dei cavalieri templari (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2022), in
collaborazione con Marco Salvador.
Pierfranco
Fabris,
nato
nel 1948 a Venezia, dove vive e lavora. Ha esercitato la professione di
architetto per quarant’anni fino al 2015 e da allora si dedica totalmente alla
pittura e all’illustrazione. Ha nel corso degli anni presentato i suoi lavori
in mostre personali e collettive. Per Biblioteca dell’immagine ha pubblicato
“Venezia, il Canal Grande” con Pier Alvise Zorzi, “Pordenone, la Città
Dipinta” con Fulvio Comin, “Trieste, la Città Imperiale” con Nicolò Girardi,
“Le Ville Venete” e “Le Ville Friulane, Istriane e Dalmate” con
Alessandro Marzo Magno.
Renzo Montagnoli
8 Maggio
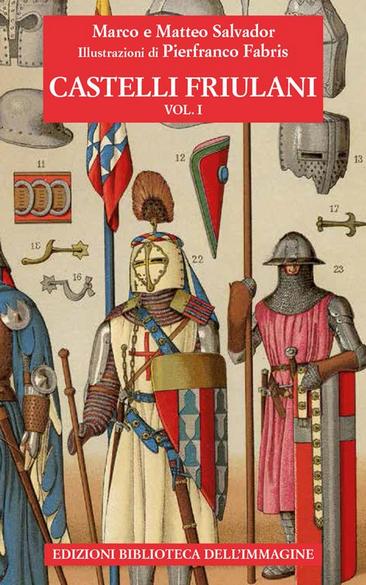
Castelli friulani.
Vol. 1
di Marco Salvador e Matteo Salvador
Illustrazioni di Pierfranco Fabris
Edizioni Biblioteca dell’immagine
Storia
Andar per castelli friulani
Questo libro è stato
scritto per essere anche una guida dei numerosi castelli del Friuli, ma
ricomprende soprattutto preziose annotazioni storiche, in cui non mancano
episodi relativi al loro passato splendore, alcuni dei quali hanno le
caratteristiche della leggenda. Del resto, se la presenza di Matteo Salvador è
garanzia di capace e attenta descrizione delle fortificazioni, la penna di
Marco Salvador è invece l’ornamento prezioso di vicende storiche che
impediscono di considerare queste strutture difensive delle semplici pareti di
pietra e così, nella narrazione, ci è data la possibilità di conoscerne il
passato, di renderli una presenza ancor oggi viva per ciò che hanno
rappresentato secoli fa.
Dal castello di
Ahrensperg a quello di Villalta, passando per molti altri manieri, si finisce
così con il conoscere un po’ la storia del Friuli, di questa terra di
frontiera in buona parte sotto il dominio del Patriarcato di Aquileia.
Nella lettura si avverte
chiaramente la presenza di uno storico di valore, capace di sintetizzare
avvenimenti di rilievo in poche righe, come queste “Il 4 novembre del 1431,
dopo una tenace resistenza degli assediati, Rosazzo venne ripresa dalle
milizie ungheresi le quali, trascorsi ben quattro secoli dalle terribili
scorrerie che avevano portato in Friuli, non dovevano aver perso certe
abitudini: tagliarono infatti la mano destra a tutti i sopravvissuti e
saccheggiarono e devastarono l'intero complesso abbaziale. Alcuni giorni dopo
l'esercito veneziano le affrontò fra Manzano e Cormons, sconfiggendole. A quel
punto scattò la terribile vendetta dei serenissimi, raddoppiata in quanto a
crudeltà: vennero infatti mozzate entrambe le mai agli ungari catturati, e
cavati loro gli occhi. Poco prima che questo fiume di sangue si riversasse nei
territori abbaziali, i monaci benedettini avevano preso la sofferta decisione
di abbandonare il complesso. La politica e le guerre avevano soffocato il
desiderio di dedicarsi a Dio in serenità. “.
Se l’intento dell’opera
è di essere anche una guida per chi vuole visitare queste fortificazioni, il
contenuto va però appunto oltre, tanto che si ha netta l’impressione di essere
presenti davanti alle mura, o ai torrioni, mentre si svolge uno degli eventi
del passato che vengono riportati in luce. Non è che possa sostituire la
visita diretta, che anzi trae ampio giovamento da quanto scritto nel volume,
ma per chi, come me, non avrà occasione di andare in Friuli queste pagine
rappresentano un documento indispensabile per avere almeno un’idea degli
apparati difensivi che caratterizzavano i feudi di questa regione.
Mi corre inoltre
l’obbligo di fare almeno un cenno alle illustrazioni realizzate da Pierfranco
Fabris, perché sono belle e, soprattutto, hanno una patina di antico che le
rendono particolarmente attraenti.
Infine, e a titolo di
ulteriore informazione, preciso che questo primo volume parla delle seguenti
fortificazioni: Ahrensperg, Ariis, Artegna, Cassacco, Castelmonte, Colloredo
di Monte Albano e Mels, Cucagna e Zucco, Moscarda, Osoppo, Partistagno,
Ragogna, Rive d’Arcano, Rosazzo, Strassoldo, Udine, Villalta.
Marco Salvador
(San Lorenzo, 10 novembre 1948 – San Lorenzo, 16 febbraio 2022). La
narrativa di Salvador, sia essa di ambientazione storica sia d'impegno civile,
ha una costante: la critica, alle volte feroce, al potere quando questo è
sopraffazione o finalizzato unicamente a soddisfare personali ambizioni e
interessi. Il tutto con una scrittura agile eppure intrigante sia nella prosa
sia nella trame, in grado di non annoiare il lettore neppure trattando
tematiche complesse. Le sue opere hanno ottenuto ottime critiche, traduzioni
in varie lingue e numerosi riconoscimenti. A prova dell'accuratezza delle
ambientazioni e ricostruzioni storiche, gli è stato assegnato il più
prestigioso premio per la divulgazione storica: il Premio Riccardo Francovich,
nel 20131.
Opere
Il Longobardo (Piemme, 2004) con cui ha vinto il "Premio Città di Cuneo per il
primo romanzo", è un romanzo
storico ambientato
nel VII
secolo e
che ha come protagonista il re Rotari prima della sua salita al trono. ISBN
88-384-8192-X
·
La casa del quarto comandamento (Fernandel
2004) narra la storia, i sentimenti e i pensieri di Martino, un settantenne
relegato dal figlio in una casa di riposo. Il romanzo ha avuto due diverse
trasposizioni teatrali e i diritti sono stati acquistati per una fiction RAI. ISBN
88-87433-49-6
·
La vendetta del Longobardo (Piemme
2005) è un secondo romanzo
storico ambientato nell'VIII
secolo, che narra le vicende di Evaldo, un franco che
dopo la deposizione dell'ultimo re merovingio Childerico
III ad
opera di Pipino
il Breve, si rifugerà alla
corte longobarda del
re Desiderio.
·
L'ultimo longobardo (Piemme
2006) è l'ultimo romanzo storico del trittico longobardo, ambientato nel
periodo detto "pornocratico" quando crolla l'ultimo dominio longobardo a
Benevento, e Marozia regna su Roma e dà origine alla leggenda della papessa
Giovanna.
·
Il maestro di giustizia (Fernandel 2007) narra una storia d'amore costretta a confrontarsi
con la "dignità" del dolore e l'eutanasia. ISBN
978-88-87433-87-6
·
La palude degli eroi (Piemme 2009), si tratta di un romanzo
storico ambientato
nel XIII secolo e riguarda le vicende della fase finale del dominio di Ezzelino
da Romano e segue le peripezie di un suo seguace scampato alla disfatta della
famiglia Da Romano.
·
L'educazione friulana (Edizioni
Biblioteca dell'Immagine 2010), è stato definito un "amarcord friulano, colmo
di ironia e di amore".
·
L'erede degli dei (Piemme 2010) [[romanzo storico]] ambientato nel XIV sec. racconta
le vicende di Corrado Da Romano, erede di Ezzelino da Romano e consigliere di Cangrande
I della Scala.
·
Il sentiero dell'onore (Piemme
2012) ultimo capitolo del trittico su Ezzelino da Romano e i suoi discendenti.
Ambientato nel Patriarcato di Aquileia nel corso di un secolo e mezzo sino
agli inizi del XVI secolo.
·
Il trono d'oro (Piemme
2013) un affresco sulla grandezza e sullo splendore dell'Italia meridionale al
tempo del principato longobardo di Salerno – Benevento.
·
Processo a Rolandina (Fernandel
2017) la storia vera di un intersessuale condannato al rogo nella Venezia del
XIV secolo. Trasposizione teatrale nel 2021.
·
Lapis Lydius,
(a cura del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Volturnia 2018) gli
intrighi tra monaci Franchi e Longobardi nell'abbazia di S. Vincenzo al
Volturno.
·
Una saga Veneziana (Edizioni
Biblioteca dell'Immagine, 2019). La storia di una famiglia emigrata a Venezia
da Firenze al principio del '300. Una saga nella quale le vicende personali e
famigliari si mescolano a quelle della Serenissima e fanno rivivere al lettore
la quotidianità di nobili, mercanti, armatori e popolani durante il periodo di
massima potenza della città.
·
Castelli Friulani (Edizioni
Biblioteca dell'Immagine, 2020). Due volumi sul castelli del Friuli e il loro
territorio, in collaborazione con Matteo Salvador e illustrati da Pierfranco
Fabris.
·
Storia dei cavalieri templari (Edizioni Biblioteca dell’Immagine,
2022), in collaborazione con Matteo Salvador.
Fonte Wikipedia
Matteo Salvador
è Laureato in Economia Aziendale, ma le sue autentiche passioni sono la storia
delle fortificazioni (dai castelli medievali alle strutture difensive degli
ultimi conflitti mondiali), la tutela e la protezione dell’ambiente
soprattutto nella destra del Tagliamento, la fotografia.
Opere:
·
Castelli Friulani (Edizioni
Biblioteca dell'Immagine, 2020). Due volumi sul castelli del Friuli e il loro
territorio, in collaborazione con Marco Salvador e illustrati da Pierfranco
Fabris.
·
Storia dei cavalieri templari (Edizioni Biblioteca dell’Immagine,
2022), in collaborazione con Marco Salvador.
Pierfranco Fabris,
nato
nel 1948 a Venezia, dove vive e lavora. Ha esercitato la professione di
architetto per quarant’anni fino al 2015 e da allora si dedica totalmente alla
pittura e all’illustrazione. Ha nel corso degli anni presentato i suoi lavori
in mostre personali e collettive. Per Biblioteca dell’immagine ha pubblicato
“Venezia, il Canal Grande” con Pier Alvise Zorzi, “Pordenone, la Città
Dipinta” con Fulvio Comin, “Trieste, la Città Imperiale” con Nicolò Girardi,
“Le Ville Venete” e “Le Ville Friulane, Istriane e Dalmate” con
Alessandro Marzo Magno.
Renzo Montagnoli
4 Maggio

Di guerra e di noi
di Marcello Dòmini
Marsilio Editori
Narrativa
Un romanzo storico piacevole e istruttivo
Da un po’
di tempo in Italia si è scoperta la bellezza del romanzo storico, soprattutto
quando a scriverlo è un italiano e relativamente a un periodo abbastanza
recente, in particolare quello che va grosso modo dalla metà del XIX secolo
agli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Sono nate
così opere più o meno interessanti che hanno aiutato e aiutano a cercare una
verità storica, e in questi lavori si inserisce Di guerra e di noi,
scritto da un medico-chirurgo, professore associato dell’Università di
Bologna. Dico subito che si tratta di un romanzo molto avvincente, perché nel
narrare la storia della famiglia Chiusoli, in particolare dei due fratelli
Ricciotti e Candido, non solo vengono rappresentati eventi che vanno dalla
Grande guerra alla fine della seconda guerra mondiale, ma soprattutto si
denota il tentativo di tracciare la biografia di un importante rappresentante
del fascismo, di quel Leandro Arpinati, dapprima ras di Bologna, poi membro
del governo Mussolini, infine caduto in disgrazia tanto da essere inviato al
confino, da cui venne liberato prima del tempo, per metterlo agli arresti
domiciliari nella sua azienda agricola vicino al capoluogo emiliano. Se
Ricciotti è il protagonista principale, Arpinati è il suo mentore, è quasi il
suo padre putativo visto che quello vero è stato ucciso in guerra. In questo
senso appare chiaramente come la figura di maggior prestigio rifletta le sue
caratteristiche peculiari nel più giovane allievo che, in tono minore, ha
un’esperienza analoga, passando dal credo fascista alla resistenza, senza però
ricorrere alla violenza, ma prestandosi con il soccorrere i feriti. Ricciotti
è quel che potrebbe essere definito un moderato e con questo si distingue dal
primo Arpinati, il capo dei picchiatori fino alla marcia su Roma; tuttavia
l’ex capo dello squadrismo bolognese è cambiato, maturando la consapevolezza
degli errori commessi, al punto dall’essere disposto, nei giorni convulsi
della liberazione, a essere processato e a scontare qualche anno di prigione,
e ciò nonostante il suo tardivo ravvedimento che l’ha portato dopo l’8
settembre 1943 a rifiutare incarichi nella Repubblica Sociale Italiana
offertigli da Mussolini e ad appoggiare invece la Resistenza, senza
materialmente combattere. Sappiamo purtroppo come andò a finire, visto che fu
assassinato da alcuni partigiani comunisti insieme al suo ospite da tempo, il
socialista Torquato Nanni. Nel libro Ricciotti è presente all’omicidio e tenta
di impedirlo, ma inutilmente, anzi restando ferito lui stesso ed è l’unico
elemento di fantasia della ricostruzione fatta dal narratore, come del resto
lo è tutta la famiglia Ricciotti, e anche altri attori; però non pochi
personaggi e molti eventi sono reali, nel senso che non sono inventati, ed è
un merito di Dòmini l’avere inserito perfettamente
il frutto della propria creatività nel tessuto storico che contraddistinse
quel periodo, rendendo ancor più credibili i protagonisti di sua invenzione.
Direi che come opera prima è riuscita molto bene e sono pochi gli appunti che
mi sento di fare, come per esempio i periodi, anche lunghi, in dialetto
bolognese (io lo capisco, ma per altri credo che risulti un po’ ostico),
oppure la favola lunghissima, interminabile che Ricciotti racconta alla sera
ai suoi figli e nipoti, atteggiamento comprensibile per fare dimenticare loro
la guerra, meno comprensibile è non averne solo accennato, ma dedicato diverse
pagine che insomma tendono a portare fuori tema.
A parte questi peccati, che mi sento di definire veniali, la creatività
dell’autore, lo stile fluente, la capacità di ricreare l’ambientazione e le
atmosfere sono veramente aspetti qualitativi di tutto rilievo che mi
consentono di caldeggiare la lettura di questo romanzo.
Marcello Dòmini
(Bologna, 1965), medico-chirurgo e professore associato all’Università di
Bologna dal 2004, opera e svolge le sue ricerche nell’ambito della chirurgia
pediatrica. Di guerra e
di noi è il suo primo romanzo.
Renzo Montagnoli
29 Aprile
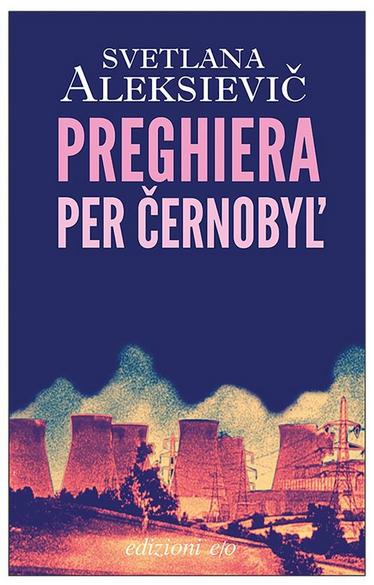
Preghiera per
Cernobyl'
Cronaca del futuro
di
Svetlana Aleksievic
Edizio
E/O
Narrativa
Un
futuro distopico
“Questo libro non parla di Cernobyl’ in quanto
tale, ma del suo mondo. Proprio di ciò che conosciamo meno. O quasi per
niente. A interessarmi non era l’avvenimento in sé, vale a dire cosa era
successo e per colpa di chi, bensì le impressioni, i sentimenti delle persone
che hanno toccato con mano l’ignoto. Il mistero. Cernobyl’ è un mistero che
dobbiamo ancora risolvere... Questa è la ricostruzione non degli avvenimenti,
ma dei sentimenti. Per tre anni ho viaggiato e fatto domande a persone di
professioni, destini, generazioni e temperamenti diversi. Credenti e atei.
Contadini e intellettuali. Cernobyl’ è il principale contenuto del loro mondo.
Esso ha avvelenato ogni cosa che hanno dentro, e anche attorno, e non solo
l’acqua e la terra. Tutto il loro tempo. Questi uomini e queste donne sono
stati i primi a vedere ciò che noi possiamo soltanto supporre... Più di una
volta ho avuto l’impressione che in realtà io stessi annotando il futuro”.
C’è un
capitolo del libro, il secondo, intitolato “Intervista dell’autrice a se
stessa sulla storia mancata”, di cui sopra ho riportato uno stralcio, che
ben esprime che cosa si è proposta Svetlana
Aleksievič quando ha scritto l’opera, perché l’incidente nucleare di Chernobil,
il più disastroso dell’ancor pur breve storia dell’energia atomica, orrendo
nella sua tragicità, ha determinato un superamento del concetto di tempo,
protraendo i suoi nefasti effetti anche negli anni a venire e definendo un
nuovo scalino dell’evoluzione con l’homo chernobiliano. Che cosa è l’uomo
chernobiliano? E’ un povero essere che fisicamente e psichicamente è la
testimonianza vivente di una tragedia che va oltre ogni possibile
immaginazione, tanto che verrebbe da dire che furono fortunati quelli che
morirono nelle prime ore successive all’esplosione del reattore numero
quattro. La conseguenza dell’incidente è stata il rilascio nell’atmosfera di
una quantità abnorme di radionuclidi che hanno contaminato circa 30.000 Kmq.
dei terreni più prossimi e che a distanza di tempo (l’incidente è avvenuto il
26 aprile 1986), in forza del continuo assorbimento, anche se in piccole dosi,
incide sulla salute delle popolazioni dei territori limitrofi con tumori,
ritardi mentali, disturbi nervosi, turbe psichiche e mutazioni genetiche. Non
solo ha avuto serie conseguenze chi era presente quel giorno nell’area che
venne contaminata, ma la maledizione si è estesa anche ai nati
successivamente. Il libro della Aleksievic è a dir poco sconvolgente, con
interviste a povera gente condannata anche per il futuro, con la rassegnazione
di chi sa di avere un marchio indelebile che, prima o poi, si risveglierà dal
letargo con tutta la sua forza provocando dolore e morte. Ma se tutto è stato
colpa di un tragico errore, ben più grave è stata la risposta del regime
sovietico, tutto teso a minimizzare l’incidente, non prendendo con rapidità
gli interventi idonei per limitare le conseguenze. La gente, inesperta, si
rivolse fiduciosamente agli scienziati che risposero in continuazione che
tutto andava bene, che non c’era da aver paura, e di ricorrere, come unica
precauzione, al lavaggio delle mani prima di sedersi a tavola per desinare. Ma
non sapevano ancora che stavano per passare la porta dell’inferno, che
quell’aria che respiravano, che quell’acqua che bevevano, che quel cibo che
mangiavano erano un veleno a scoppio ritardato che dopo qualche anno si
sarebbe mostrato in tutta la sua forza e aggressività. Così come non erano
stati avvisati del pericolo i pompieri accorsi per spegnere l’incendio e che
non erano stati dotati di tute antiradiazioni, anche gli abitanti furono
trattati alla stregua di vittime sacrificali e forse questo è l’aspetto più
grave, cioè il disinteresse di chi aveva il dovere di limitare i danni che
avrebbe subito la popolazione. Nell’immediato della sciagura ci fu l’orrore
degli altamente contaminati, condannati a una lunga e dolorosa agonia, ma per
gli anni a venire c’è lo stillicidio delle morti per cancro, dei nati deformi,
delle depressioni che finiscono con il cogliere quelli che si sentono privati
dell’unica, ma più grande ricchezza di un essere umano: il diritto alla vita.
Imperdibile.
Svetlana Aleksievič
è nata in Ucraina nel 1948 da padre bielorusso e madre ucraina.
Giornalista e scrittrice, è nota soprattutto per essere stata cronista per i
connazionali dei principali eventi dell’Unione Sovietica nella seconda metà
del XX secolo. Fortemente critica nei confronti del regime dittatoriale in
Bielorussia, è stata perseguitata dal presidente Aleksandr Lukašenko e la sua
opera è stata bandita dal paese. Dopo dodici anni all’estero è tornata a
Minsk, ma nel settembre del 2020 è stata costretta a fuggire in Germania. Per
i suoi libri, tradotti in più di quaranta lingue, ha ricevuto il Premio Nobel
per la Letteratura nel 2015.
Renzo Montagnoli
19 Aprile

Traditori di tutti.
Un’indagine di Duca Lamberti
di Giorgio Scerbanenco
La Nave
di Teseo Edizioni
Narrativa
Colpevole, ma non criminale
Accadono
troppi fatti strani fuori Milano, con un’auto che affonda nel Naviglio con due
persone a bordo e che annegano, come un analogo incidente di alcuni prima
rubricato come omicidio colposo, e poi un’altra automobile che si inabissa
sempre con due occupanti durante un furioso temporale, ma quest’ultimo però è
chiaramente un fatto delittuoso, visto che il mezzo, che era inseguito dalla
polizia, viene crivellato di colpi. Tre accadimenti simili non sono
necessariamente collegati, il tutto dipende da chi sono le vittime, che non
sono però persone incensurate, anzi sono gaglioffi non da poco, con gli uomini
papponi e trafficanti di droga e le donne un po’ troppo di facili costumi.
Sarà possibile assicurare alla giustizia i colpevoli, visto quanto sono
intricate le vicende? Niente paura, indaga Duca Lamberti, il medico cancellato
dall’ordine e anche a suo tempo rinchiuso in carcere per avere ucciso per
pietà una signora malata terminale, e che ora con questo caso si gioca la
possibilità di diventare un poliziotto.
Scerbanenco imbastisce una storia di non facile scrittura, visti gli intrecci,
i sospetti in un ambiente in cui sono maturati i delitti e con il tradimento
che sembra essere una costante, dandoci una visione di una Milano ormai
diventata metropoli e quindi anche con la malavita della grande città, che
spazia in tutti i campi profittevoli. Non troviamo più il ladro di galline o
il baro, emergono invece personaggi tesi al massimo guadagno e per questo
disposti a tutto, anche a uccidere. L’ambientazione e l’atmosfera sono rese in
modo impeccabile e, elemento di particolare pregio, la descrizione dei
protagonisti non è solo fisica, ma viene fatta anche un’analisi psicologica.
Il ritmo e la tensione poi sono palpabili, al punto che, come ho iniziato a
leggere, non mi sono concesso pause, ansioso di vedere gli sviluppi e
soprattutto di chiarire un mistero, quello del secondo incidente in ordine di
tempo, il cui movente risale a molto prima, addirittura ai primi giorni del
1945.
Ed è con
la soluzione di quest’ultimo caso che si conclude il libro, con un Duca
Lamberti, che ha superato brillantemente la prova per essere ammesso in
polizia, ma che ha un sapore amaro in bocca, quello che provano le persone
integerrime quando sono costrette dalle circostanze ad assicurare alla
giustizia un colpevole, ma non un criminale.
Da
leggere, lo merita.
Giorgio Scerbanenco (Kiev,
28 luglio 1911 – Milano, 27 ottobre 1969), scrittore italiano di origine
russa. Di madre italiana e padre ucraino, a sedici anni si stabilì a Milano.
Fu collaboratore, redattore e direttore di periodici femminili ad alta
tiratura, per i quali scrisse racconti e romanzi «rosa», per lo più ambientati
nell’America degli anni Quaranta. Più tardi approdò al genere poliziesco e fu
il successo, prima con Venere privata (1966), poi
con Traditori di tutti (1966). Altrettanto
fortunate le opere successive, da I ragazzi del massacro (1968)
a I milanesi ammazzano al sabato (1969), ai
racconti postumi di Milano calibro 9 (1969) e Il
centodelitti (1970). Protagonista di quasi tutta la serie è Duca
Lamberti, accorto investigatore della Milano «nera». Prodigioso narratore di
storie e maestro nel catturare l’attenzione del lettore, Scerbanenco fu uno
dei primi, in Italia, a confrontarsi con i gusti di un pubblico di massa. La
sua scrittura, insieme ingenua e ricercata, antiletteraria, piena di
sprezzature, veloce, è singolarmente efficace. Nel 2018 esce Luna
di miele per La Nave di Teseo.
Renzo Montagnoli
12 Aprile

Ipotetico approdo
di
Claudia Piccinno
Mediagraf
Edizioni
Poesie
Ciò che si può cogliere
La poesia
è lo specchio dell’anima, riflette quelli che sono i nostri sentimenti, è una
cartina di tornasole di quel che dentro di noi definiamo l’IO, ciò che
veramente siamo. E allora può capitare di leggersi, di scoprire nei versi che
escono dalla nostra penna una figura che nemmeno supponevamo, ma che altri,
attenti a osservare il fluire delle parole, gli accostamenti sillabici, il
filo predominante del discorso, già ci avevano classificato. Nel leggere
queste poesie della raccolta Ipotetico approdo si può solo
pensare che l’autore possa essere, anzi sia, un attento osservatore di
situazioni e di eventi, ma anche come il suo sguardo si posi soprattutto sugli
ultimi, sui più deboli, sui più sfortunati, senza compassione, ma
eventualmente con pietà verso un mondo che permette che esistano certe
situazioni, che consenta prevaricazioni e inutili crudeltà (Li ho portati i
miei / studenti al cippo di Sabbiuno di Piano / a leggere quei 34 nomi
tenendoci per mano. / Arno e Vanes erano con noi a dir più volte / non eravamo
eroi, / non c’erano né buoni né cattivi, / c’era la guerra / e urgeva
difendere la nostra terra. . /….).
Che si
tratti dell’eroico sacrificio di partigiani o del mondo chiuso di un bimbo
autistico per arrivare al tormento dei profughi bambini Claudia sa cogliere di
ognuno la dignitosa interpretazione del ruolo di emarginati, di sconfitti
dagli uomini, ma non dall’umanità. Sono versi dolenti, ma non enfatici, sono
uno stato emozionale che si trasmette al lettore in un flusso continuo, quasi
un pianto da tragedia greca, che lo scuote, gli induce una ribellione che non
è ricorso alla forza, ma condivisione, un bel passo avanti rispetto al grande
male di quest’epoca: l’indifferenza. Ma c’è posto anche per altro, per i
grandi misteri come l’amore, per i contrasti assoluti fra fede e ragione, e
non poteva mancare, a maggior ragione con i fatti di questi giorni, anche se
la raccolta è ben antecedente, il richiamo alla pace, un termine che esiste
perché è usato anche quello della guerra, perché senza guerra l’uomo non
desidera la pace.
Potrei
scrivere ancora e forse finirei l’inchiostro, tanto avrei da dire, ma ricordo
che la poesia parla da sola, non ha bisogno di intermediari, sta lì in attesa
che qualcuno la legga e, soprattutto, che sia disposto ad accoglierla; versi
dopo versi, parole che si susseguono, immagini che si materializzano nella
mente, sensazioni che prendono corpo, un piccolo sorriso di soddisfazione che
si disegna sul viso, questa è la poesia, un’ostrica che poco a poco si schiude
per rivelare il suo tesoro, una libertà che nessuno potrà mai togliere (Io
nuvola, lei rondine - Libera come nuvola / nel cielo di marzo,/ cosciente
della / piccolezza della rondine, / pretesi di guidarla / verso la luce / ….)
Claudia Piccinnonasce
a Lecce nel 1970, ma si trasferisce giovanissima in Lombardia e poi in Emilia
Romagna dove attualmente vive. Presente in oltre sessanta raccolte
antologiche, già membro di giuria in vari premi letterari a carattere
nazionale e internazionale.
Insegnante di ruolo nella scuola primaria, Laurea in Lingue e Letterature
straniere.
Per ulteriori informazioni e per quanto concerne il corposo numero
di opere pubblicate è opportuno un rimando al sito personale http://claudiapiccinno.weebly.com/
Renzo Montagnoli
8 Aprile
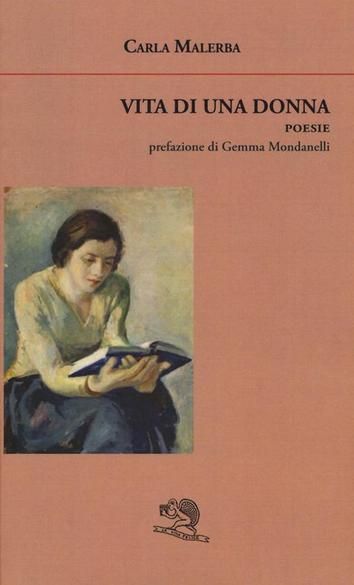
Vita di una donna
di Carla
Malerba
La Vita
Felice Edizioni
Poesia
Ricordando
Dite la
verità, chi a una certa età non si è voltato per ripensare al tempo trascorso,
a quella che è stata, fino a quel momento, la propria vita? Che si tratti di
un poeta, oppure di un uomo che non ha velleità artistiche, tutti, dico tutti,
sono passati per questa porta, spalancata sul passato a portare testimonianza
della propria esistenza. E così è stato anche per Carla Malerba che, scrivendo
poesie, ha voluto poi mettere in versi le sensazioni e le emozioni che ha
provato nel volgersi indietro. E’ nata così Vita di una donna,
una raccolta tematica che incuriosisce, poiché la vita di ognuno di noi è
unica e irripetibile. Si va indietro nel tempo, si vanno a cogliere quegli
eventi che più di altri sono rimasti indelebili, se non nella precisa memoria,
almeno in quelle sono state le impressioni, o addirittura i turbamenti
provati, come nel caso dell’amore giovanile (Ricordo quegli anni tumultuosi
/ dove tutto pareva avesse le ali, / correvano le mie gambe / come puledre al
vento dell’estate. / I portici un po’ oscuri / aprivano varchi inaspettati / e
i pensieri ad ogni angolo / incrociavano riverberi di sole. / Irragionevole
amore che ti inganna / e ti fa compiere imprese straordinarie, / radere a volo
d’angelo scarpate, / sfidare tempeste in mare aperto, / irragionevole amore
dei vent’anni. ).
Mi trovo
in sintonia con questi versi, capaci di esprimere con una vena di pudore un
sentimento che nasce all’improvviso, irragionevole appunto, salvo poi
domandarsi il perché un essere umano possa attrarre così tanto. Tuttavia,
nella vita c’è sempre un’alternanza di gioia e di dolore, quest’ultimo quando
si patisce la perdita di un proprio caro, come in Tu, padre mio (Tu,
padre mio, / eri un uomo di poche parole, / di una mitezza ferma / trattenuta
nello sguardo. / Nominavi spesso il Padreterno:/ poi il silenzio dei giorni
ultimi / precipitati nel dolore / e nella chiaroveggenza del rifiuto, / nella
parola invocata, / l’ultima tua notte sulla terra.). Poi ci sono le
nascite, i figli, di cui si cercano di serbare ricordi che evochino il loro
percorso, come per esempio, il famoso dentino da latte, per non parlare di
oggetti di uso comune, ma che hanno l’immediatezza di richiamare un periodo e
alcune caratteristiche di questo (Che assurde cose / tiene una madre / in
un cassetto:/ un fiocco azzurro / di prima elementare, / un mazzo di carte
ingiallite / di partite col nonno /nei pomeriggi invernali, / un paio di
guanti / lasciati in un’aula di università / e restituiti poi /ad un piccolo
alunno / confuso tra i dottori, / buono e tutto preso / per un giorno / da un
ruolo diverso, importante. ). Sono tanti i ricordi che emergono
dall’oblio, che pretendono quasi di essere ascoltati, in questo giorno che è
tutta una vita, amori, dolori, profumi, sensazioni, nulla è lasciato al caso,
perché sono la testimonianza che abbiamo vissuto e non mancano i sogni, i
desideri irrealizzati che fino a quando non sono rimpianti fanno bene
all’anima (Mi piacerebbe abitare / in un porto di mare / con tre bambini
che conosco / forse in altura / per vedere brillare le lampare / di notte, e
di giorno / le isole sfumate di foschia. / E vivrei qui / soltanto / di pane e
di poesia. ). Non è ancora rimpianto, ma è una lacrima pescata nel
profondo del cuore per un desiderio che si sa irrealizzabile, ma che finisce
con il rappresentare un preciso punto di riferimento nell’arco degli anni,
tanto che è rammentato in versi, e non potrebbe essere diversamente per una
donna che vorrebbe vivere lì solo di pane e di poesia.
Anche
questa, come le due precedenti raccolte (Di terre straniere e Poesie
future), mi è piaciuta per la capacità di esporre sentimenti ed emozioni
con immediatezza, per la ricerca di argomenti che sappiano toccare il cuore
senza squarciarlo, e infine per la serenità che riviene dalla lettura.
Carla Malerba è
nata in Nord Africa, ma dal 1970 risiede in Italia. A Tripoli, sua città
natale, pubblica giovanissima i suoi primi versi. Si laurea nel 1986 presso
l’Università degli Studi di Siena con una tesi sulla poesia per l’infanzia. Ha
insegnato Lettere ad Arezzo, città nella quale vive tuttora.
Nel 1999 pubblica a Cortona la sua prima raccolta “Luci e ombre “, seguita nel
2001 da “Creatura d’acqua e di foglie (Ed. Calosci, Cortona). In esse i temi
della perdita e del dolore si fanno pressanti anche se, a tratti, la memoria
assume una funzione salvifica. Con le raccolte “Di terre straniere” e “Vita di
una donna” (entrambe pubblicate con La vita felice, Milano 2010 e 2015) la
poetessa riprende i temi del viaggio esistenziale e degli affetti.
“Poesie future” (Puntoacapo editrice, giugno 2020) è la sua ultima raccolta
Alcune sue liriche sono presenti nell’antologia Novecento non più-Verso il
Realismo terminale, (La Vita Felice, 2016), in Pioggia Obliqua Scritture
d’arte (Nuovo poesia proposta) in Fiordalisi-Menti sommerse, in Tanti
pensieri, in Alma poesia, in Poetrydream. Scrive anche racconti brevi alcuni
dei quali sono stati pubblicati su Essere, periodico del Centro di solidarietà
di Arezzo.
Ha
ricevuto diversi riconoscimenti per la poesia inedita in concorsi nazionali
tra cui un Premio speciale della Giuria al Premio Ossi di seppia 2020; primo
premio al concorso Territori della parola, IV edizione 2018-2019 per la poesia
inedita; nel 2020 il Gran Premio della giuria al Concorso Le occasioni C19 per
le sezioni A e B; nel 2021 il Premio speciale Fondazione Giovanni Pascoli per
la raccolta “Poesie future”; al Premio internazionale Le occasioni 2021
secondo Premio per la sezione B.
Renzo Montagnoli
2 Aprile
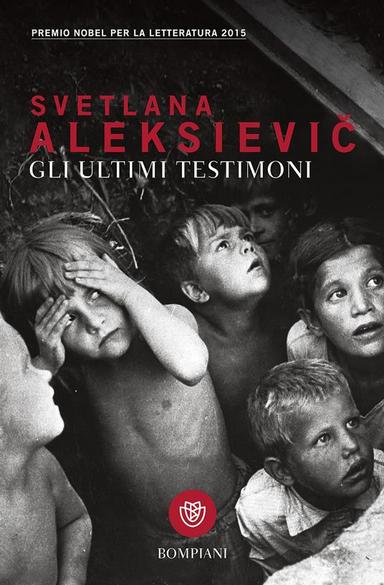
Gli ultimi testimoni
di
Svetlana Aleksievič
Bompiani
Editore
Narrativa
L’infanzia rubata
Chi può
ricordare oggi i giorni della seconda guerra mondiale se non quelli che allora
erano bambini e se un conflitto è sempre una tragedia lo è ancora di più per
l’infanzia, in tempi normali un periodo della vita spensierato e gioioso, ma
che di fronte alla violenza, alle bombe e al sangue era allora un incubo.
E’ a
questi piccoli uomini che è dedicato questo libro di Svetlana Aleksievic,
scrittrice bielorussa insignita nel 2015 del premio Nobel per la letteratura.
In giorni
come questi, in cui fra le tante infuria una guerra in un paese che ci è
vicino, leggere questo libro è quasi doveroso, perché l’autore, persona
sensibile e contro le follie perpetrate invocando soventi scopi fasulli, si è
posta tante domande, ma è arrivata a un’unica risposta, conclusiva e non
contestabile: nulla può giustificare anche una sola lacrima di bambino.
I piccoli
uomini, ormai ampiamente adulti, stimolati dalla scrittrice, rievocano,
raccontano di un dolore sopito che ritorna con le parole, di una parentesi che
sembrava chiusa, ma non lo era, e così ascoltiamo tante storie, commoventi,
struggenti, che non possono non stringere il cuore.
E’
un’infanzia rubata, piccole vite sballottate nel vento impetuoso della storia,
private di ogni cosa, ma quel che è più grave spesso rese orfane dei genitori,
soprattutto della mamma, il rifugio sicuro a cui ogni bambino tende nel
momento del pericolo. E spesso non si tratta solo di mamma o papà morti nel
corso di un bombardamento, perché c’è ancor di peggio: la follia cieca dei
tedeschi che, per imporre il loro volere, uccide spesso innocenti che non
hanno compiuto atti ostili, solo per dare una dimostrazione della loro
ferocia. Non sono solo i genitori fucilati davanti ai figli, perché non di
rado anche i bimbi cadono sotto le raffiche di mitra, colpevoli solo di
esistere.
Ci sono
pagine e narrazioni capaci di smuovere anche il cuore più indurito, bimbi
rimasti senza i genitori che fuggono disperati in cerca di qualcuno che li
soccorra e questo capita quasi sempre. Come ci sono gli uomini che uccidono ci
sono per fortuna quelli che aiutano, che comprendono e vedono il terrore negli
occhi del bambino e allora, nonostante le difficoltà e i pericoli, vengono in
soccorso, diventano nuovi padri e nuove madri, ridanno una speranza nel futuro
a chi credeva di averla irrimediabilmente persa. Questi buoni samaritani oggi
non ci sono più, sono mancati secondo il corso naturale della vita, ma sono
sicuro che sarebbero felici se sapessero quanto sono ricordati, con quanto
amore si parla di loro. Quello che però è più importante in questo libro è ciò
che meno ci si aspetta: questi bambini a cui hanno ucciso i genitori, che
hanno avuto paura per la loro stessa vita, che hanno spesso vissuto quasi solo
d’aria, come quelli di Leningrado durante il famoso assedio, non odiano chi ha
così infierito sulla loro infanzia. Era tanto il bisogno d’amore quando ne
sono stati privati che non c’è stato posto per l’odio e così queste creature,
a volte quasi in fasce, alle cui lacrime si possono unire anche le nostre,
insegnano il modo per non avere più guerre. Già lo sapevamo che l’amore può
tutto, ma spesso ce ne dimentichiamo, eppure il rimedio c’è ed è in noi, basta
metterlo in cima alle priorità, sommerso spesso da un egoismo che non soddisfa
mai.
Da
leggere, è un capolavoro.
Svetlana Aleksievič
è nata in Ucraina nel 1948 da padre bielorusso e madre ucraina. Giornalista e
scrittrice, è nota soprattutto per essere stata cronista per i connazionali
dei principali eventi dell’Unione Sovietica nella seconda metà del XX secolo.
Fortemente critica nei confronti del regime dittatoriale in Bielorussia, è
stata perseguitata dal presidente Aleksandr Lukašenko e la sua opera è stata
bandita dal paese. Dopo dodici anni all’estero è tornata a Minsk, ma nel
settembre del 2020 è stata costretta a fuggire in Germania. Per i suoi libri,
tradotti in più di quaranta lingue, ha ricevuto il Premio Nobel per la
Letteratura nel 2015.
Renzo Montagnoli
28 Marzo

Monologo dell’angelo caduto
di Giuseppe Carlo Airaghi
Fara Editore
Poesia
Angeli e
poeti
Sono sicuro che Giuseppe Carlo
Airaghi abbia tratto l’ispirazione per questo suo Monologo dell’angelo
caduto dal film di Win Wenders Il cielo sopra Berlino, in cui
Damiel e Cassiel, due angeli invisibili a tutti, si aggirano per la capitale
tedesca fino a quando il primo vede una trapezista e, poiché se ne innamora,
si fa uomo e quindi mortale. Infatti non è un caso che l’io, più che narrante
poetante, si chiami Damiel ed è pure lui un angelo che si innamora; troppe
coincidenze che finiscono con dare credito alla mia ipotesi, peraltro
avvalorata da quattro righe di introduzione e da successive illuminanti
tracce. Tuttavia il richiamo al film non va oltre, perché l’opera in versi ha
una sua autonomia che ne determina l’unicità. E’ poi particolarmente
interessante il modo con cui l’autore si cala nei panni dell’angelo, per cui
verrebbe da dire che per scrivere quest’opera da uomo si è fatto angelo (Ho
barattato una immutata eternità // per la sete di un bacio ricambiato, / per
un bicchiere di vino, per la curva / irripetibile di un collo di donna, // per
pisciare sui cumuli di neve, / per imprimere la mia presenza, /Il mio segno
tangibile nel mondo ).
Se il modo interessa, il contenuto invece stupisce, perché questa creatura
alata, caduta sulla terra e quindi fattasi mortale, mantiene ancora il
privilegio di una visione celestiale di tutto ciò che incontra (Precipitato
da una distanza di cielo / per accarezzare la curva che scende / tra il suo
collo e la spalla. // Per capire cosa fosse la pelle / ho rinunciato al tempo
eterno, / sono sceso a baciare la terra. // Da un bianco e nero manicheo / a
una incredulità di colori / ancora tutti da nominare.// Ho risalito il fiume,
raggiunto / la riva opposta per esprimere / finalmente un giudizio sul mondo.
). Fra l’altro questo straordinario protagonista rivela una simpatia del tutto
particolare, vittima dei limiti dell’essere mortale, ma ancora capace di
vedere oltre quelle nude immagini che si fissano nei suoi occhi (Non esiste
solitudine senza eco. / Ovunque ci accompagna il rimorso / del passato oppure
il rimpianto // che non dà meno dolore, il rombo / di un temporale lontano, un
vento / che non sgombra il cielo in allarme. // Le sere d’inverno duravano
anni, / troppo vaste per poterle varcare / senza pagarne il prezzo per intero.
// Di molte sono stato spettatore. / Il tramonto era un sipario calato / sopra
una recita senza finale. // Come spesso accade qualcuno balla / e qualcuno
addossato alla parete / fissa un punto cieco nella stanza. // Con il bicchiere
vuoto tra le mani. / La conversazione langue. Le cose / da dire hanno scarsa
importanza. // Abbandonare la stanza è un’opzione / non contemplata dalle
buone maniere. / A me parve non restasse altra scelta. ).
A un certo punto, e non credo di
esagerare, mi si è accesa una lampada, ho avuto, quel che si usa dire,
un’illuminazione, e cioè se Airaghi per scrivere si è fatto angelo,
quell’angelo che per amore si è fatto uomo, sono diventati entrambi un’entità
sola, e allora come è possibile questa tramutazione? A ogni domanda c’è quasi
sempre risposta, come anche in questo caso, perché sono più che convinto che
sia la creatività del poeta che conduce a quell’estasi che è propria di un
essere fuori dalla materialità delle cose, tanto elevata da sembrare
irraggiungibile, eppure a portata di mano, purché si riesca a entrare in
sintonia. In fin dei conti, chi scrive versi va oltre la modesta realtà di
ogni giorno, cerca di sublimarsi nella ricerca, spesso inconscia,
dell’Assoluto.
Questo Monologo dell’angelo
caduto è ben diverso dalla silloge precedente Quello che ancora
restava da dire, ma non è una differenza di valore, perché entrambe le
opere sono senz’altro di eccellente qualità; secondo il mio giudizio si tratta
invece della ricerca di un nuovo percorso espressivo che possa andar oltre i
limiti naturali di una
esternazione del proprio “Io” (Pensavi il
tempo fosse una retta / chiusa tra un inizio e una fine. / Il tempo non va da
nessuna parte, // non si arresta. Il presente è un punto / in continuo
movimento, effimero / e immenso. Porta con sé l’universo. // Tutte le vite
precedenti trovano posto / nel susseguirsi infinito dei secoli, / perse nelle
omissioni della Storia.
).
Da leggere, indubbiamente.
Giuseppe Carlo Airaghi
è nato a Legnano (MI) nel 1966. Vive a Lainate. È impiegato presso
un’azienda di servizi. Ha lavorato come geometra, animatore nei villaggi
turistici, venditore di prodotti siderurgici, cantante di musica blues. Ha
pubblicato le raccolte di poesia I
quaderni dell’aspettativa (Italicpequod), Quello
che ancora restava da dire (Fara Editore), La
somma imperfetta delle parti (Giuliano Ladolfi Editore) e il romanzo I
sorrisi fraintesi dei ballerini (Fara Editore).
Renzo Montagnoli
21 Marzo
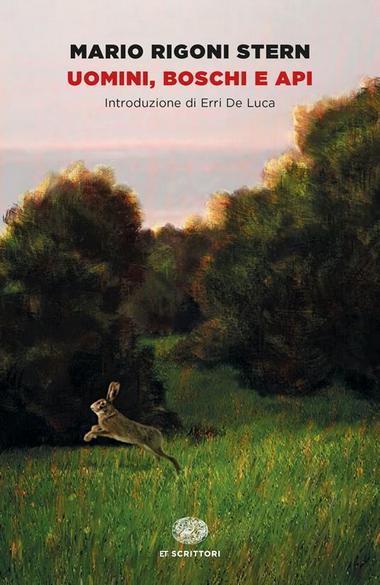
Uomini, boschi e api
di Mario
Rigoni Stern
Edizioni
Einaudi
Narrativa
La
serenità
Ogni
volta che apro un libro scritto da Mario Rigoni Stern avverto una sensazione
del tutto particolare che appare già dalle prime righe e che mi accompagna per
tutta la lettura; infatti mi sembra di entrare in un altro ambiente, in una
camera rischiarata solo dal fuoco di un camino, e c’è lui, Mario Rigoni Stern,
che, ravvivata la fiamma con nuovi ciocchi, mi invita a sedere e comincia a
raccontare, con un tono pacato, e una voce calda. E immediato è il senso di
serenità che mi pervade, un appagamento dell’anima, una pace interiore, rara e
infinitamente preziosa. E’ accaduto anche per questa raccolta di racconti, in
cui i temi preponderanti sono quelli della natura vista con gli occhi di chi
ha nei suoi confronti un profondo rispetto e così protagonisti sono diversi
animali, dal gufo delle nevi al fagiano di monte, dal picchio rosso alle
volpi, per non parlare delle api, per le quali l’autore ha una vera e propria
venerazione. Se si parla di animali si finisce poi con il parlare di caccia,
una caccia d’altri tempi, una sfida fra predatore e preda sostanzialmente su
un piano di parità, sempre nell’ottica del più profondo rispetto per la
natura. Non mancano poi prose su alcuni tipici lavori in montagna, da quello
praticato dai cavatori di marmo rosso a quello dei carbonai, attività che
oggi, non tutte, ma quasi, sono scomparse, e quindi la narrazione di Rigoni
Stern è un prezioso contributo di carattere storico, è una testimonianza per
il futuro al fine di poter conoscere tutto quanto rappresenta le nostre
radici. Se la maggior parte dei racconti deriva da quotidiane osservazioni del
mondo circostante, altri invece rappresentano il desiderio di conservare la
memoria, come quello stupendo della battuta di caccia al cervo per la
ricorrenza di Sant’Uberto, quando l’autore era detenuto prigioniero in un
lager miniera di ferro a cielo aperto in Austria; c’era la guerra, ma
l’umanità non si era persa, come dimostreranno tangibilmente dei vecchi
cacciatori. Se poi vogliamo restare su tematiche che emozionano il libro
finisce splendidamente con il racconto L’ultimo viaggio di un emigrante,
con cui rifulge tutta la carica umana di Rigoni Stern; sono righe struggenti
che portano a una inevitabile commozione, e nella figura dell’emigrante che,
con i risparmi di una vita, lascia l’albergo per anziani nel Michigan per una
vacanza al suo paese d’origine, un ritorno alla propria terra, una
rivitalizzazione delle proprie radici, un viaggio dagli Stati Uniti all’Italia
che per lui sarà di solo andata ho ritrovato un po’ di Tönle, la straordinaria figura del montanaro errante per mantenere la
propria famiglia, protagonista di un romanzo breve di straordinaria bellezza e
che a suo tempo fu onorato con il prestigioso premio Campiello.
Dispiace poi, arrivati all’ultima pagina, non poter
continuare, ma la figura di Mario Rigoni Stern - che magicamente immagino
visto che il fuoco si è spento - si alza e mi saluta, ma non è un addio, è un
radioso arrivederci a domani, foriero di altre stupende narrazioni.
Mario Rigoni Stern
(Asiago,
1 novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008). Scrittore italiano. Esordì con Il
sergente nella neve (1953), una delle più notevoli testimonianze
letterarie della seconda guerra mondiale, alla quale l’autore partecipò con
gli alpini sul fronte russo. Dopo anni di silenzio Rrigoni Stern è tornato
alla narrativa con i racconti Il bosco degli urogalli (1962)
e i romanzi La guerra della naia alpina (1967), Quota
Albania (1967), Ritorno sul Don (1973), Storia
di Tönle (1978, premio Campiello), emblematica biografia di un
solitario montanaro durante la grande guerra, uno dei suoi esiti più alti.
Successivamente, accanto a nuovi romanzi, L’anno della
vittoria (1985) e Amore di confine (1986),
lo scrittore ha pubblicato diverse opere che testimoniano di una sua crescente
adesione al mondo della natura: Uomini, boschi e api (1980), Il
libro degli animali (1990), Arboreto selvatico (1991).
In Le stagioni di Giacomo (1995, premio Grinzane)
ha raccontato i luoghi d’origine. Nella produzione successiva tornano i suoi
temi dominanti: Sentieri sotto la neve (1998), Tra
due guerre e altre storie (2001), Stagioni (2006),
I racconti di guerra (2006).
(dall'Enciclopedia
della Letteratura Garzanti)
Renzo Montagnoli
12 Marzo
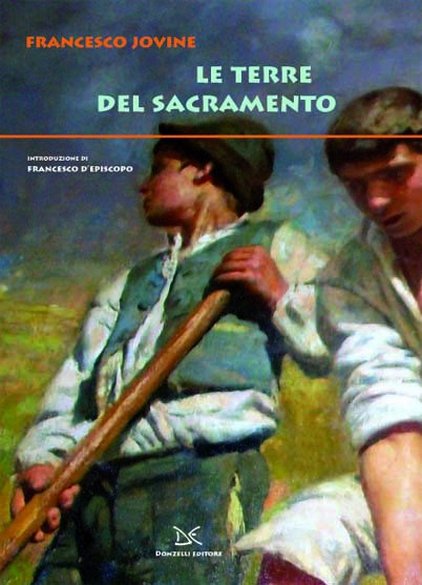
Le terre del Sacramento
di
Francesco Jovine
Donzelli
Editore
Narrativa
Su la testa
Le terre
del Sacramento è un dolente romanzo sulla condizione dei contadini del
meridione e rappresenta, idealmente, la naturale continuazione di Signora
Ava. Là l’epoca era quella dell’impresa dei Mille, in una versione del
Gattopardo dal punto di vista degli ultimi, e non dei nobili e dei
borghesi; e se la stratificazione sociale di Signora Ava poteva essere
spiegabile, ma non giustificabile, con Le terre del Sacramento
l’accusa a chi più ha e continua a volere di più è chiara e indiscutibile. La
vicenda di Luca Marano che impegna la sua parola per un riscatto dei poveri
contadini e viene tradito da una donna furba e avventuriera sembrerebbe
chiudere la possibilità di qualsiasi riscatto di una infima classe sociale, ma
è proprio il sacrificio di questo inconsapevole sindacalista a dare un tenue
barlume di speranza, perché forse, solo uniti, si può giungere alla meta. In
Signora Ava il periodo storico era antecedente di più di mezzo secolo,
al momento culminante del processo di unificazione dell’Italia, con le
speranze spezzate delle classi più deboli; in questo romanzo invece il paese è
già unito, è da poco uscito dalla Grande Guerra, anche questa infarcita di
promesse non mantenute, e corre l’anno 1922, quello della marcia su Roma e
dell’avvento del fascismo. La povera gente della Marsica, oltre ad avere come
nemica la miseria, la tracotanza dei capitalisti e del mondo finanziario,
l’indifferenza di uno stato sempre più prono di fronte al potere economico,
ora ha un nuovo pericolo, il fascismo appunto, mano armata di chi da sempre
comanda per conservare la propria posizione di privilegio.
In questo
romanzo corale, in cui la ribellione dei contadini traditi non è armata se non
dalla pacifica occupazione delle terre promesse, da loro faticosamente
dissodate in virtù della promessa di essere concesse in enfiteusi, promessa
disattesa, la trama, i protagonisti, perfino l’ambiente e l’atmosfera formano
un grandioso quadro d’insieme che non è solo lo spaccato di un’epoca, ma è il
pianto disperato di chi soffre da sempre senza riscatto. Forse qualcuno
potrebbe trovare una matrice politica, un’ispirazione socialista, ma la
visione di Jovine esula da qualsiasi preconcetto, è l’urlo di dolore di chi
rivendica la dignità di essere umano, è la descrizione impietosa di una
condizione di sudditanza, è la narrazione dell’anelito di una moltitudine a
una vita migliore.
L’autore
si può far rientrare nella tradizione verista italiana che inizia all’incirca
dopo la metà del XIX secolo e che è ricca di nomi famosi, da Giovanni Verga a
Federico De Roberto, a Ignazio Silone, a Rocco Scotellaro, ma se questo è un
inquadramento che ha più a che fare con la letteratura, rimane l’importanza di
quest’opera, come anche del precedente romanzo Signora Ava, e la sua
valenza che va oltre il periodo temporale e anche oltre il limite
territoriale. Quante genti al mondo sono da sempre, o quasi, vessate? Quanti,
ma infinitamente più pochi, forti delle loro ricchezze accumulate nel tempo,
non solo brigano per difenderle, ma per aumentarle, impedendo qualsiasi
possibilità di riscatto? Chi non ricorda “ El pueblo unido jamàs serà
vencido”? Ecco, nelle terre del Sacramento il popolo degli italici peones
ha provato a unirsi, ma è stato sopraffatto dalla violenza fascista con il
beneplacito delle autorità dello Stato. Si potrebbe dire che non c’è speranza
e invece il sacrificio degli altri è lo stimolo per non abbattersi, per
ritentare, per rialzare tutti insieme quelle teste da troppo tempo abbassate,
ed è questo il grande messaggio di questo romanzo.
Le terre
del Sacramento è assolutamente da leggere.
Francesco Jovine
(Guardialfiera, Campobasso, 1902 - Roma 1950) narratore italiano. Ispirò alla
nativa regione molisana le sue opere più significative: dal romanzo Signora
Ava (1942) alla raccolta di racconti L’impero in provincia (1945), all’altro
romanzo Le terre del Sacramento (1950, premio Viareggio), sorta di epopea del
lavoro contadino e commossa celebrazione della propria terra. I temi
tradizionali del feudo che va in rovina e del conflitto tra padroni e
contadini vengono rappresentati, all’avvento del fascismo, con una forte
carica polemica e uno stile asciutto che intreccia il rilievo di caratteri
balzachiani alla coralità della struttura. Narratore di tradizione
essenzialmente veristica, J. accolse nelle sue opere le istanze
dell’antifascismo e delle lotte sociali del dopoguerra, senza tuttavia
rinunciare a inflessioni di sottile lirismo. Nei suoi esiti migliori, egli
amalgama felicemente le agitate vicende della storia e l’aura immobile del
mito. Importante, nella Signora Ava, ma anche nell’Impero in provincia, il
delinearsi di un giudizio riduttivo sul risorgimento, con motivazioni che più
recentemente una parte della critica storica ha fatto proprie.
Renzo Montagnoli
5 Marzo

Quell’onda che ti tiene lieve
di Felice Serino
Libreria Editrice Urso
Poesie
Fra sogno e realtà
E tre,
verrebbe da dire, perché con questa sono tre le raccolte di poesie di Felice
Serino che ho avuto l’opportunità di leggere. La prima, che mi ha fatto
incontrare l’autore, è stata Dalle stanze del cuore e della mente, una
sublimazione della parola, la seconda è invece stata Sopra il senso delle
cose, una silloge che, recensendola, ho ritenuto di definire frutto
dell’esperienza e della creatività. Del resto il poeta, di origini napoletane,
ma dimorante a Torino, è un artista di lungo corso che via via negli anni ha
affinato il proprio modo di verseggiare, e ciò è facilmente riscontrabile
leggendo le sue composizioni in ordine temporale. Questa che ora ci occupa si
inserisce cronologicamente, almeno come epoca di pubblicazione, in posizione
intermedia, senza segnare una marcata evoluzione e fermo restando quella
ricerca introspettiva che è materia propria dell’autore uso ad approfondire
con progressività. Nel contesto di ricerca di ciò che può rivelare il proprio
Io si nota particolarmente, apprezzando, una visione evanescente che dona
particolare fascino, ammantando il verbo di magia, all’intero corpo come in
Angelo della luce: adagiati creatura del sogno / sulla curva del nostro
abbandono / la lontananza è ferita insanabile / un cielo d'astri divelti / e
tu balsamo sei / -tu orifiamma tu altezza / sognato stargate - /dove voce
insanguinata c'inchioda / dalla caduta. Sono versi che tendono a volare,
a superare confini naturali per congiungersi a un mondo di fantasia, la cui
porta, lo stargate, è in attesa di essere valicata. In questo universo che si
potrebbe definire poetico Serino s’invola, novello Ulisse verso un’Itaca che è
la propria dimensione interiore, un’avventura senza fine in cui conta di più
la conoscenza che si incontra nel percorso che il raggiungimento della meta
(da Sull’acqua: sul grande mare del sogno / veleggiano i miei morti / gli
occhi forti di luce / con un cenno m'invitano / al loro banchetto sull'acqua /
d'argento striata / m'accorgo di non avere / l'abito adatto / cambiarmi
rivoltarmi / devo / vestire l'altro da sé .). E tutto procede in una
sorta di limbo, un sogno che porta ad altra dimensione, e in cui con maggior
chiarezza è possibile leggere dentro di sé, in una visione che continua a
essere evanescente, una sorte di ectoplasma che avvince e respinge (da
L’elemento celeste: tornerò ad essere pensiero espanso / quando dalla scena
/ sarò sparito / dove si curva all'orizzonte il mare / sarò forse atomo /
fiore o stella e / in estasi / mi unificherò all'elemento che da sempre / mi
appartiene). Si resta attoniti, anche sgomenti spettatori di una
metamorfosi, di una trasformazione che è un’implosione della persona stessa,
e, comunque, il tutto si riassume, si comprende con chiarezza in questi versi,
con cui vorrei chiudere la recensione di un’opera complessa, ma dall’indubbio
fascino: da In vaghezza di sogno “ ti rigiri e vedi -in vaghezza di sogno /
un te estraneo vagare / per strade buie e vuote / come un san sebastiano a
trafiggerti / gli strali della notte – senti / recalcitrare / in te l'uomo
vecchio - ah convivere / con gli umori di un corpo-zavorra / ti avvedi d'aver
perso le chiavi / di casa mentre un gallo / canta / in lontananza ed è l'alba
“.
Felice Serino è
nato a Pozzuoli nel 1941 e vive a Torino. Autodidatta.
Copiosa la sua produzione letteraria (raccolte di poesia: da “Il
dio-boomerang” del 1978 a “Dalle stanze del cuore e della mente” del 2020); ha
ottenuto importanti riconoscimenti e di lui si sono interessati autorevoli
critici. E’ stato tradotto in nove lingue.
Intensa anche la sua attività redazionale.
Gestisce vari blog e tre siti.
Renzo Montagnoli
25 Febbraio

Il racconto del
cortigiano
Vita e storie di Baldassarre Castiglione
di
Edgarda Ferri
Solferino
Edizioni
Storia
biografia
Uno dei
migliori cavalieri del mondo
Baldassarre Castiglione (Casatico, 6 dicembre 1478; Toledo, 8 febbraio 1529).
E’ logico chiedere chi sia mai questo personaggio meritevole di una biografia
e basta una breve ricerca su Internet per scoprire che si tratta di un
letterato, nonché diplomatico e militare italiano al servizio dello Stato
della Chiesa, del Marchesato di Mantova e del Ducato di Urbino. A prima vista
sembrerebbe non meritevole di particolare attenzione, considerato che è stato
né più né meno un cortigiano come tanti, uno di quegli uomini sempre presenti
nelle corti dell’epoca con funzioni di consigliere e di ambasciatore, un
lavoro comunque non semplice a cui dedicare ogni momento della propria vita,
con una serie di attribuzioni e di incarichi i più disparati che richiedevano
in ogni caso la fedeltà al proprio Signore. Baldassarre Castiglione, tuttavia,
ha saputo parlare di questa professione, scrivendo un libro, Il
cortegiano, assai famoso all’epoca e che mantiene ancor oggi immutato
il proprio valore. Infatti, nella sua opera, l’autore tratta, sotto forma di
dialogo, quali debbano essere i comportamenti più idonei di un uomo di corte e
di una dama di palazzo, il tutto attraverso conversazioni che si immaginano
tenute nel corso di serate di festa a Urbino alla corte della duchessa
Elisabetta Gonzaga, consorte di Guidobaldo da Montefeltro. La premessa mi è
sembrata opportuna e non vado oltre, né intendo parlare del Cortegiano,
altrimenti andrei fuori tema, perché il libro di Edgarda Ferri è una
riuscitissima biografia di Baldassarre Castiglione. Scrivere della vita di un
diplomatico non può prescindere dall’epoca e dagli ambienti in cui ha operato,
e infatti la narrazione ci mostra il personaggio nel suo tempo e nei luoghi in
cui è stato presente, inquadrato benissimo nella storia d’Italia, teatro delle
guerre fra Spagna e Francia. Si incontrano così tanti personaggi, dal marchese
di Mantova Francesco II, di cui era parente per parte di madre, al duca di
Urbino Guidobaldo da Montefeltro, al pontefice Clemente VII, sotto i quali
prestò i suoi servigi. Nella storia del periodo poi entrano di prepotenza
altri protagonisti, come Lorenzo il Magnifico, l’imperatore Carlo V, grandi
artisti come Raffaello e Michelangelo, umanisti come il Bembo. Più che una
biografia Il racconto del cortigiano diventa un grandioso
affresco storico, narrato in forma di romanzo, appassionante e in cui tuttavia
è lasciato poco spazio alla fantasia, fedele, giustamente, Edgarda Ferri alle
fonti storiche, peraltro abbondanti. La vita di Baldassarre Castiglione è
movimentata, la dedizione ai suoi signori è totale, al punto che si sposa
tardi, a quasi 38 anni, con una giovinetta di 15, Ippolita Torelli, figlia di
Pietro Guido II, conte di Guastalla, e di Francesca Bentivoglio, figlia di
Giovanni II, signore di fatto di Bologna, un matrimonio felice, nonostante le
latitanze per lavoro dello sposo, ma finito troppo presto, con la scomparsa
della sposa a 21 anni per complicanze intervenute poco dopo aver partorito il
terzogenito. Rimasto così vedovo, si fa prete onde provvedere ai propri
bisogni materiali, visto che per le poche entrate e le ben più ampie spese è
indebitato fino al collo. In questa veste, quindi talare, ma anche come
Nunzio, cioè ambasciatore dello Stato della Chiesa, trascorre l’ultimo periodo
della sua vita in Spagna, dove, colpito da attacchi febbrili, viene a mancare
a Toledo l’8 febbraio 1529. Il suo corpo viene traslato a Mantova sedici mesi
più tardi e tumulato nel Santuario di Santa Maria delle Grazie nella tomba
predisposta da Giulio Romano.
Con lui
se ne andava una figura eccezionale, uno dei migliori cavalieri del mondo,
come ebbe a dire l’imperatore Carlo V; visse in un’epoca tormentata, di guerre
continue, seguì le alterne fortune dei suoi Signori, non venendo mai meno alla
parola data, un personaggio che la mano sapiente di Edgarda Ferri è riuscita a
far rivivere, a proporre al lettore in modo avvincente, uno dei tanti meriti
dell’opera, senza dimenticare quello forse più importante, cioè essere
riuscita a descrivere in modo ineccepibile e assai piacevole un periodo
storico convulso.
Da
leggere, senza il minimo dubbio.
Edgarda Ferri
(Mantova, 24 gennaio 1934) vive e lavora a Milano.
Scrittrice, saggista, giornalista ha esordito nel 1982 con Dov’era
il padre, un romanzo che rimane tuttora un
ritratto fondamentale e un punto di riferimento per un’intera generazione. Ha
pubblicato inoltre, Contro il padre (1983), La
tentazione di credere (1985), Il
perdono e la memoria (1988), Luigi
Gonzaga (1991), Quello
che resta di Cristo dopo 2000 anni (1996)
e, per Mondadori, Maria Teresa (1994), Giovanna
la Pazza (1996), Io,
Caterina (1997), Per
amore (1998), L'ebrea
errante (2000), Piero
della Francesca (2001), La
grancontessa (Le Scie, 2002), Letizia
Bonaparte (2003), L'alba
che aspettavamo (2005), Il
sogno del principe (2006), Rodolfo
II (2007), Uno
dei tanti (2009).
Renzo Montagnoli
19 Febbraio

Quando le montagne
cantano
di Phan Que Mai Nguyen
Editrice Nord
Narrativa
Profumo d’oriente e di pulito
Quando leggo un libro trovo inconfondibile il profumo della carta, ma in
questo caso il mio olfatto è stato colpito anche da una fragranza di legno di
sandalo, da un effluvio di spezie del lontano oriente, una miscela penetrante,
ma nulla al confronto di un aroma di pulito, di un bucato in cui la massaia di
un tempo ha profuso le sue forze ricorrendo al sapone di Marsiglia. E’ un
intreccio di buoni sentimenti che scaturiscono da queste pagine, di amori,
anche di odi, comunque di tutto ciò che è parte della vita di una famiglia, di
generazione in generazione, uno splendido affresco che contemplo con gioia e
con il timore di non riuscire a esprimere quanto elevato sia il mio grado di
soddisfazione. Qualcuno, leggendo, potrà anche non essere d’accordo, ma credo
che converrà su un punto: si può narrare dell’esistenza in tanti modi, ma in
uno così discreto, e pur preciso, sommesso, ma affascinante, è cosa assai
rara.
In breve è la storia che Dieu Lan narra alla nipote Huong, per infonderle
fiducia, nel momento più tenebroso e orribile della guerra del Vietnam,
allorché gli americani bombardano Hanoi. E questa nonna, che si piega, ma non
si spezza al vento delle tragedie che costellano la sua esistenza, narra della
vita della loro famiglia, dall’epoca del dominio francese, all’occupazione
giapponese, dal ritorno dei francesi e alla loro cacciata, alla divisione del
Vietnam in due stati, alla lunga e crudele guerra che vede il Nord, soggetto
alla spietata dittatura comunista, contro il Sud, corrotto e appoggiata dalla
più grande potenza terrestre. Come travagliata è la storia di questo paese,
travagliata è la vita di Dieu Lan, che conoscerà l’amore e il dolore, la
ricchezza e la miseria, le sofferenze e le gioie. Se tante sono le pagine in
cui predomina la crudeltà della guerra o la durezza del regime comunista, ce
ne sono altrettante che sono un canto alla vita, in cui i sentimenti sono
espressi con naturale pudore e in cui è presente una salvifica vena poetica.
Per quanto le vicende possano far apparire Dieu Lan come un’eroina,
l’autentica impressione che si ritrae è che siano esistite moltissime Dieu
Lan, donne combattenti per salvare la propria famiglia, mai dome, anche nei
momenti più bui.
Particolarmente toccante è sapere che in ogni casa c’è un piccolo altare, con
cui si venerano i familiari defunti, come avveniva in epoca romana con i lari,
a testimonianza dell’alto valore riconosciuto alla famiglia e dell’importanza
di non trascurare, anzi di ricordare le proprie radici, come fa Dieu Lan con
la nipote Huong. E poi il romanzo è impregnato di una filosofia che forse è
tipicamente orientale, ma che mi sento di condividere e che è riassumibile
nella spiegazione che la nonna dà alla nipote del perché intende parlarle
della storia della famiglia; Dieu Lan dice: “Mia adorata
nipote, non fare quell’espressione sconvolta. Comprendi perché ho deciso di
raccontarti della nostra famiglia? Se le nostre storie sopravvivono, noi non
moriremo, neanche quando i nostri corpi non saranno più su questa Terra.”.Una
vita possibile dopo la morte se si resta nel ricordo di qualcuno fa apparire
ciascun membro di una famiglia come un anello indissolubile di una lunga
catena che è fatta di nascite e morti, ma che è anche una traccia evidente di
quanto siamo stati, mai inutili e sempre necessari.
Lo stile è snello, ma assolutamente non povero, anzi elegante e se proprio
voglio trovare un difetto, di cui però non ha colpa l’autore al suo primo
romanzo, è la confusione che si può fare con i tanti personaggi, ma non perché
non siano ben descritti e identificabili, ma perché i nomi vietnamiti sono
lontani dai nostri, spesso composti da tre incomprensibili parole.
Quando le montagne cantano
è un romanzo che resta nel cuore ed è, a mio giudizio, notevolmente bello.
Phan Que Mai Nguyen
(1973), giornalista e poetessa, è nata in Vietnam, dove ha lavorato per anni
come venditrice ambulante e coltivatrice di riso. Si è trasferita all'estero
grazie a una borsa di studio, che le ha permesso di dedicarsi all'analisi
degli effetti a lungo termine della guerra e successivamente di lavorare per
diverse organizzazioni internazionali. Nel 2021, Nord pubblica il suo romanzo
d'esordio Quando le montagne cantano, una saga
familiare ambientata che ha come sfondo il Vietnam del Novecento.
Renzo Montagnoli
14 Febbraio

Il tempo che trasforma
di
Patrizia Fazzi
Edizioni
Prometheus
Poesia
A passo
di danza
Era da un
bel po’ di tempo che all’inizio di un’opera poetica non mi capitava di leggere
un preludio e del resto questo breve cenno informativo era più in uso in un
remoto passato tanto che lo troviamo nell’Iliade (Cantami, o Diva del
Pelide Achille…) e nell’Odissea (L'uomo
ricco d'astuzie raccontami, o Musa ….);
eppure,
per quanto scarsamente utilizzata, questa forma di introduzione, questa
anticipazione in termini ristretti del tema svolto, ha una sua funzione,
perché tende a mettere a suo agio chi si appresta a leggere. E senza che io in
queste righe lo riporti mi limito a dire che quello di Il tempo che
trasforma ha una liricità non di maniera e un contenuto che sembra
annunciare una visione di integrazione dell’essere umano con la natura, con un
estro creativo che giunge da lontano e trasferisce su carta in modo
tumultuoso, ma anche spumeggiante, ciò che da tempo era lì, nel proprio Io, e
che attendeva solo il momento di essere colto. Non intendo andare oltre,
perché il tempo e lo spazio sono tiranni, e passo pertanto alle sensazioni di
lettura delle poesie di questa raccolta. Come d’uopo è il bon ton, giusta
appare un’auto presentazione dell’autore, con quel Io sono Patrizia,
persona che vuole gioire della bellezza della vita, ma che presenta un fondo
di tristezza che caratterizza un po’ tutti i poeti. E dal fondo di se stessa,
da quella porta spalancata da cui esce turbinosa la poesia, frutto
dell’imperscrutabile rapporto intercorrente fra il proprio Io e il mondo
circostante, un po’ per volta conosciamo Patrizia, apprendiamo del suo
carattere, delle sue aspirazioni, in un fil rouge stabilmente fissato
nonostante che i versi abbiano visto la luce in periodi sicuramente diversi,
anche a distanza di anni. Mi ha colpito, e non poteva essere diversamente
avendo scritto anch’io qualcosa al riguardo, E’ nel silenzio, con quel
suo dialogo in poesia che si completa con la successiva Fino all’anima,
con la parte più regale di noi, appunto l’anima.
Comunque,
in questa raccolta sono presenti, riuniti in tanti corpi diversi, più temi e
non poteva mancare quello dell’amore, inteso nella sua accezione più ampia,
con il suo preludio, breve, ma esaustivo ( E solo allora capisco, / mentre
angosciata sorrido, / che formula strana / è l’amore, / che stare non può /
senza la sua rima, dolore. ). Ai versi di questo corpo è stato dato il
nome Là dove il cuore, a cui seguono quelli chiamati, nel loro
complesso, Il respiro del mondo, pure qui con il suo bel preludio (
Poesia / è guardare / dall’alto di una finestra / un blu fittissimo /
immenso,/ pullulante di stelle / e vedere / pian piano / affiorare / case e
paesi, / esseri e vite. / Poesia è / calarsi in quel blu, / meravigliosa
vertigine. ), in pratica così è la vita.
Seguono
poi quelli del terzo corpo, chiamato terza danza, e che si intitola Alla
soglia del bello, dove il bello è quello dell’arte, che attira e stupisce;
esempio lampante sono le sensazioni ed emozioni provocate dalla musica, come
in Dolce è perdersi, oppure un’architettura di difesa che richiama
gesta epiche, come proprio in Il castello di Poppi.
E infine,
a completamento della raccolta, il cosiddetto balletto finale intitolato il
Tempo che trasforma. E’ una realtà che il tempo scorre e ha effetti su
tutto, ma nel caso specifico soprattutto su di noi; in questo senso riporto
integralmente quella che ritengo la migliore fra le tante, cioè Dal
davanzale del tempo: “Dal davanzale del tempo osservo / il mulino degli
anni / che macina e gira / i giorni e i mesi / e noi tutti sospesi /
nell’acqua fluente / che chiara ci appare / solo quando ritorna alla fonte. /
E a volte una vita, / coltivata nel cuore / con fatica e sudore, / si sfarina
così, / quasi senza rumore / e del mattino di sole non resta / che uno
schianto leggero, / un lieve sfavillo / nel rosso teatro serale./ E poi tutto
- pubblico o attore - / s’ingorga e s’involve / nella ruota dentata del
tempo.”. A parte il contenuto mi preme evidenziare le felici scelte che
donano un sapore di affresco, come “il mulino degli anni / che macina e gira
/”, oppure “ il lieve sfavillo / nel rosso teatro serale.”.
Sono
arrivato così a ultimare la lettura, gratificante, con poesie dalla struttura
equilibrata, e pertanto armonica, non fini a se stesse, non esercizi di
virtuosismo, che pure non manca, ma un dialogo instaurato prima fra l’autore e
il proprio Io, e poi con il lettore, che non può che ringraziare.
Patrizia Fazzi
è nata e vive ad Arezzo. Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi
di Firenze, ha collaborato per alcuni anni presso la Cattedra di Letteratura
Italiana Moderna e Contemporanea diretta da Giorgio Luti. Docente di Materie
Letterarie e Latino negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore fino al
2007, è socia dal 1994 dell’Accademia Petrarca di Arezzo, dove ha tenuto varie
comunicazioni, dal 2004 del PEN CLUB ITALIA, Associazione Internazionale
Poets-EssaystNovelist. Attualmente è Presidente dell’Associazione degli
Scrittori Aretini “Tagete”. Da molti anni si dedica alla scrittura e alla
divulgazione culturale. Fin dalle prime opere è emersa una profonda fede nella
parola poetica, una riflessione esistenziale e molti interessi per l’arte. Ha
ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui, per la Poesia Inedita: 1° Premio
“Marco Tanzi” 1998, (Presidente Vittorio Vettori), 1° Premio “MaestraleSan
Marco” 2002 (Marengo d’Oro); 3° Premio assoluto Premio Internazionale “Il
Molinello” 2003 (Presidente Mario Luzi); Finalista al “Premio Città di
Corciano” 2001 (Presidente Valerio Magrelli); 1° Premio “Sandra Quaglierini”
2002 (Presidente Dino Carlesi) e 1° Premio Città di Rufina” 2003 , 1° Premio
“Alessandro ed Elves Vettori” 2019 ed ottime qualificazioni al Premio
“Casentino” dal 1998 al 2003 e 2014 e al Premio Firenze 2002 (“Segnalazione
d’Onore”). Ha pubblicato le raccolte di poesie: Ci vestiremo di versi, Helicon
2000; Dal fondo dei fati, Edizioni del Leone 2005, (Fiorino d’argento 2005 e
1° Premio Tagete 2006); La conchiglia dell’essere - Poesie per Piero della
Francesca, Le Balze, 2007 (Premio Speciale A.Contini Bonacossi 2007); Il filo
rosso-Segno e simbolo nell’arte di Giampaolo Talani, Polistampa, 2008 (1°
Premio Tagete 2011); L’occhio dei poeti, Edizioni del Leone, 2011, Prefazione
di Paolo Ruffilli (Premio Speciale Firenze 2012, 1° Premio Tagete 2014);
Finché ci sarà una nota, Prometheus, 2018, poesie dedicate alla Musica
(Introduzione di Roberto Fabbriciani e di Claudio Santori). La conchiglia
dell’essere, ristampata in edizione ampliata e aggiornata (anche in lingua
inglese, The Shell of Being, Polistampa 2009), ha ricevuto la “Segnalazione
d’Onore” al Premio Firenze 2010. È del 2015 il filmato Cuneo di luce, Italian
Art Movie, in cui le sue poesie dedicate alla Cappella Bacci di Arezzo sono
lette da Luca Biagini e unite alle immagini pierfrancescane e ad un sottofondo
musicale. È autrice, insieme ad Anna Bartolini, della monografia Villa degli
Orti Redi – Un giardino aretino da riscoprire, 2016, Prometheus Editrice, che
ha ottenuto nel 2017 tre pregevoli riconoscimenti e da cui è stato tratto un
omonimo filmato curato dalle autrici. Studiosa di Ottone Rosai, ha scritto
vari saggi sull’artista, pubblicati in “Nuova Antologia”, negli Atti
dell’Accademia Petrarca e in varie miscellanee. Altri saggi critici su Ugo
Foscolo, Federigo Tozzi, il futurismo fiorentino, Paolo Ruffilli, etc sono
apparsi, oltre che nelle precedenti riviste in “Studi Italiani”, “Il
Portolano” ed altri siti letterari. Nel 2001 le è stato assegnato il “Fiorino
di Bronzo” per la Saggistica, nel 2005 il Premio “Domina Donna” dalla
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Arezzo e nel 2012, nel Salone
dei ‘500 a Firenze, il “Premio Speciale Firenze Mario Conti” per la sua
attività letteraria. Dal 2013 Patrizia Fazzi è stata inserita nel sito
www.italian-poetry. org/fazzi_patrizia.html, dedicato ai poeti italiani del
Secondo Novecento, e dal 2020 ha una pagina nel sito www.wikiPoesia. Nel 2014
le è stata conferita l’Onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica”. Sue poesie sono presenti in antologie, tra cui A mio padre,
Newton Compton, 2006 e F. Manescalchi, Poesia toscana del Novecento, 2009; sue
opere sono state oggetto di presentazioni o recital teatrali, in particolare
ad Arezzo, Firenze, Roma (Ambasciata d’Austria), Parma (Teatro Regio,
Auditorium Paganini, Corale Verdi), Nizza (Consolato Italiano), Cortona,
Sansepolcro, San Vincenzo (Li), Lucca, Monterchi, Repubblica di San Marino,
Milano. Su invito della Società Dante Alighieri, il 16 ottobre 2012 durante il
Mese della Cultura e Lingua Italiana, il libro La conchiglia dell’essere è
stato presentato al Théatre des Variétés alla presenza dell’Ambasciatore
d’Italia e del Segretario di Stato del Principato; la raccolta è stata
presentata a Milano EXPO 2015 insieme al filmato Cuneo di luce,
successivamente proiettato nel 2016 al Teatro Petrarca di Arezzo durante
l’evento “Piero: l’Oro di Arezzo” e a Roma, Palazzo Cesi (Festival
Internazionale del Cinema Religioso). Sulle sue opere si sono espressi
positivamente, tra gli altri, Giorgio Luti, Roberto Carifi, Paolo Ruffilli,
Giorgio Barberi Squarotti, Giuseppe Marchetti, Luciano Luisi, Giovanni
Faccenda, Giuseppe Panella, Neuro Bonifazi, Giovanni Giraldi, Giovanna Vizzari,
Davide Puccini, Francesco Solitario, Pier Francesco Listri, Monica Venturini,
Claudio Santori, Fernanda Caprilli, Liletta Fornasari, Fabrizio Fabbrini,
Franco Manescalchi, Luciano Nanni, Vincenza Fava, Carlo Fini, Mariagrazia
Carraroli, Alma Borgini, Giorgio Poli, Eugenio Nastasi, Plinio Maggiolini,
Ettore Fini. Queste ed altre recensioni sono riportate in www. literary.it/autori/dati/fazzi_patrizia/patrizia_fazzi.
html.
Renzo Montagnoli
8 Febbraio

La sinagoga degli
zingari
di Ben Pastor
Sellerio Editore Palermo
Narrativa
Stalingrado
Estate 1942, fronte orientale, il maggiore Martin von Bora della Wermacht,
nonché membro dell’Abwehr, il servizio di controspionaggio militare del Terzo
Reich, riceve dai suoi superiori l’incarico di cercare una coppia di rumeni,
marito e moglie, due noti scienziati, eclissatisi dopo che l’aereo che li
trasportava era stato costretto a un atterraggio di fortuna. Li rintraccerà,
purtroppo ormai morti in quanto assassinati, con l’aiuto del maggiore Amerigo
Galvani, in forza alla Terza Divisione Celere Duca d’Aosta. Chi ha commesso
l’omicidio, per quali motivi e scopi è il nuovo incarico di von Bora, pressato
per una rapida soluzione anche dal Generale Friedrich Paulus, comandante in
capo della VI armata tedesca destinata a conquistare Stalingrado. E questa
località, assai nota per quanto vi accadde appunto del corso della seconda
guerra mondiale, a poco a poco prende il sopravvento nella narrazione, con i
combattimenti per impossessarsene e con gli imminenti vincitori tedeschi che
vengono circondati e stremati dalla fame e dal freddo, decimati dagli scontri,
per doversi infine arrendere. E l’indagine? A tratti riaffiora, con sospetti
che emergono, ma senza che abbiamo un riscontro positivo, così che tutto
finirebbe dimenticato se Bora cadesse prigioniero, ma invece riesce con pochi
dei suoi a forzare l’anello degli assedianti e, benché ridotto in fin di vita,
riapproda dietro le linee tedesche. Ed è in una Praga occupata che il maggiore
dell’Abwehr arriverà alla soluzione, forse inattesa, ma indubbiamente logica.
Era da un po’ di tempo che non avevo l’occasione di leggere i romanzi di Ben
Pastor con protagonista questo ufficiale combattuto fra il senso dell’onore
proprio del soldato prussiano e la coscienza dell’essere umano, una
caratteristica che lo rende unico e di sicuro interesse e, a essere sincero,
ero convinto che l’autore, a corto di idee, avesse interrotto una serie che lo
ha reso famoso; e invece riecco un altro romanzo in cui la dimensione del
dramma dell’assedio di Stalingrado ha un peso determinante, se non altro per
le oltre 650 pagine dell’opera, di cui almeno la metà, se non di più, sono il
resoconto di una delle più grandi battaglie della storia. Anche in questo
caso, nella descrizione dell’atmosfera, dell’ambiente, degli scontri,
nell’analisi psicologica approfondita dei protagonisti, Ben Pastor ha modo di
mostrare le sue non di certo trascurabili capacità, ma forse presa dallo
sviluppo della trama, magari anche un po’ esaltandosi, si è lasciata prendere
la mano e ha scritto un po’ troppo. Non si tratta di un errore di particolare
gravità, ma sta di fatto che La sinagoga degli zingari, pur
restando appassionante, non è all’altezza delle opere precedenti.
La lettura resta indubbiamente gradevole, ma lo stile perde un po’ di quella
fluidità sempre apprezzata nei lavori dell’autore, insomma il libro è buono,
ma non eccellente.
Scrittrice italo americana
Ben Pastor,
all'anagrafe Maria Verbena Volpi, nata a Roma
il 4 marzo 1950 ma trasferitasi ben presto negli Stati Uniti, ha insegnato
Scienze sociali presso le università dell'Ohio, dell'Illinois e del Vermont.
Oltre a Lumen, Luna bugiarda, Kaputt Mundi, La canzone
del cavaliere, Il morto in piazza, La Venere di Salò, Il
cielo di stagno, - ovvero il ciclo del soldato-detective Martin Bora
(pubblicati da Hobby&Work a partire dal 2001 e poi da Sellerio) - è autrice di I
misteri di Praga (2002), La camera dello scirocco,
omaggi in giallo alla cultura mitteleuropea di Kafka e Roth (Hobby &Work),
nonché de Il ladro d'acqua (Frassinelli 2007), La
voce del fuoco (Frassinelli 2008), Le vergini di
pietra e La traccia del vento (Hobby & Work
2012), una serie di quattro thriller ambientata nel IV secolo dopo Cristo.
Nel 2006 ha vinto il Premio Internazionale Saturno d'oro come migliore
scrittrice di romanzi storici.
Le sue opere sono pubblicate negli Stati Uniti e in numerosi Paesi europei.
Un suo racconto è incluso nell'antologia Un Natale in
giallo (Sellerio 2011).
Nel 2014 esce La strada per Itaca (Sellerio) e nel
2020 Il ladro d'acqua (Mondadori).
Renzo Montagnoli
3 Febbraio

Roma 1943
di Paolo
Monelli
Edizioni
Einaudi
Saggistica storica
Un anno
decisivo per l’Italia
Se uno
storico di grande prestigio come Lucio Villari scrive in IV di copertina
«Opera di grande giornalismo e di intensa testimonianza morale, "Roma 1943" -
pubblicato per la prima volta nel 1945 - resta, a mio parere, un modello
inarrivabile (forse, unico) di cronaca autentica, di verità essenziale che
poco o nulla ha a che vedere con la tradizione spesso dissimulatrice del
giornalismo italiano» c’è sicuramente da fidarsi ed è per questo motivo che
ho letto questo saggio storico – è così che deve essere classificato – con un
piacere che raramente mi è accaduto di provare per un lavoro tecnicistico,
perché è evidente, a meno che non si inventi, che un elaborato storico deve
avere un substrato rigorosamente corrispondente a quanto effettivamente
accaduto, ma proprio per questo il più delle volte, pur essendo interessante,
non è tuttavia in grado di avvincere, di tenere incollato il lettore alle
pagine. E invece questo Roma 1943 si legge come un romanzo
fluente, nonostante la presenza di non pochi incisi, sempre però molto
funzionali alla narrazione, che sono delle vere e proprie illuminazioni
relativamente alle caratteristiche dei protagonisti, alle speranze e anche
alle meschinità che si accavallano, all’incubo di quel che fu la dominazione
tedesca e alla dignità e al coraggio di un popolo, quasi sempre assai migliore
dei suoi comandanti. Il libro inizia con i malinconici auguri per il nuovo
anno scambiati fra Monelli e un suo amico il primo gennaio del 1943; c’è in
giro un’apatia che contrasta con l’incrollabilità del popolo italiano
strombazzata dai giornali di regime e in fondo è anche comprensibile, perché,
non solo la guerra è in essere con tutte le sue problematiche da quasi tre
anni, ma ormai la situazione sui vari fronti lascia intendere che di speranze
di vittoria non ce ne sono più. I caduti in battaglia, i bombardamenti, il
razionamento alimentare rappresentano ormai una costante per una nazione che
entrò in guerra solo perché lo volle il capo, un uomo descritto come malato,
vanitoso, irresponsabile. E il peggio deve ancora venire, perché persa la
Libia ci sarà lo sbarco in Sicilia, indi la caduta del fascismo il 25 luglio
votata dai membri del Gran Consiglio, l’arresto di Mussolini il giorno dopo
appena uscito da villa Savoia dove era appena andato a conferire con Vittorio
Emanuele III per quella esautorazione maturata in una notte di fuoco in cui il
duce, più che protagonista, pare essere stato un attonito spettatore, e
infine quel maledetto armistizio dell’8 settembre che portò i tedeschi a
occupare Roma e buona parte dell’Italia, una tragedia di cui fecero spese gli
italiani, soggetti di una brutale repressione.
Monelli analizza i fatti, descrive gli eventi, ricerca le motivazioni dei
comportamenti, in un crescendo che avvince il lettore che, benché almeno a
grandi linee sappia quel che accadde, ha l’impressione di trovarsi di fronte a
qualche cosa di nuovo, a una visione quasi cinematografica che va dalla
mestizia di due uomini che si fanno gli auguri il primo gennaio del 1943 alle
scene di gioia, all’unanime sollievo degli esausti romani il 4 giugno 1944
allorché le avanguardie americane entrarono in città.
Non si evita nulla, anzi si scava a fondo senza riguardo per i protagonisti,
perché in quanto tali responsabili di ciò che avvenne in quell’anno,
responsabili nel bene e nel male, dagli arrivisti fascisti senza morale ai
crudeli comandanti tedeschi, alle troppe incertezze del governo Badoglio
all’incapacità degli Alleati di saper cogliere l’occasione per poter
infliggere una sconfitta colossale alle truppe germaniche.
Roma 1943 è un libro di grande interesse, ben scritto, sincero e veramente
avvincente.
Paolo Monelli
(Fiorano
Modenese, 15 luglio 1891 – Roma, 19 novembre 1984)
giornalista e scrittore italiano. Ufficiale degli alpini durante la prima
guerra mondiale, scrisse su quell’esperienza un fortunato libro di memorie (Le
scarpe al sole, 1921). Congedato, intraprese la carriera giornalistica e fu
redattore del «Resto del Carlino», del «Corriere della sera», della «Stampa».
Scrittore elegante, educato alla scuola della prosa d’arte, portò
nell’esercizio professionale il gusto della parola «scelta», e in una sorta di
repertorio-pamphlet più volte ristampato (Barbaro dominio, 1921) difese la
«purezza» della lingua contro barbarismi e forestierismi. Al tema della guerra
dedicò altre opere di narrativa: Sessanta donne (1947), Morte del diplomatico
(1952), Nessuna nuvola in cielo (1957). Interessanti, per la lucidità
dell’analisi e la scioltezza dell’esposizione, alcuni libri di politica, fra
cui Roma 1943 (1945) e Mussolini piccolo borghese (1950).
Renzo Montagnoli
29 Gennaio
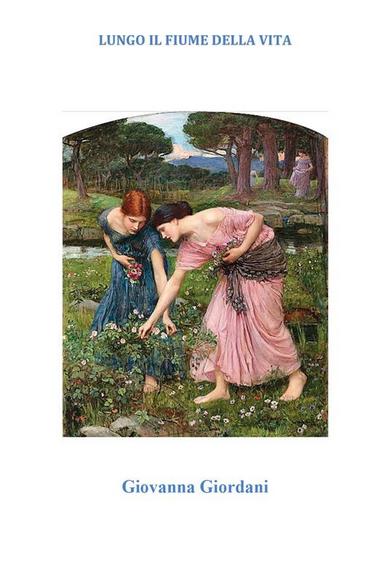
Lungo il fiume della vita
di Giovanna Giordani
Youcanprint
Poesia
Serenità naif
Giovanna Giordani non mi è certo sconosciuta, essendo un ospite frequente di
Arteinsieme, il magazine che conduco, e proprio per questo credo di poter
scrivere a ragion veduta di un'artista che, animata dai migliori sentimenti,
cerca di esprimerli in versi, non di rado con risultati lusinghieri. In cambio
rare sono le pubblicazioni delle sue poesie, tanto che prima di questa
rammento solo Sulla riva del fiume edita da Aletti nel 2009 e di cui scrissi
una recensione positiva. In quel giudizio ormai datato rammento che la stessa
Giovanna Giordani mi confermò quanto riportato nella quarta di copertina, che
trascrivo fedelmente: "Il mio poetare non è ricercato, lo definirei naif,
semplice, vero che ubbidisce ad una voce arcana che mi detta le parole per dar
forma scritta alle emozioni, ai sentimenti." Sono parole che ancor oggi mi
sembrano appropriate, perché la poesia dell'autore trentino ha effettivamente
le caratteristiche che sono proprie della pittura naif, cioè la semplicità e
il candore con cui vengono espressi i sentimenti. Ne scaturisce una poetica
che ha un suo pregio e che in genere incontra il favore di chi legge.
"Quando il clamore del mondo / si spegne / riecheggia amico / il canto dei
poeti . /…."(da Il canto dei poeti); "Il suo bussare fu lieve / e la terra
comprese / e chiese al sole / un regalo speciale / per sconfiggere il gelo /
che l'opprimeva. /..."(da il Bucaneve); "Le voci del bosco d'inverno / le
senti frusciare / fra i rami svestiti / e le foglie rimaste / a vegliare /…."
(da Le voci del bosco d'inverno); "Sguardi affacciati / dalle carrozzine /
allineate / lungo il corridoio / come rondini in sosta / sui fili della luce /
tenere / distanti" (da Casa di riposo).
Versi come questi, nella loro pacata armonia, ben esprimono sentimenti ed
emozioni, sono inclini a penetrare senza sforzo nell'animo di chi legge,
trasmettendogli un benefico senso di pace, con la dolcezza che li accompagna e
una semplicità volta appunto all'immediatezza. L'impressione che mi sono fatta
è che sgorghino senza freno dall'animo di Giovanna, pur con il pudore dei
crochi che sbocciano nella neve nel tardo inverno e con l'ardore dei primi
raggi di sole che annunciano l'arrivo dell'imminente primavera.
Dunque, una poesia semplice, ma per niente scontata, e che trova questo fiume
ricorrente nei titolo delle raccolte di Giovanna Giordani, con l'agilità della
corrente di parole che scandiscono i versi, saltellante fra le rocce con un
suono cristallino e che non diventa mai rombo prima di adagiarsi, procedendo
lentamente, nel suo cammino in pianura verso la foce.
Non c'è problema d'interpretazione perché si tratta di sentimenti puri e
innati, si fiondano nel cuore di chi legge e ci restano, sono il sereno dopo
una tempesta, sono la quiete in cui ogni tanto rifugiarsi.
Non credo di aver altro da dire, se non la raccomandazione di leggere Lungo
il fiume della vita.
Giovanna Giordani,
nata in Vallagarina (TN), vive sull’Altopiano della Vigolana,sempre in
provincia di Trento, in mezzo a bellissime montagne.
Da sempre ama la poesia e
la letteratura, ma la vita le ha impedito di dedicarsi ad esse come avrebbe
voluto.
In età matura ha conseguito la laurea in lettere moderne ed è stata
l’occasione per riprendere con piacere il suo grande hobby
capace come pochi
di rasserenarle la vita.
Renzo Montagnoli
24 Gennaio
Silloge poetica Fibre di
Possibilità
di Sergio Messere


Sinossi.
Questa silloge è suddivisa in sette aree tematiche e vuole essere un viaggio
con l’Uomo e nell’Uomo, dando voce alle innumeri sfaccettature.
Si inizia con la Tetralogia degl’Inquieti, cammino tortuoso e collettivo verso
la realizzazione del sé. Vibrazioni di amore e di energia, dove affronto il
tema dell'amore nelle salse più disparate. Nei recessi più neri, laddove ci si
interroga anche sulla presenza di un Dio impassibile, non presente. Le cose
belle e semplici, in cui spicca la poesia dedicata all'amicizia. Passaggi
autobiografici e momenti di svago. Infine, il vortice di esperienze inusuali,
totalizzanti, dimensioni altre (su tutte,"Hypnotica" e "Idea").
Sergio
Messere
23 Gennaio
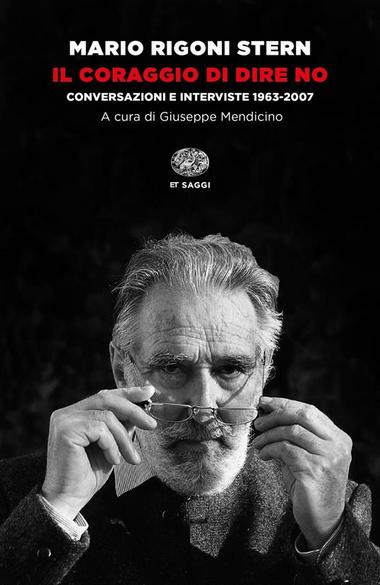
Il coraggio di dire no
Conversazioni e interviste 1963-2007
di Mario
Rigoni Stern
a cura di
Giuseppe Mendicino
Edizioni
Einaudi
Saggistica
Per
conoscere meglio Mario Rigoni Stern
Questo
libro, che raccoglie molte delle interviste rilasciate in un lungo periodo
(dal 1963 al 2007) da Mario Rigoni Stern, è frutto di una ricerca e di una
scelta oculata di colui che può essere definito senza ombra di dubbio il
miglior biografo del grande scrittore asiaghese, cioè Giuseppe Mendicino. Al
riguardo c’è da precisare che la cernita non deve essere stata facile, vista
la notevole disponibilità di Rigoni Stern a conversare con la gente e i
frequenti incontri dello stesso non solo con giornalisti o altri scrittori, ma
anche con le scolaresche. Di cosa si parlava in queste occasioni? C’è da
precisare che a domanda Rigoni Stern rispondeva, magari ampliando il discorso,
ma comunque evidenziando sempre un’ampia disponibilità a colloquiare, come se
il raccontare del passato costituisse un’impellenza trattenuta a stento.
Sarebbe però sbagliato pensare che i temi fossero solo quelli del suo
trascorso e in particolare quelli della guerra, perché, abituato a scrivere il
frutto delle sue osservazioni quotidiane, sono non pochi gli argomenti
atemporali presenti in questi colloqui.
Del resto
la grandezza dell’autore asiaghese risiede proprio in questa sua capacità di
rapportarsi con la natura, con i sentimenti e le emozioni che sono propri
degli esseri umani e che sono frutto di un attento spirito critico, una
abilità rara che rende le sue opere sempre giovani in qualsiasi epoca.
Ho
trovato, peraltro, delle risposte illuminanti e di queste intendo riferire a
titolo di esempio. A questa domanda di Alberto Papuzzi: “ E’ vero che la
guerra dice la verità sugli uomini, chi è forte, chi è debole, chi audace, chi
infingardo?”, Rigoni Stern risponde affermativamente, precisando che ci
sono le stesse reazioni come nella montagna estrema, e così gli uomini si
manifestano per quel che sono, con gesti di grande umanità, se non addirittura
di eroismi, da parte di gente umile, e con altri di autentica vigliaccheria,
come accaduto con ufficiali di carriera che scappavano a gambe levate. In
questa risposta emerge l’essenza dell’animo umano che, sottoposto a
costrizioni o a pericoli, riesce a dare il meglio o il peggio di sé. E poi ce
n’è un’altra di Renzo Oberti per Il Giornale di Vicenza, la cui risposta
condivido parola per parola, perché avrei detto così anch’io. Il giornalista
domanda:”Ha una ricetta da darci per procedere indenni fra gli scogli della
navigazione quotidiana?” Trascrivo pari pari la risposta di uno Stern che
nell’inverno della sua vita ha sublimato la saggezza che è sempre stata
presente in lui:” Leggere molti libri e guardare poca televisione. La vita
va costruita con la dignità del lavoro, non riconoscendo utopie lontane dalle
nostre possibilità e dai nostri bisogni intellettuali e materiali.”. Ecco,
questo è il senso della vita per un uomo che ha provato di tutto nella sua
esistenza, che è riuscito a uscire vivo dall’inferno bianco della ritirata
della campagna di Russia, che è sopravvissuto alla tragedia della prigionia
nei lager tedeschi, che ha saputo sempre vedere intorno a lui con umiltà, ma
soprattutto con umanità.
Fra le
tante interviste raccolte da Giuseppe Mendicino ne manca una, la mia. Sono
arrivato troppo tardi, quando già lui stava male, un po’ prima che morisse, e
ovviamente ho rinunciato. Fra le tante domande che avrei voluto rivolgergli,
ce n’era una che mi stava a cuore: “A un uomo che è scampato a tante
battaglie, che è ora nella sua vecchiaia, come pensa sia giusto vivere?”;
ebbene, leggendo i suoi libri e queste interviste mi sono persuaso che avrebbe
risposto che il rispetto degli altri e della natura, la memoria delle proprie
radici sono gli elementi basilari per poter vivere con serenità e in pace con
se stessi.
Questo
libro è sicuramente da leggere perché aiuta a conoscere meglio Mario Rigoni
Stern.
Mario Rigoni Stern
(Asiago,
1 novembre 1921; Asiago, 10 giugno 2008)
Scrittore italiano. Esordì con Il sergente nella neve (1953),
una delle più notevoli testimonianze letterarie della seconda guerra mondiale,
alla quale l’autore partecipò con gli alpini sul fronte russo. Dopo anni di
silenzio Rrigoni Stern è tornato alla narrativa con i racconti Il
bosco degli urogalli (1962) e i romanzi La guerra
della naia alpina (1967), Quota Albania (1967), Ritorno
sul Don (1973), Storia di Tönle (1978,
premio Campiello), emblematica biografia di un solitario montanaro durante la
grande guerra, uno dei suoi esiti più alti. Successivamente, accanto a nuovi
romanzi, L’anno della vittoria (1985) e Amore
di confine (1986), lo scrittore ha pubblicato diverse opere che
testimoniano di una sua crescente adesione al mondo della natura: Uomini,
boschi e api (1980), Il libro degli animali (1990), Arboreto
selvatico (1991). In Le stagioni di Giacomo (1995,
premio Grinzane) ha raccontato i luoghi d’origine. Nella produzione successiva
tornano i suoi temi dominanti: Sentieri sotto la neve (1998), Tra
due guerre e altre storie (2001), Stagioni (2006),
I racconti di guerra (2006).
(dall'Enciclopedia
della Letteratura Garzanti)
Renzo Montagnoli
18 Gennaio
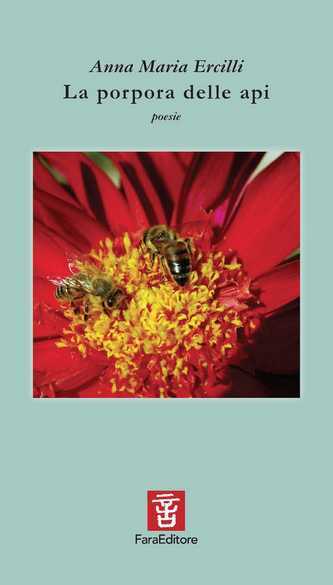
La porpora delle api
di Anna Maria Ercilli
Postfazione di Alberto Mori
Foto in copertina di Anna Maria Ercilli
Fara Editore
Poesia
La
delicatezza con cui sono espressi i sentimenti
“Non trovo nessun meridiano / per
unire i passaggi, /…” “Ricordiamoci il rumore / dei passi / nelle
strade silenziose /…” “Lente scorrono sul vetro / rispecchiano il mondo
/…”.
Se leggiamo le poesie di questa
raccolta in religioso silenzio ci è possibile sentire un battito, quello di un
cuore caldo che freme nell’osservare, nel guardare intorno per poi fissare su
carta sensazioni ed emozioni, è un cuore che trema e gioisce, che lento
scandisce ricordi trascorsi, che fa risentire passi lontani; è un cuore quello
dell’autore che accompagna la nostra emozione, che ci incanta con le sue
sublimi parole ( Si allontana, le spalle / ricurve come da / un peso /
invisibile il fardello ma pesante, / sono mancate le parole / quelle facili
per le nostre labbra, / nessuno s’è girato a raccogliere / uno sguardo, /
l’ultimo incompiuto ponte / sospeso / ignoravamo come e dove / finivano le
nostre sorti.). Di Come sospesi ho riportato integralmente i versi,
perché è raro trovare una delicatezza e una sensibilità con cui esprimere i
sentimenti, sussurrati in punta di penna.
Però questa poesia non è la sola a
presentare queste caratteristiche senz’altro innate nell’autore, visto che è
un piacere ritrovare questa dolcezza anche quando si scrive di cose che fan
male, perché in fondo constatare non vuol dire concordare (Le parole - Le
parole non portano / rancore sono disarmate, / ma sanno ferire / le parole
incontrano finestre chiuse, / aprono porte nei cortili / sfregiano muri di
argilla / non entrano nell’arido tempo / non lasciano arrivare il sonno,/
rodono il dubbio nel rumore / indefinito, stridono / nella lingua della notte
/ travisano il senso / a te pensano. ).
Chi come me scrive anche poesie
potrebbe sembrare facilitato nello stilare la recensione di una silloge, ma
non è del tutto esatto, perché prima di tutto mi deve spossessare della mia
personalità poetica per entrare in quella dell’autore e ciò a volte è
difficile, ma in questo caso non lo è, perché mi sono trovato di fronte a una
persona che è sempre presente, in ogni verso, anche quando si chiude il libro.
I sentimenti e il modo di esprimerli senza imporli, anzi proponendoli, mi
hanno appagato, mi hanno indotto a una serie di riflessioni sul senso della
vita, sui miei rapporti con gli altri che mi hanno condotto a quella serenità
che si può provare solo quando si legge qualcosa che ti tocca nel profondo,
che ti fa aprire il cuore per poi rinchiudervi dentro quell’emozione da
ripescare nei momenti grigi.
Quando un’opera mi provoca questa
sensazione non ho da chiedere altro, mi ha dato tutto ciò che cercavo e quindi
inevitabile è il giudizio positivo della stessa, un giudizio che spero
concordi con quello di altri che intendessero leggerla, ricordando che, a
differenza di una prosa, la composizione poetica deve essere ponderata parola
per parola, onde entrare in sintonia con l’autore.
Anna Maria Ercilli,
vive a Trento con memorie liguri. Ha lavorato nel Servizio Sanitario. Ha
pubblicato sette sillogi di poesia, scrive racconti e articoli culturali per
le riviste «Il Furore dei libri» e «R&S», è inserita in alcune antologie (Controparole, Hospite, L’evoluzione
delle forme poetiche, Vivere
l’abbandono) e riviste («La Mosca
di Milano», «Il Monte Analogo» e altre). Presente anche nel dizionario delle
parole perdute Nelle
pagine del tempo (EmmeTi 2011) e nei volumi Le
stagioni per posta e Una
lettera importante (entrambi con LUA di Anghiari), Quella
volta su un treno (Equinozi 2020), iPoet
Lunario in Versi (LietoColle). Fotografa per passione. Presidente della Società
Dante Alighieri di Trento nell’anno sociale 2014-2015.
Renzo Montagnoli
14 Gennaio
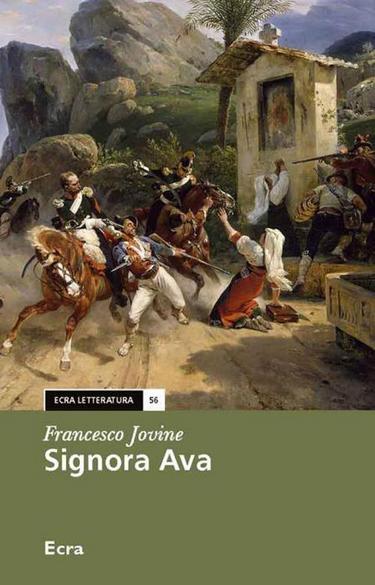
Signora Ava
di
Francesco Jovine
Ecra
Edizioni
Narrativa
Dalla
parte degli “ultimi”
Goffredo
Fofi, nella sua prefazione, l’ha chiamato “Il Gattopardo dei poveri”, ma dopo
averlo letto, concordo solo in parte; infatti, se le atmosfere e le date in
cui si svolgono entrambi i romanzi (fra il 1859 e
il 1860) sono pressoché uguali, differiscono invece nella sostanza, perché in
quello scritto da Tomasi di Lampedusa viene descritta la fine del regno
borbonico da parte di una famiglia di aristocratici, in quello di Francesco
Jovine si parla soprattutto della nascita di quel complesso fenomeno che
spesso troppo sbrigativamente va sotto il nome di brigantaggio. Dopo questa
doverosa premessa, preciso anche che nessuno dei due prevale sull’altro, ma
ambedue hanno il pregio di rappresentarci, nella loro veste di romanzi
storici, come, con la spedizione dei Mille e l’occupazione del meridione, si
poté arrivare all’unità d’Italia. Tutto ruota intorno alla famiglia De Risio,
piccola aristocrazia di campagna in uno Stato che sembra immobile e ingessato,
anche se va disgregandosi. Abitano nel paese molisano di Guardalfiera e a loro
modo sono dei personaggi, emblematici perché ben rappresentano la
stratificazione sociale degli abitanti del Regno dei Borboni nel suo
crepuscolo. Troviamo così il vecchio zio prete Don Beniamino, che tiene i
cordoni della borsa, Don Eutichio con la moglie sorda come una campana, tipico
rappresentante di una proprietà terriera medievale, il Colonnello, reduce
dalle guerre napoleoniche, aperto alle novità, ma disilluso, Don Matteo
Tridone, un prete povero, ma generoso, ingenuo e protettore dei più deboli,
Antonietta De Risio, malaticcia giovane erede della casata, e Pietro Veleno,
un servo contadino, fedele alla famiglia, segretamente innamorato di
Antonietta, che un po’ per volta ricambia. In questo contesto in cui nulla da
tempo immemorabile accade, la venuta di Garibaldi e dei suoi volontari ha un
effetto dirompente, con i contadini che cominciano a sperare nella promessa
distribuzione delle terre, in una nuova atmosfera che dovrebbe sconvolgere
l’ordine preesistente, ma i Savoia, giunti a reclamare il Meridione
strappandolo a Garibaldi, ristabiliscono con i signori locali, i
“galantuomini”, lo stato di cose precedente. Da qui la reazione esasperata, e
senza speranza, delle classi emarginate, che sfocerà in una guerra sanguinosa
in cui combatteranno l’esercito sabaudo con l’aiuto della locale Guardia
Nazionale, di cui fanno parte quelli che prima avevano un po’ di potere, che
ora temono di perdere. In questo contesto si svolge la vicenda con l’amore che
sboccia fra Pietro e Antonietta, amore benedetto da Don Matteo Tridone, che
vede nell’unione dei due giovani i germogli per una nuova coscienza civica,
con il superamento delle classi. In fuga entrambi con il sacerdote, in quanto
Pietro è stato denunciato alle autorità ingiustamente da Don Eutichio, tanto
che ha dovuto rifugiarsi dai briganti e combattere con essi, vengono traditi
da una guida mentre si apprestano a passare il confine con lo Stato della
Chiesa, loro sicuro rifugio. Non sappiamo il seguito, Jovine non ce parla, ma
si rimane come orfani di personaggi che sono entrati nel nostro cuore,
soprattutto l’ingenuo, ma buono Don Matteo, sempre dalla parte degli ultimi.
Il romanzo, scritto impeccabilmente, è veramente stupendo.
Francesco Jovine
(Guardialfiera, Campobasso, 1902 - Roma 1950) narratore italiano. Ispirò alla
nativa regione molisana le sue opere più significative: dal romanzo Signora
Ava (1942) alla raccolta di racconti L’impero in provincia (1945), all’altro
romanzo Le terre del Sacramento (1950, premio Viareggio), sorta di epopea del
lavoro contadino e commossa celebrazione della propria terra. I temi
tradizionali del feudo che va in rovina e del conflitto tra padroni e
contadini vengono rappresentati, all’avvento del fascismo, con una forte
carica polemica e uno stile asciutto che intreccia il rilievo di caratteri
balzachiani alla coralità della struttura. Narratore di tradizione
essenzialmente veristica, J. accolse nelle sue opere le istanze
dell’antifascismo e delle lotte sociali del dopoguerra, senza tuttavia
rinunciare a inflessioni di sottile lirismo. Nei suoi esiti migliori, egli
amalgama felicemente le agitate vicende della storia e l’aura immobile del
mito. Importante, nella Signora Ava, ma anche nell’Impero in provincia, il
delinearsi di un giudizio riduttivo sul risorgimento, con motivazioni che più
recentemente una parte della critica storica ha fatto proprie.
Renzo Montagnoli
8 Gennaio

L’ultima magia.
Dante, 1321
di Marco
Santagata
Edizioni
Guanda
Narrativa
I ricordi di un vecchio
Se
Dante. Il romanzo della sua vita era tutt’altro che un romanzo, bensì un
riuscitissimo saggio storico-letterario, L’ultima magia è invece
un’opera di narrativa di straordinaria bellezza.
Santagata
ha voluto raccontarci dell’ultimo periodo di vita del sommo poeta, ospite a
Ravenna dei Da Polenta, che lo incaricano di andare a Venezia in qualità di
loro ambasciatore. Corre l’anno 1321, il mese di Agosto, e Dante dopo un lungo
periodo di tribolazioni e di diversi padroni, ha trovato nella città romagnola
finalmente un’oasi di pace, in cui, finalmente riunito stabilmente con la sua
famiglia, può attendere con tranquillità l’ultimo passo, anche se qualche
problema finisce con l’assillarlo, timoroso del fatto che, per un incidente di
anni prima, un cardinale, segretario di stato pontificio, gli disse che se la
chiesa perdona, però non dimentica. E fra i tanti ricordi propri di una
persona avanti con gli anni quello di quell’incidente gli sovviene più
prepotente e così comincia a raccontare una storia di negromanzia che lo ha
visto involontario protagonista. E’ una narrazione da cui traspaiono le
preoccupazioni del poeta, i timori allora provati e che ora si riaffacciano,
più impietosi in quanto tormenti per un uomo che non ha più nulla da chiedere
alla vita, ora che ha ultimato la Divina Commedia e che è conosciuto e stimato
come il più grande dei poeti viventi. Il racconto del passato si alterna al
presente, la memoria di ciò che è stato riaffiora a minare quella tranquillità
che ha raggiunto, ma allora perché non rifugiarsi in ricordi più dolci, quale
può essere quello di un amplesso, improvviso e non ricercato, con Alagia, la
moglie del marchese Moroello Malaspina che ebbe l’opportunità di ospitarlo nel
suo castello di Mulazzo vicino a Massa-Carrara? Si trattò di un atto di
piacere isolato che non ebbe seguito se non molti anni dopo in una richiesta
proprio di Alagia di un piacere per tutelare l’ultimogenito, che potrebbe
essere stato concepito in quel rapporto frettoloso. Da lì si sviluppa la
vicenda della negromanzia, da cui uscirà Dante perdonato, ma segnato nel libro
nero della Chiesa, tanto che quando Galeazzo Visconti e Cangrande della Scala
gli riproporranno un omicidio con una fattura, Dante troverà, dopo molti
tormenti, il modo di uscirne pulito interessando la Chiesa stessa che lo
ringrazierà facendolo ospitare dai Da Polenta.
L’ultima
magia,
frutto indubbiamente della creatività di Marco Santagata, per quanto i
protagonisti principali siano veramente esistiti, è un romanzo storico molto
ben strutturato, che appassiona progressivamente il lettore, tanto più che la
trama è in grado di offrire momenti di tensione alternati ad altri di
tranquillità e con una conclusione di una dolcezza disarmante, quasi che
Dante, personaggio esistito veramente, fosse anche lui frutto della penna del
narratore, quel figlio solo immaginato, ma capace di dare un senso alla vita
di chi lo ha creato.
La
lettura è indubbiamente consigliata e assicuro che alla fine si verrà
contagiati dalla serenità raggiunta da Dante sulla base delle risultanze della
sua tormentata vita da esule, da uomo passionale, impulsivo, egocentrico, ma
anche capace di raggiungere vette sublimi con quella sua Commedia che già
allora aveva successo, ma che nemmeno poteva immaginare che tale sarebbe
rimasto anche nei secoli a venire.
Marco Santagata
(Zocca, 28 aprile 1947 – Pisa, 9 novembre 2020) è stato docente e scrittore
italiano.
Laureatosi alla Scuola Normale, ha insegnato Letteratura italiana
all’Università di Pisa. Dal 1984 al 1988 ne ha diretto l’Istituto di
letteratura italiana, ed è stato poi direttore del Dipartimento di Studi
italianistici.
È stato visting
professor in molti atenei prestigiosi come la Sorbona, l'Università di
Ginevra, la UNMA di Città del Messico e Harvard.
La sua
attività di studioso è stata rivolta soprattutto alla poesia dei primi secoli,
con una particolare attenzione a Dante e a Petrarca.
Su Dante,
di cui ha curato per i Meridiani Mondadori l’edizione commentata delle Opere,
ha scritto il libro L’io e il mondo. Un’interpretazione
di Dante (il Mulino, 2011) e la biografia Dante.
Il romanzo della sua vita (Mondadori, 2012). Tra i lavori
petrarcheschi si segnalano il commento al Canzoniere (Mondadori,
2004) e il libro I frammenti dell’anima (il
Mulino, 2011).
Si è
inoltre occupato di Leopardi (Quella celeste naturalezza.
Le canzoni e gli idilli di Leopardi, Il Mulino, 1994) e della poesia
fra Otto e Novecento (Per l’opposta balza. “La cavalla
storna” e “Il commiato” dell’”Alcyone”, Garzanti, 2002). Accanto a
quella scientifica ha svolto anche l'attività di narratore: con il romanzo Il
Maestro dei santi pallidi (Guanda) ha vinto il premio Campiello 2003.
Suoi anche Papà non era comunista (Guanda, 1996), L'amore
in sè (Guanda, 2006), Il salto degli Orlandi (Sellerio,
2007), Voglio una vita come la mia (Guanda,
2008), Come donna innamorata (Guanda, 2015) grazie
al quale entra nella cinquina dei finalisti del Premio Strega, e Il
movente è sconosciuto (Guanda, 2018). Inoltre, ha scritto con Alberto
Casadei il Manuale di letteratura italiana medievale e
moderna (Laterza, 2007) e il Manuale di
letteratura italiana contemporanea (Laterza, 2009). Per Mondadori esce
inoltre il saggio a tema scientifico Un meraviglioso
accidente, del quale è coautore insieme a Vincenzo Manca. Nel 2020
esce Il copista (Guanda). Lo stesso anno lo
scrittore contrae il Covid-19, malato da lungo tempo, questo gli risulterà
fatale portandolo alla morte il 9 novembre 2020.
Renzo Montagnoli
7 Gennaio

Abbraccio alla vita di Vincenzo Patierno
Raccolta poetica regalatami per Natale, regalo azzeccato e apprezzatissimo.
Scartato la sera del 24 e il 25 mi aveva già conquistato con la sua genuinità,
sincera, accogliente e ricca di buoni propositi. L'opera, anche se non è
questo il suo intento, abbraccia e si fonde con il vero spirito natalizio,
quello di pensare un po' più agli altri e non quello del consumismo
compulsivo. Il poeta si avvale di un linguaggio semplice per conquistare il
lettore, in finale, lui è un poeta che ci porta una cronaca delle sue
reminiscenze, sogni e paure, mica un politico che deve convincerci a votarlo.
Silloge consigliata a tutti gli amanti della poesia, quella non troppo
arzigogolata, ma che poetica come mangia e sa come scaldare il cuore.
28 dicembre 2021
Nacho Perez
5 Gennaio

Abbraccio alla vita
di
Vincenzo Patierno
Silvia Ferretti
Questo Natale, per via della situazione che noi tutti conosciamo, l'ho passato
da sola, potrei dire sola come un cane, ma sarebbe più corretto dire: sola con
un gatto e un libro di poesie.
Le amiche e i parenti, con cui sono riuscita a vedermi prima delle feste e
scambiarmici i doni, mi hanno regalato quasi esclusivamente libri (gradisco
così) ed ecco che tra tanta meravigliosa narrativa mi spunta questo libricino
di poesie, delicate e sensibili da cullarmi un po' e farmi sentire un po' meno
sola.
Ho trovato gusto nella musicalità della raccolta e il moto del poeta di gli
argomenti più scomodi, mi ha fatto riflettere e distogliere per qualche ora
dalla realtà.
Alla mezzanotte, né il gatto, né le poesie così bere il prosecco, non
volendolo sprecare in nome dei meno fortunati, mi sono ubbriacata e se questa
volta la sbornia è stata più queste dolce è stato solo grazie a poesie.
4 Gennaio

I racconti della maturità
di Anton
Cechov
Feltrinelli Editore
Narrativa
La vita in due
Questi
racconti con ogni probabilità sono stati scritti verso la fine della vita di
Cechov che morì a soli 44 anni in conseguenza di una tubercolosi che lo
divorava da tempo e a cui invano cercò di sfuggire spostandosi di continuo in
località più salubri. In ogni caso di tratta di prose che risalgono a ben
oltre un secolo fa e quindi ci sarebbe da attendersi uno stile un po’
stucchevole, non disgiunto da una certa grevità tipica di quasi tutti gli
autori russi. Invece, per fortuna, e ne guadagna così parecchio il piacere
della lettura, lo stile è snello, tutto sommato semplice senza essere
elementare, accompagnato da una tipicità di Cechov che, oltre all’indubbia
dote di saper sondare l’animo umano, inserisce sempre un rapporto con la
natura che va ben oltre lo sfondo in cui si svolge la trama, ne è parte
essenziale, con una vena poetica che, senza sfociare nel lirismo, dona un
tocco di grazia.
Il volume
riporta sei racconti, con un unico fil rouge che li accomuna, vale a
dire il rapporto di coppia, tutte storie di amori che durano quanto un amen,
di legami che da affetti si tramutano in obblighi, e in quanto tali destinati
a essere osteggiati con il piacere del tradimento. Nel mondo di Cechov non c’è
spazio per vicende in cui uomini e donne riescano a conciliare una passione
iniziale con un affettuoso legame successivo, anzi poco a poco si instaura una
incomunicabilità che porta ognuno per la sua strada. E’ questo il caso del
professor Kovrin, in preda a un delirio allucinatorio che lo porta a vedere un
misterioso monaco nero, così come appare già segnato il matrimonio fra un
infatuato Laptev e Julija, che non lo ama. E’
l’impossibilità di essere omologato alla società di Misail che incrina la sua
unione con Masa, e senza speranza è la relazione extraconiugale di Alechin con
Anna, per non parlare dell’avventura, una delle tante, di Gurov, un’avventura
che non si spegnerà in una semplice relazione. E infine c’è l’ultimo, il più
bello, con Nadja, figlia di una famiglia borghese della provincia, che
rinuncia all’imminente matrimonio per avere una vita sua, grazie ai consigli
di un caro amico minato in modo irrimediabile dalla tubercolosi ormai
all’ultimo stadio.
Per lo
più si tratta di racconti venati dall’amarezza, dall’impossibilità, che sembra
connaturata, di vivere compiutamente in due, una visione, quella della
incomunicabilità, a cui tanto concorre il tessuto sociale di un’epoca e che
precorre autori della metà del ‘900, una prova di grande maturità artistica.
Anton Cechov
(Taganrog, 29 gennaio 1860 – Badenweller, 2 luglio 1904).
Scrittore e drammaturgo russo. Cresciuto in una famiglia
economicamente disagiata, si trasferì nel 1879 a Mosca dove si iscrisse alla
facoltà di Medicina. Laureatosi nel 1884, esercitò solo saltuariamente,
dedicandosi esclusivamente all'attività letteraria.
Nel 1890 raggiunse attraverso la Siberia l'isola
di Sachalin, sede di una colonia penale, e sulle condizioni disumane in cui
vivevano i forzati scrisse L'isola di Sachalin.
Minato dalla tubercolosi, passò vari anni nella
piccola tenuta di Melichovo, nei pressi di Mosca.
Nel 1895 conobbe Tolstoj, cui rimase legato da
amicizia per tutta la vita.
Nel 1900 venne eletto membro onorario
dell'Accademia russa delle scienze, ma si dimise due anni dopo per protesta
contro l'espulsione di Gor'kij.
Nel 1901 si sposò. In un estremo tentativo di
combattere il male si recò a Badenweiler, una località della Foresta Nera e lì
morì all'età di quarantaquattro anni.
La produzione novellistica di Cechov è
particolarmente copiosa e percorsa da motivi e tonalità ricorrenti. Negli anni
universitari compose le novelle, dal tono comico e grottesco, raccolte in Racconti
di Melpomene (1884).
La fama arrivò con Racconti
variopinti (1886) e Nel
crepuscolo (1887).
Il 1888 è l'anno de La
steppa, lunga novella elegiaca il cui vero
protagonista è il paesaggio russo.
Seguono: Il duello (1892), La
mia vita (1895), La
signora col cagnolino (1898) e Nel
burrone (1900).
Tra il 1884 e il 1891 Cechov scrisse per il teatro
otto atti unici, tra i quali ricordiamo Il tabacco
da male, Tragico contro voglia e Il
canto del cigno.
A essi fecero seguito sei lavori in quattro atti
che lo hanno consacrato come drammaturgo: Ivanov (1888), Il
gabbiano (1895), Zio
Vanja (1899), Le
tre sorelle (1901) e Il
giardino dei ciliegi (1904).
I personaggi di questi drammi subiscono una sorta
di estraniazione che li rende incapaci di parlarsi. Cechov anticipa in questo
senso alcuni motivi fondamentali della drammaturgia moderna.
Dopo la rivoluzione del 1917, dagli archivi sono
emersi altri due lavori teatrali di Cechov, Tatjana
Répina (1899) e Platonov (1880-1181),
opera giovanile che ha per protagonista un eroe senza volontà.
Ci restano anche I
quaderni del dottor Cechov, redatti tra il
1891 e il 1904.
Da: "Enciclopedia
della Letteratura", Garzanti, 2004
Renzo Montagnoli
|
![]()