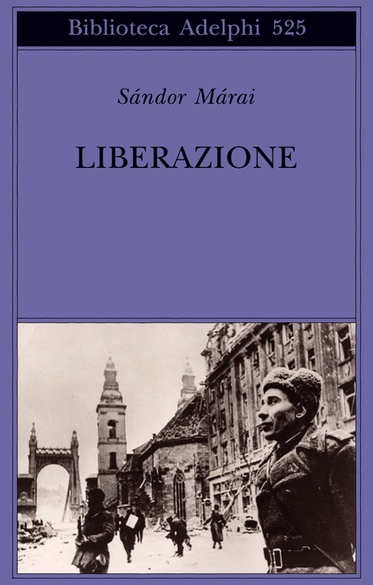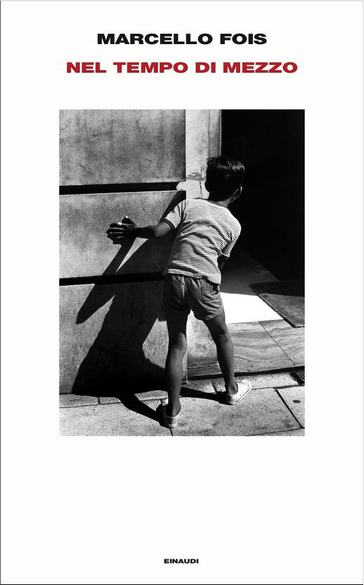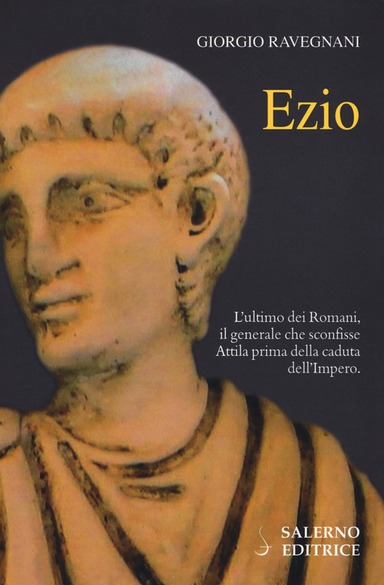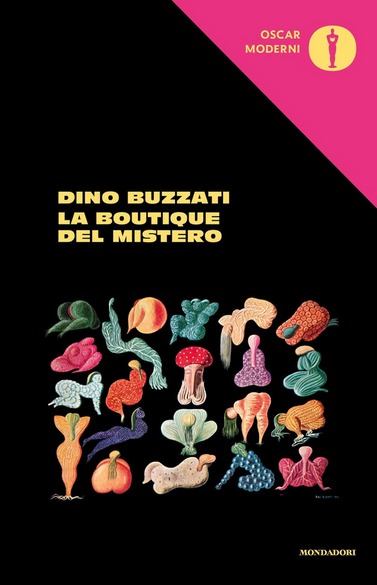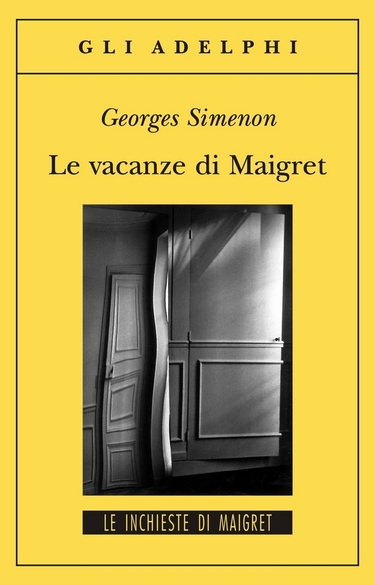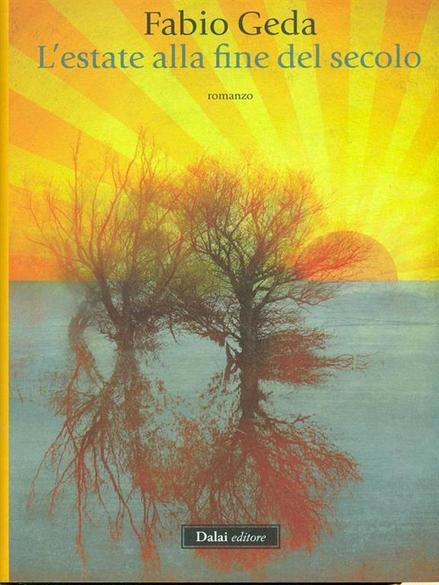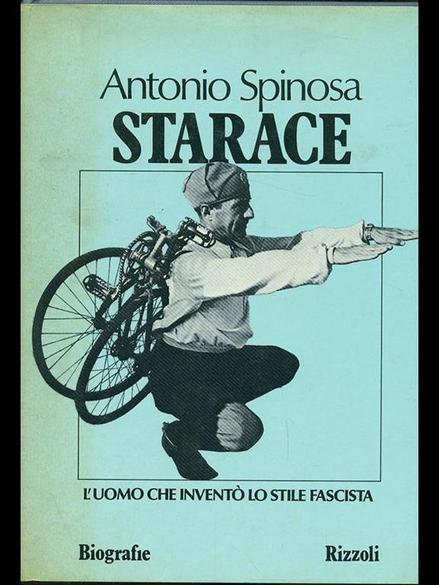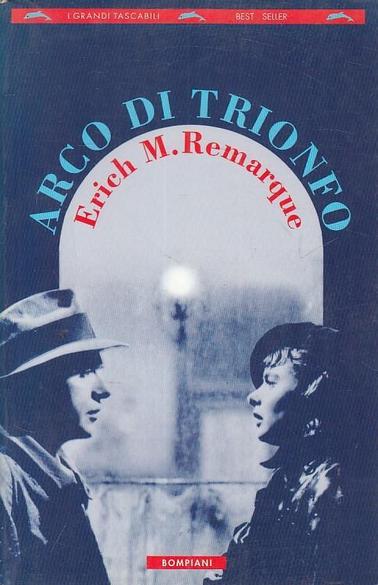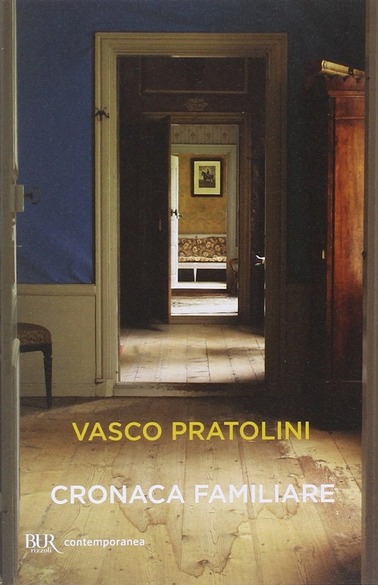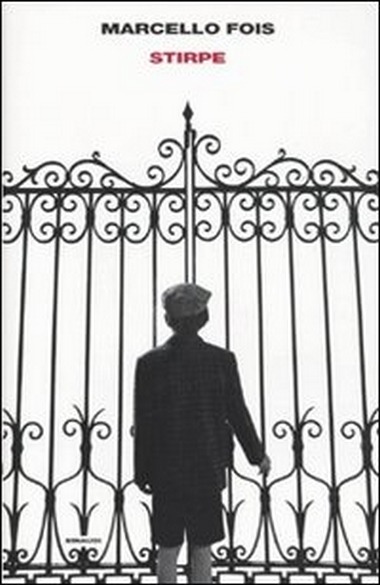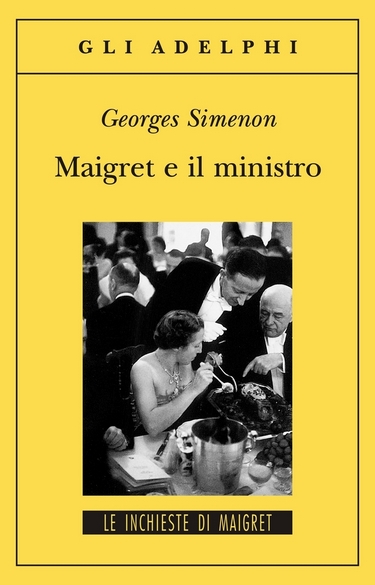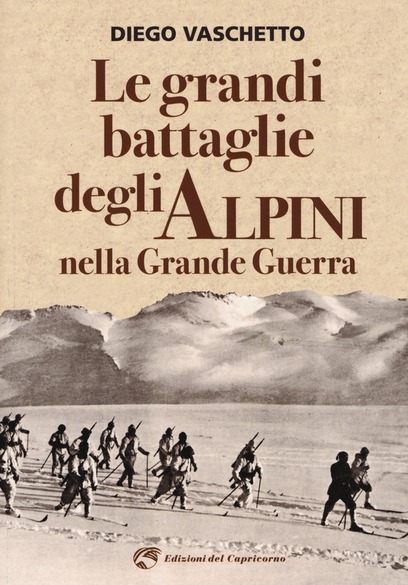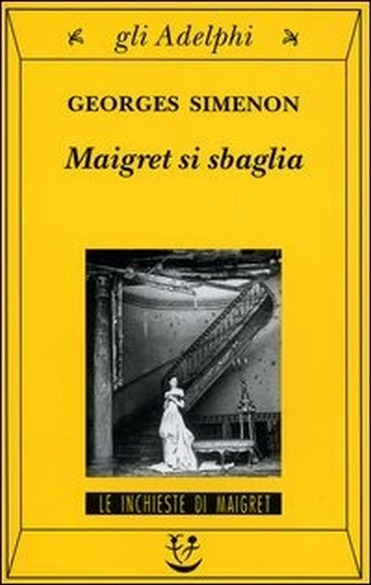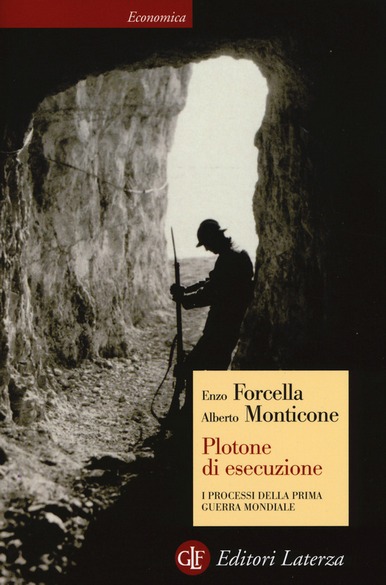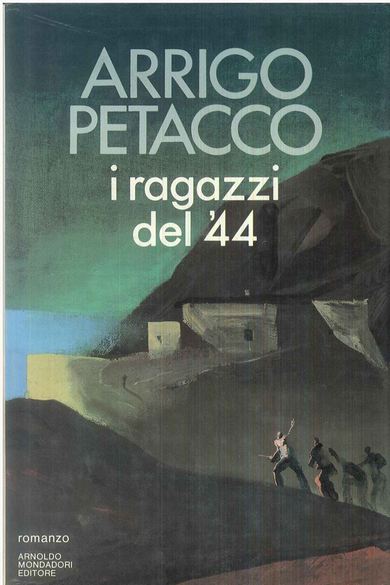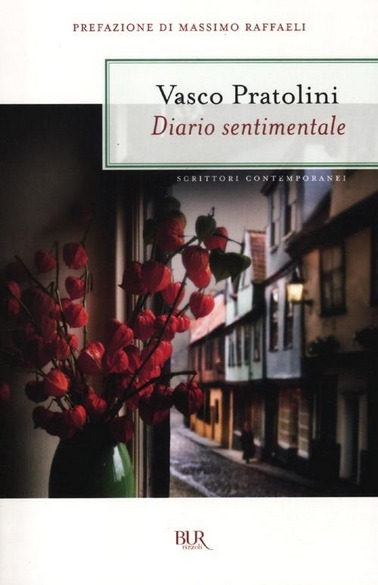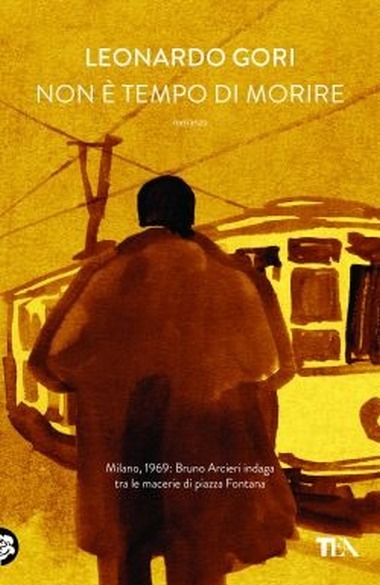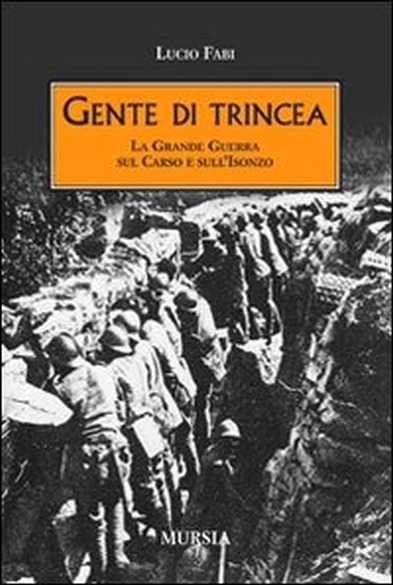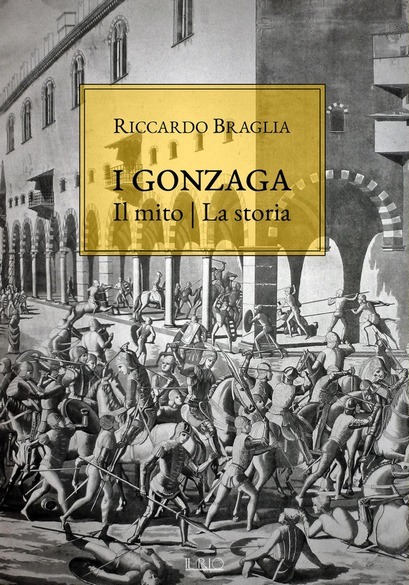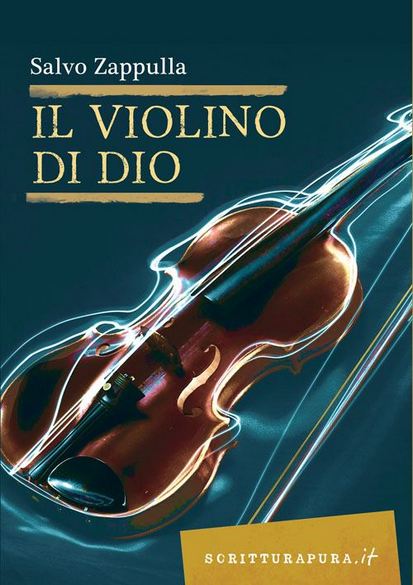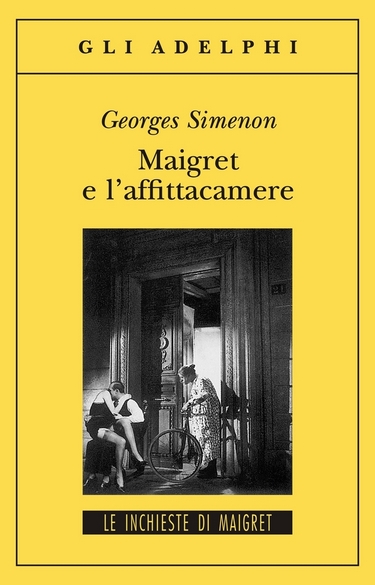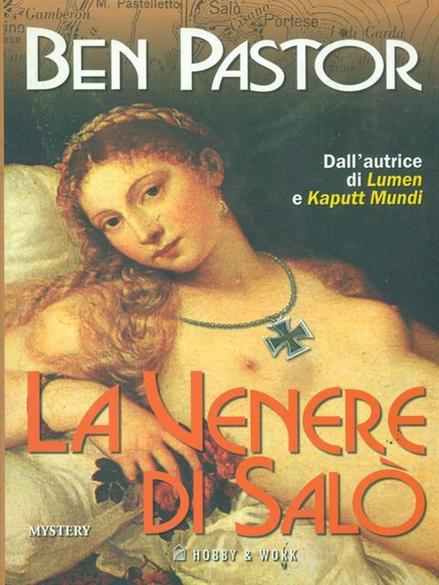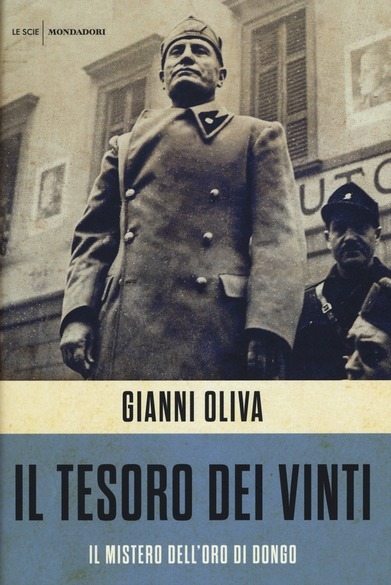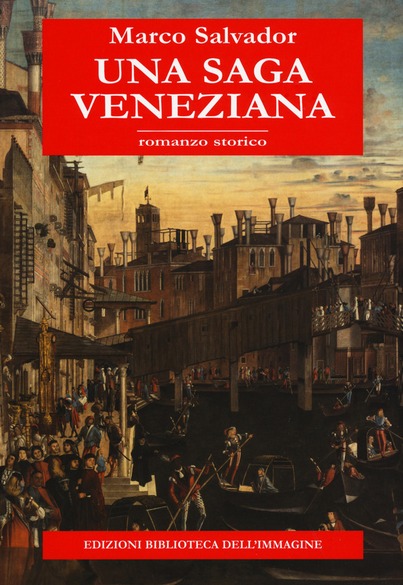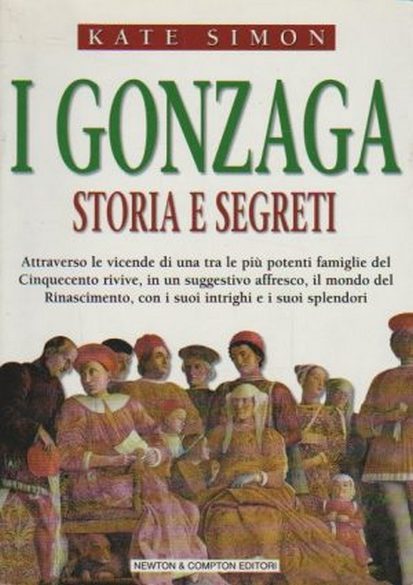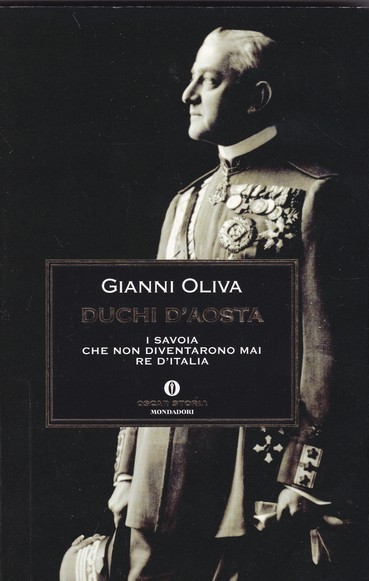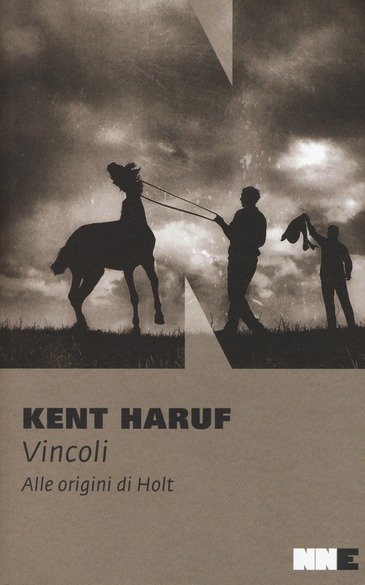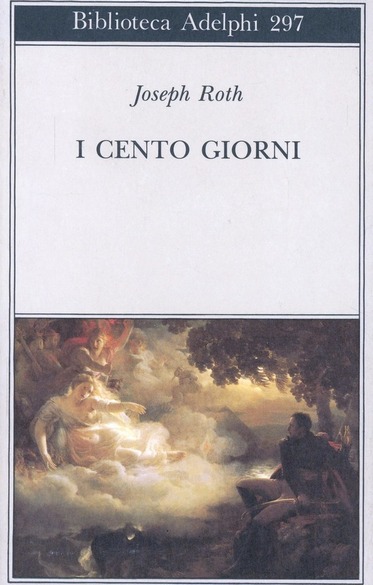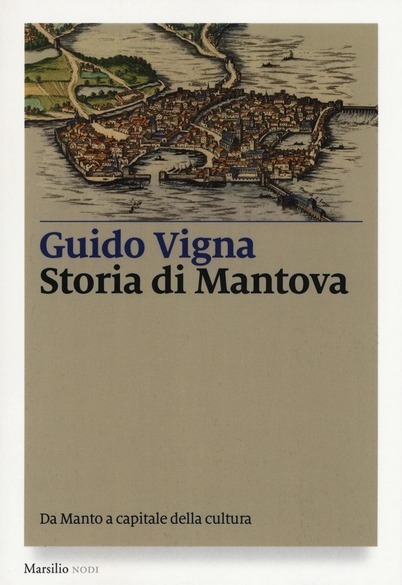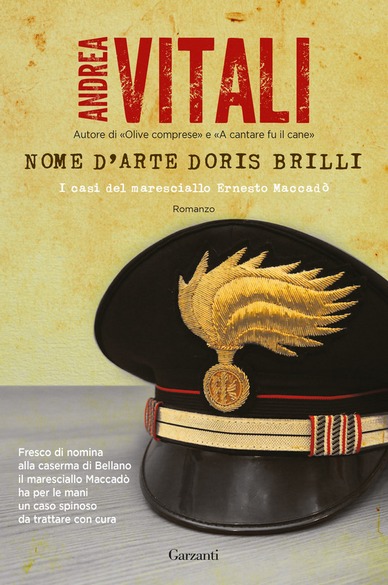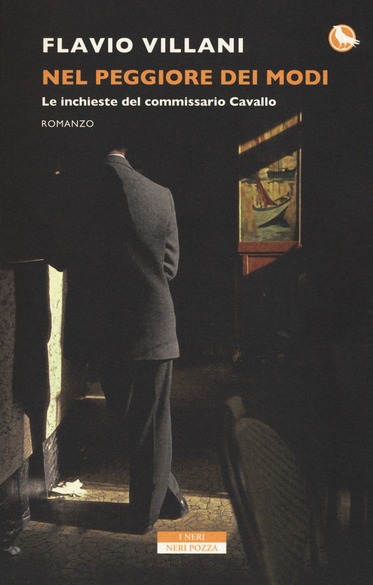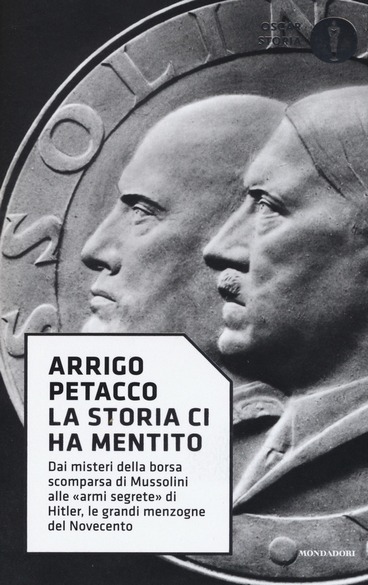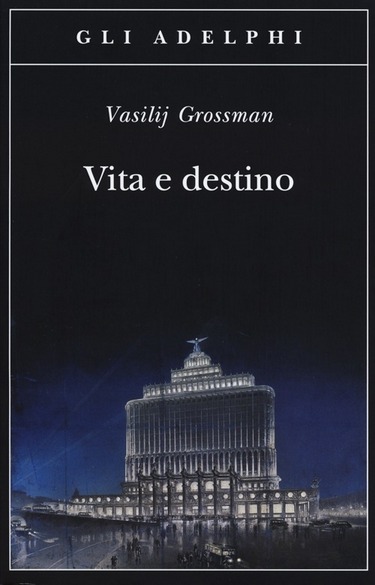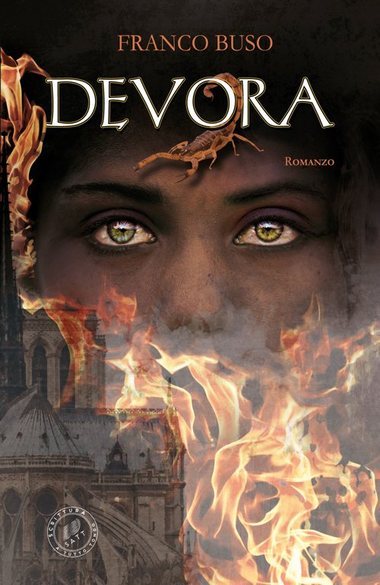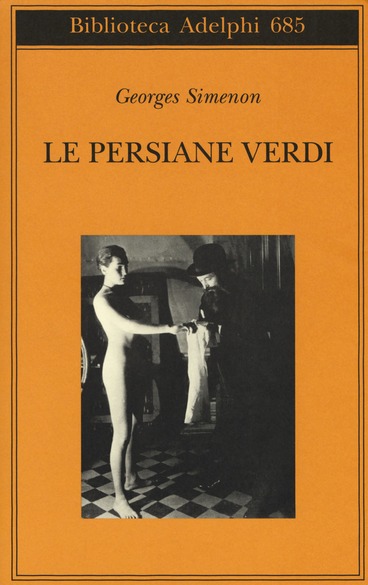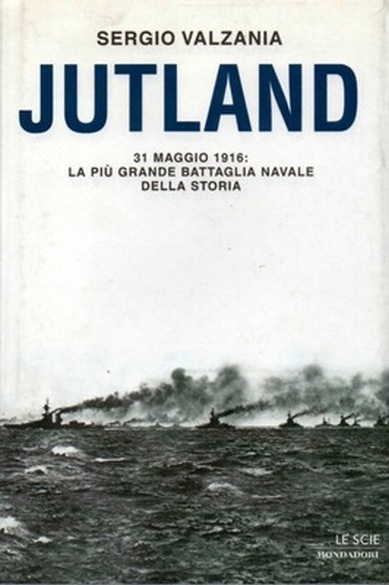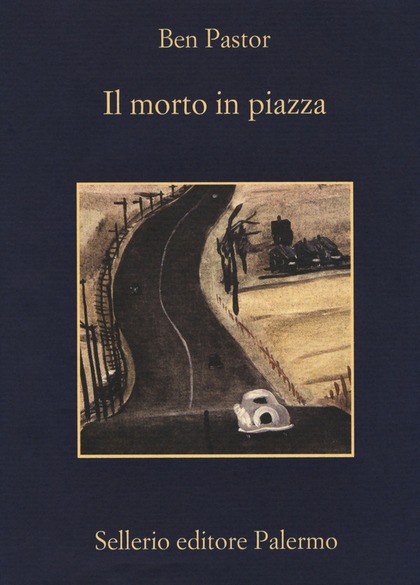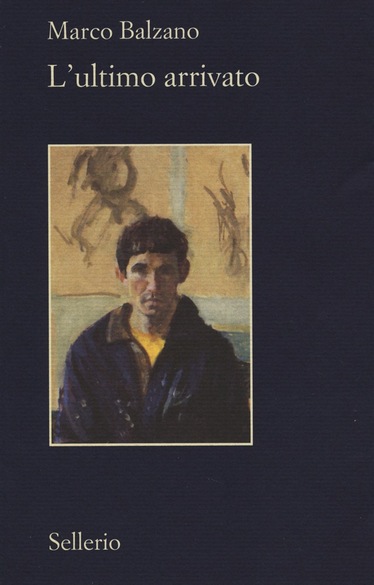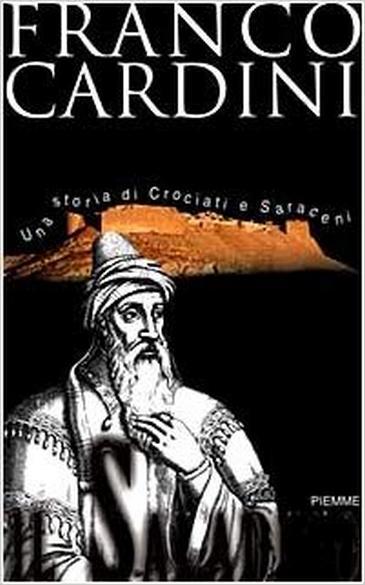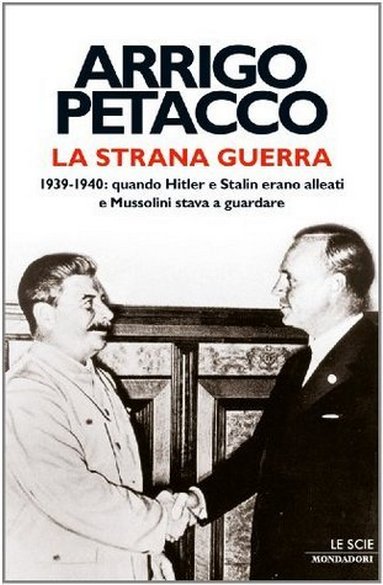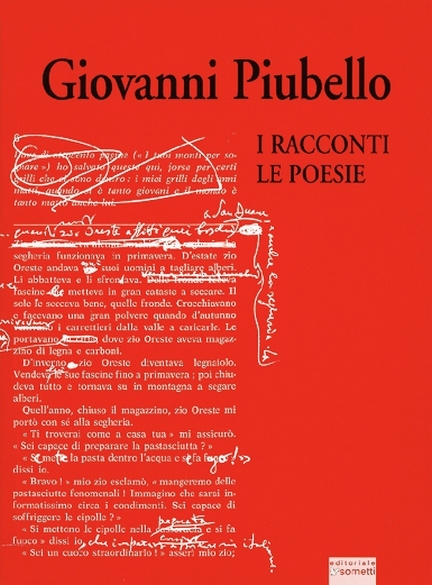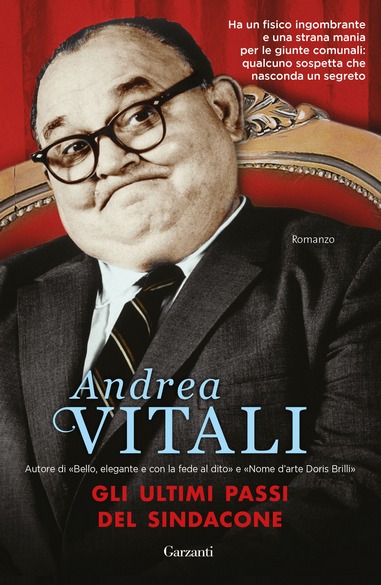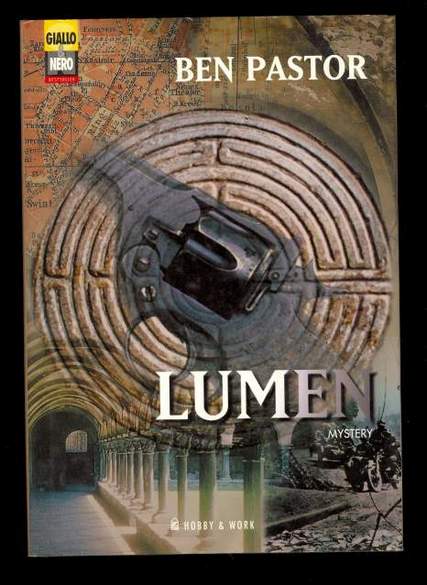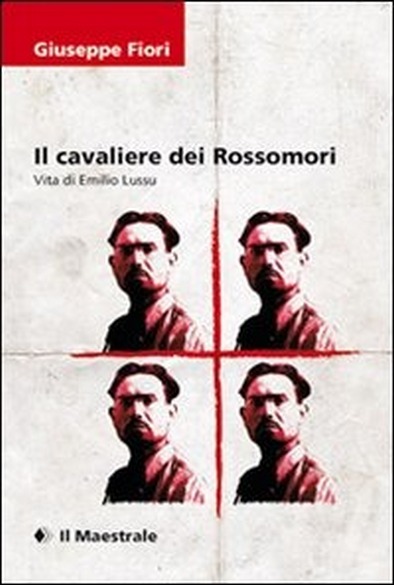Recensioni
2019
![]()
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Commenti Poesie consigliate La Giostra della satira Concorsi La Sorgente delle poesie
Questa pagina raccoglie le recensioni di romanzi, libri di racconti, volumi di poesia e di altro genere letterario (libri di saggi, viaggi, teatro, ecc.), film. |
Recensioni 2012 Recensioni 2013 Recensioni 2014 (Gennaio-Settembre) Recensioni 2014 (Ottobre-Dicembre)
Recensioni 2015 Recensioni 2016 Recensioni 2017 Recensioni 2018 Recensioni 2019
31 Dicembre
Liberazione di Sandor Marai Edizione Adelphi Narrativa
Un’umanità sotto assedio Nel dicembre del 1944 le truppe sovietiche avanzano vittoriose anche in Ungheria e posto l’assedio alla capitale Budapest sferrano l’attacco finale. Due giorni prima del Natale la venticinquenne Erzébet, braccata da mesi, trova fortunosamente un rifugio per il padre, un noto scienziato che i tedeschi e i fascisti ungherese vorrebbero uccidere unicamente perché l’uomo non ha scelto di stare dalla loro parte e dato che nelle dittature o si è con chi comanda, o in caso contrario si è considerati nemici, lui diventa un pericoloso antagonista, anche se a tutti gli effetti la sua scelta è stata di non collaborare. Sistemato il genitore, in pratica murato vivo in uno spazio angusto di una cantina in compagnia di alcuni altri ricercati, la ragazza attende la fine degli scontri nei sotterranei adibiti a rifugio della casa in cui abita, in mezzo a una moltitudine di persone che in quella promiscuità desiderano solo che tutto finisca presto. La vicenda non ha nulla di trascendentale, ma il romanzo ha un suo particolare valore per la grande capacità dell’autore di effettuare un’analisi psicologica approfondita dei comportamenti di individui costretti per giorni a stare a stretto contatto di gomito e con la paura di essere uccisi, magari da una delle tante bombe sganciate dagli aerei russi o da un proiettile della loro artiglieria. Ora dopo ora questa umanità impaurita manifesta gli effetti di un ancestrale terrore, proprio di chi è trepidante per la sua sorte, e se queste paure alimentano una tensione che consente alla gente di sopravvivere fra delusioni e speranze, pur tuttavia piano piano porta a un’assuefazione con la morte che sradica ogni pietà. Il mondo descritto da Marai non è quello di una società proletaria, ma, tranne per pochi componenti, è proprio della borghesia, avida e al tempo stesso pavida, una società che si trascina ora rassegnata, ora esasperata, ma che comunque non perde le sue caratteristiche distintive, in cui ognuno manifesta condiscendenza per ribadire il suo status, la sua superiorità. Eppure, nel trascorrere dei giorni, pigiati l’uno accanto all’altro, costretti nel fetore delle latrine comuni, poco a poco si allentano i freni inibitori, si appassisce, si diventa inerti come pecore rassegnate nell’imminenza della macellazione. E invece arriverà la liberazione, tanto agognata, tanto sognata, un istante di gioia e poi riprendono gli incubi, perché finita un’epoca se ne apre un’altra che ancora non è possibile conoscere. Sandor Marai ha ultimato la stesura di questo romanzo nel settembre del 1945, quando già da non pochi mesi la città era sotto l’occupazione sovietica e aveva sicuramente capito che questa opprimente presenza, se pur sotto altre vesti, si sarebbe protratta a lungo, fino a una nuova liberazione, con le inevitabili incertezze sul dopo. Da leggere, senz’altro.
Sandor Marai,
scrittore, poeta e giornalista ungherese. Nato nell’odierna Kosice, in
Slovacchia (allora parte dell’Impero austro-ungarico), divenne collaboratore
della «Frankfurter Zeitung». Nel 1928 si trasferì a Budapest dove, nel corso
del ventennio successivo, pubblicò numerosi romanzi in lingua ungherese (I
ribelli, 1930; Le confessioni di un borghese, 1934; Divorzio
a Buda, 1935; L’eredità di Eszter, 1939; La
recita di Bolzano, 1940; Le braci, 1942)
che si soffermano, con prosa musicale, a indagare le pieghe più intime di
personaggi che incarnano il malinconico disfacimento della mitteleuropa.
Benché premiate dal successo, le sue opere vennero bollate come «realismo
borghese» dall’intellighenzia del nuovo regime comunista: nel ’48 Márai fu
costretto a lasciare l’Ungheria per stabilirsi – dopo brevi soggiorni in
Svizzera e in Italia – negli Stati Uniti. D’indole schiva e solitaria,
continuò a scrivere nella sua lingua madre circondato dall’indifferenza,
sempre più emarginato.
tra le
fonti: Enciclopedia
della Letteratura Garzanti
2007
28 Dicembre
Nel tempo di mezzo di Marcello Fois Edizioni Einaudi Narrativa
La saga continua Stirpe terminava con Vincenzo Chironi, che del tutto inatteso, anche perché sconosciuto, entrava in casa Chironi, con la famiglia ormai ridotta ai minimi termini e costituita dal capostipite Michele Angelo e dalla figlia vedova Marianna. Il giovane ha messo piede per la prima volta sull’isola alla ricerca di quelle che sono le sue origini, in quanto figlio riconosciuto di Luigi Ippolito Chironi, morto poi in guerra, e frutto di una sua relazione con una giovane friulana, pure lei deceduta quando il piccolo era ancora in fasce e così finito all’orfanotrofio. Per quanto ovvio, a Nuoro per lui comincerà una nuova vita, così come una speranza di prosecuzione della stirpe sorge nella famiglia, abituata, purtroppo, a soffrire nell’abbondanza. In questo secondo romanzo della saga le vicende umane si susseguono scandite dal ritmo delle stagioni e percorrono, o meglio attraversano, dei tempi di mezzo con un passato che quasi si ribella all’avverarsi dei tempi nuovi, ma pur storcendo il naso li accetta; è così che si snocciola il tragitto della vita con matrimoni, nascite e le immancabili e inevitabili morti fino alla fine degli anni ‘70 del XX secolo. Sullo sfondo del cammino dei protagonisti dall’alba al tramonto si innesta forte, prepotente, ma al tempo stesso rasserenante, pur fra luci e ombre, la natura dell’isola, descritta magistralmente dall’autore, con accenni quasi poetici che impreziosiscono la narrazione e sono accolti entusiasticamente dal lettore perché il poter leggere una trama, indubbiamente interessante, innestata su un palcoscenco fatto di montagne brulle o lussureggianti, di zone aride e di altre rigogliosamente verdi, di un mare cristallino e quasi tropicale, è un piacere intenso per lo spirito. Non esagero se dico che l’ambiente appare dinanzi ai nostri occhi, si percepiscono odori e suoni, ma quel che più conta si ha netta la sensazione di esserse immersi in quel panorama, di essere presenti a vicende liete e ad altre meno liete, in poche parole di essere irresistiblimente attratti dalle righe che compongono le pagine che scorrono veloci, più veloci del tempo della narrazione e che riescono a staccarci dal nostro piccolo attuale mondo per essere partecipi di una realtà passata. Nel tempo di mezzo è un bel romanzo, come del resto il primo della serie, Stirpe, un’opera che non mancherà di soddisfare anche i palati più esigenti, visto che contenuto e forma procedono di pari passo su un livello di eccellenza. Ho scoperto tardi questo autore, ma, come si suol dire, non è mai troppo tardi, basta volere, e infatti piano piano leggerò le sue opere.
Marcello Fois (Nuoro
1960) vive e lavora a Bologna. Tra i tanti suoi libri ricordiamo Picta (premio
Calvino 1992), Ferro Recente, Meglio morti, Dura madre, Piccole
storie nere, Sheol, Memoria del vuoto (premio Super Grinzane
Cavour, Volponi e Alassio 2007), Stirpe (premio Città di Vigevano e
premio Frontino Montefeltro 2010), Nel tempo di mezzo (finalista al
premio Campiello e al premio Strega 2012), L'importanza dei luoghi comuni (2013), Luce
perfetta (premio Asti d'Appello 2016), Manuale di lettura creativa (2016), Quasi
Grazia (2016), Del dirsi addio (2017 e 2018), il libro in versi L'infinito
non finire (2018) e Pietro e Paolo (2019).
18 Dicembre
Fra le dita una favilla sembra sole di Carla De Angelis Nota critica introduttiva di Riccardo Deiana Fara Editore Poesia
Se non fossi a conoscenza del fatto che Carla De Angelis, dopo aver lavorato a lungo in un Ministero, ora si gode la meritata pensione, piacere che tanto più si apprezza quanto più in gioventù si è dato alla collettività, nel leggere i versi di questa raccolta ritrarrei l’impressione che siano stati sctitti da una donna giovane, una ragazza addirittura, tanto traspare dagli stessi una naturale meraviglia (Se ho ripreso a scrivere parole / è perché ho il tuo sorriso / il tuo abbraccio / la tua ingenuità ). Già avevo riscontrato questa caratteristica in alcune delle poesie della precedente raccolta Mi fido del mare, ma in questa mi sembra che sia ben più presente, e così è tutto un fiorire di sensazioni che lasciano anche trasparire delle sane emozioni (Il tema è grandioso. / Come controllare il tempo? / Espressione della vita / divorata dalla ricerca di senso / vincerà lo stile che si fa gentilezza). Del resto anche il titolo sembrerebbe rafforzare questa mia interpretazione proprio perché, nell’antro della creatività sempre buio fino a quando non si accende la famosa lampadina, l’immaginare che una favilla, una microscopica ed effimera scintilla fra le proprie dita possa sembrare un sole è la naturale conseguenza di un senso di stupore. E sprizzano gioia questi versi, una gioia intrinseca che possiamo trovare appunto in chi, giovane, s’affaccia al mondo e tutto gli sembra nuovo, diverso dal suo pur breve passato (Entro in un altro giorno / un nuovo sole / tra silenzio e parole / come leggere un libro che rivela pensieri). Per quanto possa apparir strano, questa quarta silloge che leggo e uscita dalla penna di Carla De Angelis si stacca dalle altre tre (A dieci minuti da Urano, I giorni e le strade e Mi fido del mare) per questa caratteristica di ringiovanimento che se stupisce però non disorienta, perché nulla toglie alle capacità poetiche dell’autore, che anzi ne vengono arricchite. Ma sarei incompleto e, soprattutto, disattenderei me stesso se mi limitassi a questo aspetto che mi ha colpito, perché, pur non essendo presente un fil rouge, un tema ben determinato da trattare, la raccolta è meritevole di altre considerazioni. E allora, e già l’avevo notato soprattutto in Mi fido del mare, appare evidente in questi versi un grande amore per la vita, che non finisce mai di stupire e pertanto di emozionare ( La candela che accende il brillio sul mare / illumina la gioventù e la vecchiaia. / La riva resta in attesa ). Così emergono giorno dopo giorno sprazzi di luce, osservazioni che da angoli diversi svelano e rivelano, insomma chi ama la vita non potrà che constatare che ciò che sembra uguale non lo è mai, perché dipende dal nostro punto d’osservazione, perché noi stessi non siamo uguali tutti i giorni, ma che in ogni caso non tralasciamo di stupirci per ciò che ci circonda, per fatti anche marginali, che mettiamo nel nostro carniere d’esperienze. Serenità d’animo che si trasmette a chi legge, che sa cogliere il lato positivo anche quando si fa all’intorno buio, lesta però a richiamar la luce (Il giorno è tenero, il buio non mi ha lasciato / [ancora. / Resta una coda di pensieri, parole e desideri / che il sole vestirà di luce ). E così Carla ha inserito un altro tassello nel mosaico del suo senso della vita, la cui immagine lenta si va formando, avendo ella ben impresso come sarà o come forse è già, perché infine nel percorso intrapreso lascia a ricordo, come pietre miliari, le sue sensazioni, le sue emozioni, la sua serenità, beninteso espresse in versi.
Carla De Angelis è
nata e vive a Roma. Suoi testi sono presenti in riviste e opere collettanee
edite da Perrone, Estroverso, David & Matthaus, Limina Mentis, Delta3, Pagine,
Aletti, Fara. Nel 1995 il Presidente della Repubblica le ha conferito
l’onorificenza di Cavaliere. Con Fara ha pubblicato in poesia: Salutami
il mare (2006),
A dieci
minuti da Urano (2010), I
giorni e le strade (2014).
Nel 2011 esce Mi
vestirei di mare (Progetto
Cultura). Ha ideato e cocurato le antologie Corviale
cerca poeti per
la Biblioteca “Renato Nicolini” di Roma e, con Stefano Martello, i saggi Diversità
apparenti (2007), Il
resto (parziale) della storia (2008), Il
valore dello scarto (2016).
Nel 2017 ha pubblicato con Fara la pluripremiata raccolta Mi
fido del mare.
15 Dicembre
Ezio di Giorgio Ravegnani Salerno Editrice Storia biografia
L’ultimo grande generale romano Verso la fine del IV secolo l’impero romano è ancora molto grande, si estende su un territorio enorme, ma, se può sembrare forte e potente, cela invece una fragilità pronta ad apparire al momento più propizio, insomma è quello che si potrebbe definire un colosso dai piedi di argilla. Sono ormai diversi secoli che i barbari premono alle frontiere, un po’ desiderosi di mettere le mani sulle ricchezze del grande stato, un po’ per fuggire altri popoli predatori che, nella loro espansione, seminano solo morte e distruzione. Un tempo l’esercito romano era forte e pressochè invincibile, ma ora, ridotto nei ranghi, composto in larga parte da quegli stessi barbari, non è monolitico come potrebbe apparire, ha perso molto della sua razionale ed efficiente organizzazione dopo le riforme militari avviate da Diocleziano e perfezionate da Costantino. Piano piano l’impero viene eroso, ma è con la grande battaglia di Adrianopoli del 9 agosto 378 in cui i Romani, sconfitti dai Visigoti, con l’uccisione anche dell’imperatore d’oriente Valente, che le sorti di quello che è stata la più grande e duratura potenza nella storia dell’umanità cominciano a evolvere in senso negativo. Si potrebbe dire che questa battaglia segna l’inizio della fine, anche se seguirono altre battaglie con esiti più favorevoli per i romani, soprattutto grazie a un loro grande generale, di cui poco sappiamo e che è stato oggetto di uno studio da parte dello storico Giorgio Ravegnani. Ezio, anzi per la precisione Flavio Ezio, vissuto dal 390 circa al 454, è il suo nome, un uomo che aveva lo stampo dell’antico romano, impregnato di un alto senso dello stato e dalle indubbie capacità di stratega, dapprima alleato con gli Unni e poi loro acerrimo nemico al punto che li sconfisse, sbaragliandoli, nella famosa battaglia dei Campi Catalaunici, nella regione dello Champagne, avvenuta il 20 settembre 451, ma secondo altri studiosi esattamente tre mesi prima. Trascorsero tre anni ed Ezio moriva, assassinato dall’imperatore Valentiniano III, timoroso per l’ascendente del suo generale. Quella dei Campi Catalaunici fu probabilmente l’ultima grande battaglia vinta dai romani, un vero e proprio canto del cigno. L’aver tolto di mezzo l’unico uomo che per le sue capacità avrebbe potuto difendere l’impero fu un errore madornale, come se Valentiniano si fosse tagliato la mano destra con quella sinistra, e, secondo la tesi dell’autore, consentì di fatto i successivi colpi deleteri sferrati dai nemici di Roma, nemici che avrebbero potuto essere facilmente ostacolati se Ezio fosse rimasto in vita. Di certo la sorte dell’impero era segnata, perché la genesi di uno stato contempla che quando questo si è avviato lungo la parabola discendente questa caduta non può essere fermata, ma al massimo solo rallentata. E appunto Ezio avrebbe spostato in là, di quanti anni non è possibile sapere, la fine di Roma. Ezio è un interessante saggio storico su un personaggio meno conosciuto di altri grandi condottieri romani, ma non meno valido e pertanto degno della massima considerazione.
Giorgio Ravegnani
è un professore di Storia Bizantina all’Università di Venezia.
11 Dicembre
La boutique del mistero di Dino Buzzati Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa
Onore al surreale Inizio subito con il precisare che è ben difficile trovare fra questi 31 racconti uno che sia di modesta levatura, perché, caso più unico che raro, oltre a essere di piacevole lettura, sono tutti di qualità. Se non ci sono punti di contatto fra gli stessi, tutti però sono improntati dall’autore al genere surreale, non frequente, di non facile realizzazione e quindi, dato il loro livello, ancora più apprezzabili. Ben lungi dall’idea di parlare di ognuno di essi desidero solo dare alcuni cenni affinché si possa comprendere di che si tratta. Sette piani, quelli di una clinica, in cui i pazienti ricoverati hanno una gravità nella loro malattia inversamente proporzionale all’altezza, e così nel settimo si trovano quelli quasi sani e nel primo i morituri. Lì si parla della sventura di un malato che rifiuta categoricamente il suo destino mano a mano scende nei vari piani. Il mantello, con il ritorno dalla guerra di un soldatino alla sua famiglia. Commovente nell’esposizione e angosciante nella conclusione. Una cosa che comincia per elle. Tutto poteva pensare Cristoforo Schroder quando, arrivato al paese di Sisto, era sceso alla locanda, come soleva fare abitualmente per la sua attività. Questa volta però lo attendeva una sgradita sorpresa che avrebbe travolto la sua vita. Una goccia, che in una casa a più piani anziché scendere per la forza di gravità, sale per le scale, terrorizzando gli inquilini. Racconto di Natale, con una disperata ricerca di Dio, forse il più bello di tutti, incalzante, visionario, ma al tempo stesso concreto. Il colombre, una specie di favola moderna, ma dai toni drammatici sugli insegnamenti sbagliati di certi genitori che, invece di educare i figli ad affrontare eventuali avversità, impongono loro di fuggirle, di fatto facendoli diventare schiavi, prima ancora che del destino, delle loro paure. La giacca stregata, un’altra favola, il cui fine, puramente morale, è che non dobbiamo lasciarci sottomettere dall’avidità e che dobbiamo pertanto agire secondo coscienza, perché a ogni nostro arricchimento corrisponde l’impoverimento di qualcun altro. I sette messaggeri, altra favoia la cui morale è che ci è impossibile arrivare ai confini del nostro mondo e della nostra conoscenza. Qualcosa era successo, con un viaggio dal Sud a Milano che si trasforma in un incubo, con le paure ancestrali che deformano semplici situazioni per portare a supporre l’esistenza di qualcosa di eclatante e pericoloso. Insomma, posso dire che prima di cominciare a leggere questa raccolta avevo qualche dubbio in ordine al fatto che mi potesse risultare gradita e invece, fin dalle pagine iniziali, dai primi racconti sono rimasto avvinto da una prosa scorrevole e da una creatività veramente notevole. Da leggere, pertanto.
Dino Buzzati,
scrittore italiano. Giornalista, disegnatore e pittore, redattore e inviato
del «Corriere della sera», è autore di una vasta produzione narrativa.
Solo i primi successi letterari gli varranno come carte di credito per salire
di grado nel quotidiano milanese. E lo scrittore dirà, convintissimo:
"L'optimum del giornalista coincide con l'optimum della letteratura".
Del 1963 Un amore "che esprime appieno i cedimenti
dello scrittore ai miti e alle mode e insomma al mercato della letteratura". Tra l'uno e l'altro libro: un'antologia di racconti, La boutique del mistero (1968) e soprattutto Poema a fumetti (1969), che ottiene il Premio di Paese Sera per il miglior fumetto e che mette in risalto le sue qualità di disegnatore e pittore, ancora recentemente sottolineate con una mostra antologica alla Rotonda della Besana di Milano.
Ricordiamo dunque: Barnabò delle montagne (1933), Il
segreto del bosco vecchio (1935), Il deserto dei
tartari (1940), I sette messaggeri (1942), Paura
alla Scala (1949), Il crollo della Baliverna (1954), Sessanta
racconti (1958, vincitore del Premio Strega), Un
amore (1963), Le notti difficili (1971).
Fonti: "Enciclopedia della Letteratura",
Garzanti, 2004 - Dizionario Biografico degli italiani Treccani
8 Dicembre
Il duca di Sabbioneta. Guerre e amori di un europeo errante di Luca Sarzi Amadé Mimesis Edizioni Storia biografia
Un Grande, non solo di Spagna Vespasiano I Gonzaga nacque a Fondi il 6 dicembre 1531 da Isabella Colonna e da Luigi Gonzaga “Rodomonte” . Rimasto giovanissimo orfano del padre, la madre si sposò con il principe di Sulmona, rinunciando a crescere il figlio che, grazie all’interessamento del nonno Lodovico presso l’imperatore, fu affidato alla zia paterna Giulia Gonzaga che lo allevò amorevolmente e che, anche per evitare al nipote di essere eliminato dai Colonna per questioni successorie, lo inviò alla corte di Carlo V d’Asburgo, dove fu nominato paggio d’onore del futuro re Filippo II. Grande condottiero, abilissimo diplomatico, fece una rapida e notevole carriera, investito direttamente dall’imperatore Massililiano II del titolo di principe del Sacro Romano Impero. Gli onori di certo non gli mancarono, come i titoli e gli appannaggi: Grande di Spagna, vicere di Navarra e di Valencia, marchese e poi duca di Sabbioneta, un feudo del mantovano sempre rimasto indipendente dal ramo principale dei Gonzaga, cavaliere dell’ordine del Toson d’Oro. Ma il capolavoro della sua vita, di cui restano ancor oggi le preziose testimonianze, fu l’aver ideato e realizzato la città ideale: Sabbioneta. Gli ci vollero trentacinque anni, dal 1556 alla sua morte, avvenuta il 26 febbraio 1591, ma alla fine lo scrigno di bellezza si aprì agli occhi del mondo, mostrando i suoi gioielli, che ancor oggi sono meta di un flusso consistente di turisti. I suoi feudi comprendevano, oltre a Sabbioneta, il marchesato di Ostiano, la contea di Rodigo, le Signorie di Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Commessaggio, il ducato di Trajetto, la contea di Fondi, la baronia di Angiona, le Signorie di Turino e Caramanico. Andarono tutti alla figlia Isabella (l’unico maschio, Luigi, era morto quattordicenne) che li portò in dote al marito Luigi Carafa della Stadera, principe di Stigliano. Vespasiano fu indubbiamente un grande protagonista della sua epoca, ma l’aver realizzato la città ideale, che tutti possiamo vedere, costituisce senz’altro il suo più grande merito. Di tutto questo parla Il duca di Sabbioneta, un’eccellente biografia scritta da Luca Sarzi Amadè dopo un lungo lavoro di ricerca delle fonti che, come nel caso di uno storico che si rispetti, sono elencate al termine dell’opera, la cui realizzazione deve aver richiesto una certosina collazione delle tante notizie, non tutte strettamente attinenti alla figura del protagonista, ma che vanno anche oltre, al fine di collocarlo esattamente in un periodo di tempo in cui i numerosi eventi lo videro alla ribalta. Non si possono non apprezzare i risultati, atteso che di quell’epoca (il XVI secolo) molto in questo modo ci è stato dato di conoscere, con una lettura avvincente e, soprattutto, mai greve, tanto che a volte si ha l’impressione (beninteso è solo un’impressione) di avere per le mani un romanzo storico. Prima di leggere questo libro avevo una conoscenza approssimativa di Vespasiano, che consideravo, erroneamente, un personaggio minore rispetto ai membri della linea principale dei Gonzaga, ma ora ho la certezza che non fu da meno di Francesco II, il consorte della celebre Isabella d’Este, e soprattutto del suo quasi coevo Vincenzo I, il famoso splendido principe rinascimentale dalle mani bucate. Di conseguenza, sono più che convinto della validità e dell’interesse di questo lavoro di Luca Sarzi Amadè.
Luca Sarzi Amadè
ha collaborato con alcuni tra i maggiori quotidiani e periodici
nazionali (La Repubblica, Il Giorno, Famiglia Cristiana, L’Espresso) e, per la
televisione, con la Rai. La sua passione per l’indagine storica e per la
scrittura si è sviluppata lontano da congreghe accademiche e politiche. Ha
svelato (in parte) i suoi segreti di indagatore nel suo manuale di ricerca
genealogica (di cui sta curando un’edizione aggiornata). Ha dedicato vari
libri alla sua città come: la guida Milano
fuori di mano,
con prefazione di Jannacci, e il divertente Milano
in periferia.
Tra le sue opere: Il
duca di Sabbioneta. Guerre e amori di un europeo errante (Mimesis, 2013), L'
antenato nel cassetto. Manuale di scienza genealogica (Mimesis,
2015), Scipione
Gonzaga. Vita burrascosa e lieta di un aspirante cardinale del Cinquecento (Odoya, 2017).
6 Dicembre
Un eroe del nostro tempo di Vasco Pratolini BUR Biblioteca Universale Rizzoli Narrativa romanzo Un amore senza amore L’anno è il 1945 ed è da poco che è avvenuta la Liberazione; la vita è difficile, c’è un’Italia da ricostruire anche nel suo tessuto sociale, perché la lunga guerra, il periodo della Resistenza, con il conflitto civile, si sono chiusi ufficialmente il 25 aprile, ma gli strascici sono ben lontani dallo scomparire. E’ così che in un appartamento di Firenze sono costretti a convivere Faliero e Bruna, marito e moglie comunisti ex partigiani, il sedicenne fascista Sandrino con la madre succube Lucia, e Virginia, una bella donna, vedova di un ex repubblichino. In questa forzata coabitazione è rappresentata l’Italia post bellica, con i suoi drammi e anche le sue speranze, ma non è questa la chiave di lettura del romanzo di Pratolini, o meglio non è l’unica, perché protagonista assoluto è forse quello che non ti aspetti, il ragazzino, fascista fino al midollo e che come tale si comporta, violento con i deboli e pavido con i forti, un ritratto eseguito in modo perfetto. Sandrino approfitta della condiscendenza della madre, attrae a sé la debole Virginia, prima succube del padre, poi del marito repubblichino e ora infine di quel ragazzo che dimostra qualche anno in più della sua effettiva età. Con brutalità la fa sua, la tormenta, le sottrae i soldi, e più dimostra la sua intima cattiveria, più viene adorato da una donna che ha forti tendenze masochiste. Faliero, a cui dispiace vedere un giovane, se pur nemico, prendere una strada senza ritorno cerca di ricondurre alla ragione Sandrino, ma è tutto inutile, perché logica e sentimento, che danno smalto a una persona, sono del tutto sconosciute nel ragazzo, che con la vocazione a una progressiva e totale disumanizzazione si avvia senza accorgersi a un percorso di eccessi convulsi che lo porteranno all’autodistruzione. Senza che Faliero e Bruna appaiano degli eroi viene evidenziata la differenza nel vivere rispetto a Sandrino, con il quieto rapporto di due persone in cui l’amore, quello fatto di sentimento e di dedizione, riesce a colmare qualsiasi dissidio, fortifica l’ideale politico, lascia sempre aperta una porta alla speranza. Nel ragazzo invece c’è una sorte annunciata dall’assenza di autentici sentimenti, di un amore non nel suo più alto significato, una specie di amore senza amore; c’è invece una compulsione che lo porta a torturare, non solo psicologicamente, chi gli offre il suo amore, sia che si tratti di quello materno di Lucia, sia che appaia come la disperata passione di Virginia. E in una Firenze sotto la neve, mentre Faliero e Bruna fanno progetti per l’avvenire, Sandrino, che ha avuto per un attimo l’opportunità di un affetto che forse potrebbe diventare autentico amore, a passi rapidi giunge alla fine della sua strada, con il rosso del sangue di Virginia che sporca la neve. Bello, anzi di più, Un eroe del nostro tempo è un bellissimo romanzo.
Vasco Pratolini
(Firenze,
19 ottobre 1913 – Roma, 12 gennaio 1991). Di
famiglia operaia, è costretto a interrompere gli studi e svolge mestieri
diversi per potersi mantenere.
Pratolini comincia a collaborare al periodico «Il Bargello» e diviene
redattore con Alfonso Gatto, nel 1938, della rivista «Campo di Marte». Nel
1951 si trasferisce a Roma, città nella quale vivrà da allora in poi.
Il registro adottato, sin da quelle prime prove, si pone a mezza via fra il
realistico e il lirico. Pratolini svolge con successo, in questi anni, anche un'attività di sceneggiatore e soggettista cinematografico, e intraprenderà in seguito una carriera di autore di testi teatrali ("La domenica della povera gente", 1952; "Lungo viaggio di Natale", 1954).
Nel 1955 pubblica Metello (premio Viareggio), primo romanzo di quella che
diverrà la trilogia "Una storia italiana", essendo completata da "Lo scialo"
(1960) e da "Allegoria e derisione" (1966).
Alla città e al mondo dell’adolescenza sono dedicati ancora un romanzo, "La
costanza della ragione" (1963), e le poesie raccolte in "La mia città ha
trent’anni" (1967). Alcune «cronache in versi e in prosa», scritte dal 1930 al
1980, sono riunite nel volume "Il mannello di Natascia" (1984, premio
Viareggio).
2 Dicembre
Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale di Filippo Focardi Laterza Editori Storia
E’ ora di sfatare un mito Fin da ragazzo, allorchè si parlava soprattutto della seconda guerra mondiale, una frase ricorrente era “Italiani brava gente” in contrapposizione ad asserzioni del tipo “i tedeschi erano belve assetate di sangue”. Poichè sono italiano mi sentivo quasi orgoglioso, mi vedevo in guerra coraggioso sì, ma pure pietoso, disponibile ad aiutare le famiglie dei nemici. Era un mantra che finiva per portare alla convinzione che i nostri soldati fossero diversi, soprattutto dai tedeschi, che fossero degli autentici eroi, ma anche stimati se non addirittura amati dal nemico. Poi, leggendo testi di storia seri, e quindi non basandomi su quelli scolastici, quasi mai sinceri, ho scoperto purtroppo che anche noi non eravamo bravi, magari non avevamo messo in pratica un olocausto, non eravamo arrivati nelle città sovietiche per ammazzarvi prima di tutti gli ebrei e poi anche altri cittadini, tanto per dare un esempio e restare in esercizio. Invece, le occupazioni fasciste sono state sostanzialmente in linea con quelle naziste, nonostante anche di recente alcuni distinguo da parte di politici, uno su tutti Silvio Berlusconi, che vede il fascismo come un fenomeno politico-sociale nel complesso del tutto normale, fino all’alleanza con Hitler, il cui funesto influsso poi portò a degenerazioni senz’altro esecrabili. Non è così, ed è inutile che i neo fascisti neghino l’evidenza dei fatti, perché, per quanto a lungo celate come vergogne nazionali, le stragi compiute in Etiopia bastano da sole a dimostrare che Mussolini andava per le spicce, che emanava ordini volti ad effettuare degli eccidi, ordini per lo più eseguiti con la massima partecipazione. Insomma, troppo a lungo abbiamo assistito a un rifiuto collettivo della memoria della dittatura fascista e delle guerre dalla stessa intraprese. E così, siamo pervenuti a un’idea di autoassoluzione con quegli “italiani brava gente”. Come è stato possibile chiudere gli occhi di fronte alle evidenze e credere ciecamente a ciò che ci assolveva? Ecco a queste domande risponde l’interessante saggio storico di Filippo Focardi che non intende aggiungere altro a quelle che sono le ricerche iniziate una cinquantina di anni fa sugli eccidi compiuti dagli italiani, studi che portano la firma di illustri autori, quali Angelo Del Boca e Giorgio Rochat, ma, e questo viene precisato da subito, <questo libro intende ricostruire lo specifico percorso di costruzione di una narrazione italiana dell’esperienza della seconda guerra mondiale.> Detto in parole più semplici il lavoro di Focardi intende dissacrare l’intento revisionistico di non poche opere scritte nell’immediato dopo guerra dai nostri generali sconfitti e dai gerarchi scampati alla punizione che avrebbero meritato, opere che, stranamente – ma poi è abbastanza chiaro il motivo -, sono state recepite come oro colato nei testi scolastici, tutti miranti all’autoassoluzione. Per quanto di non facile lettura, trattandosi di un testo rigorosamente storico e volto a capire i motivi, i modi e i fini di questo processo di autoassoluzione (basti pensare che l’alleanza di Mussolini con Hitler viene vista dai monarchici, dagli antifascisti, dagli agnostici come frutto di un patto privato, come se le responsabilità di entrambi potessero essere tenute separate nell’aspetto civile da quello pubblico), mi sembra che il risultato che si era prefisso l’autore sia stato raggiunto, chiarendo non poche cose. E del resto per enfatizzare il bravo italiano è stato sufficiente esagerare la figura del cattivo tedesco; ora, premesso che è impossibile che tutti gli italiani fossero bravi e tutti i tedeschi fossero cattivi, non bisogna dimenticare che se nell’Unione Sovietica occupata i soldati nazisti spesso e volentieri commisero degli eccidi, anche senza piani preordinati, non devono essere tralasciati quelli compiuti dall’esercito italiano nei Balcani, crimini non dissimili da quelli commessi dal loro alleato. Che dire poi della nostra occupazione in Slovenia con deportazioni in massa nel famigerato campo di concentramento dell’isola di Rab, dove la mortalità era addirittura superiore a quella di Auschwitz? É evidente che il famoso motto evangelico “chi è senza peccato scagli la prima pietra” è alquanto pertinente. E invece si celebrano le vittime delle foibe (beninteso questi poveri italiani soppressi in modo così orrendo comportano un più che giustificato nostro sdegno), ma chissà per quale ragione non si parla degli eccidi da noi commessi in quelle zone, di cui furono vittime non solo uomini, ma anche donne e bambini. Le conclusioni dell’opera sono purtroppo disarmanti, perché Focardi evidenzia come il popolo italiano sia completamente privo dell’etica della responsabilità, di una presa di coscienza su quanto è stato fatto di negativo in passato; questa carenza è assai grave, perché ci impedisce di comprendere gli errori, onde poi evitarli, ci rinchiude in un bozzolo dorato, ma falso, di una memoria autocelebrativa, in cui ci sentiamo vittime, anziché carnefici. É inutile che aggiunga che Il cattivo tedesco e il bravo italiano è senz’altro da leggere.
Filippo Focardi è
ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova. Si è
occupato di memoria del fascismo e della seconda guerra mondiale, di
risarcimenti per le vittime del nazismo e della questione della punizione dei
criminali di guerra italiani e tedeschi.
29 Novembre
La nave dei vinti di Leonardo Gori Edizioni TEA
Narrativa
romanzo Chi è Morgan? Leonardo Gori, che ha creato il personaggio di Bruno Arcieri, ufficiale dei carabinieri in forza al SIM, l’intelligence militare, sembra trovarsi a proprio agio nell’ambientare la trama dei suoi romanzi durante il ventennio. Ricordo con vero piacere Nero di maggio, con la visita di Hitler in Italia e in particolare a Firenze nel 1938, e Il passaggio, ambientato a Firenze durante l’insurrezione partigiana. E anche La nave dei vinti si colloca in uno degli ultimi anni di fulgore del fascismo, nel marzo del 1939, mentre già diventano più frequenti i sintomi dell’imminente conflitto, a proposito del quale c’è gente interessata a mettere le mani su un microfilm riproducente il documento del famoso patto Molotov – Ribbentrop. Pare, anche se non si è del tutto certi, che un agente segreto di nome Morgan potrebbe averlo con sé e che lui si trovi su un bastimento fuggito dalla repressione franchista con numerosi profughi, andato in avaria e alla fonda nel porto di Genova. E’ inutile dire che a questo reperto sono interessati in tanti, anche il capitano Bruno Arcieri, che, ben al di fuori degli ordini del capo del SIM ma dipendendo solo dal suo comandante, dovrà collaborare con un vescovo del Vaticano, di nome Eugenio Winkelmann, pure lui facente parte di una sorta del servizio segreto del papato. Non vado oltre con la trama, ricca di continui colpi di scena, in cui si avvicendano fascisti, carabinieri, agenti sovietici, sgherri della Gestapo, un complesso intrigo in cui francamente non è facile raccapezzarsi, tanto più che personaggi, all’inizio insignificanti, diventano quasi all’improvviso dei protagonisti. La vicenda, il cui ritmo accelera notevolmente verso la fine, pare abbia divertito non poco l’autore, e del resto anche il lettore non ha di che lamentarsi, nel senso che progressivanente prova un desiderio crescente di giungere alla verità. Tutto bene quindi? Sì e no, nel senso che il romanzo non è scevro da difetti; ha indubbiamente dei pregi, visto che riesce ad avvincere, ma se chi legge arriva alla fine appagato basta che si metta un po’ a riflettere e rileva delle incongruenze non trascurabili, come tempi degli eventi che dovrebbero coincidere e invece sono spaiati, protagonisti a cui si attribuiscono capacità ben al di fuori della loro portata, un personaggio creato ad hoc come diversivo e che dovrebbe muovere alla compassione il lettore. Si tratta indubbiamente, nell’ambito della finalità di svago dell’opera, di difetti di poco conto, tanto che, ripeto, ci si accorge a lettura ultimata e purché si desideri effettuare qualche riflessione, ma nel quadro generale dell’attività artistica di Leonardo Gori sono appunti che mi sembrano necessari, visto che si deve tendere sempre a migliorare. Infatti non di rado sono gli aspetti marginali che distinguono un romanzo di buona fattura da un romanzo eccellente e ho l’impressione, che a differenza di questo, Nero di maggio e Il passaggio possano essere inquadrati in un giudizio altamente positivo. Pertanto se Gori ci è riuscito non una volta, ma due a costruire qualche cosa di pregevole, per quanto sempre perfettibile, auspico che con il suo prossimo lavoro si ripeta. In ogni caso La nave dei vinti rimane un’opera di gradevole lettura.
Leonardo Gori
è uno scrittore italiano, autore del ciclo di romanzi di Bruno
Arcieri, capitano dei Carabinieri nell’Italia degli anni Trenta. Il primo
romanzo, Nero
di maggio,
si svolge nella Firenze nel 1938; seguono Il
passaggio, La
finale, L’angelo
del fango (Premio
Scerbanenco 2005), Musica nera, Lo
specchio nero e Il fiore d’oro, gli ultimi due
scritti con Franco Cardini. La serie di romanzi è in corso di riedizione in
TEA. Ha scritto anche thriller storici ed è stato co-autore di saggi sul
fumetto e forme espressive correlate (illustrazione, cinema, disegno animato).
24 Novembre
Le vacanze di Maigret di Georges Simenon Edizioni Adelphi Narrativa Collana Gli Adelphi. Le inchieste di Maigret
Una corsa contro il tempo Maigret e consorte sono in vacanza al mare alle Sables d’Olonne, ma un improvviso attacco di appendicite costringe la signora a essere ricoverata in ospedale, dove viene operata e dove trascorre i previsti giorni di convalescenza. Già di per sé poco propenso a oziare il commissario imposta la giornata in modo monotono, con la visita alla moglie ogni pomeriggio, alla stessa ora, diventata ormai un’abitudine, ma di ritorno dalla clinica si ritrova in tasca un biglietto anonimo che lo invita a far visita alla paziente della camera n. 15, una giovane donna caduta da un’auto in corsa per l’improvvisa apertuta della porta a cui era appoggiata. La paziente, con grave trauma cranico e in coma, muore e da lì Maigret inizia un’indagine, non ufficiale trovandosi fuori zona, e che costituisce il fil rouge di uno dei più bei gialli scritti da Simenon. Ed è tanto più bello perché i sospetti si addensano fin dall’inizio su un uomo dall’apparenza imperturbabile, un signore in tutti i sensi, il dottor Bellamy, illustre medico e personaggio di spicco non solo a livello locale. Inizia così una sorta di tenzone fra questi e Maigret, un commissario che questa volta è scorbutico più del solito e meno disposto a essere indulgente, perché quando c’è di mezzo l’omicidio di una ragazzina, poco più di una bambina, non si può essere clementi, ma si deve andare fino in fondo senza tanti riguardi. Come avrete capito, non c’è un solo omicidio, anzi ce ne sono diversi e ce ne sarebbero ancora di più se Maigret, mosso dal suo straordinario intuito, non accelerasse le indagini, in una corsa contro il tempo, per fermare il colpevole. Le vacanze di Maigret è indubbiamente un romanzo ben costruito, in cui i pochi personaggi, dipinti con la consueta abilità, si incontrano a perfezione, come le rotelle di un ingranaggio.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato centonovantatre romanzi pubblicati sotto il suo nome e un numero
imprecisato di romanzi e racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi
di «dettature» e memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in tutto il
mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è anche,
paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da Henry Miller a Jean
Pauhlan, da Faulkner a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli autori che
hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André Gide: «Considero
Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più autentico che
la letteratura francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo
romanzo di Simenon»; Louis-Ferdinand Céline: «Ci sono scrittori che ammiro
moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
21 Novembre
L’estate alla fine del secolo di Fabio Geda Dalai Editore Narrativa romanzo
Un’estate insieme A forza di sentir parlar bene di Fabio Geda mi sono convinto di leggere qualcosa di suo e la mia scelta è caduta, anziché sul più famoso Nel mare ci sono i coccodrilli, su L’estate alla fine del secolo, solo perché mi ha incuriosito un brano, tratto dal romanzo, riportato nell’ultima di copertina. Benchè fossero poche righe, sono state sufficienti per infondermi una sensazione di serenità e, si badi bene, non sapevo ancora chi fossero i due soggetti di cui si parla nelle stesse. Agli inizi il libro ci presenta Zeno, un ragazzino che vive in Sicilia e il cui padre, colpito da una grave forma leucemica, deve farsi curare in un ospedale di Genova. E’ una famiglia raccolta, tanto che la madre decide di andare pure lei a Genova, portandosi dietro il ragazzino. Ma a chi affidarlo, perché stante la giovane età ci deve sempre essere l’occhio attento di un adulto? Non trova di meglio che consegnarlo a suo padre, che vive in un paesino di montagna, sempre in Liguria, e con cui i rapporti sono freddi da anni, tanto che Zeno non sa nemmeno di avere un nonno materno. L’incontro fra l’anziano, ebreo che ha dovuto penare durante la guerra per il solo fatto di appartenere a una razza perseguitata, e il giovane Zeno sarà foriero di grandi sviluppi, tanto che il primo riuscirà a rivedere la vita con quella gioia che l’assurdo odio nazifascista gli aveva impedito, e il secondo, conoscendo le sue radici, grazie ai racconti del nonno, potrà affacciarsi nel mondo degli adulti consapevole e senza paure. Grosso modo è questa la trama del libro, suddiviso in capitoli in cui si alternano il racconto della vita trascorsa del vecchio e l’esperienza che va maturando il ragazzino: l’amicizia, il primo amore, la paura di perdere il padre, la vita misteriosa del nonno che, svelandosi, gli fa apparire da un’ottica diversa quell’uomo che, di primo acchito, gli era sembrato scostante nel suo quasi totale silenzio. Il romanzo è interessante, non c’è dubbio, e l’idea è azzeccata, anche se il suo sviluppo non è scevro da difetti, perché il raccordo fra presente e passato a volte non è ben calibrato e si corre il rischio di confondersi, evidenziando così una struttura non studiata a priori con la dovuta attenzione; ci sono inoltre lungaggini che non trovano giustificazione, come la passione del nipote per disegnare i fumetti, di cui si fa ben di più di un cenno; il ritmo, costante e tutto sommato idoneo al filo narrativo, a un certo punto rallenta non poco e le ultime pagine possono provocare anche qualche sbadiglio, soprattutto perché, in base a quel che è stato prima scritto, la conclusione della vicenda diventa del tutto prevedibile. Quel che però mi è piaciuto di meno è stata la mancanza di un’analisi psicologica approfondita del nonno e della figlia, personaggi chiave nel loro rapporto. Se è vero poi che ci sono delle ingenuità, delle omissioni, è altrettanto certo che in alcune pagine l’autore riesce a ricreare un’atmosfera quasi magica, con pennellate poetiche che impreziosiscono la narrazione. Per concludere, il romanzo è di piacevole lettura, anche se il mio giudizio nell’insieme è solo discreto; per esprimere un’opinione invece sul narratore dovrò leggere altre sue opere, il che mi riprometto di fare abbastanza a breve.
Fabio Geda
(1972, Torino), si è occupato per anni di disagio giovanile, esperienza che ha
spesso riversato nei suoi libri. Ha scritto su «Linus» e su «La Stampa» circa
i temi del crescere e dell'educare. Collabora stabilmente con la Scuola
Holden, il Circolo dei Lettori di Torino e la Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura. Esordisce nel 2007 con Per
il resto del viaggio ho sparato agli indiani;
segue L'esatta
sequenza dei gesti (2008)
e Nel
mare ci sono i coccodrilli (2010) che
ha avuto uno straordinario successo sia in Italia che all'estero. Nel 2011
esce L'estate
alla fine del secolo,
mentre del 2014 è Se
la vita che salvi è la tua (Einaudi).
Nel 2015 esce il primo volume della serie per ragazzi Berlin (Mondadori)
scritta insieme con Marco Magnone, del 2017 Anime scalze (Einaudi).
Nel 2019 pubblica per Einaudi Una
domenica.
17 Novembre
I fantasmi dell’Impero di Marco Consentino, Domenico Dodaro e Luigi Panella Sellerio Editore Palermo Narrativa romanzo storico
Giochi di potere L’anno è il 1937 e in Etiopia, da poco conquistata, il viceré è il generale Graziani, che è da poco scampato a un attentato, a cui ha fatto seguito una repressione che definire feroce potrebbe quasi essere un eufemismo. Da allora è diventato sospettoso e teme di essere avviluppato in una ragnatela, ordita da nemici esterni e interni. Proprio per parare le mosse di questi ultimi invia un avvocato militare, il tenente colonnello Vincenzo Bernardi, a indagare sui presunti abusi compiuti ai danni della popolazione dal capitano Corvo, un residente nei pressi del lago Tana; infatti ha il timore che si tratti dell’indizio di un complotto che ha lo scopo di provocare una rivolta con cui farlo apparire un incapace agli occhi di Mussolini. L’operazione, una vera e propria missione, vede l’avvocato militare accompagnato da una piccola, ma idonea scorta, comandata dal sottotenente Vittorio Vivarelli, e costitituita da pochi, ma validi ascari. Durante il tragitto non mancano attacchi e attentati, ma tutti falliscono, e allora, visto che sorge il dubbio che gli attaccanti non siano ribelli etiopici, sorgono subito spontanee due domande: chi vuole ostacolare la missione e che cosa non vuole che venga scoperto? Non vado oltre, perché I fantasmi dell’Impero non è solo un romanzo storico, ma è anche un giallo ben congegnato, che al di là del fatto che possa essere visto come un lavoro adatto a far trascorrere piacevolmente un po’ di tempo presenta caratteristiche proprie che lo rendono di notevole interesse. Intanto, come esposto in una nota degli autori, l’occasione per scriverlo è venuta da un caso fortuito accaduto a Luigi Panella: il ritrovamento nei fascicoli del disciolto Ministero dell’Africa delle tracce di un’inchiesta del 1938, rimasta segreta, condotta da un magistrato militare sull’operato del capitano Gioacchino Corvo, un ufficiale accusato di crimini di guerra nell’Etiopia occupata. A prima vista sembrerebbe un Cuore di tenebra all’italiana, ma procedendo nell’esame dei carteggi emergono non poche differenze che portano invece a ipotizzare dei pericolosi giochi di potere. Fra l’altro i protagonisti sono esistiti veramente e di alcuni viene riportato il nome e cognome, mentre per altri, per nulla inventati, si è preferito attribuire loro una nuova identità, anche se poi viene rivelato a chi corrispondano. Questo romanzo, che ha incontrato un notevole successo, ha senz’altro un pregio, cioè la demistificazione del colonialismo italiano, non dissimile da quello di altre nazioni europee, con una conquista che impose una totale sottomissione della popolazione, a completa disposizione degli occupanti, che potevano permettersi di fare quello che volevano, certi di restare impuniti, e allora furono numerosissime le violenze quotidiane, soprattutto sulle donne, considerate oggetti di un piacere usa e getta, per non parlare dei villaggi incendiati, della gente gassata, degli eccidi quasi sempre non giustificati. La ricostruzione storica è talmente dettagliata che anche particolari, in altre opere trascurati, come le divise indossate, sono descritti fedelmente. Se qualcuno poi pensa che si esageri nel parlare della nostra violenza, basta leggere i telegrammi dell’epoca, scambiati fra il potere centrale e i comandanti, per capire che non si è mai trattato della follia di qualche singolo, quanto basta ancora una volta per sfatare il mito degli italiani brava gente, un’invenzione nostra per autoassolverci. I fantasmi dell’Impero è un romanzo indubbiamente coinvolgente, ma è anche un’opera coraggiosa che descrive un pezzo della nostra storia prima volutamente ignorato.
Marco Consentino, esperto di relazioni istituzionali,
Domenico Dodaro,
business lawyer, e
Luigi Panella,
avvocato penalista, vivono a Roma e sono amici da anni. I
fantasmi dell’Impero è il loro primo romanzo.
14 Novembre
Il bell’Antonio di Vitaliano Brancati Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa romanzo
Dal trono alla polvere Con Il bell’Antonio Vitaliano Brancati affronta una tematica tanto cara agli italiani e maggiormente apprezzata nel mezzogiorno d’Italia, perché, a voler essere del tutto sinceri, in ogni maschio si cela, frenato, oppure solo vagheggiato, l’istinto del galletto, con alcuni che poi diventano autentici sciupafemmine e delle continua prova della loro virilità fanno l’unico scopo di un’esistenza dietro la quale c’è quasi sempre il vuoto. Il protagonista, Antonio Magnano, è un giovane di una bellezza straordinaria che entra nei sogni di tutte le donne che lo incontrano e anche di non pochi uomini. Gli si attribuiscono conquiste in serie, si vagheggiano rapporti di alcova in cui il kamasutra potrebbe essere il breviario di questo sacerdote dell’amore. Un grande seduttore, quindi, quel che si dice un tombeur des femmes e che a un certo punto finisce oggetto di un matrimonio architettato dal padre che nel voler sistemare bene il figlio con la ricca e bella ereditiera Barbara spera così anche di avere un’eventuale valvola di salvezza nel caso che un suo grosso investimento non vada a buon fine. Ebbene si celebrano le nozze, tutte le donne di Catania (la storia si svolge nella città siciliana durante il ventennio) invidiano la sposa e tutto andrebbe bene, se non fosse che dopo un po’ di tempo Barbara si accorge di qualcosa che non funziona, che quel marito, peraltro assai affettuoso, non consuma il matrimonio e quindi apriti cielo, anche perché si deve procedere all’annullamento del sacramento da parte della Sacra Rota, affinché lei possa sposare il ricchissimo duca di Bronte. Anche se non si volesse dare scandalo, anche se si volesse tacere l’impotenza di Antonio, l’annullamento del matrimonio e le conseguenti nozze non possono che diventare di dominio pubblico, e così in un Italia in cui la virilità era da considerarsi il miglior biglietto da visita, e al tempo stesso il minimo requisito per essere un perfetto fascista, il bell’Antonio precipita dal trono nella polvere. Sulla base di ciò che ho scritto verrebbe da pensare che lazzi e allusioni erotiche dovrebbero essere ben spalmate nell’opera, ma se è pur vero che c’è un certo sipirito goliardico, una certa verve tipicamente sicula, non potrei parlare di comicità, perché il romanzo è invece intriso di grottesco, imperniato come è sul dramma personale di Antonio Magnano, che si trincera in un non voler comprendere la sua condizione e che finirà poi per confessare questa sua disgrazia allo zio Ermenegildo, l’unico che sembra in grado di capirlo. C’è invece una comicità indiretta, e che è una vera e propria satira, nelle diatribe in casa Magnano e nel fraseggio, sovente in dialetto, dei cittadini catanesi, che sembrano trovare quasi un sollievo nell’apprendere che il giovane Magnano non era lo sciupafemmine di cui si vagheggiava e che in fondo si invidiava. La gente non comprende la tragedia di un uomo che si sente meno uomo, quelli che prima lo adulavano ora lo prendono quasi in giro, insomma c’è una emarginazione che finisce con il minare l’equilibrio psichico di un individuo che poco a poco si convince che per lui la vita non ha più senso. Il romanzo mi è piaciuto, è ben scritto, graffia il giusto senza eccessi, insomma è senz’altro da leggere.
Vitaliano Brancati,
scrittore italiano. Compì gli studi a Catania e si
trasferì a Roma per svolgervi l'attività letteraria e giornalistica.
Suggestioni di problematiche esistenziali e di un già invadente erotismo
appaiono nel romanzo "Singolare avventura di viaggio" (1934). In quell'anno
Brancati aveva maturato la sua crisi politica che lo portò a ripudiare tutti i
suoi scritti giovanili, improntati alla mitologia fascista dell'azione. Tornò
a Catania e si dedicò all'insegnamento collaborando nel frattempo al
settimanale "Omnibus".
10 Novembre
Starace. L’uomo che inventò lo stile fascista di Antonio Spinosa Edizioni Rizzoli Storia biografia
Un cretino obbediente Mussolini era Mussolini, ma il fascismo era Starace. Può sembrare una battuta a buon mercato, ma non lo è, perché Achille Starace diede un’impronta ben precisa alla nazione italiana, riuscendo però a farsi detestare sia dai fascisti che dagli antifascisti. Ci si chiederà il perché, ovviamente, e la risposta non è difficile, perché questo pugliese, eroe di guerra, nel lungo periodo in cui fu segretario del Partito Nazionale Fascista fu ubbidiente e fin troppo zelante nell’adempiere all’ordine del duce di far diventare fascisti gli italiani. Ed ecco allora le divise, gli esercizi ginnici obbligatori, il sabato pomeriggio occupati a marciare o a saltare il cerchio di fuoco, il tutto condito da un’aria di vuota retorica e da un patriottismo che esaltava quelli che erano definiti i nostri avi, cioè i romani. Dal punto di vista dell’organizzazione di questo spettacolo Starace era imbattibile, sempre pronto a inserire novità suggeritegli da Mussolini, che lui venerava, non contraccambiato però nella stima, tanto che in occasione della sua nomina a segretario, allorchè il gerarca fascista Arpinati, rivolto al duce, sbottò:”Ma è un cretino!”, la risposta fu eloquente: “Lo so, ma è un cretino obbediente!”. Dato che nel partito fascista non mancavano le fronde, i giochi di potere, non era ben vista questa sua posizione di contatto diretto con Mussolini e di continuo si cercava di screditarlo. Si arrivò al punto di rinfacciargli le numerose amanti, ma questa era un argomento che al Duce, anche lui impegnato allo stesso modo, interessava poco, si architettarono presunte ruberie, che fra i gerarchi erano la norma, ma nemmeno lì i congiurati ebbero successo, perché, se era cretino, era un cretino onesto. Invece cadde perché il fascismo di per sé si logorava, era invecchiato precocemente in una decadenza che con la guerra forse voleva evitare, ma che invece finì con il dare il cosiddetto colpo di grazia. Durante il secondo conflitto mondiale anche Starace, ormai senza più incarichi, senza redditi e quindi in difficoltà economiche, non fu che l’ombra di se stesso e dopo il 25 luglio del 1943 lo sbatterono anche in galera, per poi liberarlo quasi subito, ma per poco tempo, perché costituita la Repubblica Sociale Italiana lo misero in carcere a Verona, vicino alle celle dei congiurati del 25 luglio 1943. Lui continuava a scrivere lettere al duce, pregandolo di avere un incarico, ma quello faceva orecchi di mercante e così, una volta rimesso in libertà, si rifugiò a Milano dove visse quasi in miseria e in solitudine. Poi, chissà perché, il 29 aprile del 1945 uscì dalla sua tana in tuta da ginnastica per correre un po’. Venne riconosciuto dai partigiani e, sottoposto a un processo sommario, fu condannato a morte. Portato in piazzale Loreto, dove ancora erano appesi i cadaveri dei gerarchi fucilati a Dongo, della Petacci e di Mussolini, morì colpito dalle pallottole del plotone d’esecuzione gridando ancora una volta:” Viva il duce!”. Non c’è che dire se non che è il caso più unico che raro del perfetto cretino, coerente fino all’ultimo. Eppure, secondo la mia personale opinione, il personaggio merita rispetto, poiché non si macchiò di nefandezze ma fece l’errore di credere di trasformare gli italiani in un popolo di permanenti rivoluzionari, diventando oggetto della satira, ovviamente non ufficiale, con cui in fondo il fascismo poteva sembrare meno pericoloso e meno opprimente di ciò che effettivamente era. Antonio Spinosa, autore di numerose biografie di personaggi storici celebri, è esauriente nel parlarci dell’esistenza di Starace, senza essere greve, anzi inserendo un sottofondo ironico in quella che è anche la storia dell’Italia fascista. Non tace dei difetti del personaggio ed evidenzia l’unico pregio di non essere corruttibile; per quanto ne esca una macchietta, spesso indisponente, tuttavia l’autore dimostra anche di avere compassione per quest’uomo, morto spiritualmente dal momento in cui Mussolini non lo volle più alla sua presenza, una condanna infamante per chi per il duce sarebbe morto. Da leggere, senza dubbio.
Antonio Spinosa,
giornalista e scrittore, è stato direttore del nuovo «Roma», dell'agenzia
Italia, della «Gazzetta del Mezzogiorno» e di Videosapere-rai; inviato
speciale del «Corriere della Sera» e del «Giornale». È autore di numerosi
saggi storici, politici, di costume e di biografie di personaggi che hanno
c"ambiato il mondo e l'Italia in particolare, tra cui "Cesare", "Tiberio",
"Augusto", "Paolina Bonaparte", "Murat", "Starace", "Mussolini", "Vittorio
Emanuele III", "Hitler", "Pio XII", "Salò", "Edda", "Italiane", "L'Italia
liberata", "La grande storia di Roma", "La saga dei Borgia", "Mussolini
razzista riluttante", "Alla corte del duce", "Churchill", "Il potere", il
destino e la gloria", "Cleopatra", "D'Annunzio", tutti editi da Mondadori.
6 Novembre
Arco di trionfo di Erich Maria Remarque Edizioni Bompiani Narrativa
Un amore tormentato Il narratore alsaziano, dopo il fortunato romanzo sulla prima guerra mondiale (Niente di nuovo sul fronte occidentale), ha scritto opere che, benchè brillino meno se accostate a quel mostro sacro, pur tuttavia sono belle e alcune si possono definire senz’altro eccellenti, come Tempo di vivere, tempo di morire, Ama il prossimo tuo, La notte di Lisbona. Non posso invece dire così per Arco di trionfo, un testo corposo, in cui si ripresentano le tragiche storie dei fuorusciti, profughi all’estero senza asilo ufficiale, in quanto sprovvisti di documenti validi. La sensibilità dell’autore fa sì che non si tratti solo di ripetitive vicende strappalacrime, inserendo fra l’altro magari un amore tormentato. Ed è così anche per Arco di trionfo, che in più presenta il desiderio di vendetta di un antinazista torturato dalla Gestapo, il Dr Radic (ma sarà questo il suo vero cognome?), eminente chirurgo che per vivere si adatta a operare a Parigi per conto di altri. Il romanzo è indubbiamente interessante, anche se a volte la penna di Remarque esagera, tanto da far sorgere il dubbio che Radic possa essere un avventuriero. E’ un sospetto che viene pressochè subito fugato, ma il fatto che si ribelli deve far pensare che qualcosa nell’impianto non abbia funzionato. La storia d’amore è intrisa di romanticismo e smussa un po’ quell’atmosfera di trepida attesa di chi non ha più patria, né casa, con le nubi minacciose della guerra che si addensano sempre di più. In questo contesto mi è sembrato come uno di quei piatti che dalla lista degli ingredienti fanno nutrire aspettative eccezionali, ma che poi, a causa di un non perfetto amalgama, risultano assai inferiori, cioè solamente buoni. Non aiuta poi il numero delle pagine che a mio avviso è francamente eccessivo, tanto che è mia opinione che con un centinaio in meno l’opera sarebbe venuta molto meglio e del resto è ben più conosciuto il film che ne è stato tratto, uscito nel 1948 per la regia di Lewis Milestone e interpretato da un convincente Charles Boyer e da una bravissima Ingrid Bergman. Quindi, secondo me, ci si trova di fronte solo a un buon romanzo che non mancherà tuttavia di essere gradito, in particolare da chi ama storie d’amore tormentate e senza speranza.
Erich Maria Remarque,
combattente nella prima guerra mondiale, fu più volte ferito. Giornalista a
Berlino, lasciò la Germania all’avvento del nazismo e nel 1939 si stabilì a
New York, dove prese la cittadinanza americana. Raggiunse un vasto successo
con il romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im
Westen nichts Neues, 1929), radicale condanna della guerra e amara
analisi delle sue spaventose distruzioni materiali e spirituali. Seguirono,
sempre ispirati a ideali pacifisti e di solidarietà umana, Tre
camerati (Drei Kameraden, 1938), Ama
il prossimo tuo (Liebe deinen Nächsten,
1941), Arco di trionfo (Arc
de Triomphe, 1947), Tempo di vivere, tempo di
morire (Zeit zu leben und Zeit zu sterben,
1954), La notte di Lisbona (Die
Nacht von Lissabon, 1963) e Ombre in paradiso (Schatten
im Paradies, postumo, 1971). Numerosi romanzi di R. sono stati ridotti
per il cinema.
3 Novembre
Cronaca familiare di Vasco Pratolini BUR Biblioteca Universale Rizzoli Narrativa romanzo
La consolazione Cronaca familiare è un romanzo indubbiamente autobiografico che parla dei non certo facili rapporti fra Vasco Pratolini e il fratello Dante che i genitori adottivi hanno ribattezzato con il nome di Ferruccio. La storia familiare dell’autore è indubbiamente complessa ed è caratterizzata da distanze fra i suoi membri, con la madre che muore presto di spagnola, con il padre che va a vivere con un’altra donna senza avvertire la necessità di allevare i figli, con Vasco che viene accudito dalla nonna materna e con Dante, di fatto adottato dal maggiordomo di un lord inglese. Quest’ultimo è cresciuto in un ambiente totalmente diverso, rigido, ma indubbiamente ricco, quell’agiatezza che per Vasco è solo una chimera, costretto ad arrangiarsi fin dalla pubertà. Fra i due i rapporti formali dei primi anni dell’infanzia sono scemati presto, perché troppo diversi sono i mondi in cui vivono, ma non si tratta solo di un distacco, perché Vasco è ossessionato da quanto fin da piccolo sentiva e che cioè la causa della morte della madre era stata proprio il fratello Dante, che lei aveva da pochi giorni dato alla luce. Casualmente si incontreranno e da adulti vivranno appassionatamente quella vita da fratelli che prima non avevano mai avuto. Sarà un periodo intenso, in cui Vasco darà tutto il suo amore per far perdonare a se stesso quell’astio derivante dall’errata notizia della causa della morte della madre, ma sarà un periodo breve, perché Dante, ritornato nel mondo in cui era nato e quindi alla pari del fratello, si ammalerà di una malattia tanto grave quanto sconosciuta e morirà, raggiungendo idealmente quella mamma che non poteva aver mai conosciuto. Cronaca familiare è un’opera che esce un po’ dai canoni delle autobiografie e che rappresenta invece il desiderio dell’autore di porre un tardivo rimedio ai rimorsi della sua coscienza, tanto che molto opportunamente scrive in premessa: “ Questo libro non è un’opera di fantasia. É un colloquio dell’autore con suo fratello morto. L’autore, scrivendo, cercava consolazione, non altro. Egli ha il rimorso di avere appena intuita la spiritualità del fratello, e troppo tardi. Queste pagine si offrono qiondi come una sterile espiazione.”. E il libro mantiene quanto indicato in premessa, in pagine sofferte, che sembrano scritte con le lacrime e in alcuni casi addirittura con il sangue, in una storia di un’infanzia tribolata e priva del senso della famiglia, fatta eccezione per la nonna, che verso i nipoti ha un affetto materno, quella nonna che ormai vecchia e ridotta all’ospizio, dove poi morirà, sarà l’elemento chiave per riavvicinare i fratelli. A una prosa scarna si alternano momenti di autentica poesia, fra i quali mi permetto di ricordare le pagine in cui si descrive la dipartita appunto della nonna, ma anche la fine, le ultime righe non sono da meno, perché quest’opera è come una sinfonia che per ritmo e risonanze mi ricorda il Canone di Pachelbel. E’ una musica che entra direttamente nel cuore, sono note sublimi che rendono partecipi del dramma dell’autore.
Vasco Pratolini
(Firenze,
19 ottobre 1913 – Roma, 12 gennaio 1991). Di
famiglia operaia, è costretto a interrompere gli studi e svolge mestieri
diversi per potersi mantenere.
Pratolini comincia a collaborare al periodico «Il Bargello» e diviene
redattore con Alfonso Gatto, nel 1938, della rivista «Campo di Marte». Nel
1951 si trasferisce a Roma, città nella quale vivrà da allora in poi.
Il registro adottato, sin da quelle prime prove, si pone a mezza via fra il
realistico e il lirico. Pratolini svolge con successo, in questi anni, anche un'attività di sceneggiatore e soggettista cinematografico, e intraprenderà in seguito una carriera di autore di testi teatrali ("La domenica della povera gente", 1952; "Lungo viaggio di Natale", 1954).
Nel 1955 pubblica Metello (premio Viareggio), primo romanzo di quella che
diverrà la trilogia "Una storia italiana", essendo completata da "Lo scialo"
(1960) e da "Allegoria e derisione" (1966).
Alla città e al mondo dell’adolescenza sono dedicati ancora un romanzo, "La
costanza della ragione" (1963), e le poesie raccolte in "La mia città ha
trent’anni" (1967). Alcune «cronache in versi e in prosa», scritte dal 1930 al
1980, sono riunite nel volume "Il mannello di Natascia" (1984, premio
Viareggio).
29 Ottobre
Stirpe di Marcello Fois Edizioni Einaudi Narrativa romanzo
Il destino dà, il destino toglie In fondo rientra nei desideri di ognuno di noi lasciare un’impronta della nostra esistenza, perché così ci sembra di essere vissuti per qualcosa, di non essere stati solo un microscopico tassello della storia dell’Universo. Potrebbe essere l’idea base di questo romanzo di Marcello Fois e in parte lo è, ma non è l’unica chiave di lettura e nemmeno la più importante. Quel che intendo dire si potrà comprendere meglio leggendo quel che segue. Michele Angelo Chironi e Mercede Lai sono due figli illegittimi, senza genitori, e che vengono pertanto da una condizione di particolare disagio sociale che però li accomuna a tal punto che si legheranno per sempre con il matrimonio. Ci troviamo a Nuoro, alla fine del XIX secolo, in un’atmosfera che tanto ricorda più che i romanzi di Grazia Deledda, quelli di Giuseppe Dessì. E’ un mondo rurale, chiuso e spesso silenzioso, quello in cui si muovono i due protagonisti, con lui, che preso in affido da un fabbro vedovo e senza figli, diventa il padrone della fucina che ben presto lo arricchisce. Non sto a spiegare la trama, perché abbraccia un periodo di tempo che va appunto dalla fine del nostro secolo risorgimentale alla seconda guerra mondiale, e preferisco delineare ciò che mi è piaciuto e che non è poco. In questa vicenda, che è poi la storia di una famiglia, e non a caso il titolo è Stirpe, ben si può comprendere il significato di come il destino nella vita dia e come anche tolga, perché gioie e dolori saranno una costante dei Chironi. In questo contesto l’autore è bravo nel non cadere nella tentazione di muovere alle facili lacrime, eppure di occasioni ce ne sono tante, come la tragica morte dei due gemelli che avvia una serie di lutti tali da togliere ogni speranza. E invece no, Fois ci dice che si può perdere tutto, meno che la speranza, l’unica che consenta di proseguire, nonostante tutto. Ed è grazie a questo proposito di non cedere le armi che un giorno la vita opaca dell’ormai vecchio Chironi si illuminerà di quell’unica luce che possa ancora dare un senso alla vita. L’autore sardo, di cui prima non avevo mai letto nulla, è una piacevole sorpresa, perché in un ambito letterario in cui spesso si cerca invano di riempire il vuoto questo suo romanzo acquista una particolare rilevanza; di fatto Fois entra nella scia di un narratore che ho particolarmente apprezzato, vale a dire Giuseppe Dessì, purtroppo ai tempi nostri scarsamente conosciuto. Certo, si tratta di epoche diverse e anche la scrittura, pur avendo nello stile molto in comune, è differente, come pure la verve creativa, tanto più che Fois ha aggiunto la straordinaria invenzione di far parlare i morti con i familiari, facendo dire loro quello che in vita per un motivo o per l’altro non erano riusciti a comunicare. Per contro, e questo secondo me è l’unico difetto, non sempre, ma ogni tanto appare una certa verbosità, un trascinare un discorso oltre il già detto e che per questo si nota subito, ma si tratta di cosa da poco, se raffrontata con la bellezza dell’intera opera, un romanzo che parte lento, che non avvince da subito, ma che poi va in crescendo, pur in presenza di parti necessariamente poco veloci. Tanto per dare un’idea, ho impiegato non poco a leggere le prime venti pagine, ma poi è come se avessi premuto il piede sull’acceleratore e in poche ore sono arrivato alla fine, con l’ultima pagina che non può non commuovere, ma non è una commozione triste, è una commozione lieta nel vedere che quest’uomo, così provato duramente dai lutti familiari e che si è sempre battuto contro la malasorte, trova un motivo per vivere, in un autentico colpo da maestro che Marcello Fois ha saputo preparare con grande abilità. E per quanto ovvio, nelle vicissitudini di questa famiglia, c’è anche un po’ di storia d’Italia, una storia che nell’isola appare sempre lontana, come se gli avvenimenti del mondo avvenissero su un altro pianeta e lì ne arrivasse solo l’eco. Da leggere, ovviamente.
Marcello Fois (Nuoro
1960) vive e lavora a Bologna. Tra i tanti suoi libri ricordiamo Picta (premio
Calvino 1992), Ferro Recente, Meglio morti, Dura madre, Piccole
storie nere, Sheol, Memoria del vuoto (premio Super Grinzane
Cavour, Volponi e Alassio 2007), Stirpe (premio Città di Vigevano e
premio Frontino Montefeltro 2010), Nel tempo di mezzo (finalista al
premio Campiello e al premio Strega 2012), L'importanza dei luoghi comuni (2013), Luce
perfetta (premio Asti d'Appello 2016), Manuale di lettura creativa (2016), Quasi
Grazia (2016), Del dirsi addio (2017 e 2018), il libro in versi L'infinito
non finire (2018) e Pietro e Paolo (2019).
24 Ottobre
Racconto d'autunno di Tommaso Landolfi Edizioni Adelphi Narrativa romanzo Pagg. 141 ISBN 9788845911224 Prezzo Euro 18,00
Un’atmosfera da romanzo gotico Sembra che Racconto d’autunno sia l’opera più riuscita e più nota, soprattutto all’estero, di Tommaso Landolfi, narratore laziale di certo fra i non più conosciuti, anche per una sua naturale ritrosia a essere parte di correnti letterarie, nelle quali in verità sarebbe peraltro difficile trovare una sua collocazione. L’aspetto saliente delle sue opere, e ovviamente anche di questa, è lo stile ricercato che non è un corollario, ma uno degli scopi, e senz’altro il principale, di ogni suo scritto. Anche un lettore non particolarmente attento potrà notare la ricercatezza del linguaggio, l’uso, mai inappropriato, di termini non frequenti, ma soprattutto un’impostazione che privilegia la descrizione di ambienti e di atmosfere con una precisione mai eccessiva e che anzi affascina, con proiezioni oniriche e con la capacità di ricreare una tensione che accompagna perfettamente angoscia e curiosità. Inserito in un periodo storico che, senza nominarla, ricorda quello della Resistenza, Racconto d’autunno è un’opera per certi versi visionaria, densa di metafore che un po’ ricalcano aspetti della vita dell’autore, ma che anche sono propri di ogni essere umano, per il quale la propria esistenza è già un mistero. Il castello in cui si imbatte il protagonista, un edificio ormai cadente alla cui scoperta dedica pressochè per intero il suo soggiorno, è una lunga sequenza di camere, di scale, di porte, di sotterranei, un labirinto da percorrere senza mai venirne effettivamente a capo. Cosa nasconde? Quale segreto si cela? Con pochi personaggi (il vecchio nobile, due cani, la giovane figlia che tanto assomiglia alla madre morta la cui immagine è impressa in un dipinto) il protagonista si muove in un’atmosfera gotica, in cui predomina il buio, é timoroso, ma curioso di conoscere, ossessionato da irreali presenze, di cui una scaturita da un esperimento di negromanzia. Il romanzo si sviluppa in 141 pagine in cui amore e morte si fondono mirabilmente dando vita a un’opera che attrae e respinge, attrae perché avvince nelle aspettative (che non verranno deluse) e respinge perché se il mondo descritto può sembrare del tutto estraneo al nostro è in effetti una sua immagine speculare, è quella parte che in noi è timore e sgomento, è consapevolezza dei nostri limiti e tentativo di superarli, è quel pensiero mai sopito della morte, è il flusso di domande senza risposte sul perché esistiamo. Leggere Racconto d’autunno rappresenta pertanto un’esperienza e richiede la massima disponibilità a lasciarsi rapire dalla descrizione di un mondo che ha anche risvolti surreali, ma che pagina dopo pagina riconosciamo come nostro, dove ogni elemento ha un suo ben preciso scopo e anche noi siamo parte di quello scopo.
Tommaso Landolfi
(Pico, 9 agosto 1908 – Ronciglione, 8 luglio
1979), nato da famiglia nobile, si laurea in Lingua e Letteratura Russa
all'Università di Firenze nel 1932. In gioventù frequenta la cerchia degli
ermetici e collabora a «Letteratura» e «Campo di Marte». Landolfi esordisce
come narratore nel 1937 col racconto umoristico e concettuale Dialogo
dei massimi sistemi. Alimentato da infinite
suggestioni letterarie (da Rabelais a Gogol' passando per i simbolisti...), il
discorso narrativo di Landolfi verte soprattutto sull'incontro-scontro tra
istinti e ragione, tra consapevolezza e inconsapevolezza, registrato con
ironia e e lirismo. Tra i successivi libri di narrativa ricordiamo Il
mar delle blatte e altre storie (1939), La
pietra lunare (1939), Racconto
d'autunno (1947, da cui sarà tratto un
film), Ottavio di Saint Vincent (1958,
premio Viareggio), Rien va (1963), Le
labrene (1974) e A
caso (1975, premio Strega). Ha scritto
anche opere di poesia, tra le quali Viola di morte (1972)
e Il tradimento (1977,
premio Viareggio), e un volume di critica letteraria: Gogol'
a Roma (1971). Per il teatro ricordiamo Landolfo
VI di Benevento (1959), Scene
della vita di Cagliostro (1963), Faust
'67 (1969). Landolfi è considerato uno dei
massimi scrittori del Novecento: in Italia le sue opere sono pubblicate presso
Adelphi. Da ricordare che Italo Calvino, che apprezzava particolarmente il suo
lavoro, ha curato un'antologia di racconti landolfiani nel 1982.
21 Ottobre
Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra di Giovanna Procacci Bollati Boringhieri Edizioni Storia
Carne da macello Se la guerra è un’immensa tragedia lo è ancora di più se la mancanza di umanità non è caratteristica del nemico, ma dei propri comandanti. In questo senso la prima guerra mondiale fu una devastante esperienza per i nostri soldati, mandati al macello in insensati attacchi nelle prime undici battaglie dell’Isonzo, costretti a vivere miseramente in trincee inospitali, soggetti a una disciplina più sadica che razionale. Dire che la colpa di questo stato di cose fu del comandante in capo generale Luigi Cadorna appare un’asserzione incompleta, perché se è vero che a lui furono concessi i più ampi poteri è altrettanto vero che il governo che glieli attribuì fu direttamente o indirettamente complice della sua crudeltà. Diciamo francamente che il concetto di disciplina che aveva Cadorna era ben lungi dalla necessità di instaurare una scala gerarchica con ben identificati diritti e doveri per ogni grado, in quanto la truppa non era considerata niente di più di carne da cannone e affinchè come bestie inviate al macello lo facesse di buon grado doveva vivere nel terrore quando anche non andava all’attacco. La più piccola mancanza era punita in modo del tutto sproporzionato e perfino le lettere scambiate con i familiari, se contenevano anche modeste allusioni alle paure derivanti dal conflitto, erano materia per accuse e allestimento di processi, conclusi con sentenze esemplari. Tengo a precisare che un così alto numero come in Italia di condannati a morte in proporzione alla forza effettiva non ha riscontri negli altri paesi belligeranti, e quindi non c’è da meravigliarsi se alla disfatta di Caporetto abbia contribuito un ritrovato spirito di ribellione a una situazione ormai diventata insostenibile. Quindi, quel che si scriveva anni fa nei testi scolastici di storia e cioè di un soldato italiano ubbidiente e disposto a tutto pur di giungere alla vittoria non solo era una falsità, ma era anche la negazione di un fenomeno che non ha avuto uguali nella storia in altri conflitti. Basti pensare ai nostri prigionieri, a cui, a differenza di quegli degli eserciti alleati, non erano inviati dallo stato italiano pacchi viveri e vestiario, ben sapendo che l’Austria e la Germania non avevano la possibilità di nutrirli e di vestirli. Il tutto partiva dall’assurdo concetto che quei soldati rinchiusi nei lager austriaci e tedeschi si fossero arresi unicamente per fuggire i pericoli della guerra. Per qualcuno forse fu così, ma per la stragrande maggioranza no. Questo comportò che su 600.000 nostri soldati in prigionia ne soccombessero per gli stenti circa centomila, un’enormità che avrebbe potuto essere salvata in gran parte senza l’assurdità di non inviare da parte del nostro stato pacchi viveri e vestiario, generi di conforto che, se è pur vero che potevano essere spediti dai familiari, trovavano continui ostacoli nelle spesso misere finanze e in una disorganizzazione postale a cui molto contribuivano i ritardi provocati dall’ossessionante censura. E infatti si controllava tutta la corrispondenza, soprattutto quella che gli internati inviavano a casa alla ricerca di conferme di questa diserzione, tanto che i prigionieri erano considerati alla stregua di criminali, pronti a processarli a guerra finita e a condannarli. Dopo l’armistizio del 4 novembre questi poveri nostri soldati non poterono ritornare subito alle loro famiglie, ma furono internati, sottoposti a interrogatori e a ogni angheria, un comportamento talmente vergognoso che da solo basta a condannare i veri colpevoli, vale a dire il re, il governo e lo Stato maggiore. Di tutto questo parla, sulla base di una rigorosa documentazione, Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra, il risultato di un grande e approfondito studio svolto da Giovanna Procacci che ha senz’altro il merito di aver svelato un fatto storico in precedenza trascurato, ma della massima importanza per capire tante cose, sia per eventi che caratterizzarono la prima guerra mondiale, sia per accadimenti successivi, perché la storia non è mai il frutto di un qualcosa di improvviso e di impensabile, visto che a ogni effetto corrisponde sempre una causa, magari di molto antecedente. Per quanto si tratti di un testo di storia la lettura è agevole, perché lo stile della Procacci non è mai greve, riuscendo peraltro a interessare sempre più, pagina dopo pagina. Inoltre, al termine del saggio sono riportate numerose lettere, prevalentemente di protesta, divise in tre gruppi: il primo (Soldati) sono quelle provenienti dal fronte, oppure da disertori che avevano trovato rifugio in Svizzera; il secondo (Prigionieri) sono quelle dei vari prigionieri nei campi di concentramento in Austria-Ungheria e Germania; il terzo (Lettere varie) è costituito da corrispondenza di vario tipo e considerata interessante per i particolari contenuti. E’ quasi superfluo aggiungere che queste testimonianze su carta hanno un notevole valore perchè permettono di comprendere lo stato d’animo dei nostri soldati e, quantunque spesso scritte non del tutto sinceramente per non incorrere nei rigori della censura o per evitare di allarmare i familiari, sono in grado di far comprendere quanto dolorosa, nei suoi molteplici aspetti, sia stata quella guerra. Per quanto ovvio il mio consiglio è di leggerlo.
Giovanna Procacci,
studiosa di storia sociale e delle mentalità, ha
insegnato Storia contemporanea presso l'Università di Modena. Tra le sue
pubblicazioni recenti: Dalla rassegnazione alla
rivolta. Mentalità e comportamenti popolari nella Grande Guerra (1999), Deportazione
e internamento militare in Germani. La provincia di Modena (2001), Le
stragi rimosse. Storia, memoria pubblica, scritture (2008), Per
la difesa della razza. L'applicazione delle leggi entiebraiche nelle
università italiane (2009) e Soldati
e prigionieri italiani nella Grande Guerra (2016).
16 Ottobre
Maigret e il ministro di Georges Simenon Edizioni Adelphi Narrativa romanzo Collana Gli Adelphi. Le inchieste di Maigret
Un’indagine particolarmente difficile Credo che l’unico aspetto che mi accomuni a Jules Maigret sia la innata sfiducia nei politici; anche il celebre commissario cerca di starne alla larga, consapevole dei doppi giochi che spesso caratterizzano il loro operato, ma quando, dopo circa un mese che era crollata un’ala di un sanatorio seppellendo numerosi bambini deceduti nell’occasione, riceve una telefonata serale dal ministro dei Lavori Pubblici che chiede il suo aiuto, per quanto dubbioso e titubante va all’appuntamento. In un’abitazione privata si incontra così con un uomo simile a lui nella stazza e perfino nelle origini, un avvocato che viene dalla provincia e che gli racconta della sparizione misteriosa di un documento, il rapporto Calame, che molto ha da dire sulla disgrazia accaduta. Auguste Point, così si chiama il ministro, fa una buona impressione al commissario che finisce per credergli e per accettare l’incarico di togliere il politico dal fuoco in cui è caduto con il furto del predetto documento che aveva temporaneamente depositato proprio nello stesso appartamento nell’attesa di consegnarlo al Presidente del Consiglio. Come è possibile comprendere, è un’indagine per niente facile, dovendo procedere come su un campo minato, e Maigret dovrà giocare d’astuzia più del solito, cercando di mantenersi sereno e di adottare un dignitoso comportamento diplomatico. E’ inutile che aggiunga che il commissario ancora una volta chiuderà positivamente un caso in cui, fatto insolito, non ci sono omicidi. Maigret e il ministro è quindi un poliziesco strano, ma ha una sua ben costruita suspense che lo rende avvincente dalla prima all’ultima pagina.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e racconti
pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e memorie. Il
commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in tutto il
mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è anche,
paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da Henry Miller
a Jean Pauhlan, da Faulkner a Cocteau, molti e
disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André Gide:
«Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più
autentico che
la letteratura francese
abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
12 Ottobre
Le grandi battaglie degli Alpini nella Grande Guerra di Diego Vaschetto Edizioni del Capricorno Storia
La leggenda degli Alpini Gli scontri fra i ghiacci dell’Ortles e dell’Adamello, il sangue copioso versato sul Pasubio, i combattimenti cruenti sostenuti sull’Altopiano di Asiago, le imprese di guerra e alpinistiche sul monte Cauriol, gli incredibili assalti ai castelli rocciosi in Val Costeana fra il Castelletto e il Lagazuoi Piccolo, le epiche vicende su Monte Cristallo sono i teatri naturali in cui gli Alpini si dissanguarono, mai domi, con un eroismo di corpo di cui si sarebbero resi protagonisti anche nel secondo conflitto mondiale. Sulle alte cime, a cui già arrivare può considerarsi un’impresa, visto il gelo perenne e le tempeste che le battono, gli alpini osarono di più di quello che la logica avrebbe consentito, attaccando il nemico, combattendo corpo a corpo, immolandosi anche in attacchi senza probabilità di successo. Ma anche scendendo di quota opposero un muro agli austriaci della Strafexpedition e lasciarono la vita in quella Verdun italiana che è stato il monte Pasubio. Non furono le uniche truppe a combattere in quella Grande Guerra, perché va dato atto anche al coraggio delle fanterie e dei bersaglieri, ma loro, quelli con la penna sul berretto, erano diversi, erano fieri di essere reparti specializzati, costituiti da gente che di montagne se ne intendeva, perché viveva da civile nelle valli alpine; non solo questo, però, perché lo spirito di corpo era tale che, salvo poche eccezioni, vigeva un cameratismo stretto al punto che la disciplina non prevedeva un rigido distacco fra la truppa e gli ufficiali, anche quelli di rango superiore, elemento catalizzatore sempre presente anche nelle epoche successive. Non sarebbe facile trovare nemmeno oggi un uomo come Gabriele Nasci, durante quella guerra ufficiale di rango inferiore, ma che in seguito diventò generale, sempre in testa ai suoi uomini in ogni battaglia, pronto a dividere con loro la dura realtà di ogni giorno di guerra, o come Achille Papa, un generale idolatrato dai suoi soldati, teso sempre a limitare le perdite, a essere di esempio e se necessario di conforto, uomini certo d’altri tempi, ma che ben seppero interpretare lo spirito che ha sempre animato il corpo degli Alpini. Diego Vaschetto ci parla delle quasi incredibili battaglie che li videro protagonisti nel corso della Grande Guerra, con una narrazione snella e schematica, con l’aiuto di cartine e di fotografie dell’epoca; inoltre, ben consapevole dell’interesse dei lettori, completa ogni teatro di scontro con una dettagliata descrizione dei percorsi da seguire affinché chi è in grado di effettuare escursioni possa andare a vedere quei palcoscenici, ormai silenziosi, dove si è forgiata la leggenda degli Alpini. Forse non è un libro di storia come quelli che siamo abituati a leggere, ma è veramente efficace, in grado di appassionare dalla prima all’ultima pagina, e questo è certo un grande merito.
Diego Vaschetto.
Laureato in Scienze geologiche all’università di Torino, specialista in
scienze e culture alpine, difesa del suolo e tutela dell’ambiente, si occupa
di glaciologia alpina e artica, vulcanologia, meteorologia e rilevazione
nivometrica. Ha collaborato come fotografo con alcune riviste ed è stato
consulente scientifico nella stesura di guide turistico-escursionistiche.
8 Ottobre
Una manciata di more di Ignazio Silone Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa romanzo
La speranza non deve morire Questo romanzo, parafrasando in parte il titolo di una più fortunata opera successiva dell’autore, avrebbe potuto meglio essere intitolato L’avventura di un disilluso comunista. Che Ignazio Silone sia stato un cristiano senza chiesa e un socialista senza partito penso sia ormai incontrovertibile, così come appare forse incontestabile che dalla sua innata religiosità promani un’aspirazione politica a un mondo senz’altro più sociale, in cui le comuni identità non soffochino la spiritualità di ognuno. Questi contrasti nell’impossibilità per l’autore di trovare un partito in cui identificarsi finiscono per incernierare questo racconto ambientato nell’immediato dopo guerra nella sua Marsica, terra ricca di miseria, con piccoli borghi in collina e montagna, caratterizzata da ampie foreste in cui trovano rifugio i lupi. Non sto ad anticipare nulla della trama, peraltro non semplice, limitandomi a evidenziare i caratteri salienti dell’opera che è un’evidente denuncia dei comportamenti non certo canonici del Partito Comunista Italiano in quel periodo, un’istituzione rifugio, ma anche fonte di lucrose opportunità per gli ex fascisti che avevano l’impellente bisogno di cancellare il passato, rifacendosi una nuova verginità. In contrapposizione vi è invece la profonda delusione di chi credeva in un mondo diverso e più equo, grazie a un’idea di comunismo associata a uno stampo egalitario e di giustizia che mai si ebbe poi a concretizzare. Il partito diventa così un apparato per imporre ai suoi accoliti una cieca obbedienza, per far credere che solo con la supina accettazione delle direttive sarà possibile raggiungere quegli scopi, quegli ideali che non tarderanno a rivelarsi chimerici. Come è possibile comprendere Una manciata di more è un romanzo amaro, è la disillusione di un’antifascista che tanto ha rischiato nel ventennio confidando in un’Italia migliore e che si accorge che dopo tanti patimenti, dopo le sofferenze di un intero popolo nulla è cambiato. Tuttavia, proprio perché a un uomo non può essere negata la speranza in un mondo nuovo, Silone nello spiegare in questo romanzo il motivo perché è uscito dal Partito a cui è stato iscritto con partecipazione attiva per molti anni, non può non far balenare, prima per se stesso che per gli altri, una soluzione, l’unica ormai rimasta e che possa consentire di guardare con fiducia al futuro, ed è una soluzione utopistica, è quel desiderio di essere parte di piccole comunità spontanee, non istituzionalizzate; è un ritorno alle origini, allo spirito innato di chi crede ancora nell’amicizia, nella solidarietà, e che è convinto che non sia impossibile trovare una via per percorrere una strada comune verso la la giustizia e la libertà, come anche in fondo viene espresso in un altro suo romanzo (Il seme sotto la neve). Una manciata di more è un bel libro, non bellissimo, perché Silone ne ha scritti di migliori, come Fontamara e appunto Il seme sotto la neve, ma è comunque senz’altro meritevole di lettura.
Ignazio Silone,
pseudonimo di Secondo Tranquilli (Pescina, 1 maggio 1900 – Ginevra, 22 agosto
1978), è stato scrittore, politico e uno degli intellettuali italiani più
conosciuti e letti in Europa e nel mondo. Il suo romanzo più celebre è Fontamara.
5 Ottobre
Maigret si sbaglia di Georges Simenon Edizioni Adelphi Narrativa
L’uomo che credeva che tutto gli fosse dovuto E’ indubbia la capacità di Simenon di proporre un’approfondita analisi psicologica dei suoi personaggi, spesso ricorrendo ai contrasti per dare corpo alla trama o per meglio evidenziare le differenze caratteriali. E’ anche questo il caso di Maigret si sbaglia, dove una mantenuta, che prima faceva la prostituta, viene trovata assassinata nel suo appartamento sito in un edificio dei quartieri nobili di Parigi; il suo amante, noto chirurgo e coniugato, abita nell’appartamento sovrastante quello della vittima che aveva da tempo una relazione con un giovane musicista squattrinato. Etienne Gouin, questo è il nome dell’illustre medico, è un personaggio del tutto particolare; venuto dal nulla, studiando e dandosi da fare, è diventato un luminare della chirurgia, forte anche della sua convinzione di essere superiore a tutti e a tutto, tanto dal presentare la caratteristica di una disarmante sincerità. Per lui le donne sono solo l’occasione di uno sfogo sessuale e come una farfalla, che svolazza da un fiore all’altro, lui passa da una femmina all’altra, per avventure brevissime, tranne quella con la donna assassinata. Non fa mistero di queste sue relazioni, tanto che ne parla alla moglie, convinto che debbano essere un suo diritto. La donna è apparentemente consenziente, ma in effetti lo detesta profondamente per questo suo carattere contraddistinto da una superbia che non si sfoga in una soddisfazione personale, ma che è il risultato di questo concetto di essere unico e il migliore. Fra lui e Maigret si instaura un sottile gioco volto da un lato alla massima franchezza e dall’altro al tentativo di incastrarlo, ma il commissario si accorgerà di sbagliare e nel momento in cui ne prende coscienza capirà chi è veramente l’omicida. Maigret si sbaglia è un poliziesco molto bello che si eleva chiaramente dal livello medio delle opere del romanziere belga con protagonista Maigret. In un’atmosfera rilassata più che la suspense contra il duello psicologico e verbale fra il grande uomo e il commissario, una trama che è senz’altro originale e che, oltre che avvincere il lettore, finisce con l’insegnargli molto sul comportamento umano. Ed è anche per questo che mi sembra meritevole di lettura.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato centonovantatre romanzi pubblicati sotto il suo nome e un numero
imprecisato di romanzi e racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi
di «dettature» e memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in tutto il
mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è anche,
paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da Henry Miller a Jean
Pauhlan, da Faulkner a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli autori che
hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André Gide: «Considero
Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più autentico che
la letteratura francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo
romanzo di Simenon»; Louis-Ferdinand Céline: «Ci sono scrittori che ammiro
moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
1 Ottobre
Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale di Enzo Forcella e Alberto Monticone Editori Laterza Storia
La disciplina con il terrore Non fossero bastate le tragedie di ogni giorno, gli attacchi scriteriati che consentivano di avanzare di qualche centinaio di metri a prezzo di perdite spaventose, i nostri soldati della Grande Guerra dovevano temere anche il regime di ferrea disciplina imposto e che prevedeva per ogni mancanza, anche la più lieve, pene severissime. Eppure l’orrore era talmente imperante che molti ricorrevano all’autolesionismo per fuggire da quell’inferno; c’era gente che si sparava a un dito, altri che si provocavano infezioni, altri ancora che con metodi empirici si accecavano, ma il comando era vigile, per principio non credeva a una ferita accidentale o avvenuta nel corso di uno scontro, e così in tanti andavano al Tribunale militare in processi che raramente si concludevano con un’assoluzione, ma che sovente terminavano con pene detentive di non poco conto e in taluni casi anche con la morte per fucilazione; a maggior ragione venivano punite con la massima severità le frequenti diserzioni, lo sbandamento davanti al nemico, e non mancavano i reati di opinione, sia di tipo politico che di semplice sfogo individuale, tutti sanzionati con una fermezza raramente riscontrabile. Il Codice militare che si applicava in tempo di guerra era ancora quello albertino, rivisto dopo l’unità d’Italia, e già di per sé severo, considerando la truppa niente di più che bestiame votato al macello. Poi, nel corso del conflitto, le ordinanze di Cadorna furono sempre tese a instaurare un regime di terrore, con l’espresso invito ai giudici di non andar tanto per il sottile e fu così che l’esercito italiano fu quello che, raffrontato alla sua entità, ebbe in percentuale il maggior numero di denunce, il maggior numero di processi e il maggior numero di condanne a morte. Nel computo poi non rientrano le crudeli decimazioni, quasi sempre ingiustificate, e le diffusissime renitenze alla leva. Insomma, per dirla breve Cadorna alla vigilia di Caporetto si trovò a comandare truppe stanchissime e impaurite per la severità dei metodi imperanti, e forse anche questo contribuì alla disfatta. Nella prima parte di “Plotone di esecuzione” troviamo due introduzioni storiche degli autori che aiutano a comprendere il perverso meccanismo della disciplina militare dell’epoca e a leggere le sentenze, che vengono riportate nel corposo seguito, dal punto di vista dei giudici che le hanno scritte. Per comprendere di che si tratta riporto una di queste decisioni della magistratura militare, scelta non a caso, per dimostrare che un comportamento che oggi sarebbe del tutto normale invece all’epoca e nelle circostanze della guerra si configurò come reato, con una sanzione peraltro pesantissima. Da notare che Forcella e Monticone hanno riportato i testi integrali senza correzioni quindi e con un italiano non proprio da accademia della crusca, ma anche allora gli italiani, almeno il popolo, non brillava di certo per conoscenze linguistiche. Sentenza N° 22 «Se non si muore oggi si muore domani … » R. V., anni 23, carrettiere, celibe, soldato nell’83° fanteria; condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione militare per lettera denigratoria, Tribunale militare di guerra del XVIII corpo d’armata. Feltre, 31 agosto 1916. (TS, Trib. Guerra, b. 113, f. 175, sent. 139). IL R. V. spediva dalla zona di guerra il 18 luglio 1916, una lettera a tale F. C., in cui, fra le altre, si leggono le frasi seguenti: «Non so se avrai ricevuto le lettere perché le censurano, e le scassano tutti gli scritti: per non far sapere i disagi e le perdite che si fanno nelle file e gli errori che commettono i nostri superiori… Nella mia compagnia eravamo 250 uomini. Dopo essere stato rinforzata 6 o 7 volte di venti, trenta, quaranta e fino cento per compagnia, il giorno 6 luglio eravamo rimasti appena ottanta persone, e dei venti partiti da Pistoia, nel mio plotone che erano tempo fa 65 soldati, oggi compresi i caporali e caporalmaggiore siamo rimasti in quattordici. Dunque immaginati che è successo in questi giorni – sono stato due giorni in aspra lotta, ove avemmo decimato il secondo battaglione del mio reggimento… Ma la guerra è ancora lunga e si deve concludere la pace sul nostro fronte e quello Russo, allora certo che la pace non verrà mai e si deve venire ancora a lungo tanto da non sospirare e se non si muore oggi si muore domani, perché cara mia scamparla in questa, scamparla in questa altra e dagli un mese e dagli due, dagli cinque dagli dieci e dagli dodici e quattordici, poi un giorno bisogna cadere e non si puote sfuggire, perché la storia e troppo lunga e mi è venuta a noia, io non sento più nulla e qualche giorno vado nel carcere e finisco di tribolare e di far guerra … Non credevo mai che questa guerra volesse essere così lunga e così sanguinosa e neanche disgraziata. Così se non era questa maledetta guerra, avevo quasi terminato il mio servizio … ». E’ appena il caso di far notare che né i nostri politici né i capi militari si posero mai il problema di convincere i soldati della necessità della guerra, illustrandone le ragioni e le finalità; si preferì invece avere, anziché dei collaboratori coscienti, degli uomini che non capivano il perché di tutte quelle sofferenze, asserviti come schiavi e trattati come le bestie. Il libro è estremamente interessante, anche perché affronta un tema non frequentemente trattato, e pertanto la lettura è senz’altro consigliata. Enzo Forcella (1921-1999), noto giornalista e scrittore, è stato redattore del «Mondo», corrispondente romano della «Stampa», editorialista del «Giorno» e della «Repubblica». È stato presidente dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza. Autore di numerosi programmi televisivi, ha pubblicato, tra l'altro, Millecinquecento lettori (1959), Celebrazione di un trentennio (premio Bagutta 1974), Un altro dopoguerra (1976).
Alberto Monticone
ha insegnato Storia moderna presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università La Sapienza di Roma. È autore, tra l'altro, del volume Fascismo
al microfono. 1924-1945 (Roma 1975) e curatore dell'antologia La storia
dei poveri (Roma 1978).
28 Settembre
I ragazzi del ‘44 di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Narrativa
Giocare alla guerra Arrigo Petacco, scomparso lo scorso anno, è senz’altro conosciuto come autore di saggi storici e di biografie; è quindi una vera è propria chicca scoprirlo narratore, se pur occasionalmente, e con una trama che si ricollega direttamente alla storia, nel caso specifico alla resistenza in Lunigiana dal 1944 fino alla Liberazione. La trama è senz’altro frutto di fantasia, ma l’ambientazione e l’atmosfera furono all’epoca con ogni probabilità quelle proposte da Petacco con una narrazione che racconta delle vicende di tre ragazzi, ma soprattutto di uno, un io narrante che è tuttavia poco probabile che possa coincidere con l’autore. Per chi ancora porta i calzoncini corti l’esperienza della guerra rappresenta una sorta di gioco solo momentaneamente interrotto da vicende dolorose, quali possono essere la distruzione della propria casa o l’uccisione di un amico e perfino di un nemico. Questi soldati in erba si muovono non sorretti da ideologie, ma dall’entusiasmo di partecipare a un qualcosa che fanno solo i grandi, quasi una naturale continuazione dei giochi di guerra da bambino, con l’unica differenza che qui si usano fucili e proiettili veri e non si fa finta di morire. E’ indubbio che l’autore nutra una particolare simpatia per gli uomini della resistenza, ma nei confronti degli altri, cioè i tedeschi e i fascisti, non c’è odio, perché sono pedine indispensabili per poter concretizzare il gioco della guerra. Le prime imprese sono picaresche, ma poi piano piano emerge tutta la realtà di un conflitto sanguinoso, di una guerra civile in cui gli amici di un tempo diventano nemici. Così il protagonista matura, apprende dalla dura realtà di ogni giorno quello che un padre non gli ha mai insegnato, in quanto assente per non cadere, lui antifascista politicizzato, nelle mani dei nemici. Ci saranno anche serate di gioiosa amicizia, il protagonista avrà modo di conoscere più volte i rapporti sessuali, proverà anche a cercare di arruolarsi con gli americani e finirà con l’assistere ai festeggiamenti della liberazione con le prime vittime delle ritorsioni che sono sempre presenti in una guerra civile, anche quando questa è da poco finita. La scrittura di Petacco è snella, tanto che le 210 pagine si leggono in un amen; forse avrebbe dovuto più approfondire l’analisi psicologica dei personaggi, ma credo che ne avrebbe risentito l’interesse del lettore per l’opera. Dalla penna di Petacco è così uscito un romanzo che non è certamente un capolavoro, ma è ben scritto ed è capace di avvincere dalla prima all’ultima pagina.
Arrigo Petacco
(Castelnuovo Magra 1929 - Porto Venere 2018), è stato un giornalista e inviato
speciale, direttore della «Nazione» e di «Storia illustrata». Scrittore e
saggista molto prolifico, ha sceneggiato numerosi film e scritto diverse
trasmissioni televisive a tema storico per la Rai. Nel suo lavoro di
giornalista, per il quale nel 1983 ha vinto il Premio Saint Vincent, ha avuto
modo di intervistare alcuni tra i protagonisti della Seconda guerra mondiale.
Tra i suoi libri, in cui affronta tematiche storiche spesso intrise di mistero
e ribalta verità giudicate incontestabili, ricordiamo Joe
Petrosino (1978,
da cui è stato tratto uno sceneggiato Rai), Dear
Benito, caro Winston. Verità e misteri del carteggio Churchill-Mussolini (1985),
La nostra guerra. 1940-1945 (1997),
Regina. La vita e i segreti di Maria Josè di Savoia (1998),
L'esodo. La tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia (1975 e 2000),
L'armata nel deserto. Il segreto di El Alamein (2002),
Il prefetto di ferro. L'uomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia (1977 e 2004, da cui è stato tratto un film),
L'uomo della provvidenza. Mussolini, ascesa e caduta di un mito (2006),
La strana guerra. 1939-1940: quando Hitler e Stalin erano alleati e Mussolini
stava a guardare (2008),
Il regno del Nord. 1859: il sogno di Cavour infranto da Garibaldi (2009),
La principessa del Nord: la
misteriosa vita della dama del Risorgimento: Cristina di Belgioioso (1993 e 2009), L'ultima
crociata. Quando gli Ottomani arrivarono alle porte dell'Europa (2009), Quelli
che dissero no. 8 settembre 1943: la scelta degli italiani nei campi di
prigionia inglesi e americani (2011), Eva
e Claretta. Le amanti del diavolo (2012), A
Mosca, solo andata. La tragica avventura dei comunisti italiani in Russia (2013), La
storia ci ha mentito. Dai misteri della borsa scomparsa di Mussolini alle
«armi segrete» di Hitler, le grandi menzogne del Novecento (2014) e Nazisti
in fuga. Intrighi spionistici, tesori nascosti, vendette e tradimenti
all'ombra dell'Olocausto (2014),
tutti editi da Mondadori. Con UTET nel 2019 puibblica L'archivio
segreto di Mussolini. Inoltre, ha scritto i monumentali volumi de La
seconda Guerra Mondiale (1979), Storia
del Fascismo (1982)
e Storia
d'Italia dall'Unità ad oggi (1987) per Curcio. Nel 1986 gli è stata conferita
l'onorificenza di Commendatore, su proposta dell'allora Presidenza del
Consiglio.
24 Settembre
Diario sentimentale di Vasco Pratolini Edizioni BUR Biblioteca Universale Rizzoli Narrativa raccolta di racconti
Intensa umanità Ogni volta che inizio a leggere un libro di Pratolini avverto, già dalle prime righe, un fremito che, dapprima quasi impercettibile, poco a poco satura il mio animo. Anche questi racconti, che riflettono in buona parte la vita dell’autore, sono un concentrato di grande umanità: un’infanzia segnata dal dolore per la perdita della madre, un’adolescenza in cui si combatte per sopravvivere e infine l’età adulta, caratterizzata dagli amori, ma anche dai dolori per la perdita di chi si ama, e inoltre la malattia occasione per altri dispiaceri, nonostante la guarigione. Senza trascendere, senza mai giungere a degli eccessi Vasco Pratolini ha l’incredibile capacità di trasmettere al lettore l’immagine dei suoi sentimenti, racconto dopo racconto, alcuni brevi, altri più lunghi, ma tutti di grandissimo interesse. Che si parli del padre che tornato dalla guerra e rimasto vedovo si risposa per un rapporto non dei più felici, che si narri delle esperienze da scugnizzo o che si dica dei nonni, le uniche relazioni familiari solide fino a quando sono rimasti in vita, la scrittura di Pratolini è intrisa di un lirismo che fa pensare a ispirazioni poetiche trasformate in prosa, un risultato di eccezionale bellezza, con una capacità affabulatoria che non fa mai cadere il ritmo del racconto, che accompagna il lettore al mondo dell’autore, un mondo così lontano dal nostro in cui pur tuttavia ci si immerge volentieri, perché accanto a povertà e miserie umane ci sono dei sentimenti forti, quali l’amicizia e anche l’amore, quest’ultimo travolgente, intenso nel desiderio quanto aleatorio nel risultato. Sì, per quanto possa sembrar strano, anche Pratolini non viene meno a certe caratteristiche del romanticismo, pur inquadrate in un neorealismo che sembra stridere con emozioni e sensazioni, ma che è il palcoscenico ideale per poter intonare un grande canto di umanità. Non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro, perché il bello, quando è veramente tale, si commenta da solo.
Vasco Pratolini
(Firenze,
19 ottobre 1913 – Roma, 12 gennaio 1991). Di
famiglia operaia, è costretto a interrompere gli studi e svolge mestieri
diversi per potersi mantenere.
Pratolini comincia a collaborare al periodico «Il Bargello» e diviene
redattore con Alfonso Gatto, nel 1938, della rivista «Campo di Marte». Nel
1951 si trasferisce a Roma, città nella quale vivrà da allora in poi.
Il registro adottato, sin da quelle prime prove, si pone a mezza via fra il
realistico e il lirico. Pratolini svolge con successo, in questi anni, anche un'attività di sceneggiatore e soggettista cinematografico, e intraprenderà in seguito una carriera di autore di testi teatrali ("La domenica della povera gente", 1952; "Lungo viaggio di Natale", 1954).
Nel 1955 pubblica Metello (premio Viareggio), primo romanzo di quella che
diverrà la trilogia "Una storia italiana", essendo completata da "Lo scialo"
(1960) e da "Allegoria e derisione" (1966).
Alla città e al mondo dell’adolescenza sono dedicati ancora un romanzo, "La
costanza della ragione" (1963), e le poesie raccolte in "La mia città ha
trent’anni" (1967). Alcune «cronache in versi e in prosa», scritte dal 1930 al
1980, sono riunite nel volume "Il mannello di Natascia" (1984, premio
Viareggio).
10 Settembre
Non è tempo di morire di Leonardo Gori TEA Editore Narrativa romanzo
Arcieri non ha pace nemmeno in pensione Povero colonnello Bruno Arcieri, il suo creatore, Leonardo Gori, non ha nessuna pietà per lui, lo colloca a riposo e lo fa lavorare ancora di più di quando era in servizio. C’è da dire, a difesa del narratore, che questo ex agente dei servizi segreti non è capace di star fermo, va a trovarsi ogni possibile rogna e, quando questo non accade, i suoi numerosi amici provvedono alla bisogna, come in questo caso, in cui una giovane ragazza, Nicoletta Arnai, è più che mai convinta che il padre non sia fra le vittime del famoso attentato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano. Certo, il corpo non si trova, ma tutto lascia presagire che si sia volatilizzato nell’esplosione. Arcieri indaga e, come se non bastasse, deve anche rimediare ai reati commessi dalla cuoca del ristorante che si è messo a condurre. Quando ho letto dell’attentato che inaugurò lo stragismo in Italia ho avvertito un brivido, quasi un timore per Gori perché, nel caso avesse trovato nuovi indizi, la sua vita sarebbe stata certamente in pericolo. Per fortuna del narratore non è stato così, perché l’idea di avere reperito nuovi elementi per l’individuazioni dei veri colpevoli si ferma lì e quindi non ci sono rivelazioni, diciamo che è servita solo per arricchire la a trama di ulteriore suspense, anche se, a mio avviso, ha provocato una dispersione dell’attenzione del lettore, ovviamente incuriosito dai presunti sensazionali sviluppi. Di questo soffre un po’ la vicenda dello scomparso nell’attentato, che già da sola avrebbe costituito materiale di notevole interesse. Il romanzo, comunque, procede spedito con la narrazione tipica di Gori, senza tanti fronzoli e che bada al sodo, accentuando il ritmo nel finale, dove i colpi di scena abbondano, a tutto vantaggio di chi legge che non potrà non apprezzare la soluzione del caso, perfettamente logica, anche se imprevedibile. Non è tempo di morire è quindi un libro che si legge con vero piacere e che mi ha riavvicinato all’autore dopo la prova, secondo me poco convincente, di Il ritorno del colonnello Arcieri.
Leonardo Gori
è uno scrittore italiano, autore del ciclo di romanzi di Bruno Arcieri,
capitano dei Carabinieri nell’Italia degli anni Trenta. Il primo romanzo, Nero
di maggio, si svolge nella Firenze nel 1938; seguono Il
passaggio, La finale, L’angelo
del fango (Premio Scerbanenco 2005), Musica nera, Lo
specchio nero e Il fiore d’oro, gli ultimi
due scritti con Franco Cardini. La serie di romanzi è in corso di riedizione
in TEA. Ha scritto anche thriller storici ed è stato co-autore di saggi sul
fumetto e forme espressive correlate (illustrazione, cinema, disegno animato).
4 Settembre
Gente di trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull’Isonzo di Lucio Fabi Ugo Mursia Editore Storia
Come si viveva, come si moriva Più o meno tutti, sia per aver visto filmati d’epoca, sia per aver letto romanzi come Niente di nuovo sul fronte occidentale e Un anno sull’altipiano, abbiamo un’idea di cosa sia stata la Grande guerra, di quanto misere e terribili fossero le condizioni dei soldati in trincea, di come la morte fosse compagna fedele di chi combatteva, in ogni momento, sia per il concreto pericolo di essere uccisi dal proiettile di un cecchino o dall’esplosione di una bomba, sia per la visione continua dei numerosi corpi insepolti e in putrefazione. Abbiamo provato un senso di pietà, anche un certo ribrezzo nel leggere di certi fatti, ma mai e poi mai avremmo potuto sapere come era la vita, e anche la morte, sui campi di battaglia, sia per i militari che per i civili, se non ci fosse stato questo libro di Lucio Fabi; così possiamo sapere come vestivano i soldati, come erano addestrati, cosa mangiavano, come potevano soddisfare le più semplici esigenze corporali, come e dove riposavano, come avvenivano gli avvicendamenti e i turni di riposo, il trattamento ai civili dagli occupanti, i rapporti con i familiari a casa, insomma, e non voglio dilungarmi, tutto e anche di più di quello che si desidererebbe conoscere. Si tratta di un’opera che per completezza non ha eguali, quattrocentodieci pagine fitte fitte che riescono a dare concretamente l’immagine di chi, in divisa o in abiti borghesi, fu coinvolto in quel grande conflitto, e non si parla solo di italiani, ma anche di austriaci. Il fatto che riguardi gli opposti contendenti è tanto più importante perché veniamo a conoscenza di comportamenti simili, di una vita estremamente disagiata che ha accomunato i nostri e i nemici, uguali perfino nel trattamento riservato alle popolazioni occupate, sospettoso, inquisitore, non di rado, purtroppo, anche feroce. Questo dimostra che indipendentemente dalla nazionalità e dalla divisa il comportamento degli esseri umani, pur nell’eccezionalità di un conflitto, è sostanzialmente analogo. Entrambi combattono più per paura di essere uccisi che per convinzione, sono capaci di di gesti di umana pietà come di incredibili nefandezze, sono carnefici e vittime di una rigorosa e fredda disciplina senza la quale probabilmente getterebbero le armi alle ortiche. Non è un libro facile da leggere, anche perché a volte può sembrare un po’ tedioso per effetto delle minuziose descrizioni, ma arrivati alla fine si comprende senz’altro che cosa sia stata veramente la Grande guerra, una mattanza che ha accomunato nelle sofferenze e nell’orrore entrambi gli schieramenti. Fabi non giudica, racconta senza enfasi e senza mai cadere nella retorica, è uno storico serio che non fa altro che raccogliere i dati delle fonti e confezionare un testo che credo possa essere preso a esempio per completezza e serietà, una di quelle rare opere dove ciò che conta sono i fatti, nella loro crudezza, nella loro asettica descrizione, senza personali e rischiose interpretazioni. Da leggere, quindi.
Lucio Fabi,
nato a Trieste nel 1954, collaboratore di riviste storiche e istituzioni
culturali, da tempo dedica le sue ricerche alla Prima guerra mondiale dal
punto di vista dell’esperienza collettiva, della memoria e dell’escursionismo
storico-turistico, collaborando fra l’altro all’allestimento di vari musei e
mostre sulla Grande Guerra.
31 Agosto
I Gonzaga. Il mito, la storia di Riccardo Braglia Edizioni Il Rio Storia
Storia di una grande dinastia Che i Gonzaga siano stati una dinastia fra le maggiori in Europa in un arco di tempo di circa quattro secoli è fuor di dubbio e il fatto che il loro piccolo staterello riuscisse non solo a restare indipendente, ma anche che rappresentasse un polo di attrazione per tutte le arti ha finito con il creare una sorta di alone mitico intorno a questa famiglia. Ora il mito è una cosa e la storia è un’altra e deve aver tenuto ben presente questa differenza Riccardo Braglia quando ha scritto questo pregevole saggio. Il suo lavoro è apparso quindi quanto mai necessario per contestare leggende, luoghi comuni e dicerie intorno ai personaggi di questa Signoria, perché in realtà i Gonzaga furono dei principi per nulla diversi da quelli della loro epoca, quindi con gli stessi difetti e gli stessi pregi, però con una sostanziale differenza: vuoi per una naturale inclinazione, vuoi per un sottile calcolo politico avevano compreso che, più che con le armi, avrebbero potuto acquisire prestigio e con esso anche rispettabilità e caratura nobiliare grazie alle arti, nessuna esclusa, ma con evidente prevalenza di quelle figurative, perché ciò che si vede costituisce immediata sensazione. Il saggio, però, presenta anche altre qualità, fra le quali, in primis, un’impostazione snella che consente di vedere l’ascesa dei Corradi da Gonzaga dagli inizi, da quando erano agricoltori che coltivavano grandi estensioni di terreno, a quando si affacciarono nella vita comunale di Mantova, e da lì avviarono la loro scalata al potere, fino al momento in cui il bel sogno che avevano costruito si infranse, con la scomparsa della dinastia. Così, capostipite per capostipite, Braglia fa un ritratto dei personaggi, della corte, degli eventi, ricorrendo talvolta anche a una gradevole ironia. Dal 1328, anno in cui il 16 agosto Luigi Corradi, con l’aiuto di Cangrande della Scala, spodestò il capitano del popolo Rinaldo Bonacolsi, detto il Passerino, fino al 21 gennaio 1707 quando l’ultimo Duca di Mantova lasciò la città, dopo che già il 20 maggio 1701 l’imperatore Leopoldo I aveva sciolto i mantovani dal giuramento di fedeltà al loro Signore, si dipana la storia di questa grande Casata. E’ stato un periodo lungo quello dei Signori di Mantova, anzi direi molto lungo considerata la dimensione del piccolo stato da essi governato e come in tutte le dinastie si può riscontrare una parabola, con un’ascesa che nel caso specifico stupisce, con figure di assoluto rilievo in Europa, una su tutte Isabella d’Este, e che raggiunge il suo vertice con Vincenzo I (n. 1562 – m. 1612), quarto duca di Mantova e secondo del Monferrato, un principe bello, gioviale, simpatico, purtroppo dalle mani bucate e che finì per indebitare in modo irrimediabile il suo piccolo regno. Con la sua morte la dinastia iniziò la fase calante, che si accentuò in modo drammatico sotto Vincenzo II (n. 1594 – m. 1627) che, non avendo eredi maschi, in punto di morte fece sposare la nipote Maria con il figlio del Duca di Nevers, che così diventò l’ottavo duca di Mantova con il nome di Carlo I. Fu questa la causa della sanguinosa guerra di successione scoppiata appunto nel 1627 e conclusa con l’immane tragedia del sacco di Mantova del 18 luglio 1630, che vide la città e i suoi ormai pochi abitanti, in quanto decimati dalla peste, alla mercé dei feroci lanzichenecchi. La città non si risollevò più e i Nevers si dimostrarono non solo degli incapaci, ma anche dei felloni, autori di gesti inqualificabili che li fece diventare gli zimbelli delle corti europee. Un altro merito di Braglia è di non aver trascurato i rami secondari dei Gonzaga, signori di minuscoli staterelli del tutto indipendenti, quali Guastalla, Castiglione delle Stiviere, Sabbioneta. A essi infatti è dedicato un apposito capitolo, in cui è possibile conoscere maggiormente realtà non di rado trascurate, perché messe in ombra dal rilievo della Signoria di città. Per concludere sono dell’idea che l’autore abbia realizzato un saggio di grande valore che ha anche il pregio di essere facilmente e piacevolmente leggibile, opera che è consigliata senz’altro non solo a chi vuole approfondire la conoscenza della dinastia dei Gonzaga, ma anche ai profani, a chi per la prima volta voglia avere notizie storiche su chi furono questi principi capaci di fare di Mantova uno stato prestigioso, lasciando bellezze artistiche che fanno della città, giustamente, un patrimonio dell’umanità.
Riccardo Braglia,
mantovano, è storico dell’arte, conferenziere, scrittore e giornalista, nonché
consulente di varie reti televisive. Per molti anni ha inoltre ricoperto
l’incarico di Ispettore Onorario della Soprintendenza per i Beni Storici e
Artistici di Mantova. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, oltre che
curatele di mostre e di eventi culturali di valenza nazionale ed
internazionale. Per i tipi de Il Rio ha pubblicato La grotta delle meraviglie.
Il collezionismo di Isabella d’EsteGonzaga (2014) e ha curato il catalogo
della rassegna Burgio. Opere 1959-2016 (Reggio Emilia, 2016)
26 Agosto
I ragazzi del ciliegio 1918 - 1945 di Fiorella Borin Edizioni Solfanelli Narrativa romanzo
Un’incrollabile amicizia In un periodo storico come l’attuale in cui gli uomini sembrano usciti di senno, sbraitano, cercano di soverchiarsi, rispolverano antiche ideologie come il fascismo e il nazismo per alimentare quello che sembra l’unico scopo di una vita priva di valori, vale a dire l’odio, pescare nel mare delle pubblicazioni che caratterizzano l’editoria un libro che riproponga un elevato senso di umanità, che sappia parlare al cuore e alla mente in modo semplice, ma convincente, è sempre più un’impresa. Perle rare potrebbero essere definiti questi testi che non hanno forse ambizioni di larga diffusione, ma che sono pur tuttavia di grande e ineccepibile pregio. Prima ho avuto la fortuna di leggere Dal fondo, di Franca Canapini, un’autobiografia dei primi dieci anni di vita dell’autore, ma anche lo spaccato di un paese che cercava di risollevarsi dalle rovine della guerra, che sperava e credeva in un futuro migliore, poi, più di recente, Fiorella Borin, narratrice assai nota per i suoi romanzi storici, mi ha fatto avere I ragazzi del ciliegio, un volume corposo da leggere con attenzione e che riserva più di un motivo di autentica commozione. L’opera, in gran parte basata su carteggi e diari del padre dell’autrice scritti fra il 1942 e il 1945 in Russia e a Roma, è la storia di alcuni ragazzi che amano trascorrere i giorni tristi della Grande guerra all’ombra di un ciliegio ed è uno spaccato della vita in Italia dalla fine di quel conflitto fino ai mesi immediatamente successivi all’aprile 1945, con l’eccezione di un capitolo riportante nel settembre 2014 la scoperta dell’autore di una lettera del lontano 20 dicembre 1963 che accompagna i precitati carteggi e diari, ma che è anche un’illuminante riflessione sull’inutile crudeltà della guerra. Si tratta certamente di un romanzo storico, ma è anche una preziosa fonte storica per capire con immediatezza cosa sia stato il fascismo, come sia potuta accadere la disfatta dell’Armata italiana in Russia e le opposte ragioni di chi ha scelto di stare da una parte piuttosto che dall’altra dopo l’8 settembre 1943. In quelle pagine non c’è spazio per roboanti eroi, c’è solo un dolore intimo che toglie il respiro, che non solo fa temere la morte, ma che rende impossibile la vita. Eppure, per quanto di idee diverse, fra i ragazzi continua l’amicizia, una solidarietà che si spezzerà solo con le tragedie della guerra, con la morte che colpirà alcuni di loro. Sarebbe difficile fare un riassunto dell’opera, tanto è intensa, ma in ogni caso non è mia abitudine fornire troppe anticipazioni, così influenzando magari negativamente il lettore; è per questo motivo che intendo solo sottolineare la commozione che non poche pagine vibranti provocano nel lettore, anche perché, se uno si ferma un momento a pensare, si rende conto che non sono invenzioni, che quella gente che tanto ha sofferto e che in parte è anche morta è esistita veramente. Il rischio di scivolare in un romanzo strappalacrime c’era, ma Fiorella Borin ha saputo raccontare episodi tristissimi con uno sguardo di pietà che sazia il cuore di chi legge e che alla fine magari non può trattenere qualche lacrima, ma che è consapevole che è appena stato il destinatario di un grande messaggio di umanità, in cui non c’è spazio per guerre e violenze, ma dove il sentimento dell’amicizia raggiunge il suo punto più alto in una forma di amore sublime che da solo può cancellare le brutture del mondo. Da leggere e rileggere, lo merita ampiamente.
Fiorella Borin,
nata a Venezia nel 1955, laureata in psicologia, per
un breve periodo ha insegnato storia e filosofia negli istituti superiori. Nei
primi anni ‘90 ha iniziato a proporsi come narratrice, vincendo prestigiosi
premi letterari e pubblicando più di trecento novelle e alcuni romanzi storici
ambientati nel XVI secolo. Ha collaborato con numerose riviste letterarie e
con periodici a diffusione nazionale. Per onorare la memoria del padre, reduce
dalla Russia, ha scritto molti racconti sulla seconda guerra mondiale, alcuni
dei quali sono confluiti in questo romanzo.
21 Agosto
Il violino di Dio di Salvo Zappulla Scritturapura Editrice Narrativa romanzo Collana 'Scritturapura.it
Nessuno, nemmeno Lui, è perfetto Le ipotesi su come potrebbe essere il cosiddetto “dopo”, cioè l’esistenza eterna post-mortem è stata oggetto di numerose opere, anche cinematografiche (famoso è il film Il paradiso può attendere uscito nelle sale nel 1978 per la regia di Buck Henry e Warren Beatty, quest’ultimo anche protagonista, omaggiato di premi Oscar e di riconoscimenti Saturn Awards). Raramente si tratta di lavori drammatici, anzi, probabilmente per esorcizzare quel gran passo, sovente sono intrisi di umorismo, mai spiccio o triviale, anzi più incline a una moderata e quasi sempre raffinata vis comica. Non fa eccezione a questa impostazione l’ultimo romanzo di Salvo Zappulla, a cui non manca certo l’ironia, sovente accompagnata dalla satira, e che ho già avuto occasione di apprezzare con I ladri di sogni, Kafka e il mistero del processo e ancor più in Viaggio con Dante all’inferno. Nell’autore siciliano, a cui non fa difetto di certo la creatività, vi è tuttavia uno scopo comune nella realizzazione della sua produzione, vale a dire dissacrare, beninteso non con l’intento di porre in cattiva luce consuetudini, credenze e comunque aspetti sociali, bensì per indicare ciò che sembra stonato, fuori luogo, o comunque estraneo alla logica. Peraltro, il suo non è un atteggiamento puramente distruttivo, anzi il porre in risalto le storture ha come scopo quello di porvi rimedio. Nella vicenda del ragionier Morelli che, appena diventato ragioniere capo del Comune di Milano, viene improvvisamente a mancare prima del tempo per un banale errore del computer celeste si innestano situazioni concrete e reali, quali il dolore dei parenti, le visite di condoglianza, tutte viste dal morto, che è in un limbo in base al quale, non essendosi l’anima ancora staccata dal corpo, questo è a tutti gli effetti privo di vita, come se però fosse stato ibernato. Tutte le opere di Zappulla, e anche questa, hanno la parvenza di una favola, non per bimbi, ma per adulti, anche se una loro esatta collocazione le vedrebbe rientrare nella categoria assai variegata del fantasy. Favole, o meglio quasi favole dunque, perché l’autore resta ben ancorato alla terra con un angelo custode che invece vorrebbe diventare mortale, ma soprattutto disporre di quegli attributi fisici indispensabili per amare una bella ragazza di cui si è invaghito. Del resto la vicenda del ragionier Morelli, morto, ma non morto, rappresenta il pretesto per ironizzare sui tanti vizi e le poche virtù degli uomini; al riguardo, basti pensare al riccone, che in fila per entrare in paradiso, cerca di corrompere San Pietro per varcare il cancello, o ai dialoghi fra lo stesso ragionier Morelli e il suo angelo custode, venati da un sottile e gradevole sarcasmo, senza mai cadere nel blasfemo. Non intendo dilungarmi troppo perché correrei il rischio di anticipare situazioni che dovrebbero risultare di particolare gradimento, con delle battute che strappano più di un sorriso, anzi anche delle risate. A proposito, faceva ridere anche Charlot, ma faceva anche piangere con la sua umanità contrapposta alle ferree logiche della società, e non è da meno Zappulla; senza far scendere lacrime fa sì che il nostro sorriso o la nostra risata siano accompagnati da una vena di amarezza per la vita di ogni giorno, asettica, pregna di indifferenza, in pratica disumana. Del resto il mondo che ci viene mostrato è un’estremizzazione dell’attuale, ma non campata in aria, perché andando avanti di questo passo, con lo sfruttamento insensato delle ricchezze del pianeta e con l’inquinamento crescente che tanto contribuisce a creare fenomeni climatici disastrosi ormai non manca molto che arriviamo a mettere fine alla nostra specie. Tuttavia, un po’ per sua natura, un po’ perché auspica che l’essere umano possa finalmente correggersi, l’autore chiude il romanzo con una speranza, a cui mi appiglio pure io, sebbene consapevole che il domani non potrà che essere peggiore di oggi. In ogni caso il mio consiglio è di lasciarvi permeare dalla vicenda narrata, che potrebbe benissimo essere la base per la sceneggiatura di un film che solo per evitare omonimie non intitolerei Il paradiso può attendere, ma considerata la trama e l’imperfezione di ciò che dovrebbe essere perfetto, vedrei bene come Nessuno, nemmeno Lui, è perfetto. Da leggere, senza dubbio.
Salvo
Zappulla è
nato il primo marzo 1961 a Sortino (SR) dove vive.
Attualmente è tra i redattori di "Notabilis”.
3 Agosto
La notte delle stelle cadenti di Ben Pastor Sellerio Editore Palermo
Narrativa
romanzo giallo-storico Il crepuscolo del Terzo Reich Le avventure di Martin von Bora, ufficiale della Wermacht, nonché agente dell’Abwehr, seguono il corso della seconda guerra mondiale, che volge al termine e con la fine della stessa è logico presumere anche il termine degli episodi, di cui questo, intitolato La notte delle stelle cadenti, è con ogni probabilità l’ultimo. Richiamato a Berlino dal fronte italiano, dove sta combattendo il suo reggimento, per le esequie solenni dello zio, eminente pediatra, quasi sempre in rotta con il regime, soprattutto per la sua avversione alla politica di eliminazione dei nati con grave disabilità, tanto che si ha ragione di credere che la morte del parente a mezzo suicidio sia stata indotta, Von Bora si vede affidato, direttamente di Arthur Nebe, il potente capo della polizia criminale, il caso dell’omicidio di Walter Niemyer, notissimo veggente e illusionista. Non ha molto tempo per individuare il colpevole, solo una settimana, e peraltro si deve avvalere della non gradita collaborazione del vice ispettore della Kripo (polizia criminale) Florian Grimm. Benchè quasi da subito i sospetti si appuntino su un colpevole di comodo, che confesserà fra l’altro, il nostro bravo investigatore si accorgerà che l’indagine è tutt’altro che risolta ed è particolarmente complessa, perché dietro i personaggi interessati a quella scomparsa violenta ci sono dei congiurati, in primis il colonnello Claus von Stauffenberg, che stanno complottando per rovesciare il regime, previa uccisione dello stesso Adolf Hitler. Quindi, tutto deve essere perfetto per arrivare al colpo di stato e nessuna notizia o il minimo sospetto debbono trapelare, e poiché il fine giustifica i mezzi...Non vado oltre, perché la trama gialla è particolarmente avvincente e predomina nella narrazione, anche se è sempre presente l’eterna lotta di Bora fra il dovere e la sua coscienza; un elemento che prima appariva invece secondario, cioè l’amore, inteso quasi sempre dal punto di vista materiale, cioè della soddisfazione delle pulsioni sessuali, in questo romanzo diventa un aspetto caratterizzante ed è proprio il lato erotico non accompagnato dall’affetto che fa di von Bora un perdente, nonostante le sue innegabili eccelse qualità. E’ stato già lasciato dalla moglie, gli è andata buca con la moglie dell’ambasciatore americano accreditato in Vaticano, riesce a compiere l’atto sessuale con una giovane ausiliaria in punto di diventare vedova; non riuscirà come sempre a creare un legame solido e duraturo, soverchiato dal dramma del Reich che sta crollando nel fumo degli incendi, mentre l’unica certezza della sua vita, vale a dire l’obbedienza come soldato, sta evaporando, tanto che non è difficile prevedere che una tardiva vittima del fallito attentato a Hitler sarà pure lui, lui che non era dalla parte dei congiurati, ma che sapeva ed è stato zitto per fedeltà all’esercito. Il libro è molto bello, appassiona, evidenzia ancora una volta le doti di questa narratrice che si attiene strettamente a ciò che accadde, finendo così con il regalare al lettore un ennesimo riuscito romanzo storico.
Ben Pastor,
nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha scritto
narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico.
Della serie di Martin Bora Sellerio ha già pubblicato Il
Signore delle cento ossa (2011), Lumen (2012), Il
cielo di stagno (2013), Luna bugiarda (2013), La
strada per Itaca (2014), Kaputt Mundi(2015), I
piccoli fuochi (2016), Il morto in piazza (2017)
e La notte delle stelle cadenti (2018).
29 Luglio
Maigret e l’affittacamere di Georges Simenon Edizioni Adelphi Narrativa romanzo giallo Collana Gli Adelphi. Le inchieste di Maigret
Una simpatica ragazzona Era da un po’ che non leggevo un giallo di Simenon con protagonista Maigret, così quando ho potuto mettere le mani su Maigret e l’affittacamere non mi sono tirato indietro, anzi mi sono detto che era la lettura ideale per il mio primo giorno alle terme, sdraiato comodamente sul lettino, all’ombra degli alti fusti del parco e nel silenzio di un luogo in cui normalmente prevale la natura. E’ stato così e non mi sono pentito della scelta, perché se la suspence non è certamente di quelle che tengono con il fiato sospeso, tuttavia per situazioni, trama e personaggi mi sono trovato di fronte a un’opera godibilissima. Già il pensare che, per indagare sul tentativo di omicidio dell’ispettore Janvier, Maigret, orfano della moglie accorsa ad assistere la sorella in Alsazia, si adatta a soggiornare in una stanza di una affittacamere, una sorta di ragazzona stagionata e bene in carne, peraltro assai simpatica, muove subito a un inizio di sorriso, più evidente poi quando la familiarità fra i due ingombranti personaggi presenta delle velate allusioni sessuali, in una sorta di tenzone che lascia ampio spazio a ogni personale fantasia. Non è che l’aspetto investigativo sia trascurabile o moscio, ma forse più che in altri casi è secondario, preferendo Simenon insistere sulla descrizione degli attori principali e secondari, ricreando come sa solo fare lui delle atmosfere del tutto particolari. Poi, alla soluzione il commissario arriva quasi all’improvviso, con una di quelle sue intuizioni che lo differenziano da tutti gli altri investigatori; tuttavia, non c’è compiacimento nell’aver risolto il caso, anzi c’è una nota di pietà nei confronti di chi direttamente e indirettamente si è macchiato di un crimine. Questa umanità di Maigret, che ho già avuto modo di trovare in altri episodi, chiude il libro, lasciando un sapore amaro e portando a riflettere sul fatto che il delitto in genere non paga mai e se uno non è proprio un delinquente incallito finisce con l’essere pervaso da un rimorso che la confessione riesce solo in parte a lenire. Da leggere, quindi, senza dubbio.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e racconti
pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e memorie. Il
commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in tutto il
mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è anche, paradossalmente,
un caso di «scrittore per scrittori». Da Henry Miller a
Jean Pauhlan, da Faulkner a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André Gide:
«Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più autentico che
la letteratura francese abbia
oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
23 Luglio
I vinti di Vittorio Veneto a cura di Mario Isnenghi e Paolo Pozzato Edizioni Il Mulino Storia
Il dramma degli sconfitti Come è noto (o come dovrebbe esserlo, vista la crescente disaffezione per la storia) la battaglia di Vittorio Veneto, iniziata il 24 ottobre 1918 e terminata con l’armistizio firmato a Villa Giusti il 3 novembre dello stesso anno, segnò per noi italiani la fine della Grande Guerra, dopo più di tre anni di sanguinosi combattimenti. E’ indubbia la gioia che dovettero provare i nostri soldati, anche per la cessazione del sempre incombente pericolo di restare uccisi, ma quale fu il comportamento dei vinti, dei soldati di quel cosmopolita esercito imperial asburgico? E’ questa la domanda da cui è nato questo saggio scritto a quattro mani da Mario Isnenghi e Paolo Pozzato. Il quesito è più che mai necessario perché posto che gli sconfitti abbiano tirato un sospiro di sollievo per aver allontanato così l’incombente pericolo della morte, è altrettanto vero che quei militi battuti, laceri, affamati, si trovarono frastornati per la perdita di quello che era sempre stato, da secoli, il faro della loro esistenza, quell’impero dissoltosi e smembrato ben presto in tanti stati non sempre legati da rapporti amichevoli. Questa impensabile sconfitta si tradusse in una generale sfiducia, tanto più marcata quanto più forte, ed errata, era stata la convinzione di una supposta inferiorità del soldato italiano, quel soldato che, quasi travolto con la dodicesima battaglia dell’Isonzo e con la disfatta di Caporetto, era quasi miracolosamente risorto già nel novembre 1917, per cambiare completamente, in modo positivo, a partire dal mese successivo, tenacemente attaccato alla linea del Piave, capace di respingere il nemico incalzante, per poi vanificare l’attacco austriaco nella battaglia del solstizio, arrivando a contrattaccare e ora addirittura travolgente nell’ultima e definitiva battaglia. Onestà vuole che si riferisca che dopo il cruento scontro del giugno 1918 le cose erano molto cambiate in campo nemico, era subentrata una rassegnazione che in non pochi casi si era sviluppata in una crescente tensione che aveva portato diversi reparti, all’inizio soprattutto ungheresi, a disertare in massa, a lasciare il campo per tornare nei luoghi d’origine. Quell’impero, che dal di fuori pareva monolitico, si frantumò come se fosse d’argilla e le tante nazionalità che lo componevano e che da anni reclamavano un’autonomia sempre negata, ora rialzavano la testa e cercavano di ottenere non diplomaticamente o politicamente, ma con l’azione quello che era da troppo nelle loro mire. I vinti di Vittorio Veneto è un libro che è fatto di testimonianze, secondo un preciso criterio cronologico nell’ordine dell’evolversi degli eventi; abbiamo così degli scritti di parte avversa che ben riescono a spiegare cosa accadde veramente e anche il perché; sono affrontati quattro periodi temporali in cui è diviso anche il volume: dall’illusione di vincere alla fine, la battaglia di Vittorio Veneto, il crollo, cattura e prigionia. Emergono così dei temi meritevoli di ulteriori approfondimenti: l’incapacità di accettare come evento certo la sconfitta, i dissapori, per non definirli vere e proprie esacerbazioni nei confronti degli ungheresi e degli sloveni, l’illogica convinzione dell’inferiorità del soldato italiano, la fine di un mondo sempre mitizzato, di quell’epoca d’oro dei romantici balli di corte al ritmo dei valzer degli Strauss. In questo senso il libro di Isnenghi e Pozzato assume un’importanza basilare non solo per comprendere i motivi del dissolvimento di un impero millenario, ma anche per rendersi conto che la Grande Guerra fu l’occasione per legare quegli italiani che nell’unità d’Italia vedevano solo un’entità astratta, e non il sogno realizzato di un intero popolo. Da leggere, quindi. Mario Isnenghi, uno dei più autorevoli storici italiani, è professore ordinario all’Università di Venezia, presidente dell’Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della società contemporanea e condirettore di «Belfagor». Ha pubblicato fra l’altro: Il mito della Grande guerra (Il Mulino 1970 e ss.); L’Italia in piazza (Mondadori 1994); I luoghi della memoria (Laterza 1997 e ss.); La tragedia necessaria. Da Caporetto all’8 settembre (Il Mulino 1998), Storia d'Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo (Laterza 2014), Paolo Pozzato (Bassano del Grappa, 1958), docente di storia e filosofia, come storico del primo conflitto mondiale è membro della
16 Luglio
Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini Edizioni BUR Biblioteca Universale Rizzoli Narrativa romanzo
Una stupenda epica popolare Via del Corno, a Firenze, è una strada lunga al più una cinquantina di metri, senza marciapiedi, isolata dal traffico, popolata quasi esclusivamente da un proletariato che spesso non ha nemmeno gli occhi per piangere, ma che è percorso da un desiderio di amore che si trasforma, spesso e volentieri, in infedeltà. In questo rione chiuso nulla sfugge e si può dire che ognuno dei suoi abitanti sappia tutto dell’altro, anche perché qualcuno spesso mette in piazza i fatti suoi, per trovare più che consenso, conforto. Il romanzo è ambientato negli anni in cui il fascismo, salito al potere, getta la sua maschera di aspirante alla democrazia assumendo le vesti tipiche della dittatura, con l’introduzione delle Leggi speciali. In via del Corno si nasce, si cerca di vivere e si muore, ci sono due antifascisti e due fascisti, e questi ultimi faranno valere drammaticamente la legge del più forte. Le pagine in cui il compagno Maciste, insieme a Ugo, corre per Firenze con il suo sidecar per mettere in guardia gli oppositori del fascismo sono di una maestria indiscutibile, perché sono rappresentazione filmica; in un crescendo di tensione la morte di Maciste, colpito da un proiettile sparato da un fascista, commuove e al contempo indigna, perché il personaggio è il classico gigante buono e proprio per questo lotta per un mondo più giusto e migliore. A via del Corno i suoi abitanti hanno tutti una personalità ben precisa e Pratolini li descrive in modo mirabile, sono figure che parola dopo parola vengono a comporsi davanti agli occhi del lettore e sono tutti protagonisti, nel bene e nel male. Non ci sono individui complessi, fatta eccezione per la Signora, l’ex tenutaria di bordelli, invecchiata e ormai fuori dal giro, in possesso di un buon gruzzoletto, disperatamente sola, ma attratta irresistibilmente dalle ragazze giovani; è una fredda calcolatrice a cui piace dominare, tutta intenta, nonostante l’infermità che la costringe quasi sempre a letto, ad architettare piani diabolici con cui rovinare il malcapitato di turno, in un trionfo del male che sembra essere ormai l’unico scopo della sua vita. In via del Corno nascono nuovi amori, altri finiscono, c’è gente sposata che ha l’amante, e questo sembrerebbe l’origine del nome della via, ma le corna non hanno nulla a che fare con il corno. Eppure, tranne i due fascisti e la Signora, i personaggi, a loro modo, finiscono con il diventare simpatici e si riesce perfino a cogliere quel loro senso della vita, che è proprio dei poveri, perché chi manca di tutto o quasi trova conforto solo nell’amore, che può essere delirio dei sensi, ma anche comunione di sentimenti, affetti profondi. Sono figure che restano scolpite nella memoria, senza che tuttavia una fra tutte incida di più, perché in fondo la coralità del romanzo fa sì che volti e figure appaiano e scompaiano, si sovrappongano, si uniscano, e alla fine non è difficile accorgersi che l’autentica protagonista è proprio lei, via del Corno, come l’aveva conosciuta Vasco Pratolini, che non troviamo su quel selciato, che pure a suo tempo ha calcato, ma è il burattinaio che muove i fili dei ricordi, che rinnova l’affetto per chi lì ha condiviso con lui parte della sua vita. L’autore soleva dire che via del Corno, in cui aveva abitato da ragazzo, era la sua Aci Trezza, il suo quadro di un’epica popolare, di un mondo ormai lontano, ma rimasto nel cuore, un mondo in cui, nonostante l’orrore di un regime sanguinario e crudele, circolava ancora un filo di speranza, quella speranza che come una brace sotto la cenere sarebbe tornata ad ardere più avanti nel tempo. Per me è un capolavoro. Vasco Pratolini (Firenze, 19 ottobre 1913 – Roma, 12 gennaio 1991). Di famiglia operaia, è costretto a interrompere gli studi e svolge mestieri diversi per potersi mantenere. Pratolini comincia a collaborare al periodico «Il Bargello» e diviene redattore con Alfonso Gatto, nel 1938, della rivista «Campo di Marte». Nel 1951 si trasferisce a Roma, città nella quale vivrà da allora in poi. Il registro adottato, sin da quelle prime prove, si pone a mezza via fra il realistico e il lirico. Pratolini svolge con successo, in questi anni, anche un'attività di sceneggiatore e soggettista cinematografico, e intraprenderà in seguito una carriera di autore di testi teatrali ("La domenica della povera gente", 1952; "Lungo viaggio di Natale", 1954). Nel 1955 pubblica Metello (premio Viareggio), primo romanzo di quella che diverrà la trilogia "Una storia italiana", essendo completata da "Lo scialo" (1960) e da "Allegoria e derisione" (1966). Alla città e al mondo dell’adolescenza sono dedicati ancora un romanzo, "La costanza della ragione" (1963), e le poesie raccolte in "La mia città ha trent’anni" (1967). Alcune «cronache in versi e in prosa», scritte dal 1930 al 1980, sono riunite nel volume "Il mannello di Natascia" (1984, premio Viareggio).
7 Luglio
Dal fondo. I miei primi dieci anni di Franca Canapini Youcanprint www.youcanprint.it
Come eravamo Non è mia abitudine riportare nelle recensioni che scrivo le eventuali dediche dell’autore che normalmente si trovano nella seconda pagina, ma questa volta faccio un’eccezione che ritengo più che motivata; infatti leggo “Caro Renzo, mi fa piacere donarti questo libro nato per essere regalato a parenti ed amici. Con affetto Franca”. Quanto pudore in queste poche righe! Franca Canapini, poetessa assai valida e conosciuta anche come narratrice, ha quasi un senso di timore nel proporre questo Dal fondo. I miei primi dieci anni, una autobiografia limitata a un periodo di tempo assai breve dove quello che conta non è la storia del soggetto che scrive la sua esistenza da bambina, ma è il narrare di un’epoca passata, di un’Italia che faticosamente viene ricostruita sulle macerie della guerra, con i primi sviluppi industriali che ancora non lasciavano presagire la fine di una millenaria civiltà, quella contadina. E Franca è in grado di parlarne compiutamente non solo per gli studi effettuati e le sue capacità di analisi, ma anche perché abitava in campagna e nella sua crescita da lattante a bambina ha potuto vedere come il mondo rurale subisse una modificazione quale non si era mai vista prima. Ero povera, scrive, povera, ma non misera, perché non le mancava da mangiare, ma il suo mondo, come del resto il mio che analogamente ero povero, imponeva una rinuncia dietro l’altra che i bambini di oggi, abituati ad avere tutto, nemmeno possono immaginare. Eppure, e probabilmente senza enfatizzare il senso di questa congiunzione, eravamo felici per il poco che avevamo. Per Franca Canapini la vita all’aria aperta, i contatti con gli altri bambini, più o meno anch’essi poveri, erano l’occasione per vivacizzare l’esistenza, per dare tutto se stessa in cambio di poco, ma con la soddisfazione di aver dato un senso alla giornata. La gioia derivava da piccole cose, oggi impensabili, come l’acqua corrente in casa, la stufa economica a legna, anziché il focolare, una passeggiata al mercato e perfino al cimitero, per non parlare dell’osservazione attenta della natura, delle ricorrenze capitali nel lavoro dei campi, quali l’aratura, la semina, poi la mietitura e la trebbiatura. Anche la vendemmia aveva una sua importanza, richiama epoche ancor più antiche e quasi sembra di vedere la raccolta dell’uva, il trasporto, la pigiatura con gli occhi di quel grande cantore che è stato Virgilio. C’è proprio tutto un mondo scomparso in questa narrazione di una giovinezza che di certo non tornerà più, come è altrettanto sicuro che quella civiltà di cui erano permeati i popoli, così immobile nei secoli, non la potremo più rivedere, né ci sarà dato il piacere di vedere la mungitura a mano nelle stalle, o di sentire il chiacchiericcio delle lavandaie prone sugli scanni ai lavatoi. Tutto è scomparso, annientato da un boom economico, ma anche da una nuova mentalità, che ha sostituito poco a poco i carri trainati dai buoi con le lambrette, e poi con le Topolino e le 500, per non parlare dell’avvento della televisione, capace anche di far vedere come vere cose che non lo sono e che ha soppiantato le riunioni serali nella stalla d’inverno o sull’aia d’estate dove c’era sempre chi era capace di raccontare fole, anticipando la narrativa horror con storie di fantasmi che facevano tremare i più piccoli, paurosi nel buio della stanza quando andavano a dormire. Franca Canapini ha una scrittura snella, una capacità affabulatoria che attrae e incanta, non di rado accompagnata da una certa vena poetica che le è propria e che la induce a integrare la prosa con dei versi che, oltre a essere belli, non sono per niente fuori luogo. Certo il fatto che parli di un’epoca che ha visto anche la mia giovinezza ha un peso non trascurabile nel giudizio, ma questo voler scrivere di un passato ormai lontano non ha solo il significato di una sorta di testamento da lasciare ai nipoti (e infatti l’opera inizia con un’introduzione in cui, rivolta alla nipote Alice, ne è spiegato il fine), è anche l’omaggio per i bambini di oggi, affinché sappiano quali sono le vere radici da cui provengono, sperando che apprezzino e che, soprattutto, possano comprendere, loro che hanno tutto, troppo direi, tanto da essere sempre insoddisfatti, quanto il poco dei loro nonni sia stato considerato un bene prezioso, una ricchezza irripetibile. Da leggere, e non è un consiglio, ma una raccomandazione. Franca Canapini, nata a Chianciano Terme (Si), risiede ad Arezzo dal 1975. Laureata in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Perugia, è stata Maestra nella Scuola Primaria e Professoressa di Lettere nella Scuola Secondaria di primo grado. Della poesia (e della scrittura in generale) dice “ La poesia, per me, è folgorazione da cui scaturisce una piena magmatica di suoni, immagini, pensieri, emozioni che necessita trovare foce in parole scritte. Scrivere è stato il sogno più bello della mia giovinezza. Ora, in età matura, il sogno è diventato esaltante progetto di vita.” A partire dal 2010 ha pubblicato 6 raccolte di poesia, un romanzo e una raccolta di favole, per le quali pubblicazioni ha ricevuto premi e segnalazioni. Fa parte del Consiglio dell’Associazione degli Scrittori Aretini Tagete ed è membro di giuria di alcuni premi letterari. Suoi lavori si trovano in diverse antologie e riviste di poesia, in vari siti e blog letterari e nel suo blog personale: www.lieve2011.wordpress.com Sito personale: www.francacanapini.weebly.com
3 Luglio
La Venere di Salò di Ben Pastor Hobby & Work Publishing Narrativa romanzo giallo
Strappato nel sonno in un rifugio della linea Gotica dal brutale Mengs, agente della Gestapo, e trasportato fino a Salò al comando del generale Sohl, Martin von Bora è nominato ufficiale di collegamento fra la Wermacht e la Repubblica Sociale Italiana. In aggiunta è incaricato di recuperare un quadro rubato, vale a dire la preziosa tela della Venere di Salò, opera del pittore Tiziano Vecellio. Inizia così le indagini che si presentano particolarmente complicate, tanto più che comincia a imbattersi in strani omicidi, che sono solo in apparenza suicidi di belle donne, i cui cadaveri sono sempre privi di vestiti. Non bastassero questi problemi von Bora deve anche anche occuparsi della repressione partigiana, scontrandosi quotidianamente con un un irascibile e vanitoso Maresciallo Graziani, nonché procedere guardandosi le spalle perché la Gestapo lo ha nel mirino, soprattutto per le sue segnalazioni di eccidi sul fronte orientale. Peraltro, in giorni che per lui dovrebbero essere più lunghi di 24 ore, trova anche il tempo per allacciare una storia d’amore con la bella ed enigmatica Anna Maria Tedesco, figlia di un ricco industriale tessile. In questo romanzo non mancano di certo l’azione e i colpi di scena, anche perché von Bora viene addirittura catturato, insieme con un pavido ufficiale della RSI, da un feroce capo partigiano, ma riesce a fuggire, non seguito dal suo compagno di prigionia, troppo timoroso di indispettire i carcerieri che non mancheranno di contraccambiare uccidendolo. Il colonnello tedesco sembra proprio un gatto con nove vite, sfuggendo anche al mitragliamento di un aereo americano che riesce perfino ad abbattere, e quando uno ha questa vitalità e queste capacità è ovvio che riesca sempre nello svolgimento dei compiti assegnatigli, uscendo indenne (o quasi) anche dalle situazioni più difficili. Infatti l’indagine si chiude assicurando alla giustizia il colpevole degli efferati omicidi e restituendo il quadro al legittimo proprietario. Comunque questa volta von Bora rischia grosso perché catturato dalla Gestapo, giunta in possesso del diario personale che ha pagine compromettenti, viene torturato a lungo; poiché non arriva una confessione, viene mandato in teno in Germania per un processo la cui sentenza di morte è già scritta e buon per lui che ha un amico nelle SS che lo sottrarrà ai suoi carcerieri, così che potrà con il suo reggimento andare sul fronte orientale a contrastare l’avanzata dell’esercito sovietico. Di carne al fuoco ce n’è tanta, ma è forse troppa, così che la cottura non è perfetta, nel senso che il romanzo, pur scritto con il piacevole stile che è proprio dell’autore, mostra nella trama non poche incongruenze e anche alcune ingenuità. E’ quindi inutile attendersi chissà cosa, ma è indubbio che come mezzo per trascorre piacevolmente alcune ore è senz’altro riuscito e in tal senso la lettura è senz’altro consigliabile. Ben Pastor, nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha scritto narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico. Della serie di Martin Bora Sellerio ha già pubblicato Il Signore delle cento ossa (2011), Lumen (2012), Il cielo di stagno (2013), Luna bugiarda (2013), La strada per Itaca (2014), Kaputt Mundi(2015), I piccoli fuochi (2016), Il morto in piazza (2017) e La notte delle stelle cadenti (2018).
29 Giugno
Ballata senza nome di Massimo Bubola Edizioni Frassinelli Narrativa
Voci mute contro la guerra E’ il 28 ottobre del 1921 e siamo all’interno della Basilica di Aquileia, affollata di vedove di guerra, di reduci, di militari di alto grado e di politici; tutti gli occhi sono rivolti a Maria Bergamas, madre di un irredento disperso nella grande guerra, la quale dovrà scegliere fra gli undici feretri allineati nella navata centrale quello del milite ignoto, che dovrà poi essere traslato a Roma per essere posto dentro il Vittoriano. Quindi la geniale intuizione del generale Giulio Douhet sta per concretizzarsi, intuizione che vuole essere un ringraziamento ufficiale a chi è caduto sul campo di battaglia, a chi si è immolato per la patria. La donna, in gramaglie, che ha già da tempo un colloquio muto con il figlio defunto, si avvicina a ogni bara e percepisce il racconto della vita e della morte che ciascuno di quei corpi ignoti le trasmette e per ognuno lei ha una reazione altrettanto muta, in una sorta di colloquio silenzioso che non viene intuito dai presenti, tutti tesi a vedere quale sarà il feretro scelto da Maria Bergamas. L’idea di Bubola, poeta, musicista e scrittore, è geniale, con quel suo dare la voce a chi voce non ha, ma il rischio, dato l’argomento, di incorrere in una retorica asfissiante è concreto, anche se l’abilità dell’autore è tale da evitarlo, soprattutto perché gli scopi dell’opera non sono l’esaltazione della nostra vittoria in una guerra sanguinosa, non è l’ode a una patria volta ad affermare la sua supremazia, sono invece quelli ben più nobili di un’invocazione alla pace, alla fratellanza fra i popoli, a ritrovare un’umanità che sappia cogliere nei comuni gesti della vita un punto di unione e non di disaccordo. Fra questi poveri soldati che riposano nelle bare non c’è mai odio e anche la vita che raccontano è quella di gente costretta alla guerra e che si accorge di combattere non per ideali, bensì per l’interesse di chi ha il potere, un sentimento comune che si lascia supporre, da alcune riflessioni, anche nel nemico, che non è più tale, ma che diventa al più un semplice avversario. Con in mente Niente di nuovo sul fronte occidentale e Un anno sull’Altipiano Bubola confezione un’opera di elevato valore, che pur nella scia dei libri che ho appena citato ha una una sua autonomia di trama e di sviluppo che la rendono ben identificabile e ulteriormente apprezzabile. L’autore è accorto nell’esporre, forte di una struttura ben congegnata, ed è altrettanto abile nel passare dalla creatività che si innesta nel fatto storico alla storia stessa, poiché l’opera si conclude, una volta che Maria ha fatto la sua scelta, con il trasporto della salma a Roma con un treno speciale, coperto di fiori, che procede lentamente di modo che la gente possa accorrere a vederlo, possa entrare in sintonia con l’eroe per eccellenza della patria, ma anche con colui che rappresenta, a nome dei tanti caduti, il simbolo di una tragedia. Nei nostri soldati, accomunati dalla morte, ma anche da una vita fatta di duro lavoro, dall’amore e da sogni che si sono infranti, si specchiano i vivi, i reduci, i mutilati, insomma tutto un popolo che si sente così universalmente rappresentato e che in cuor suo, contento di essere scampato al massacro, grida forte “ Mai più guerre”, purtroppo ignaro che anche per la pace occorre combattere. Ballata senza nome è stata una piacevolissima sorpresa, uno di quei libri che farei leggere anche a scuola, affinché, fin da giovani, i futuri uomini possano comprendere la scellerata inutilità della guerra. Massimo Bubola, nome di culto e figura centrale della musica d'autore italiana, poeta, musicista, scrittore. Ha al suo attivo venti album che tracciano un percorso unico nella letteratura musicale del nostro Paese. Già alla fine degli anni Settanta, Bubola crea una poetica che si abbevera alla tradizione della musica popolare e alla poesia contemporanea, arrivando a maturare una formula musicale ricca di suggestioni letterarie, che influenzerà la scena italiana a cominciare da Fabrizio De André, con cui scrive e compone due storici album come Rimini e L'Indiano, contenenti brani come Fiume Sand Creek, Rimini, Sally, Andrea, Volta la carta, Franziska, Canto del servo pastore, Hotel Supramonte, oltre a Don Raffaè, e firmerà altre grandi canzoni popolari come Il cielo d'Irlanda. Nel 2006 ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo Neve sugli aranci, e nel 2009 il suo primo romanzo, Rapsodia delle terre basse (Gallucci). Negli ultimi anni si è dedicato alla riscoperta del patrimonio artistico, musicale e storico legato alle vicende della Prima guerra mondiale in Italia. Da questo lavoro hanno avuto origine due album: Nel 2005 Quel lungo treno e nel 2014 Il Testamento del Capitano, seguito dall'album antologico Da Caporetto al Piave e dal libro Ballata senza nome (Frassinelli 2017).
24 Giugno
Il tesoro dei vinti. Il mistero dell’oro di Dongo di Gianni Oliva Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia
Pecunia non olet Scappavano, fuggivano di fronte agli alleati portandosi dietro parte del tesoro nazionale, oltre a ricchezze personali, più o meno lecitamente accumulate; la colonna di auto al seguito di Mussolini fermata a Dongo era quella dei gerarchi e compromessi con il regime in marcia verso un’improbabile salvezza. La storia poi ci racconta dell’esecuzione di cui furono vittime il Duce e la sua amante e separatamente ministri, sottosegretari, federali della Repubblica di Salò e del partito nazionale fascista. Tuttavia questo racconto non è detto che sia l’assoluta verità, perché nel trascorrere del tempo emergono fatti nuovi e versioni differenti che se nulla cambiano circa la fine di questi personaggi, quelle che vengono modificate sono invece le circostanze e le modalità. La verità, quella senza se e senza ma, senza incertezze, non è mai facile da trovare e ancor più difficile lo è quando ci sono di mezzo delle ricchezze, in special modo se sono tante. E, benché non si abbia certezza sull’esatta entità, già alcuni dati che appaiono nel complesso possibili parlano di circa 8 miliardi di lire dell’epoca, di un’ingente quantità di oro, di preziosi vari, insomma quello che non a caso si può definire un tesoro. Tanti l’hanno visto, è passato per non poche mani, ma si è inspiegabilmente perso e tutto lascia supporre che in larga parte sia finito nelle casse del Partito Comunista Italiano, disposto a difendere questa appropriazione indebita con tutti i mezzi, non esclusa forse anche l’uccisione di chi sapeva e probabilmente voleva parlare. Ci furono indagini, si trovarono anche dei presunti colpevoli, tutti dell’area comunista, ma il processo fu continuamente rinviato, tanto che approdò alla Corte di Assise di Padova ben dodici anni dopo i fatti e li si arenò, con il colpo di grazia dato dalla morte improvvisa di uno dei giurati che mandò all’aria tutto il procedimento che evidentemente non s’aveva da fare. Nulla di nuovo, perché è uno dei tanti misteri all’italiana, ma se l’aspetto di giustizia resta scoperto quello storico invece pretende giustamente che si tenti almeno di pervenire a un barlume di verità ed è quello che fa Gianni Oliva con questo libro, senza con ciò apparire un revisionista secondo una moda attualmente in voga, tanto più che politicamente l’autore non è anticomunista, anzi è il contrario. Assume quindi una particolare rilevanza la sua ricerca, che non può essere considerata di parte, in quanto fa emergere responsabilità proprie di esponenti del suo partito. Oliva, con meticolosità e rigore, ricostruisce la vicenda partendo dagli ultimi giorni di Mussolini, ai quali è dedicata quasi la metà del libro, e proseguendo sulla base dei documenti processuali, di quel procedimento avanti la Corte d’Assise di Padova interrotto per la scomparsa di uno dei giurati e non più ripreso in quanto il coinvolgimento di due parlamentari (Dante Gorreri e Pietro Vergani) avrebbe comportato tempi lunghissimi per le autorizzazioni a procedere e infine, a salvare capra e cavoli, e a mettere una pietra tombale sull’aspetto giudiziario intervennero le due amnistie del 1970 e del 1973. Tuttavia, secondo Oliva, resta incontrovertibile la responsabilità politica del Partito Comunista se non altro nella gestione dell’emergenza dei giorni turbolenti della fine di aprile del 1945. Non c’è certezza peraltro su dove finì il tesoro, se fu oggetto di mire individuali, o di partito, o di entrambi, anche se si può ragionevolmente supporre che il Partito Comunista ne abbia almeno in parte beneficiato. Oliva non conclude quindi l’opera con certezze, ma la storia spesso non è verità e già porsi dei problemi o dei dubbi sulle versioni ufficiali è almeno un tentativo di avvicinarsi alla verità. Il libro si fa apprezzare, peraltro, anche per altri aspetti, come l’analisi approfondita dei motivi che portarono all’esecuzione di Mussolini e degli altri gerarchi, nonché alla macabra esposizione dei loro corpi a Milano in piazzale Loreto. Insomma, in ogni caso Il tesoro dei vinti è un saggio storico che si dovrebbe leggere. Gianni Oliva, storico, giornalista e politico italiano, studioso del Novecento, da anni si occupa degli aspetti meno indagati della storia nazionale, in particolare dei nodi irrisolti del 1943-48. Da Mondadori ha pubblicato, fra gli altri, La resa dei conti (1999), Foibe (2002), Le tre Italie del 1943 (2004), Profughi (2005), Si ammazza troppo poco (2006), L'ombra nera (2007), Soldati e ufficiali (2009), Esuli (2011), L'Italia del silenzio (2013), Un regno che è stato grande (2013). Alle vicende della dinastia sabauda ha invece dedicato I Savoia (1998) e Duchi d'Aosta (2003). Per Edizioni del Capricorno ha pubblicato La Grande Guerra degli italiani. 1915-1918 (2015), Mussolini 1945. La fine del Fascismo (2015), L’avventura coloniale italiana. L’Africa Orientale Italiana 1885-1942 (2016), Un secolo d’immigrazione a Torino. Storia e storie dall’Ottocento a oggi (2017) e Torino anni di piombo (2018).
16 Giugno
Una saga veneziana di Marco Salvador Edizioni Biblioteca dell’immagine Narrativa romanzo storico
Le radici Non so se ho letto tutti i romanzi che ha scritto Marco Salvador, quel che è certo è che quelli che sono passati per le mie mani sono tanti e il fatto che il loro numero sia di tutto rilievo è sintomo del fatto che mi sono piaciuti. E’ vero, tranne in un caso o due, che si tratta di romanzi storici, genere letterario a me particolarmente gradito, ma resta il fatto che mi sono sempre trovato di fronte a opere confezionate con rigore storico e abilità letteraria, alla base di trame che a definire avvincenti può apparire riduttivo. Dal ciclo dei Longobardi, che mi ha fatto conoscere questa popolazione germanica molto di più delle striminzite notizie dell’insegnamento scolastico, passando per i romanzi sui da Romano, capaci di mostrare una realtà storica che va ben oltre la fama del capostipite Ezzelino, e infine per giungere alla vicenda della transgender Rolandina, che non è scritta per richiamare istinti morbosi, ma per descrivere con pietà la triste vicenda di un diverso, il percorso letterario di Marco Salvador è una progressione di trame, sempre basate su fatti veri e rigorosamente documentati. Posso solo ipotizzare che Una saga veneziana sia frutto di ricerche approfondite effettuate a Venezia per conoscere un po’ l’origine della famiglia dell’autore; infatti, nel libro si parla di un Salvatore, mercante fiorentino, che si rifugia a Venezia nel primi decenni del XIV secolo, e darà vita a una famiglia (una vera e propria dinastia) di commercianti e di armatori. In tempi piuttosto rapidi ci sarà l’arricchimento di questa famiglia, il cui cognome, per adattamento al dialetto veneziano, che era la lingua della Serenissima, diventerà Salvador. Questo ceppo conoscerà le alterne fortune della vita, ma diventerà un riferimento nella Repubblica, imparentandosi con le maggiori famiglie patrizie. Gli anni, anzi i secoli passano, con un numero di personaggi che si affacciano sulla scena e che poi scompaiono, uomini e donne non scevri da difetti, ma con pregi che li caratterizzano e che soprattutto si traducono nella difesa del buon nome della famiglia. Troviamo, mercanti, ma anche armatori, uno addirittura ammiraglio dell’Arsenale, perfino un console a Palermo, tutti discendenti da quel Salvatore che trovò a Venezia una seconda patria, dopo la sua fuga da Firenze per motivi oscuri che diventeranno chiari alla sua morte. La mano dell’autore, come al solito, è felice, nel senso che non trascende mai, mantenendo un tono moderatamente distaccato, tanto più apprezzabile in questa circostanza, visto che parla dei suoi avi. Certo Salvatore, Marco, Daniele, tanto per citare solo alcuni degli antenati, non hanno la fama di altri personaggi dei romanzi di Salvador, come Guido da Romano, o Rotari il longobardo, ma hanno una loro forza, un loro vigore, che è quello di una borghesia che reclama il suo posto dell’assetto sociale; a loro modo sono anche degli eroi, che non conquistano territori, ma ruoli sempre più di rilievo in una società come quella della Repubblica in cui avevano voce quasi esclusivamente i nobili. Ho accennato prima al rigore con cui l’autore ha condotto le ricerche storiche, rigore che è testimoniato dai Regesti di una famiglia cittadinesca veneziana tra il XIV e il XVI secolo riportati al termine dell’opera e che hanno costituito la base della stessa. Il romanzo è indubbiamente interessante e pertanto meritevole di lettura, spiace solo che ci si fermi al XVI secolo, tanto che viene da chiedersi: e dopo? Chissà che Salvador abbia pensato anche a questo dopo e questo è il mio augurio, ma anche la richiesta che rivolgo all’autore. Marco Salvador vive in un paesino della pianura friulana, nella stessa antica casa dov’è nato. Dopo un giovanile esordio letterario, si è dedicato soprattutto allo studio delle comunità rurali friulane nel medioevo pubblicando numerosi saggi. Solo all’inizio di questo millennio è tornato alla narrativa con la pubblicazione quasi in contemporanea di due romanzi: uno ambientato nel mondo longobardo (Piemme) e l’altro in un’odierna casa di riposo (Fernandel).
10 Giugno
Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna di Marco Mondini Edizioni Il Mulino Storia
Dalla gloria alla polvere Il cognome Cadorna richiama immediatamente il nome di una località, ora in Slovenia, chiamata Caporetto, perché è inevitabile l’associazione fra la figura del comandante in capo e il tragico evento della celebre ritirata, con gli austriaci e i tedeschi che nei pressi di quella località sfondarono le nostre linee e che in pochi giorni non solo ripresero il territorio che avevamo conquistato nelle undici sanguinose battaglie dell’Isonzo, ma addirittura minacciarono la sorte stessa dell’Italia, spingendosi fino al Piave, che divenne così il baluardo dell’estrema difesa. Il generale Luigi Cadorna fu lo sconfitto di Caporetto, ma questo fatto fu il frutto di una strategia militare dello stesso che portò a questi inevitabili conseguenze. Desideroso di essere padrone non solo della propria vita, ma anche di quella altrui condusse una guerra d’aggressione all’Austria in modo sconsiderato, con continui attacchi frontali che portarono a limitati successi territoriali a prezzo di centinaia di migliaia di morti. E’ vero che anche sul fronte occidentale le battaglie degli anglo-francesi con i tedeschi erano pur sempre scontri frontali, ma l’ottica con cui erano avviate appariva diversa, nel senso che ambo i contendenti cercavano in tal modo di dare la spallata decisiva, mentre il nostro Cadorna aveva una visuale più ristretta, alla ricerca di una vittoria significativa, ma non determinante. Quell’accanirsi sul Carso, quel cercare di conquistare l’arido e impossibile altopiano della Bainsizza danno l’idea di una strategia limitata, volta magari a cogliere un successo prestigioso, ma comunque non tale da porre fine al conflitto. Marco Mondini con Il Capo fornisce un ritratto del comandante in modo puntuale e rigoroso, sulla base dei documenti della commissione d’inchiesta successiva ai fatti Caporetto e sempre contestualizzando l’operato del generale con l’epoca e la situazione dello stato italiano in cui Cadorna non era altro che il rappresentante di una generazione di militari di carriera permeati dalla convinzione che l’Italia fosse un paese debole e che avesse bisogno dell’indispensabile disciplina; a ciò si deve aggiungere che questi “signori della guerra” erano ossessionati dal passato certamente non glorioso, soprattutto da quell’infausta terza guerra di indipendenza che ci vide sconfitti per terra e per mare. L’immagine che risulta non è quella di un incapace, bensì quella di un uomo inadatto all’incarico ricevuto, come del resto comprovato dal giudizio della citata commissione d’inchiesta, che parla di un accentratore, tetragono alle critiche e ai punti di vista altrui, irremovibile nelle proprie certezze e convinto della propria infallibilità, incapace di ammettere i propri errori. Questa specie di dio ovviamente non aveva nessuna considerazione per i suoi sottoposti, considerati carne da macello, era continuamente teso ad affermare un principio di rigida obbedienza da imporsi con il terrore, con frequenti condanne a morte e decimazioni. E’ un libro di indubbio interesse e che aggiunge un altro prezioso tassello al mosaico della nostra storia, risultando anche un prezioso contributo per comprendere quelle che furono le cause originarie della ritirata di Caporetto. Marco Mondini fa parte del direttivo dell’Historial de la Grande Guerre di Péronne e del board editoriale di «1914-1918 online. The International Encyclopedia of the First World War». Tra i suoi volumi più recenti: Tutti i giovani sui vent'anni, una storia di alpini dal 1872 a oggi (Mondadori, 2019), Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna (Il Mulino, 2017, premio Friuli Storia), I luoghi della Grande Guerra (2015), La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-1918 (Il Mulino, 2014).
6 Giugno
Dove un’ombra sconsolata mi cerca di Andrea Molesini Sellerio Editore Palermo Narrativa romanzo storico
Crescere in fretta Strano titolo quello dell’ultimo romanzo di Andrea Molesini, talmente strano che mentre leggevo ogni tanto mi chiedevo il significato. Giunto al termine del libro l’autore veneziano ha soddisfatto la mia curiosità in una Nota al testo e così ho appreso che quel Dove un’ombra sconsolata mi cerca è la traduzione di un verso della poetessa russa Anna Achmatova, che aggiunge:” Ogni tentativo di presentare le proprie memorie in forma coerente equivale a un falso. Nessuna memoria umana è predisposta in modo da ricordare tutto in una sequenza continua.”. In questo modo si spiega la struttura dell’opera che alterna capitoli di epoche non successive, ma salta da un periodo antecedente la seguente guerra mondiale ad anni assai più recenti, per tornare poi a quelli drammatici del secondo conflitto, proprio di chi, giunto a una certa età, cerca di riordinare i suoi ricordi che affiorano a sprazzi e quasi mai in un preciso e continuo ordine temporale. Ciò premesso devo dire che Andrea Molesini mostra una spiccata preferenza per quelle trame che hanno come palcoscenico la laguna della sua Venezia nel corso di una guerra e con protagonista principale non tanto un uomo adulto, quanto un bambino, al più un adolescente. Naviga sempre bene in questo schema che gli è congeniale e lo fa con mano sicura, inserendo sempre una punta di suspense che non può che giovare a una narrazione già di per sé interessante. In questa sua ultima opera troviamo così la vicenda di Guido, un bambino veneziano, figlio di un ufficiale della Regia Marina che in effetti è un agente segreto e che si fa chiamare Comandante, un uomo pragmatico, che si diletta a costruire mappamondi, e che è abituato a prendere decisioni, anche drammatiche, portato più per le materie scientifiche che per quelle letterarie, a differenza della moglie, che vede il mondo attraverso una lente poetica che la porta, per esempio, a chiamare i fiocchi di neve “farfalle fredde”. Se i ricordi degli anni del fascismo ante guerra sono tutto sommato sporadici, molto più frequenti sono quelli del periodo bellico, in special modo dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945; il motivo è che il padre di Guido e Guido stesso, rimasti rispettivamente vedovo e orfano, sono membri attivi della Resistenza, anzi il Comandante ne è il capo in Laguna. Non c’è miglior occasione dei pericoli di una guerra e dentro essa di un conflitto civile per accelerare la crescita di un ragazzino; e infatti Guido in quel non lungo lasso di tempo sboccerà all’età adulta, conoscendo l’amore, le angosce di chi si sente braccato, il dramma di un’amicizia che verrà interrotta da un’esecuzione. Intorno a lui si agitano altri personaggi, tutti ben definiti, quali il nostromo Tobia, la vecchia e saggia zingara Sussurro, la bella nera Maria, il sacerdote tabagista don Rino, la desiderabile Francesca, il maestro Gorlato, la domestica Concetta con le sue Ave Marie, l’equivoca Madame la Petasse, il maggiore tedesco Werner che sta con i partigiani perché consapevole dell’imminente fine del Terzo Reich, il Comandante stesso, ma soprattutto Scola, il grande amico la cui tragica fine inciderà sulla sua vita per sempre. Questo è indubbiamente un romanzo di formazione, ma non solo, perché è anche un’opera in cui l’autore pone a confronto la bellezza della natura con la follia degli uomini, il peso del potere che a volte costringe a prendere decisioni ingiuste, ma necessarie, i conflitti che possono nascere fra padre e figlio e che diventano talora insormontabili, il tradimento, subdolo e inspiegabile, insomma un insieme di situazioni, di stati d’animo, dipinti con rara maestria sullo sfondo di una laguna che è insieme rifugio e fonte delle nostre paure. E’ leggera la mano di Molesini, anzi direi meglio leggiadra, visto che non è infrequente l’innesto di una vena poetica in quello che, secondo me, è il più bel romanzo scritto dall’autore, tanto da consigliarne vivamente la lettura. Andrea Molesini ha pubblicato Non tutti i bastardi sono di Vienna, che nel 2011 ha vinto, tra gli altri, il Premio Campiello e il Premio Comisso, tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo e molte altre lingue, La primavera del lupo (2013) e Presagio (2014), tutti e tre editi da Sellerio, nonché La solitudine dell’assassino (2016) edito da Rizzoli.
3 Giugno
I Gonzaga Storia e segreti di Kate Simon Newton Compton Editori Storia
I Gonzaga e il Rinascimento A essere sincero, quando ne ho iniziato la lettura affrontando il primo capitolo interlocutorio e, soprattutto, quando mi sono imbattuto nell’Interludio intestato La peste ho perso la voglia di proseguire, perché, francamente, come incipit non è assolutamente invitante; poi, mi sono imposto di andare avanti e la mia decisione si è rivelata giusta, perché l’opera è di pregevole fattura. Non era certo facile narrare dell’ascesa, delle glorie e poi della decadenza del casato dei Gonzaga perché si trattava di avere a che fare con quattro secoli di storia e soprattutto con quel periodo così fecondo per tutte le arti e che è rappresentato dal Rinascimento. Kate Simon si è dimostrata consapevole di queste difficoltà, ma, anziché limitarsi a un puro e semplice, per quanto valido saggio storico sui Gonzaga, ha inteso andar oltre, proponendo al lettore, attraverso le vicende dei Signori di Mantova, un quadro ampio e affascinante del Rinascimento. Riesce a far questo senza perdere di vista l’argomento principale, anzi il lettore, attratto dalle trame ordite dai Gonzaga, dalle loro alterne fortune e dallo splendore che seppero dare a una piccola corte, finirà con il ritrarre un vero piacere nell’essere edotto di un periodo storico, sovente mitizzato, ma qui presentato nella sua nuda realtà costituita da splendore e miseria, da trionfo delle arti e onnipresenti intrighi, da uomini encomiabili e da altri esecrabili. Non sono facile alle lodi sperticate, ma in questo caso, visto l’ambizioso fine e la non comune difficoltà per raggiungerlo, difficoltà abilmente superata, posso dire in tutta consapevolezza che questo saggio relativo proprio al periodo rinascimentale è uno dei migliori che ho letto. Fra l’altro, pur mostrando una certa simpatia per questa famiglia di agricoltori, che, grazie alle fortune accumulate con i frutti della terra, seppe assurgere al rango di nobiltà, facendo diventare la piccola corte di Mantova un punto di preciso riferimento in tutta l’Europa, l’autore non fa sconti, disegnando ritratti a volte impietosi di questi Signori, ben evidenziando i loro pregi e i loro difetti, smitizzando alcuni di essi e ricollocandoli nella corretta posizione di persone magari capaci e influenti, ma certamente non prive di vizi, vizi che in tutte le epoche e forse anche di più nel Rinascimento sono propri del genere umano. Ciò che più colpisce, però, è l’inserimento nella narrazione cronologica delle vite dei Gonzaga di parti chiamate Interludi e che potrebbero far pensare, di primo acchito, come è appunto capitato a me, a delle inopportune digressioni. E invece si rivelano interessanti e indispensabili per comprendere come la storia di una famiglia non possa prescindere dal contesto vigente pro tempore dei grandi fatti e delle arti. Senza citarli tutti, per ovvie ragioni di spazio, segnalo quello dedicato a un grande pedagogo quale fu Vittorino da Feltre, un altro che parla di due autentici virtuosi dell’arte, quali furono per la pittura Andrea Mantegna e per l’architettura Leon Battista Alberti, nonché quello con cui viene dato, per sommi, ma esaurienti capi, un sunto di opere ancor oggi di estremo interesse quali furono Il cortegiano di Baldassarre Castiglione e Il Principe di Nicolò Machiavelli; non posso inoltre dimenticare l’excursus dedicato al teatro e alla musica, che completa nel migliore dei modi un affresco di grande bellezza. Il libro si conclude, mestamente, con la fine della grande casata, con tutte le opere di grande valore, acquistate nei secoli dai Gonzaga, che lasciano il Palazzo Ducale, disperse nel mondo, per l’ignavia e la scelleratezza degli ultimi discendenti. La luce non si spegne di colpo, ma gradualmente e rimarrà spenta per il periodo di dominazione austriaca, francese, di nuovo austriaca e del nuovo stato italiano, per poi tornare a rifulgere a partire dal dopoguerra, accelerando la vocazione turistica della città di Mantova a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso. Mantova, senza i Gonzaga, sarebbe rimasto un umile borgo agricolo ed è per questo motivo che dobbiamo essere riconoscenti a questa dinastia, che proietta il concetto del bello rinascimentale ai giorni nostri. Da leggere, senza alcun dubbio. Kate Simon (5 dicembre 1912 - 4 febbraio 1990) è stato un autore americano di origine polacca e noto anche come Larry.
28 Maggio
Duchi d’Aosta di Gianni Oliva Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia biografie
Il ramo secondario Credo che dopo più di settant’anni di repubblica ben pochi abbiano una conoscenza dei rami dinastici dei Savoia, tranne forse per la diatriba insorta secondo la quale il legittimo successore, come re d’Italia, di Umberto II non sarebbe suo figlio Vittorio Emanuele di Savoia, bensì il duca Amedeo d’Aosta. Credo altresì che di questi litigi monarchici siano interessati forse solo i contendenti e quindi è inutile che mi dilunghi in questa querelle, mentre riveste più interesse sapere come hanno avuto origine i Duchi d’Aosta e chi siano stati in passato per l’Italia monarchica. Vittorio Emanuele II, il re dell’Unità d’Italia, ebbe diversi figli fra illegittimi e legittimi, ma a noi quelli che interessano sono questi ultimi; il primogenito fu Umberto I che, in quanto tale, alla morte del padre divenne re d’Italia; a sua volta, caduto sotto i colpi di pistola dell’anarchico Bresci, gli succedette Vittorio Emanuele III, quella della correità con il fascismo e uno degli artefici dell’armistizio dell’8 settembre 1943, con il quale riusci, mirabilmente, a tradire i tedeschi, gli italiani e la stessa monarchia; alla sua abdicazione subentrò come sovrano, per l’esattezza dal 9 maggio 1946 al 10 giugno del medesimo anno, il figlio Umberto II. Il secondogenito di Vittorio Emanuele II, Amedeo Duca d’Aosta, diede inizio a questa seconda linea dinastica che, nelle confuse conoscenze del popolo, ha vantato dei rappresentanti più stimati della linea principale e al riguardo basti pensare a due soprattutto, figli entrambi del capostipite: Luigi Amedeo duca degli Abruzzi, grande esploratore, ed Emanuele Filiberto, che, in quanto primogenito, fu investito del titolo di duca d’Aosta, il personaggio forse più conosciuto della famiglia, in quanto comandante nel corso della Grande Guerra della gloriosa III armata. Il divario con la linea principale si acuì proprio grazie ai figli di Amedeo Duca d’Aosta che si trovarono a essere raffrontati con Vittorio Emanuele III: loro alti, aitanti, brillanti, intraprendenti, maschi, lui, come noto, un nanetto per niente simpatico, ben poco comunicativo, anche se probabilmente più intelligente dei cugini. Il bel saggio di Gianni Oliva ci parla appunto della dinastia dei Duchi d’Aosta, ponendo l’accendo sul fatto che, benché non abbiano mai tentato di impadronirsi della corona, sono sempre apparsi meritevoli della stessa, quasi sempre di più di chi la portava sul capo. Sotto questo aspetto il libro ripercorre la storia d’Italia dalla sua unità fino all’estinzione della forma monarchica di governo del paese, con interessanti annotazioni riguardo ai fatti più salienti, da cui fra l’altro si evince che non è vero che il fascismo non sarebbe andato al potere nel caso che il re non fosse stato Vittorio Emanuele III, perché anche suo cugino Emanuele Filiberto era un nazionalista di ispirazione fascista e quindi è il caso di dire che se la storia non si fa con i “se” e con i “ma” questo è il classico caso che lo conferma. Da leggere, perché c’è da imparare. Gianni Oliva, storico, giornalista e politico italiano, studioso del Novecento, da anni si occupa degli aspetti meno indagati della storia nazionale, in particolare dei nodi irrisolti del 1943-48. Da Mondadori ha pubblicato, fra gli altri, La resa dei conti (1999), Foibe (2002), Le tre Italie del 1943 (2004), Profughi (2005), Si ammazza troppo poco (2006), L'ombra nera (2007), Soldati e ufficiali (2009), Esuli (2011), L'Italia del silenzio (2013), Un regno che è stato grande (2013). Alle vicende della dinastia sabauda ha invece dedicato I Savoia (1998) e Duchi d'Aosta (2003). Per Edizioni del Capricorno ha pubblicato La Grande Guerra degli italiani. 1915-1918 (2015), Mussolini 1945. La fine del Fascismo (2015), L’avventura coloniale italiana. L’Africa Orientale Italiana 1885-1942 (2016), Un secolo d’immigrazione a Torino. Storia e storie dall’Ottocento a oggi (2017) e Torino anni di piombo (2018).
24 Maggio
Vincoli. Alle origini di Holt di Kent Haruf Traduzione di Fabio Cremonesi NN Editore Narrativa romanzo
Il primo di una serie fortunata Corrono circa trent’anni (dal 1984 al 2015) fra le pubblicazioni di Vincoli e di Le nostre anime di notte, quest’ultimo uscito postumo, e in questo lasso di tempo sono stati dati alle stampe anche Canto della pianura, Crepuscolo e Benedizione, romanzi tutti ambientati a Holt, una cittadina americana del tutto immaginaria, ma simile a tante altre a vocazione prettamente agricola. Lo stile scarno, ma non povero rimane sostanzialmente uguale, quello stile che non poco ha contribuito al successo e alla fama di Kent Haruf; non si può infatti rimanere insensibili di fronte all’immediatezza della comprensione di ciò che è scritto, un mezzo per esprimere passioni proprie del genere umano, capaci, grazie a trame ben congegnate, di avvincere dalla prima all’ultima riga. Eppure il narratore americano non è che arzigogoli pensieri particolarmente complessi, rivelando analisi delle personalità in modo determinante, no, senza troppe complicazioni ci porta a conoscere i suoi personaggi sia nella loro esteriorità sia all’interno del loro animo. Risulta, quindi, una lettura facile, gradevole e avvincente ed è questo che ha determinato il successo di Haruf, conosciuto in Italia solo da poco tempo e grazie all’editore NN. Vincoli ci introduce per la prima volta a Holt e lo fa quasi alle sue origini, alla fine del XIX secolo, allorché i pellirosse che lì vivevano prima dei coloni bianchi avevano lasciato quelle terre aride da circa una ventina di anni. La storia che ci viene narrata è quella di famiglie i cui terreni agricoli sono confinanti, ma è anche la storia di un grande amore che la grettezza di un padre padrone ha troncato, rendendo infelici i suoi due figli e il figlio dei vicini. La vicenda è narrata da Sanders Roscoe, un uomo che non è stato vittima di questo amore ostacolato, ma che ne è perfettamente a conoscenza, essendo il figlio di uno degli interessati e ciò che più sorprende è l’affetto che poco a poco cresce in lui per quella che avrebbe potuto essere sua madre e non lo è stata, un affetto che è quasi infatuazione e che rischia di diventare amore, nonostante una trentina di anni di differenza. A Holt, in questo microcosmo quasi sperduto nelle grandi pianure americane, si nasce, si vive e si muore, come in ogni parte del mondo, ma anche si ama o si odia, come appunto in ogni altra parte del mondo. E allora che cosa c’è di tanto interessante per apprezzare e amare i romanzi di Haruf? C’è la dolcezza e la pietà, a seconda dei casi, con cui Haruf anima i suoi personaggi, con cui descrive le loro passioni, i loro pregi e i loro difetti, ma senza giudicare, perché sembra dirci che la vita è così, quella vita di cui anche noi siamo parte con le nostre virtù e le nostre pecche. E per quanto lo stile sia semplice e scarno, a tratti è venato da un alone di poesia, capace di stemperare tragedie e di infondere speranze, così che i protagonisti non compaiono per ritirarsi poi come ombre, ma entrano in noi. Come sono possibili da dimenticare il padre padrone Roy Goodnough che agita i suoi moncherini, il figlio Lyman un po’ ritardato e succube, la dolce figlia Edith, una vittima sacrificale, il suo mancato sposo John Roscoe e l’io narrante Sanders Roscoe? No, ognuno immaginandoseli a modo suo se li ricorderà ogni volta che andando in campagna vedrà qualcuno che ara la terra, qualcun altro che porta le mucche al pascolo o una donna che dà il becchime alle galline. Perché? Perché sono personaggi di fantasia, ma che sembrano veri, nel senso che si ha la sensazione che siano esistiti veramente e che, prima o poi, altri come loro si possano incontrare. Vincoli è un romanzo stupendo. Kent Haruf (1943-2014), scrittore americano, dopo la laurea alla Nebraska Wesleyan University ha insegnato inglese. Prima di dedicarsi alla scrittura ha svolto diversi lavori, come operaio, bracciante, bibliotecario. Grazie ai suoi romanzi, tutti ambientati nella fittizia cittadina di Holt, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Whiting Foundation Award e una menzione speciale dalla PEN/Hemingway Foundation. Con il romanzo Il canto della pianura è stato finalista al National Book Award, al Los Angeles Times Book Prize, e al New Yorker Book Award. Con Crepuscolo, secondo romanzo della Trilogia della Pianura, ha vinto il Colorado Book Award, mentre Benedizione è stato finalista al Folio Prize.
21 Maggio
I cento giorni di Joseph Roth Traduzione di Ervino Pocar Edizioni Adelphi Narrativa romanzo storico
Il tramonto di un mito I cento giorni sono un periodo storico compreso fra il ritorno di Napoleone a Parigi dall’esilio all’isola d’Elba (20 marzo 1815) e la restaurazione della dinastia borbonica con Luigi XVIII (8 luglio 1815); in questo lasso di tempo il 18 giugno si svolse la celebre battaglia di Waterloo che vide la definitiva e irrimediabile sconfitta dell’Imperatore dei Francesi. Lo scopo di Roth, però, come egli stesso dice non è di scrivere una saggio storico e anche l’attribuzione generica di romanzo storico gli andrebbe stretta perché in effetti ha inteso mostrare il crepuscolo di un quasi onnipotente, spogliandolo delle vesti ufficiali affinché restasse solo l’uomo, con i suoi dubbi, le sue incertezze, le sue paure e la stanchezza che aggredisce chi ha ormai imboccato velocemente il tratto di discesa della sua parabola. E’ un tramonto senza gloria, la fine di un mito di cui piano piano lo stesso Napoleone prende coscienza; é il grande generale che ha sempre cercato la battaglia, ma che ora, che gli viene imposta, lo trova riluttante, con un presagio di sconfitta che lo assillerà fino alle battute finali. Il tempo inesorabile corre, ma non verso il sole di Austerlitz, verso le piogge, i terreni pantanosi di Waterloo e in questo susseguirsi veloce e implacabile di istanti si intreccia la storia dell’imperatore con quella di una sua lavandaia, Angelina. Lei, come tutte le donne di Francia, lo adora, è follemente infatuata di questo mito che va decomponendosi; c’è chi la dissuade di intestardirsi in un sentimento irragionevole, a maggior ragione ora che l’uomo Bonaparte è l’ombra di se stesso, ma inutilmente, e così entrambi saranno sconfitti. I cento giorni è un’opera dalla straordinaria potenza visiva, tanto da sembrare una pellicola cinematografica, ma questa caratteristica non è fine a se stessa, è semplicemente la cornice di un quadro di irresistibile bellezza, dove i cento giorni di un’epopea, in cui tutti credono illudendosi consapevolmente che i disegni del destino possano cambiare, scandiscono la fine di un’epoca prima ancora dell’esito di Waterloo nell’animo dei due protagonisti, l’astro che si spegne di Napoleone e la donna con le ali di Icaro che inutilmente cerca di raggiungere il suo Sole. Imperdibile. Joseph Roth, giornalista e scrittore austriaco.
18 Maggio
Album Piubello. Uno scrittore in piazza di AA.VV. A cura di Mario Artioli e Vladimiro Bertazzoni Sometti editoriale Biografia
Chi era Giovanni Piubello Il quarto volume del cofanetto dedicato a Giovanni Piubello, dopo che era stato pubblicato nei primi tre ogni suo scritto, è una sua biografia, frutto di più mani e in grado, ancor di più della lettura delle sue opere, di far comprendere chi fosse prima di tutto l’uomo e poi l’artista. Si avvicendano così fonti di diversa natura, che vanno dalle testimonianze ai documenti, da alcune prose autobiografiche a fotografie, da un breve riepilogo della sua vita, più che altro anagrafico, a brevi interventi di chi l’ha conosciuto e ha inteso delineare il suo ritratto. Sono ben 353 pagine che per varietà, novità anche e qualità dei diversi autori sono in grado di far conoscere Giovanni anche a chi non ha mai avuto occasione di vederlo, oppure di chiarire la natura del personaggio a coloro, fra i quali il sottoscritto, che hanno avuto occasionalmente l’opportunità di scambiare due chiacchiere. Nel mio caso penso sia accaduto non più di un paio di volte, peraltro brevi, e avevo ritratto l’impressione di un uomo originale, non matto, ma comunque diverso dalla media, più interessato a parlare di letteratura che a vendere, tanto che mi chiesi all’epoca se quella bancarella non costituisse solo il passatempo di un uomo che viveva di rendita. E invece era la sua unica fonte di reddito, che non gli consentiva di certo voli pindarici. E’ molto bello leggere come ne parla chi l’ha conosciuto non di certo occasionalmente e i giudizi sull’uomo e sull’artista sono convergenti: Piubello era così, un poeta, anche se scriveva soprattutto la prosa, che viveva romanticamente per la sua arte, per le conversazioni letterarie con gli amici, per qualche riunione conviviale con fini sempre culturali; però era sostanzialmente solo, tranne la compagnia di qualche felino, perché era scapolo e non avrebbe potuto essere diversamente dato il tipo di vita scelto. Fra le testimonianze mi ha colpito una di Andreina Bergonzoni che ebbe modo di conoscerlo per puro caso mentre si aggirava per Mantova alla ricerca di notizie su Arturo Frizzi per la sua tesi di laurea. L’incontro non fu il solo e quindi il giudizio della Dr.ssa Bergonzoni non può essere considerato di primo acchito, ma ponderato. Scrive, fra l’altro: “Tornai con un bottino di notizie che mi avrebbero consentito di scrivere almeno tre capitoli della mia tesi, con uno strano libro di Gobbi ricevuto in dono e con una certezza in cuore: avevo incontrato un poeta, un uomo che aveva fatto della libertà la sua bandiera, dell’onestà intellettuale un credo, di quella bancarella una patria dell’anima.”. Sono dell’opinione che quelle poche parole dopo i due punti riescano a descrivere in modo impeccabile Giovanni Piubello, un uomo e un artista rari; entrambi avrebbero meritato maggior fortuna, ma come posso io pensare che le soddisfazioni economiche e materiali dovessero arridergli? Non ha mai cercato la notorietà e anche dopo la pubblicazione di Matti beati e la vincita del premio Duomo non ha fatto nulla per battere il ferro quando era caldo; no, a Gioàn non interessava leggere il suo nome a lettere cubitali sui giornali, né seguire la vendita delle sue opere, non era questo il suo mondo perché invece la bancarella era il rifugio sicuro in cui riusciva a stemperare, con gli incontri con la gente e lo scambio di parole, una tristezza di fondo che lo portava alla solitudine, un male intimo non raro nei poeti e non dimentichiamo che Gioàn scriveva anche poesie. La lettura di questo libro è quindi sicuramente consigliata.
9 Maggio
Storia di Mantova Da Manto a capitale della cultura di Guido Vigna Marsilio Editori Storia
Dalle origini ai nostri giorni Parlare di più di duemila anni di storia in 288 pagine può sembrare di primo acchito una missione impossibile, ma se, senza trascurare nulla, si espongono cronologicamente le vicende di una città senza approfondire la cosa diventa possibile ed è quello che ha fatto Guido Vigna, giornalista mantovano che con questo libro, di agevole lettura, ha inteso evidentemente fornire un testo affinché i mantovani, ma anche i tanti turisti possano avere almeno un’idea di cosa sia questa entità urbana, talmente bella da diventare patrimonio mondiale dell’umanità. Il periodo storico affrontato è indubbiamente assai lungo e aggiungo che addirittura non si è in grado di sapere con certezza quando Mantova è stata fondata; si parte ovviamente dal mito che Virgilio riporta nell’Eneide, di quella profetessa Manto, figlia di Tiresia, che avrebbe dato il nome alla città. Se però ritorniamo con i piedi sulla terra, c’è una buona probabilità che sia stata fondata dagli Etruschi nel VI secolo a.C. e poiché fra le divinità di quel popolo c’era quella dell’oltretomba chiamata Manth si può anche logicamente ipotizzare che il nome del dio sia stato esteso all’abitato. Poi seguono i periodi delle dominazioni celtiche, romane, delle calate dei barbari, dei Longobardi, dei Franchi, del libero comune per arrivare alla Signoria dei Gonzaga, ricchi agricoltori che in verità si chiamavano Corradi, ma che per la nobiltà acquisita assunsero come cognome quello del luogo di provenienza. E’ fuor di dubbio che il rinascimento è stato il periodo più bello, di autentico splendore di questa città a vocazione prettamente agricola, poi c’è stata la decadenza, l’estinzione della dinastia, l’avvento degli austriaci, indi quello dei francesi, di nuovo degli austriaci e infine, dal 1866, del Regno d’Italia. La storia, però, anche quella raccontata da Vigna non si ferma qui, perché arriva fino ai nostri giorni, con il dopo guerra che vede il sorgere di tante realtà industriali, che a partire dalla fine dello scorso secolo si ridimensionano alquanto, con diverse cessazioni di attività. Se non fosse per le ciminiere, alcune ormai da tempo spente, che costellano la periferia, si potrebbe quasi dire che il tempo si è fermato e in effetti nel bel centro storico e nelle vie adiacenti, con le antiche dimore, si può ancora respirare l’atmosfera di un tempo andato, così che, grazie a quei campagnoli venuti da Gonzaga, Mantova è andata riscoprendo la sua vera vocazione, cioè di essere meta del turismo che accorre a frotte a estasiarsi di fronte alla più bella camera del mondo, la camera picta realizzata da Andrea Mantegna, o a meravigliarsi per le sale affrescate dello splendido palazzo Te che porta la firma di Giulio Romano, e per tante altre bellezze che meriterebbero di essere almeno citate, ma che per ragioni di spazio sono costretto a omettere. Oggi come oggi la città vive del riflesso di quel periodo aureo in cui si affollavano a Mantova pittori, scultori, architetti, poeti e musicisti, un trionfo di opere d’arte in parte emigrate verso altri lidi o andate disperse, ma quel che resta basta a testimoniare una grandezza culturale di cui non solo i mantovani, ma tutti gli italiani devono essere orgogliosi. Da leggere. Guido Vigna (Mantova, 1942) ha scritto per molte grandi testate: dal «Corriere della Sera» a «Repubblica», dal «Giorno» all’«Avvenire», dalla «Domenica del Corriere» al «Mondo». Ha lavorato in Rai, a Prima Pagina, con la rubrica Vocabolariando, e pubblicato, per Rusconi, le biografi e di Ezio Vanoni e Pasquale Saraceno. Dissacratore per vocazione, a cominciare da se stesso, colleziona necrologi sognando di scrivere con essi una Spoon River italiana. Ha creato iniziative diventate famose: Un Natale di Libri a Bolzano e Titolo e Copertina dell’anno, premio giornalistico ideato per la Ferrari di Trento.
6 Maggio
Nome d’arte Doris Brilli. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò di Andrea Vitali Garzanti Editore Narrativa romanzo Lo scandalo “Cavallo vincente non si cambia” e Andrea Vitali ha fatto proprio questo motto, perché in tutti i suoi romanzi segue uno schema prefissato e ben collaudato. Infatti scrive due storie agli inizi apparentemente senza nulla in comune, poi le vicende procedono parallele, cominciando ad avvicinarsi all’incirca da metà dell’opera per convergere su un’unica linea nelle ultime pagine. E così è anche questo il caso di Nome d’arte Doris Brilli che inizia quasi in sordina con la bellanese Desolina Berilli fermata a Milano a Porta Ticinese in seguito a una lite in pubblico con un giornalista del Popolo d’Italia, il giornale diretto dal fratello del Duce. E’ inutile dire che, ragioni a parte, il pericolo di un intervento del potente Arnaldo Mussolini fa decidere la polizia di rimandare a Bellano la signorina, appassionata di teatro e di operette, con buone doti canore e di recitazione, tanto che si esibisce al momento in spettacolini di quart’ordine con il nome d’arte di Doris Brilli. Contemporaneamente, al paese natale troviamo il vicedirettore del cotonificio, perito industriale Delmerio Passanò, tirchio come uno scozzese, alle prese con i tentativi di maritare con un buon partito la figlia Giannetta. In mezzo, o meglio ancora vicenda nelle vicende, abbiamo il maresciallo Maccadò, di fresca nomina e di altrettanto fresco matrimonio, uomo dotato di intelligenza, a differenza dei carabinieri delle barzellette, e anche non privo di umanità, quasi una garanzia per il buon esito del romanzo. Prende corpo così una commedia degli equivoci, che vedrà coinvolti anche altri personaggi, invenzioni fortunate dell’autore, che fra una tabacchiera che scompare per poi riapparire, il pericolo, che si rivelerà infondato, che uno dei protagonisti sia affetto da tubercolosi, pranzi con intenti matrimoniali e tutta una serie di situazioni comiche arriverà a tambur battente alla fine con la scoperta di quello che ancor più all’epoca (siamo nel ventennio) si sarebbe potuto definire un grosso scandalo. E’ inutile che aggiunga altro, perché non voglio far cadere la suspense che è una delle caratteristiche positive di questo romanzo che accompagna il lettore dall’inizio alla fine con il consueto garbo proprio di Vitali, consentendo di trascorrere alcune ore in una sorta di gradevole evasione. Dopo aver frequentato «il severissimo liceo Manzoni» di Lecco, Andrea Vitali si laurea in medicina all'Università Statale di Milano ed esercita la professione di medico di base nel suo paese natale.
3 Maggio
Nel fiato umido dell’autunno di Mariangela De Togni Prefazione di Silvia Castellani Fara Editore poesia
Un’intensa spiritualità E tre, nel senso che tante sono le sillogi poetiche di Mariangela De Togni che ho letto e ho apprezzato: dal mistico abbandono di Frammenti di sale a l’essenza di Dio in Si può suonare un notturno su un flauto di grondaie?, per arrivare a questa Nel fiato umido dell’autunno, fresca fresca di stampa. Poiché l’autore è una religiosa (è una suora delle Orsoline di Maria Immacolata) sarebbe stato logico attendersi una poesia eminentemente religiosa, quasi un’opera teologica, e invece Mariangela De Togni riesce a parlare di Dio attraverso le infinite meraviglie del Creato. Questa impostazione presenta due pregi, di cui il primo è essenzialmente poetico e il secondo è tale da rendere maggiormente fruibile in concetto di Onnipotente, quasi un messaggio, un’evangelizzazione in versi che raggiunge facilmente e con particolare efficacia il lettore. In ogni manifestazione della natura, da un cielo a un umile fiore c’è Dio, c’è un qualche cosa di indefinibile che presiede perfettamente a tutte le cose, al moto del mare, all’avvicendarsi del giorno con la notte, alla vita di ogni essere ed è quel mistero che non può essere svelato con metodologie scientifiche, ma solo ed esclusivamente con la fede. Bearsi della natura vuol dire così bearsi di Dio, lasciarsi andare a quell’onda lunga dell’emozione che sola può saziare il nostro spirito. Le occasioni possono essere tante, i temi altrettanti, ma lo scopo e il risultato è sempre quello, come, per esempio, in Fu il sospiro della notte (Un cupo blu di Prussia / s’adagia sui pioppi, / carichi di pensiero, / mentre rapite dal vento / le nuvole / vagano senza meta / nel silenzio dei chiostri / simili a cumuli di cirri / addensati sul mare. /…), oppure come nella brevissima Eco (Eco ma di altre maree / e di altre aurore. / E di cieli stellati diversi.). Oserei dire che la poetessa è permeata, prima ancora che di religiosità, di spiritualità, che sono due termini che potrebbero sembrare uguali, ma non lo sono, perché per il secondo non c’è necessità di insegnamento, non ci sono regole o dogmi, c’è solo un grande sentimento innato che si traduce in una crescita interiore che può completarsi con la religiosità. Le sensazioni che ritrae dall’osservazione della natura sono percorsi di spiritualità che approdano poi alla religiosità e per chi legge è più facile comprendere e credere, e questa è un’altra notevole valenza dell’ars poetica di Mariangela. Non si può restare insensibili a versi come quelli che seguono, parole sapientemente accostate che toccano quelle vette sublimi che più facilmente consentono di accostarsi a Dio: La notte vedi le stelle / più chiare dell’acqua del mare, / più bianche delle ninfee, / a tessere tele di luce / sulla finestra a bifora / della chiesa vuota. / Ricucendo ombre solitarie / nel vento d’autunno. // I ricordi sono linfa / dei nostri pensieri, /armonia di voci / nel lento solfeggiare / del sospiro. E poi ce n’è un’altra brevissima che più esplicativa di così non potrebbe essere: Ma il mare è come l’anima, / e non fa silenzio mai. / Nemmeno quando tace. Non credo sia necessario aggiungere altro, se non l’invito a leggere questa raccolta che, forse, è la più bella di Mariangela De Togni. Mariangela De Togni, nata a Savona, è suora delle Orsoline di Maria Immacolata (Piacenza). Insegnante, musicista, studiosa di musica antica. Membro dell’Accademia Universale “G. Marconi” di Roma, ha pubblicato le raccolte di versi: Non seppellite le mie lacrime (1989),Nostalgia (1991), Una Voce è il mio silenzio(1995), Chiostro dei nostri sospiri (1998), Profumo di cedri (1998), Un saio lungo di sospiri (2000), Flauto di canna (2004), Nel sussurro del vento (in Quaderni di Letteratura e Arte, 2005), Nel silenzio della memoria (ne Le visioni del verso, 2008), Cristalli di mare (2010), Fiori di magnolia (2011), Frammenti di sale (2013), Si può suonare un notturno su un flauto di grondaie? (2016, prima classificata al Faraexcelsior). È presente nel Dizionario della Biblioteca di Stato, in agende, antologie, blog e riviste di poesia contemporanea. Numerosi i premi e i riconoscimenti.
1° Maggio
Scrivere è più di vivere di Ferdinando Camon Guanda Editore Saggistica politica e attualità
Uno sguardo sul mondo Nel 2006 Ferdinando Camon ha riunito in un volume (Tenebre su tenebre) una serie di pensieri, ragionamenti, meditazioni, ricordi, scritti nel corso di circa tre lustri in concomitanza con i fatti più eclatanti della storia e della cronaca, come guerre, encicliche, omicidi, suicidi, fenomeni sociali di vario genere, tutti eventi che, senza che magari ce ne accorgiamo, incidono in modo determinante sulla nostra vita. Poi è passato del tempo, ma l’abitudine di osservare, di riflettere su certi comportamenti, su ciò che un occhio attento può cogliere anche nel quotidiano della vita non è cessata ed ecco allora che il risultato di quel lavorio della mente, a volte apparso già su quotidiani e periodici, è stato riunito in unico volume, appunto questo Scrivere è più di vivere. Tengo a precisare, a beneficio di chi per la prima volta si accosta alla scrittura di questo grande artista, che Camon è una persona un po’ fuori dei canoni, certamente non allineata e pertanto anche scomoda, politicamente scorretta insomma, pur tuttavia senza essere anarchica, ed è forse quest’ultima caratteristica che rende più interessanti i suoi articoli, che non ribaltano, non capovolgono giudizi, ma che richiamano l’attenzione su fatti che, sovente partendo dal particolare, possono pervenire a una generalizzazione sicuramente di maggior rilievo. Il suo, poi, è uno stile che non appesantisce la lettura e che si presenta semplice, ma contemporaneamente efficace; come prima ho scritto, alcuni di questi articoli, editoriali, elzeviri mi erano già noti perché apparsi nel tempo sulla stampa, mentre altri invece sono nuovi e in genere si tratta di brevi riflessioni e anche di aforisma. In ogni caso, sono in grado di interessare ampiamente, come il caso dell’esame universitario superato, con l’esito trascritto sul libretto personale, ma non sul registro. Qualcuno potrà pensare che in fondo si tratta di un banale errore e in effetti in una società non a compartimenti stagni sarebbe stato risolto, subito e senza difficoltà, a tutto vantaggio dello studente Camon vittima dell’incidente. Purtroppo non fu così, perché i professori universitari, non sempre, ma spesso, si credono infallibili, ma quel che è peggio è un’altra cosa, vale a dire la consorteria mafiosa che all’epoca e credo anche adesso esiste negli atenei. Quante a volte avete sentito parlare dei cosiddetti baroni? Ecco, questo è stato un caso che ha confermato la loro esistenza e che la mafia non è prerogativa solo di certi ambienti siciliani. In ogni caso Camon non attinge solo da esperienze personali, purché abbiano una valenza di essere generalizzate, ma cerca anche di smontare i falsi miti di un passato che sono sempre presenti nel nostro paese, come nel caso di Cadorna, il generalissimo che con la sua insensata strategia e la sua indifferenza mandò a morire, per niente, centinaia di migliaia di soldati italiani. Destituito dopo Caporetto, l’indagine su di lui, come spesso accade nel nostro paese, si concluse con un nulla di fatto, tanto da restare celebre e da meritare il suo cognome nelle toponomastiche di diverse città. Camon ne avrebbe voluto la cancellazione dal piazzale che sta davanti alla ex caserma dei Vigili del Fuoco a Udine, prima di una lunga serie di cancellazioni che avrebbe ridato una giustizia postuma ai nostri soldati caduti nella Grande Guerra. Mi risulta che sia stato accontentato, ma la ricaduta a valanga non c’è stata e ancora adesso, quando vado in giro, non è infrequente che mi imbatta in piazze e strade intestate a quest’uomo che soprattutto difettava di umanità. Poi ci sono semplici osservazioni con opportune conclusioni, come quella che riporto di seguito intitolata Contro di noi: Ci sono immigranti che vengono per vivere in mezzo a noi, e possono restare; altri che vengono per vivere accanto a noi, e possono restare; altri che vengono per vivere contro di noi, e non possono restare. Una conclusione che è ineccepibile e che non può portare a considerare razzista l’estensore, perché il suo è un ragionamento del tutto logico, indipendente pertanto da qualsiasi ideologia. Non posso andar oltre per ragioni anche di spazio, ma credo che per chiudere questa recensione non ci sia nulla di meglio di questo aforisma, che condivido totalmente: Per invecchiare felici non occorre essere felici, basta vedere felici coloro tra i quali s’invecchia. A un certo punto della vita, la felicità è la visione della felicità altrui. Da leggere, centellinando, nei momenti di relax, in quelli di sconforto, in quelli assai più rari di felicità, in poche parole, anzi in una sola, sempre. Ferdinando Camon è nato in provincia di Padova. In una dozzina di romanzi (tutti pubblicati con Garzanti) ha raccontato la morte della civiltà contadina (Il quinto stato, La vita eterna, Un altare per la madre – Premio Strega 1978), il terrorismo (Occidente, Storia di Sirio), la psicoanalisi (La malattia chiamata uomo, La donna dei fili), e lo scontro di civiltà, con l’arrivo degli extracomunitari (La Terra è di tutti). È tradotto in 22 paesi. Il suo ultimo romanzo è La cavallina, la ragazza e il diavolo (2004). Nel 2016 ha vinto il premio Campiello alla Carriera.
26 Aprile
Il ferro e la polvere Una storia inaspettata di Mauro Guido Editoriale Sometti Narrativa romanzo storico
L’angoscia di un periodo storico La Seconda guerra mondiale è quel grande tragico evento che vide coinvolto anche il nostro paese e su cui tanto si è scritto, sia come saggistica storica che come romanzi storici veri e propri, questi ultimi per lo più legati al fenomeno della Resistenza; però, di come abbia vissuto quel periodo la popolazione civile italiana si è parlato ben poco, e in queste limitate prose non ne rientra nemmeno una su Mantova. Eppure, anche di lì è passata la guerra, anche le sue case hanno subito i bombardamenti alleati con numerose vittime, anche sul selciato delle sue vie è risuonato dopo l’8 settembre 1943 il rumore degli scarponi chiodati dei soldati tedeschi, che, come loro abitudine, non hanno certo lasciato un buon ricordo, rendendosi colpevoli di eccidi che non avevano giustificazione. A questa gente comune che ha sopportato in silenzio, non ponendosi a fianco dell’uno o dell’altro contendente nel corso della guerra civile che ha insanguinato l’Italia dall’armistizio dell’8 settembre 1943 alla liberazione del 25 aprile 1945, qualcuno ha voluto pensare, consapevole che si trattò della stragrande maggioranza di chi all’epoca pativa il freddo, la fame e la paura. E questo è un merito che va dato a Guido Mauro, ex direttore di banca, ora in pensione, spronato da un suo vecchio insegnante di diritto ed economia, il professor Leonello Levi, che ha all’attivo alcune pubblicazioni di altro genere. Ecco quindi quale è lo scopo di questo libro, basato rigorosamente su fonti documentate e che quindi, anche come impostazione, più che un romanzo storico potrebbe essere classificato come storia romanzata. Per far questo l’autore è ricorso alla fantasia, inventando il ritrovamento, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio alla fine degli anni settanta dello scorso secolo, di una cassetta contenente le pagine di un diario scritto subito dopo l’armistizio dell’8 settembre. E’ un escamotage non nuovo, a cui a suo tempo sono ricorso pure io per due miei racconti, e che ha però il pregio di rendere più facilmente presente il lettore ai fatti raccontati, con in cambio, tuttavia, l’inconveniente che alla lunga finisce con l’annoiare. Chi ha tenuto quel quaderno di memorie è un tipografo, di modesta cultura, a suo tempo fascista convinto in forza dell’indottrinamento giovanile, ma ora vacillante di fronte allo sfacelo non solo di un regime, ma di una intera nazione. Per accattivare maggiormente il lettore è stato inventato un altro personaggio, un capitano austriaco che negli anni 20, quando era un bambino affamato in una Vienna allo sbando, come altri suoi coetanei venne ospitato per un certo periodo da famiglie italiane, fra le quali alcune mantovane. Sebbene venga ritrovata l’antica amicizia l’italiano diffida dell’austriaco e questo, benché consapevole dell’esito avverso della guerra, prosegue ottusamente nell’obbedienza cieca, anche se del sogno dello spazio vitale del popolo tedesco non c’è più traccia. I giorni scorrono, le restrizioni, non solo alimentari, aumentano, i soldati del Terzo Reich compiono degli eccidi crudeli, i bombardamenti aerei martirizzano la città, più che la paura è l’angoscia che prende il sopravvento e che diventa palpabile. E quando il tipografo decide da che parte stare il diario si interrompe, lasciando come un vuoto greve, senza possibilità di conoscere quello che dovrebbe essere accaduto. L’interruzione brusca, che può lasciar pensare a un seguito infausto, ha anche il pregio di evitare la noia che, come ho sottolineato, inizia a prendere il lettore di un diario quando le pagine di questo cominciano a essere tante. Il libro in pratica finisce lì, fatta eccezione per una breve nota in corsivo e per le conclusioni dell’autore, conclusioni a cui ormai è tempo che arrivi pure io. Si tratta dell’opera prima di Mauro Guido e sconta inevitabilmente un po’ di mancanza di esperienza, anche se è doveroso dire che lo scopo prefissato è stato raggiunto e che il lettore si è fatta un’idea abbastanza esatta di ciò che fu quel periodo per la maggior parte degli italiani. E questo è un merito, di fronte al quale si possono perdonare alcune ingenuità, quali i ragionamenti un po’ troppo approfonditi di un tipografo dal modesto livello culturale. Lo stile è semplice, ma non elementare, e l’italiano è corretto, una caratteristica che diventa sempre più rara in campo letterario. Insomma Il ferro e la povere non è probabilmente un capolavoro, né le aspettative avrebbero potuto essere in tal senso data anche l’inevitabile inesperienza, ma è la positiva e convincente prova di esordio di un nuovo narratore. Mauro Guido è nato a Mantova nel 1959. Dopo il diploma in Ragioneria, è stato bancario per trentanove anni. Il ferro e la polvere è il suo primo romanzo, concluso nel corso dei primi sette mesi di pensionamento.
24 Aprile
Sangue di Giuda di Milvia Comastri Giraldi Editore Narrativa romanzo
Quattro donne alla deriva Mio nonno, che forse era un po’ maschilista, diceva che una casa con due donne e senza un uomo su cui potessero sfogare le loro frustrazioni era un posto infernale; non riesco a immaginare, pertanto, come potrebbe essere una dimora in cui vivono quattro donne, peraltro di tre generazioni. E questo libro parla appunto di quattro persone di sesso femminile, strettamente imparentate, che risiedono nella stessa abitazione, ma quasi come estranee, perché nel tempo si è accumulata una indifferenza che a poco a poco è diventata rancore e che ha fatto sì che pur così vicine diventassero così lontane. Abbiamo così modo di conoscere Celeste, la più anziana, che da da anni non esce e sta rintanata in casa e la cui vita sembra imperniata su quei tre pacchetti giornalieri di sigarette di cui non riesce a farne a meno e la cui unica preoccupazione è la nipotina Mira, a parte la litania di una continua imprecazione, quel Sangue di Giuda che dà il titolo all’opera; poi c’è una donna a cui la vita sembra aver negato tutto o quasi e che risponde al nome di Assunta, figlia di Celeste; indi è presente, quando non in giro in cerca di una velleitaria scrittura, Nadia, la bella Nadia, altra figlia di Celeste e madre di Mira, una donna che senza sosta spera di sfondare nel mondo del cinema e che ha numerosi rapporti sessuali con uomini diversi, relazioni fugaci che illusoriamente scambia per amore, e infine l’adolescente Mira, che detesta il comportamento della madre, tutta tesa a prendere sul serio quello che serio non è e viceversa. Insomma direi che è un bel campionario di donne deluse, senza un futuro, fatta eccezione per la giovane Mira che comprende che l’unico modo per fuggire da quella ragnatela domestica è di andarsene, di fuggire. C’è un’atmosfera opprimente in questo romanzo, quasi un senso di soffocamento tombale e il lettore arriverà a conoscere con gradualità il carattere delle quattro protagoniste e a comprendere cosa si celi in realtà dietro un palpabile alone di mistero. Ma non ci sono solo donne, c’è pure qualche uomo, e direi che i protagonisti maschili non ci fanno una gran bella figura, ma del resto questo è in tutto e per tutto un libro al femminile, in un mondo di sentimenti tipici di questo sesso e con dei risvolti, sul finale, un po’ melodrammatici che personalmente avrei stemperato, ma io sono un uomo e non una donna. Una cosa è certa, il romanzo di esordio di Milvia Comastri, che fino a ora aveva pubblicato solo prose più brevi, è una rappresentazione intimistica di quella che dovrebbe essere una normale famiglia e non lo è, perché è evidente che non è il vivere sotto lo stesso tetto che fa un’autentica famiglia, e in questo senso sembra quasi rappresentare un’istituzione passata, con la sua storia particolare propria di certe saghe del secolo scorso. Non è facile, in questi casi, esporre ciò che si sente, si corre anche il rischio di infarcire il tutto con dei flash back, che per fortuna l’autrice è riuscita a limitare. Eventualmente ciò che può frenare il lettore è costituito dalle prime pagine, che appaiono abbastanza nebulose e che potrebbero anche distogliere l’attenzione, o addirittura far cessare la lettura. Però, basta superare questo scoglietto, e le cose diventano più semplici, la nebbia si schiarisce e il romanzo fluisce senza inciampi. L’argomento non è di quelli che rientra propriamente nei miei gusti e pur tuttavia devo dire che è riuscito a interessarmi e che quindi questo esordio in una prosa lunga può essere considerato complessivamente positivo e soddisfacente. Milvia Comastri ha pubblicato tre raccolte di racconti: Donne, ricette, ritorni e abbandoni (Pendragon 2005), Colazione con i Modena City Ramblers (Historica 2012), Squilibri (Antonio Tombolini Editore 2014) e suoi contributi sono presenti in molte antologie. Questo è il suo primo romanzo.
20 Aprile
Nel peggiore dei modi. Le inchieste del commissario Cavallo di Flavio Villani Neri Pozza Editore Narrativa romanzo giallo
Attenzione, dà assuefazione Corre l’anno 1990 e in una giornata nebbiosa, opprimente, fetida, come solo un certo tempo atmosferico sa essere presente a Milano, un padre porta suo figlio a scuola, ma prima di arrivare a destinazione si ferma da un tabaccaio per comprare le sigarette, non senza aver prima parcheggiato l’auto nei pressi con il bimbo a bordo. Esce dal negozio, gli si fa incontro un uomo alto, con una caratteristica non ben definibile di uno degli arti superiori, forse vuole solo un po’ di fuoco per accendere, ma invece gli spara due colpi di pistola che lo accasciano sul marciapiedi e quando il corpo è a terra ne viene sparato un terzo, quello di grazia. Inizia così il secondo romanzo poliziesco scritto da Flavio Villani e che vede ancora una volta all’opera il commissario Cavallo, lo stesso del primo episodio, tanto per intenderci quello della donna assassinata il cui corpo sezionato viene trovato in una valigia del deposito bagagli della stazione Centrale di Milano. Come al solito la trama è piuttosto intricata, complicata nel caso specifico da una guerra fra elementi della mafia e della ndrangheta; è fra sparatorie, scomparse definitive e morti ammazzati che si muove questo poliziotto di origini meridionali, coscienzioso e onesto, non disposto a chiudere gli occhi o per fare carriera o per pregiudicare quella già fatta. In fin dei conti Cavallo ha il pregio di essere l’uomo della porta accanto, il vicino di casa che alla mattina parte presto per il lavoro e ritorna sempre tardi, senza nessuna mania di protagonismo, consapevole che il suo destino è solo quello di fare, sempre e comunque, il proprio dovere. Lo coadiuva il più giovane ispettore Montano, che più che un fratello minore sembra un gemello, almeno come modo d’essere e di fare, e la sua è una collaborazione preziosa, perché non è solo capace di obbedire, mettendo in pratica nel migliore dei modi le direttive del superiore, ma ha anche delle opinioni che nel contesto di un’indagine risultano sempre preziose. La trama, come ho detto prima, è piuttosto intricata e il tutto ha origine molti anni prima, all’epoca degli anni di piombo, con il massacro di un giovane di estrema destra, un episodio delittuoso che sembrava dimenticato, ma si sa che il destino, prima o poi, presenta sempre il conto. E’ superfluo dire che Cavallo riuscirà a venire a capo dell’indagine, di per sé difficile, ma ancora più complessa e delicata perché gli investigatori devono muoversi sul terreno minato della politica, con il commissario che non arretra, non si fa mai da parte, perché lui vuole solo e sempre arrivare alla verità, assicurando alla giustizia il colpevole. Flavio Villani è un narratore di razza e lo conferma con questa sua seconda opera, dal ritmo costante, dall’ambientazione perfetta, dalle atmosfere ricreate in modo quasi prodigioso, caratteristiche tutte che avvincono il lettore e che lo inducono a superare la stanchezza, a non fermarsi mettendo un segnalibro, perché è quasi maniacale il desiderio di andare avanti, per sapere cosa accadrà, chi è il misterioso assassino, quali sono i complici, quale è il movente. Ci sarebbe infine da dire che i libri di questo giallista milanese danno assuefazione, come una droga, ma a differenza di questa non fanno male al fisico e anzi sono un toccasana per la mente. Flavio Villani è nato a Milano nel 1962. Neurologo, ha lavorato negli Stati Uniti come ricercatore nel settore della neurofisiologia. Come scrittore ha esordito con L’ordine di Babele (Laurana, 2013), seguito dal poliziesco Il nome del padre (Neri Pozza, 2017), con protagonista il viceispettore Cavallo. Nel 2018 Villani ha pubblicato un secondo romanzo giallo, dal titolo Nel peggiore dei modi (Neri Pozza).
17 Aprile
Nuove anime di Vincenzo D’Alessio Prefazione di Alessandro Ramberti Note critiche dei giurati Nicoletta Mari e Colomba Di Pasquale Fara Editore Poesia
Ragione e sentimento E’ da un po’ di tempo che ho l’opportunità, e la fortuna, di leggere la produzione poetica di questo autore avellinese, che a definirlo un cantore del Sud è volerlo considerare a tutti i costi un artista stanziale, cioè abbarbicato alla sua terra e alla sua gente, che costituiscono la tematica delle sue liriche. In effetti, se è pur vero che Vincenzo D’Alessio trae ispirazione dalla natura dei suoi luoghi, dalle tradizioni, ma anche dalla disperazione della sua gente, la sua è una voce che si leva forte e chiara contro le ingiustizie sociali e avverso una pratica egoistica ed edonistica volta a corrompere e a distruggere l’ambiente in cui viviamo. E anche dove sembra che il discorso poetico tragga fonte dall’analisi introspettiva del proprio animo, questa lacerante invocazione per un mondo migliore, alla fin fine, è sempre presente (C’era una volta un paese felice / dove la gente pensava al lavoro /ogni giorno benediceva, quello /che i campi donavano loro / passarono gli anni e fuori dal paese / sorsero case, fabbriche e chiese / la gente allora lasciò i campi /per guadagnare e… andare avanti / ma il sole sorge, come ogni giorno, / sulle ricchezze, sciagure ed orgoglio, / e quella terra, ormai morta, / diventa schiava di altra sorte / c’era chi pianse e chi ancora aspetta / che dalle Alpi ritorni suo figlio / ma come i campi anche lui muore / in un silenzio che fa male al cuore /….). Questi versi sono parte della prima poesia e ben evidenziano il mutamento economico, sociale e culturale che ha interessato le zone eminentemente agricole del meridione, con uno sradicamento indelebile e il tormento di chi ha preso coscienza che il benessere tanto promesso, e solo in parte concretizzato, porta a un malessere interiore che lentamente distrugge la vita. Tuttavia, pur restando stilisticamente non ricercato, per quanto di indubbia efficacia, constato con vivo piacere che D’Alessio ha voluto mettere alla prova la sua poeticità dipingendo immagini di celestiale bellezza, ricorrendo ad artifizi letterari che impreziosiscono senza gravare ( Scolora il seppia del fondo / dove raggiante il tuo viso riluce / profuma di rose intatte nel tepore / di maggio,.../… oppure anche chissà cosa pensa il buio / mentre dormiamo avvolti /nello scialle della notte /…). C’è una ricercatezza di immagini, ma anche di suoni (provate a leggerle a voce) prima non rara, ma nemmeno frequente, come se l’autore, senza perdere di vista le tematiche a lui care, avesse deciso che rinchiudere un quadro già bello in una cornice azzeccata avrebbe ulteriormente impreziosito l’opera, e così infatti è stato. E poi ho colto forse un’altra caratteristica delle poesie di questa raccolta: sembrano sgorgate direttamente dall’anima in un lavoro sinergico con la mente che ha smussato i toni, ha addolcito là dove era necessario, ha calcato la mano dove più evidente doveva essere il messaggio, ha instaurato un dialogo muto con il lettore, in un abbraccio di parole e di sentimenti a cui è piacevole abbandonarsi. Così il poeta si svela, eliminato il naturale pudore, e ciò trova conferma anche in questi tre significativi brevi versi (anima mia, poesia / né occhi né bocca /nuda al mondo). Vincenzo D’Alessio continua a emozionarmi con la sua poesia che anche quando parla di morte è ricerca di vita, che anche quando piange le miserie di un mondo che appare sconfitto lascia tuttavia intravvedere una sua possibile resurrezione; quindi, leggere le sue sillogi fa bene, è una tremula, ma indomita luce che brilla nelle tenebre di un mondo che solo l’amore potrà salvare. Vincenzo D’Alessio (Solofra 1950), laureato in Lettere all’Università di Salerno, ha ideato il Premio Città di Solofra, fondato il Gruppo Culturale “Francesco Guarini” e l’omonima casa editrice. Acuto e attento critico letterario, ha pubblicato saggi di archeologia e storia, recensioni e versi in numerosi periodici, antologie, siti e blog (in particolare Narrabilando e Farapoesia). Raccolte poetiche per i tipi di Fara: La valigia del meridionale e altri viaggi(2012, 20162); Il passo verde (in Opere scelte, 2014); La tristezza del tempo (in Emozioni in marcia, 2015) e Alfabeto per sordi in Rapida.mente, 2015) poi in appendice a Immagine convessa (2017), opera finalista al concorso Versi con-giurati. Nel 2017 è uscita la raccolta Dopo l’inverno, II class. al Faraexcelsior, III premio del Concorso Terra d’Agavi 2018 (Gela, AG), segnalata al Premio Civetta di Minerva (Summonte, AV), finalista al Premio Tra Secchia e Panaro 2018 (Modena). Del 2018 sono i Racconti di Provincia.
16 Aprile
Il Mistero della Statuetta Egizia di Marco Giorgini Kult Virtual Press Narrativa per ragazzi
L’antico Egitto a Modena Devo ammettere che delle mie letture da ragazzo ho solo un vago ricordo, sia per il non indifferente tempo trascorso, sia anche perché all’epoca non è che per casa circolassero molti libri, soprattutto per il loro costo per niente trascurabile se confrontato con le modeste entrate familiari; aggiungo che il sistema del prestito bibliotecario non era così diffuso come oggi, che le biblioteche erano poche e che non avevano molti titoli. A mente mi sovvengo di alcune opere: Senza famiglia, un romanzo strappalacrime con protagonista un orfano, L’isola del tesoro, Robinson Crusoe e Ivanhoe, tre opere queste che vuoi per l’impronta avventurosa, vuoi per il fatto che consentivano ampi spazi allo sviluppo della fantasia mi risultarono particolarmente gradite. Da allora sono passato a una letteratura più complessa adatta agli adulti, anche se di tanto in tanto non ho mancato di chiedermi come dovesse essere la narrativa per ragazzi negli anni che vorticosamente sono seguiti, con mezzi di conoscenza che ai miei tempi erano impensabili, dalla televisione al personal computer. L’occasione per soddisfare la mia naturale curiosità è venuta con la pubblicazione di un romanzo di un amico, Il Mistero della Statuetta Egizia,di cui molto gentilmente mi è stata fatta avere una copia. Devo dire che ho cominciato la lettura cercando di immedesimarmi in un ragazzo, cioè tornando ai 12-13 massimo 14 anni, un’età per me lontanissima e infatti non ci sono riuscito, e allora ho deciso di accostarmi all’opera scevro di pregiudizi e cioè, in particolare, il testo non doveva essere diverso da quelli che comunemente leggo e recensisco, con l’unica avvertenza che in questo tipo di narrativa non ci devono essere complicazioni, i personaggi devono avere caratteristiche ben precise (o del tutto buoni, o del tutto cattivi), la trama deve costituire il quasi esclusivo elemento di giudizio. Così ho fatto e se devo essere del tutto sincero dico pure che la lettura mi ha divertito, avvincendomi, tanto che mi ha reso partecipe dell’impresa di questi tre ragazzini modenesi alle prese con un mistero egizio, il cui lato più inquietante è dato dalla materializzazione di Anubi, il dio con la testa di cane, il protettore del mondo dei morti, e poiché la trama in queste opere è tutto, o quasi tutto, non aggiungo altro. Comunque, per quanto abbia limitato il mio metodo di esaminare il romanzo, non ho potuto fare a meno di verificare altri aspetti e ho fatto bene. Infatti l’italiano con cui è scritto è corretto, cosa che dovrebbe essere scontata, ma sempre più spesso non lo è, addirittura anche nel caso di autori contemporanei che vanno per la maggiore; l’ambientazione, per quanto sia il risultato di descrizioni non approfondite, tuttavia è esposta bene, visto che le linee essenziali sono chiare e assai indicative, l’atmosfera di suspense c’è tutta e regge fino alla fine, le caratteristiche dei personaggi sono abbozzate, ma visto l’età dei lettori ai quali è soprattutto indirizzato il libro va bene così. Insomma, Il Mistero della Satuetta Egizia non sarà un libro destinato a costituire una pietra miliare della letteratura, ma è un prodotto ben confezionato, un romanzo che sono più che convinto potrà piacere alla maggior parte dei ragazzi a cui è destinato e anche ai loro genitori, purché abbiano la volontà di leggerlo togliendosi di dosso la maschera di adulti. Marco Giorgini, nato a Modena nel 1971, lavora nel campo mdella linguistica computazionale. Per hobby sviluppa videogiochi e gestisce una delle più antiche e-zine italiane, KULT Underground. Da sempre appassionato lettore, si è dilettato negli anni a scrivere racconti. Questo è il suo primo romanzo per ragazzi.
6 Aprile
I piccoli fuochi di Ben Pastor Sellerio Editore Palermo Narrativa romanzo giallo Indagine in Bretagna Sarà per la pioggia che cade di frequente, o anche per l’atmosfera onirica di cui è impregnato, ma I piccoli fuochi è un romanzo che si stacca decisamente da quelli che ho letto finora, scritti da Ben Pastor e con protagonista l’Ufficiale dell’Abwher Martin von Bora. Questa volta, di stanza a Parigi, viene inviato in Bretagna per indagare sul misterioso omicidio della moglie di un ammiraglio tedesco e, come se non bastasse, per cercare di capire che cosa sia andato a fare là un capitano dell’esercito, dal nome assai famoso, Ernst Junger. La trama non è delle più semplici, anzi è decisamente complessa e intricata, anche perché a quell’omicidio se ne aggiungono altri due e Bora dovrà ricorrere a tutte le sue ben note capacità per arrivare alla soluzione del caso, aiutato anche da un medico francese e, soprattutto, da Ernst Junger. E’ inutile e anche irrispettoso che cerchi di spiegare altro della vicenda, veramente ad alta tensione, perché quel che mi preme evidenziare è l’atmosfera, in cui accanto a piccoli accenni a riti celtici predomina un senso di oppressione con notti che sembrano occasioni per passeggiate di fantasmi, scricchiolii, squittii che potrebbero far pensare ad animali, ma anche a oscure presenze. Nell’esecuzione degli omicidi, nel ritrovamento dei corpi e nell’aspetto dei cadaveri si inserisce una tensione che richiama quel senso delle tenebre come fonte di ogni pericolo, come immersione totale in uno spazio non più terreno che è proprio del gotico. Non siamo nella scia di Il castello di Otranto di Horace Walpol o di Frankenstein, di Mary Shelley, ma poco ci manca, e questo aggiunge un ulteriore motivo di interesse per un romanzo che, nonostante la lunghezza (ben 543 pagine) come si inizia a leggere non si vorrebbe mai smettere. Per il resto trovano conferma le notorie capacità di Ben Pastor di descrivere i personaggi, di pervenire a validi approfondimenti psicologici, non tralasciando per la figura del capitano von Bora il tradizionale dilemma del militare, vale a dire quel conflitto interiore certamente non infrequente in tempo di guerra fra la propria coscienza e il senso del dovere. Come noto, questo contrasto è sempre presente nelle opere della serie, ma in questa mi sembra più sfumato, più teso a privilegiare le reazioni umane a fronte di chi commette gravi colpe, magari spinto da un grosso torto subito. Senza venir meno al senso dell’onore e ai suoi obblighi di soldato Bora dimostra che sotto quell’aspetto controllato e freddo si cela un cuore che è capace di capire, ma senza esimersi dal punire. I piccoli fuochi è un bel romanzo, sicuramente meritevole di essere letto. Ben Pastor, nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha scritto narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico. Della serie di Martin Bora Sellerio ha già pubblicato Il Signore delle cento ossa (2011), Lumen (2012), Il cielo di stagno (2013), Luna bugiarda (2013), La strada per Itaca (2014), Kaputt Mundi(2015), I piccoli fuochi (2016), Il morto in piazza (2017) e La notte delle stelle cadenti (2018).
4 Aprile
La storia ci ha mentito. Dai misteri della borsa scomparsa di Mussolini alle «armi segrete» di Hitler, le grandi menzogne del Novecento di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Saggistica storica La verità è una chimera Le bugie o le menzogne in tempo di guerra sono pane quotidiano e poi a conflitto terminato la storia viene scritta dai vincitori, ovviamente preoccupati di non ristabilire la verità; in relazione a ciò lo scopo che si è proposto l’autore con questo saggio è di dare ascolto alle istanze degli sconfitti, senza tuttavia arrivare a determinare con certezza quella che è la verità. Infatti Arrigo Petacco ha inteso soprattutto fare l’avvocato del diavolo, ponendo in luce incongruenze, comportamenti strani già ben noti, con il tentativo, a puro livello di ipotesi, di fornire una spiegazione. Rientra in queste fattispecie anche il silente fronte occidentale per buona parte del primo anno di guerra e che sembrò frutto di una tregua non sottoscritta. I motivi di questo comportamento da parte tedesca potevano forse risiedere nell’ipotesi di arrivare a un accordo con gli anglo-francesi per un’azione comune verso l’Unione Sovietica, nonostante il patto di non aggressione sottoscritto da Stalin con Hitler; si tratta tuttavia unicamente di un’ipotesi, come quella che vide la discesa in campo dell’Italia con l’alleato tedesco solo nel giugno del 1940, in virtù di quel patto d’acciaio dalle condizioni capestro che sarebbero state sottoscritte da Ciano in difformità degli ordini ricevuti da Mussolini, ipotesi che mi sembra del tutto azzardata vista la notevole avversione per i tedeschi del genero del Duce. Insomma, almeno nella prima parte del saggio, abbiamo solo chiacchiere e non poteva essere diversamente perché gli attori dell’epoca sono morti, documenti che chiariscano non si trovano e quindi nascono delle teorie, più o meno opinabili. Molto più interessante è la seconda parte in cui si parla non solo della famosa seduta del Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio 1943, a cui Mussolini, un Mussolini stanco e preoccupato avrebbero potuto opporsi, ma anche delle testimonianze di Edda Ciano che notoriamente era in intimità con suo padre, nel senso che con lei si apriva, e che potrebbero spiegare tante cose, come tentano di fare, ma non lo fanno. Infatti il Duce, a proposito della guerra d’Etiopia, da cui sarebbero nati tutti i suoi problemi con l’opposizione di paesi colonialisti come la Francia e l’Inghilterra, avrebbe preteso di dimostrare che fu costretto proprio da queste due potenze a gettarsi nelle braccia di Hitler, nell’impossibilità di lasciargli spazio. Più che un movente, sembrerebbe una scusa per giustificare un operato francamente scellerato che portò l’Italia alla guerra e alla rovina. Mi sembra invece più plausibile il fatto che Mussolini non avesse a che fare con il delitto Matteotti, visto che gli esecutori, tutti fascisti, probabilmente volevano dare solo una lezione al parlamentare socialista, ma poi la faccenda era sfuggita loro di mano. C’è poi una terza parte in cui si parla di un Mussolini privato, sia di quando ancora non era il Duce, sia di quando lo era nel pieno esercizio delle sue funzioni; si passa così dal periodo scolastico, in cui già si ravvisava la capacità di oratore, alle gestioni dei rapporti con i parenti (sempre esosi, ma lui era stretto di manica) allorché comandava l’Italia. E c’è anche il Benito Mussolini della Repubblica di Salò, l’ombra di se stesso, un uomo che ogni tanto sogna di dar vita a uno stato effettivamente socialista, circondato dalle SS, ma anche da amici romagnoli, fra i quali quel Bombacci fondatore del partito comunista italiano. Sono illusioni, momenti di evasione, nel grigiore plumbeo di una decadenza inarrestabile e vedere l’uomo che ha comandato con il pugno di ferro l’Italia ridotto a una pura figura di rappresentanza, senza potere e senza avvenire, può muovere anche a pietà, ma non si deve dimenticare che lui, nella sua enorme vanità, pur realizzando anche cose buone, precipitò un paese e un popolo nell’orrore e nelle distruzioni di una guerra. Da leggere. Arrigo Petacco (Castelnuovo Magra 1929 - Porto Venere 2018), è stato un giornalista e inviato speciale, direttore della «Nazione» e di «Storia illustrata». Scrittore e saggista molto prolifico, ha sceneggiato numerosi film e scritto diverse trasmissioni televisive a tema storico per la Rai. Nel suo lavoro di giornalista, per il quale nel 1983 ha vinto il Premio Saint Vincent, ha avuto modo di intervistare alcuni tra i protagonisti della Seconda guerra mondiale. Tra i suoi libri, in cui affronta tematiche storiche spesso intrise di mistero e ribalta verità giudicate incontestabili, ricordiamo Joe Petrosino (1978, da cui è stato tratto uno sceneggiato Rai), Dear Benito, caro Winston. Verità e misteri del carteggio Churchill-Mussolini (1985), La nostra guerra. 1940-1945 (1997), Regina. La vita e i segreti di Maria Josè di Savoia (1998), L'esodo. La tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia (1975 e 2000), L'armata nel deserto. Il segreto di El Alamein (2002), Il prefetto di ferro. L'uomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia (1977 e 2004, da cui è stato tratto un film), L'uomo della provvidenza. Mussolini, ascesa e caduta di un mito (2006), La strana guerra. 1939-1940: quando Hitler e Stalin erano alleati e Mussolini stava a guardare (2008), Il regno del Nord. 1859: il sogno di Cavour infranto da Garibaldi (2009), La principessa del Nord: la misteriosa vita della dama del Risorgimento: Cristina di Belgioioso (1993 e 2009), L'ultima crociata. Quando gli Ottomani arrivarono alle porte dell'Europa (2009), Quelli che dissero no. 8 settembre 1943: la scelta degli italiani nei campi di prigionia inglesi e americani (2011), Eva e Claretta. Le amanti del diavolo (2012), A Mosca, solo andata. La tragica avventura dei comunisti italiani in Russia (2013), La storia ci ha mentito. Dai misteri della borsa scomparsa di Mussolini alle «armi segrete» di Hitler, le grandi menzogne del Novecento (2014) e Nazisti in fuga. Intrighi spionistici, tesori nascosti, vendette e tradimenti all'ombra dell'Olocausto (2014), tutti editi da Mondadori. Inoltre, ha scritto i monumentali volumi de La seconda Guerra Mondiale (1979), Storia del Fascismo (1982) e Storia d'Italia dall'Unità ad oggi (1987) per Curcio. Nel 1986 gli è stata conferita l'onorificenza di Commendatore, su proposta dell'allora Presidenza del Consiglio.
1 Aprile
Vita e destino di Vasilij Grossman Traduzione di Claudia Zonghetti Edizioni Adelphi Narrativa romanzo
Viaggio nel profondo dell’animo umano “E dove la violenza cerca di cancellare varietà e differenze, la vita si spegne.” Non è stato un caso, ma una scelta quasi obbligata riportare questa fra le tante riflessioni dell’autore di Vita e destino, un aspetto non trascurabile di un’opera impegnata e impegnativa sul tema del bene e del male, trattato ricorrendo a un grandioso affresco storico in cui sono stati dipinti alcuni anni della seconda guerra mondiale, l’ultima del secolo scorso, caratterizzato dall’ascesa e caduta di due grandi totalitarismi, dall’orrore dei lager e dei gulag. Ma c’è qualcosa che va anche oltre questo orrore ed è una Stalingrado dilaniata dalla guerra in cui il confine fra la vita e la morte è labile, tanto che i vivi sembrano ombre di quello che sarà il loro imminente futuro, un corpo esanime che è già tanto se è rimasto intero. La descrizione di questa lunga e quasi interminabile battaglia è una prova di bravura che rasenta l’inverosimile, tanto che sembra di udire, leggendo, il crepitio delle mitragliatrici, il sibilo dei proiettili in arrivo e infine lo scoppio degli stessi. Se questo è il palcoscenico la recita ha per oggetto le due grandi tragedie di quel secolo, il nazismo e lo stalinismo, mostrate in modo non tecnicistico, ma ricorrendo all’indubbio potere della letteratura. Nella miriade di personaggi che affollano quest’opera, alcuni realmente esistiti, altri inventati, c’è un comune denominatore, nel senso che ognuno di loro, o per essere carnefice, o per essere vittima, oppure per restare indifferente, è parte indispensabile dell’assurdità dei totalitarismi, in cui l’ideologia distorta soffoca sempre la verità, in cui si tende a rendere gli esseri umani delle copie precise, capaci di interpretare l’orrore di ogni giorno sia attivamente che passivamente, e al riguardo mi vengono in mente certi processi staliniani in cui gli imputati, quasi sempre accusati ingiustamente, si autoaccusavano quasi con letizia, desiderosi di dare il loro contributo, se pur passivo, al continuo falò dell’orrore. E’ impossibile parlare dei protagonisti di questo libro, tanti sono da sembrare essi stessi il libro, ma è appunto attraverso le loro storie, vere e proprie testimonianze, che Grossman dà voce al suo pensiero. Tuttavia, un’eccezione la faccio, se non altro perché è in grado di spiegare meglio di me i concetti di questo romanzo; mi riferisco al bolscevico Mostovskoj e soprattutto al colloquio notturno in un lager nazista in cui il comandante, un SS di nome Liss, gli dice: “ .../ Quando io e lei ci guardiamo in faccia, non vediamo solo un viso che odiamo. È come se ci guardassimo allo specchio. È questa la tragedia della nostra epoca. Come potete non riconoscervi in noi, non vedere in noi la vostra stessa volontà? /...”. E’ la simmetria del male, perché il male è male, qualunque sia l’ideologia alla sua base. Sono tentato di andare oltre, di parlare più compiutamente di altri protagonisti di questo romanzo che accanto a pagine che fanno rabbrividire ne presenta altre a dir poco struggenti, come per esempio la lettera, l’ultima, al figlio di una madre ebrea rinchiusa in un ghetto e in procinto di affrontare il viaggio verso la morte. Fra tante verità, sommessamente pronunciate, fra le quali colpisce come una stilettata la bontà di chi non ha nulla, il suo altruismo insospettabile, c’è una vena poetica capace di far palpitare nel cuore del lettore il sentimento materno. Su tutto, però, fiorisce l’anelito per la libertà, il desiderio di ognuno di avere un destino non imposto da altri, tanto più forte, quanto più è assente quella libertà che la violenza sopprime per tacere la verità. Non a caso Grossman scrive. “ .../ Il desiderio congenito di libertà non può essere amputato; lo si può soffocare, ma non distruggere. Il totalitarismo non può fare a meno della violenza. Se vi rinunciasse, cesserebbe di esistere. Il fondamento del totalitarismo è la violenza: esasperata, eterna, infinita, diretta o mascherata. L’uomo non rinuncia mai volontariamente alla libertà. E questa conclusione è il faro della nostra epoca, un faro acceso su tutto il nostro futuro. /...”. Il romanzo è ovviamente molto bello, probabilmente uno dei capolavori dello scorso secolo; gli nuoce solo una certa discontinuità dovuta a una lunghezza non indifferente, ma cosa possono essere 750 pagine di fronte al piacere di scoprire che la lettura è un viaggio nel più profondo dell’animo umano? Se ne potrà uscire sconvolti, oppure rapiti da un senso di serenità, ma in ogni caso c’è la convinzione che questo viaggio doveva essere fatto e che noi che l’abbiamo compiuto siamo un po’ cambiati, ora guardiamo la vita con occhi diversi. Vasilij Semënovic Grossman (Berdyciv, 12 dicembre 1905 – Mosca, 14 settembre 1964) è stato un giornalista e scrittore sovietico di origine ebraica.
28 Marzo
Piccole storie, Lettere e bottoni in piazza di Giovanni Piubello a cura di Mario Artioli e Vladimiro Bertazzoni Sometti Editoriale Narrativa racconti
Un artista molto versatile Pubblicati nell’ambito del progetto “Per ricordare Giovanni Piubello” i romanzi (Matti beati e Gli ubbidienti) con il primo volume del cofanetto a lui dedicato, dati alle stampe con il secondo volume i racconti, divisi in due raccolte omogenee, e le poesie, si sarebbe potuto pensare che sarebbe rimasto ben poco, e invece la prolificità di questo artista ha imposto ai curatori di procedere con un terzo volume. Nello stesso sono ricompresi racconti di tema vario nati dal dialogo giornaliero in piazza delle Erbe con ortolani, giornalai, ambulanti del mercato cittadino del giovedì, con lo scaccino della concattedrale di Sant’Andrea (al riguardo di quest’ultimo è veramente spassosa la narrazione di “Spogliarello in Sant’Andrea”, una vicenda per nulla oscena o blasfema). Si potrebbero definire Piccole storie e così le hanno intitolate i due curatori dell’opera omnia Mario Artioli e Vladimiro Bertazzoni. Forse si tratta di racconti non così belli come quelli delle raccolte omogenee, ma pur tuttavia sono il sintomo di una capacità dell’autore di spaziare con la creatività in campi assai vari e diversi; peraltro più d’uno di questi è senz’altro riuscito benissimo, in particolare “Tutti al ricovero?” sul non facile tema della destinazione, per gli ultimi giorni della loro vita, di non pochi anziani, fra cui figura anche il padre, in una narrazione più malinconica che ironica, affettuosa e dolente nel parlare della dipartita del proprio genitore, un racconto che ci svela l’animo autentico di Piubello, spesso rinchiuso nella corazza di una innata timidezza. Il terzo volume però si intitola non solo Piccole storie, ma anche Lettere e Bottoni in piazza. Vediamo di che si tratta: le lettere sono quelle della corrispondenza con i lettori della rivista letteraria “Bancarella”, una pubblicazione fortunata, protrattasi per dieci anni con la quale Piubello regalò ai lettori pagine di indubbio gusto, precise informazioni librarie, dando ampio spazio ai giovani ed esercitando quell’attività che lui definiva con termine, quanto mai appropriato, di “apostolato”. Ci sono risposte, a volte secche, altre più accomodanti, secondo il tenore della lettera ricevuta, a chi gli inviava poesie e racconti per avere il suo giudizio o il suo conforto, ma c’è anche altro, come ironiche riflessioni e anche aforisma, di cui uno talmente riuscito che non posso fare a meno di riportare di seguito: “L’uomo ha creato la Legge, per garantire secondo giustizia se stesso e il prossimo suo. E in un momento di esaltazione romantica ha dichiarato che la Legge è uguale per tutti. Balle. <<Anche la pioggia è uguale per tutti>> dice Brocchieri, <<ma chi ha l’ombrello non si bagna>>”. Da ultimo ci sono i Bottoni in piazza, non racconti, non lettere, ma una narrazione quasi sempre breve, come brevi sono gli scambi di battute, soventi divertenti, e che si chiudono con un tono ora malinconico, ora ilare. A spiegare di che si tratta faccio prima a riportarne uno, necessariamente corto per ovvi motivi:” Cartolina del Vladimiro da Monaco. <<Salutoni agli amici del portico. Mia moglie, a Mantova, ha fatto Alessio. Non lo sai?>>. No. A Mantova, le notizie di Mantova, non le possiamo sapere che attraverso i canali internazionali.” Questo terzo volume, che completa la raccolta degli scritti di Giovanni Piubello (ma non esaurisce il cofanetto, perché ce n’è un quarto che è in pratica una sua biografia) finisce con il darci una visione completa dell’artista, dotato di una versatilità non comune, appassionato come pochi di letteratura, divulgatore della stessa, amante della cultura per il piacere di sapere, insomma tutte caratteristiche che fanno dell’autore di origini veronesi un autentico intellettuale, non salottiero, ma portato a uno scambio continuo di conoscenza. Se anche questo libro è utile per comprendere la personalità di Piubello, è altrettanto vero che di per sé presenta motivi di sicuro interesse, tanto da essere ampiamente meritevole di lettura. Giovanni Piubello (San Bonifacio, 24 giugno 1921 – Mantova, 16 giugno 1983) trascorse l'infanzia nel paese natale, e si trasferì a Mantova nel 1928 dove conseguì il diploma di perito industriale, ma volle diventare scrittore, libraio ed editore. La sua prima opera, pubblicata in proprio, fu Zingara e poi diede alle stampe numerosi volumetti di racconti, prose, lettere in piazza e A proposito di gobbi, in versi. Nel 1967 l'editore Rizzoli pubblicò il romanzo Matti beati, con il quale vinse il premio nazionale Duomo. Il romanzo è autobiografico e racconta l'infanzia dello scrittore nel paese di San Bonifacio (Sambonifacio), descrivendo un quadro suggestivo della vita contadina e di paese negli anni Venti, in un contesto di sostanziale povertà vissuto tuttavia con allegria. Il successo fu di breve durata e Piubello continuò a stampare in proprio, nelle Edizioni di Bancarella, le sue storie, le sue lettere e i suoi dialoghi con lettori veri o presunti. Fu straordinario osservatore della vita cittadina nella sua patria d'adozione, e fu amato dai mantovani che trovavano nella bancarella sotto i portici Broletto un dimesso ma profondo uomo di cultura.
25 Marzo
Il signore delle cento ossa di Ben Pastor Sellerio Editore Palermo Romanzo giallo Un caso di coscienza In questo romanzo troviamo Martin von Bora con il grado di tenente dell’esercito e alle prese con il suo primo incarico in quanto appartenente al Abwehr, il servizio segreto militare tedesco. L’epoca è la primavera del 1939 e quindi non si è ancora in guerra, fatto questo invece caratterizzante gli altri episodi in cui lui è protagonista. Il compito che gli è stato affidato é di trovare una spia, presumibilmente giapponese, chiamata Il signore delle cento ossa che dovrebbe approfittare di una visita in Germania di una delegazione nipponica per passare agli americani un importante segreto relativo a un anestetico. Ciò che a prima vista dovrebbe apparire semplice non lo è affatto, tanto più che il principale indiziato, un generale giapponese, viene trovato assassinato in una camera d’albergo unitamente al suo aiutante e amante, un apparente omicidio – suicidio che però non inganna von Bora. Da lì prende avvio una trama intricata in un crescendo di tensione che costringe il lettore in una tela di regno, dove l’unica possibilità di liberarsene è procedendo velocemente onde pervenire, con l’ultima pagina, a scoprire la verità. Come al solito la spy story è un pretesto per descrivere atmosfere e ambienti (fra l’altro si è prossimi a una particolare ricorrenza, poiché il 20 aprile Adolf Hitler compie cinquanta anni e si stanno preparando grandiosi festeggiamenti che non poco complicheranno l’indagine). Ai due primi omicidi ne seguiranno altri e anche Martin rischierà di fare una brutta fine, ma un po’ di fortuna, un po’ di intuito gli permetteranno di salvarsi. Peraltro, non è ancora presente il conflitto che attanaglierà von Bora, cioè il contrasto fra il senso del dovere e la propria morale, ma questo sarà presente in uno dei protagonisti e sarà tanto importante da dare un senso all’intera vicenda. Più leggo i libri di questo autore, più ne apprezzo le qualità, perché se è vero che sono un gradevolissimo passatempo hanno pure il pregio di far sorgere delle riflessioni, di porre delle domande sul ciò che è giusto secondo i principi di una società e ciò che è giusto per il senso etico dell’individuo. Sono opere non solo fini a se stesse, ma che lasciano qualcosa dentro, meritevoli quindi di essere lette. Ben Pastor, scrittrice italo americana, all'anagrafe Maria Verbena Volpi, nata a Roma ma trasferitasi ben presto negli Stati Uniti, ha insegnato Scienze sociali presso le università dell'Ohio, dell'Illinois e del Vermont. Oltre a Lumen, Luna bugiarda, Kaputt Mundi, La canzone del cavaliere, Il morto in piazza, La Venere di Salò, Il cielo di stagno, - ovvero il ciclo del soldato-detective Martin Bora (pubblicati da Hobby&Work a partire dal 2001 e poi da Sellerio) - è autrice di I misteri di Praga (2002), La camera dello scirocco, omaggi in giallo alla cultura mitteleuropea di Kafka e Roth (Hobby &Work), nonché de Il ladro d'acqua (Frassinelli 2007), La voce del fuoco (Frassinelli 2008), Le vergini di pietra e La traccia del vento (Hobby & Work 2012), una serie di quattro thriller ambientata nel IV secolo dopo Cristo.
22 Marzo
Devora di Franco Buso Selfpublishing Narrativa romanzo storico
La fine dei Templari Di libri, soprattutto romanzi storici, sui cavalieri dell’Ordine dei Templari ne sono stati scritti in gran quantità e l’argomento continua a interessare i lettori, nonostante la grande massa di opere, peraltro raramente di qualità. Un mondo lontano, l’ambientazione sovente esotica, il mistero che ha sempre avvolto questi monaci soldati, nonché anche l’aspetto religioso sono gli argomenti che attraggono e che inducono a leggere romanzi che in certi periodi escono nelle librerie in continuazione. In questo contesto si inserisce anche Devora, l’opera prima di Franco Buso, nato a Meda, ma residente a Treviso, città dove la sua famiglia si è trasferita quando lui aveva sette anni. Il romanzo inizia con Jacques de Molay, l’ultimo maestro dell’Ordine, che brucia sul rogo a Parigi, urlando profezie che si concretizzeranno nel tempo a venire; poi l’opera si snoda fra avventure varie in un arco di tempo piuttosto lungo e che va dagli ultimi anni del tredicesimo secolo fino addirittura all’aprile del 2013 restando, almeno nelle linee generali, abbastanza fedele ai fatti storici. Non mi sembra che dica qualcosa di nuovo sotto il profilo storico e d’altra parte sarebbe stata una pretesa eccessiva, perché Buso è un narratore, magari appassionato di eventi passati, ma non è certo uno storiografo. Il suo scopo è evidente, cioè raccontare qualcosa, con una trama fitta e anche intricata, per proporre un testo che sia di gradevole lettura. L’aspetto creativo diventa così determinante e la fantasia non manca certo all’autore che ha anche un certo senso della misura, pur con l’artificio di far vivere Devora, la protagonista, per oltre settecento anni. A onor del vero questa invenzione ha fatto scivolare il romanzo nel genere fantasy che non è mai stato di mio particolare gradimento, tanto che la vicenda non ha rivestito per me un particolare interesse, ma questo esula da un giudizio oggettivo sull’opera. Per il resto Buso si presta a una diligente narrazione, magari dilungandosi a volte un po’ troppo, con uno stile elementare, ma dall’italiano corretto (e di questi tempi non è poco). I colpi di scena non mancano di certo, a tratti il romanzo procede spedito come un treno, in altre circostanze opportunamente rallenta, altre volte si sofferma un po’ troppo su questioni di scarso contributo all’opera, i personaggi sono tanti, con i buoni che hanno solo pregi e i cattivi invece solo difetti, ma comunque il divertimento è assicurato. In tutta sincerità sono dell’opinione che si tratti di un libro che si lascia leggere e che consente di trascorrere senza porsi troppi problemi più di qualche ora, magari sotto l’ombrellone al mare, senza pretendere e chiedere oltre, perché già quello che dà è più che sufficiente allo scopo di consentire un appagante svago. Franco Buso nasce nel 1952 a Meda, allora provincia di Milano e ora Monza-Brianza. A sette anni si trasferisce con la famiglia a Treviso, dove vive tuttora. Consegue la Maturità Classica e si iscrive alla facoltà di Ingegneria presso l’Università di Padova. Nel 1977 sposa Chiara e dal matrimonio avrà una figlia, Irene. È autore di racconti e questo è il suo primo romanzo, nato dal suo interesse per la storia nonché ispirato dalla tesi di laurea della figlia, incentrata sul processo a Jacques de Molay: l’ultimo Maestro dei Cavalieri Templari.
18 Marzo
Tentativo di dialogo sul comunismo di Ferdinando Camon e Pietro Ingrao a cura di Alberto Olivetti Edizioni Ediesse Saggistica politica Un confronto serrato Pietro Ingrao è l’uomo politico che ha visto, nella sua lunga vita, l’ascesa e poi la caduta del comunismo, un’ideologia che per lui ha rappresentato una vera e propria fede, in una inossidabile coerenza che lo ha portato a superare e probabilmente anche a digerire bocconi amari come la rivolta di Ungheria e la primavera di Praga, duramente represse da quel paese che rappresentava e ha rappresentato il tentativo di mettere in pratica l’ideologia marxista. Lo sfaldamento del suo partito, che a un certo punto ha deciso di ricostituirsi abbandonando nella denominazione il termine “comunista” ormai diventato scomodo e che per Ingrao ha rappresentato sicuramente un dolore tale da comportare anche lacrime, ha finito, complice anche l’età, per portare questa figura di primo piano in un esilio volontario, a rinchiuderla in un bozzolo intorno al quale ha costruito una barriera onde impedire che almeno la speranza di una rinascita non potesse venire meno. In questo contesto nessuno meglio di lui avrebbe potuto fornire la spiegazione sul fallimento della realizzazione dell’ideologia comunista e così Ferdinando Camon ha provato a intervistarlo. Ci sono stati tre incontri durante i quali sono state poste domande e sono state ricevute risposte, ma il libro che le avrebbe dovute riportare nella loro integrità è uscito solo da pochissimo e postumo, perché all’epoca non ne volle la pubblicazione proprio Ingrao, che lamentò la difficoltà di spiegare bene i concetti con un’intervista e non con un saggio ponderato. E’ merito del dottor Alberto Olivetti, condirettore della collana Carte Pietro Ingrao della Ediesse aver riscoperto le pagine di quell’intervista e di averle ritenute meritevoli di essere date alle stampe. Io, per quanto contrario al comunismo, e comunque a ogni ideologia che per imporsi abbia bisogno della forza, togliendo la libertà, avevo tuttavia sempre apprezzato la coerenza del politico laziale, ma dal tono delle risposte alle domande sempre incalzanti di Camon, e anche dal loro contenuto, ho ritratto l’impressione di un individuo complesso, cosciente degli errori imperdonabili commessi nell’applicazione pratica della sua ideologia e ciò nonostante irremovibile, abbarbicato come un glicine al pensiero che la colpa dei fallimenti non fosse propria dell’idea, ma della sua traduzione in pratica, senza tener conto che ci possono essere idee in apparenza valide, ma del tutto impraticabili. Messo a volte alle strette si arrampica sugli specchi non tanto per difendere se stesso, ma i tanti anni di militanza, onde evitare di considerare la sua una vita gettata al vento. Eppure, pur avendo acclarato che Pietro Ingrao in fondo non era così coerente, dalla lettura di questa intervista ho potuto constatare in quest’uomo una virtù ormai rara: la fede in un’idea, quella comunista, la cui realizzazione, almeno in prospettiva, avrebbe dovuto assicurare a tutti una vita serena, a ognuno quanto gli sarebbe stato necessario e un lavoro atto allo scopo. Si tratta indubbiamente di utopie, ma ciò che mi ha colpito è quel credere, pur fra tanti tentennamenti, più dell’uomo che del politico Ingrao. In un’epoca in cui sembra che non esistano più ideologie e nemmeno idee, ma si seguono i suonatori di piffero che procedono per slogan, ecco, in un’epoca falsa e vuota, un essere umano che ancora spera in un’ideologia, per quanto sbagliata essa sia, è merce rara, è un seme che sotto terra aspetta che passi la bufera per affacciarsi fulgidamente sul mondo. Da leggere, senza dubbio. Ferdinando Camon è nato in provincia di Padova. In una dozzina di romanzi (tutti pubblicati con Garzanti) ha raccontato la morte della civiltà contadina (Il quinto stato, La vita eterna, Un altare per la madre – Premio Strega 1978), il terrorismo (Occidente, Storia di Sirio), la psicoanalisi (La malattia chiamata uomo, La donna dei fili), e lo scontro di civiltà, con l’arrivo degli extracomunitari (La Terra è di tutti). È tradotto in 22 paesi. Il suo ultimo romanzo è La cavallina, la ragazza e il diavolo (2004). Nel 2016 ha vinto il premio Campiello alla Carriera. Pietro Ingrao (Lenola, 30 Marzo 1915 – Roma, 27 settembre 2015) nel 1936, in seguito all'aggressione franchista alla Repubblica spagnola, diviene membro attivo dell'organizzazione clandestina comunista. Alberto Olivetti, professore di Estetica, Università di Siena. Membro del consiglio scientifico del Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato - Archivio Pietro Ingrao. Direttore della Collana Carte Pietro Ingrao insieme a Maria Luisa Boccia.
15 Marzo
Il Quartiere di Vasco Pratolini Edizioni BUR Narrativa romanzo
Il rifugio Il romanzo è ambientato in un quartiere di Firenze durante gli anni Trenta, con protagonisti alcuni ragazzi che vivono la loro adolescenza con gli entusiasmi e le paure tipiche dell’età; sono anni caratterizzati dal regime fascista che culmineranno nella tragedia della guerra. Palcoscenico della storia è un quartiere proletario, una sorta di rifugio, di tana, in cui i giovani trovano la ragion d’essere e avvertono, nonostante tutto, una protezione offerta da vincoli di amicizia e di solidarietà. Il Quartiere non è solo un agglomerato di case, di vie e di piazzette, è la gente che vi abita, accomunata da un unico status economico e sociale che in fondo la porta ad accettarsi, pur con tutti i suoi difetti, bilanciati da un pregio di umana comprensione. A prima vista potrebbe sembrare un ghetto, ma non lo è, poiché chi vi sta può anche essere libero di andarsene, anche se poi finisce per accorgersi che il mondo dall’altra parte non è il mondo per il quale si è fatti e allora è meglio pensare come Giorgio, uno dei personaggi, più maturo della sua età, che dice: “Insomma, a me pare che occorra resistere nella propria casa, nel proprio Quartiere, aiutare ed essere aiutati a migliorarci fra la nostra gente. Se si stesse ciascuno al proprio posto, che è sempre il posto che ciascuno conosce meglio, si sarebbe meno complicati." Queste parole potrebbero sembrare espresse da uno che non vuole uscire dalla sua condizione, più un conservatore che un rivoluzionario, ma sono di una saggezza antica, di chi è consapevole che la lunga evoluzione, con la ricerca di un accrescimento della propria dignità sociale, non può prescindere dal tenersi legati alle radici, a pena di stravolgere la propria vita. Nel perdere il senso di appartenenza al quartiere si perde anche la propria identità, si rompono quelle catene di amicizia che alla fine sopravvivono a tutto, anche al progetto di abbattere le vecchie e fatiscenti case per dare vita a un quartiere nuovo. Il Quartiere è un romanzo non certo facile, ma al termine della lettura ci si accorgerà di quanto sia bello. Vasco Pratolini (Firenze, 19 ottobre 1913 – Roma, 12 gennaio 1991). Di famiglia operaia, è costretto a interrompere gli studi e svolge mestieri diversi per potersi mantenere. Pratolini comincia a collaborare al periodico «Il Bargello» e diviene redattore con Alfonso Gatto, nel 1938, della rivista «Campo di Marte». Nel 1951 si trasferisce a Roma, città nella quale vivrà da allora in poi. Il registro adottato, sin da quelle prime prove, si pone a mezza via fra il realistico e il lirico. Pratolini svolge con successo, in questi anni, anche un'attività di sceneggiatore e soggettista cinematografico, e intraprenderà in seguito una carriera di autore di testi teatrali ("La domenica della povera gente", 1952; "Lungo viaggio di Natale", 1954). Nel 1955 pubblica Metello (premio Viareggio), primo romanzo di quella che diverrà la trilogia "Una storia italiana", essendo completata da "Lo scialo" (1960) e da "Allegoria e derisione" (1966). Alla città e al mondo dell’adolescenza sono dedicati ancora un romanzo, "La costanza della ragione" (1963), e le poesie raccolte in "La mia città ha trent’anni" (1967). Alcune «cronache in versi e in prosa», scritte dal 1930 al 1980, sono riunite nel volume "Il mannello di Natascia" (1984, premio Viareggio).
10 Marzo
La profezia dei Gonzaga di Tiziana Silvestrin Scrittura & Scritture Edizioni Narrativa romanzo giallo storico
La scomparsa della mummia Con una cadenza mediamente biennale vengono date alle stampe le avventure del capitano di giustizia Biagio dell’Orso, un personaggio assai indovinato che è riuscito a entrare nel cuore dei lettori, desiderosi di vederlo risolvere casi particolarmente complicati, come anche di sapere le novità del suo tormentato rapporto con la bella e gelosa Rosa. Questo nuovo episodio si sviluppa nell’anno 1596, in autunno, un autunno che si presenta per i Gonzaga foriero di sventure, visto che la loro stella avrebbe continuato a brillare in cielo finché avessero conservato a palazzo il corpo mummificato di Rinaldo Bonacolsi, detto il Passerino, colui che, nella congiura ordita per sottrargli il potere, fu ferito a un fianco e cercò di riparare a cavallo nel Palazzo del Capitano, ma cadde, battendo il capo contro uno stipite del portone e morì per il grave trauma patito; quanto agli altri suoi familiari non fecero miglior fine perché rinchiusi nel castello di Castel d’Ario vi furono lasciati morire di fame. La profezia, del resto, segna l’inevitabile declino del casato nella malaugurata ipotesi che la mummia non resti dentro il Palazzo Ducale, da cui qualcuno che agisce nell’ombra l’ha sottratta. Non solo, ma gli stessi duchi, Vincenzo ed Eleonora, i loro figli sono oggetto di ripetuti attentati che il Capitano di giustizia riesce a sventare anche con un po’ di fortuna. E’ diabolico chi sta tessendo una fitta tela di ragno volta a spodestare i Gonzaga e, visto che è informato di tutto, è più che logico supporre che si tratti di uno che vive o lavora a palazzo. Perfino Biagio dell’Orso rischia molto, quando ingiustamente accusato, viene chiuso nelle segrete con il solo scopo di togliergli la vita, ma riuscirà a venirne fuori, questa volta grazie al fattivo interessamento di Rosa e della moglie di Marcello Donati, l’amico consigliere del duca di Mantova. I colpi di scena si susseguono, la vicenda addirittura approda alla corte imperiale di Praga per cercare di scoprire chi è che sta tramando; le congetture e le ipotesi si sprecano, i sospetti si appuntano ora sull’uno, ora sull’altro, ma alla fine il capitano di giustizia riuscirà a scoprire il colpevole che, manco a farlo apposta, fra tutti i papabili è il meno sospettabile. Nonostante che già su Biagio dell’Orso Tiziana Silvestrin abbia scritto con questo cinque corposi romanzi il personaggio non è ancora venuto a noia, tanto che giunti all’ultima pagina di La profezia dei Gonzaga sorge spontaneo il desiderio di poter leggere un altro episodio; in questa affezione indubbiamente ha la sua importanza la felice scelta del protagonista, le sue caratteristiche, il suo modo di procedere con razionalità da investigatore sì capace, ma non certamente fenomenale, insomma un uomo del tutto normale con i suoi pregi e i suoi difetti, in cui il lettore tende a identificarsi; peraltro, i personaggi di contorno sono tutti felicemente riusciti, come la gelosa Rosa o l’amico Donati, oppure il capitano delle guardie Giò Morisco; aggiungo che l’ambientazione e l’atmosfera sono resi splendidamente con uno stile particolarmente efficace, semplice, ma in grado di avviluppare, di avvincere chi legge, teso a scorrere le pagine per assaporare l’evolversi di una vicenda che, per quanto intricata, l’autore riesce a proporre in modo accattivante. Quindi, viste le qualità dell’opera, un invito a leggerla è quasi d’obbligo. Tiziana Silvestrin vive e lavora a Mantova. Entrata a far parte di una compagnia di teatro amatoriale, inizia a scrivere commedie. Alla passione per la recitazione e per la lettura, si aggiunge la curiosità per la storia. Quando, con un racconto, vince un premio letterario, le viene il sospetto che forse può mettere a frutto le sue ricerche per scrivere gialli storici. Così, mescolando fantasia, storia, personaggi reali e non, ha scritto I leoni d’Europa (2009), Le righe nere della vendetta (2011), Un sicario alla corte dei Gonzaga (2014), Il sigillo di Enrico IV (2017) e La profezia dei Gonzaga (2018). Tutti pubblicati da Scrittura & Scritture.
7 Marzo
Le persiane verdi di Georges Simenon Traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio Edizioni Adelphi Narrativa romanzo Il grande Emile Mauguin La casa editrice Adelphi si è assunta il compito di ripubblicare l’intero considerevole repertorio di Georges Simenon, un lavoro enorme che ha portato agli occhi dei lettori per lo più opere di elevata qualità, anche se alcune si devono giudicare onestamente mediocri; è stato dopo la delusione di due sue raccolte di racconti che mi sono imbattuto in questo romanzo, che non è giallo e nemmeno noir, è semplicemente la storia di un uomo, passato dalla miseria alla ricchezza, che fugge non sa nemmeno lui da cosa, ma che cerca disperatamente di dare un senso alla sua vita. Emile Mauguin è un celebre attore teatrale e cinematografico, idolatrato e temuto, un uomo che, venuto dal nulla e dalla fame, può ora disporre di tutto ciò che desidera, tranne che della serenità. E’ uno che prende, e se dà lo fa facendo cadere la sua elemosina come un dono del cielo, e perciò, proprio per questo, non ha in pratica amici, insomma è un uomo solo. Dopo diversi rapporti con non poche donne ha sposato una molto più giovane di lui, con una bambina che ha avuto da un altro uomo, e benché la moglie gli possa apparire fedele lui non ha perso l’abitudine di avere rapporti con altre, ivi compresa la cameriera; un altro vizio a cui si abbandona con eccesso, in una vita di tutta di eccessi, è il vino, quello rosso, non necessariamente di qualità. La visita di un medico specialista, un famoso luminare, gli porta la ferale notizia che, nonostante lui abbia quasi sessant’anni, ha il cuore di uno di settantacinque e quindi se vuole avere la speranza di andare avanti deve necessariamente limitare o eliminare gli eccessi. E’ più facile da dire che fare per uno che, grande attore, ha finito con il mescolare le sue caratteristiche di uomo con quelle dei personaggi interpretati, in cui sono inconfondibili i tratti autoritari che lo contraddistinguono. Riesce a contenere l’abuso del vino, ma è evidente che non basta, che occorre darsi una calmata, gratificarsi di un po’ di riposo ed è così che, memore del desiderio della sua prima moglie di una casetta, lontana dalla ribalta e con le persiane verdi, prende in affitto una villa ad Antibes, con vista sul mare, ma con le persiane azzurre. Si accorge che è tempo per fare un bilancio della propria vita, quello che prima saltuariamente gli riusciva in sogno immaginando di essere l’imputato di un processo i cui giudici erano tutte le persone che aveva conosciuto. In realtà questo è il frutto di una sua costante paura della morte e del desiderio, quasi inconsapevole, della pace dell’anima, simboleggiata da una casetta con le persiane verdi. Non si può tornare indietro, però, e si arriva così prima o poi al momento in cui ciò da cui si fuggiva, andandovi inconsciamente incontro, diventa vicinissimo e allora non ci si può sottrarre alla sconfitta, ci si lascia andare e tutto ha una fine e un fine, perché, come scriveva Ungaretti (Sono una creatura -Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916), “la morte si sconta vivendo”. Il romanzo è semplicemente bello, ma le ultime pagine sono altamente struggenti, finiscono con il commuovere e nell’ingenerare nel lettore un profondo senso di pietà per questo uomo massiccio, spigoloso, scorbutico, ma infinitamente solo. Georges Simenon, nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989, ha lasciato centonovantatre romanzi pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da Henry Miller a JeanPauhlan, da Faulkner a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più autentico che la letteratura francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «… leggo ogni nuovo romanzo di Simenon»; Louis-Ferdinand Céline: «Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard, per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
4 Marzo
Jutland 31 maggio 1916: la più grande battaglia navale della storia di Sergio Valzania Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Saggistica storica
Vittoria strategica della Gran Bretagna Non so se la battaglia navale dello Jutland (31 maggio – 1 giugno 1916) sia stata, come asserisce l’autore, la più grande della storia, so invece che è stata l’ultima che ha visto contrapposti schieramenti composti solo da corazzate, incrociatori e cacciatorpediniere, con l’assenza quindi di portaerei, che invece nella seconda guerra mondiale saranno sempre presenti e determinanti. L’intenzione dei tedeschi di rompere il blocco dei rifornimenti marittimi imposto dalla Gran Bretagna fu senz’altro la causa di questo epico scontro i cui esiti, se ci limitiamo alle sole perdite di navi e marinai, furono senz’altro sfavorevoli agli inglesi; tuttavia, nel quadro più generale della guerra condotta sul mare, poichè i tedeschi non riuscirono a cogliere una vittoria determinante, volta a interrompere l’assedio, con perdite sì inferiori all’avversario, ma consistenti se raffrontate con le forze disponibili, li vide strategicamente sconfitti, tanto che da allora non uscirono più in mare aperto per dare battaglia alla flotta nemica. L’interessante saggio di Valzania, nel ripercorrere le ore di quell’epico scontro, va anche oltre, cercando di spiegare i motivi per i quali il II Reich, che mai aveva avuto ambizioni sul mare decise invece di dotarsi di una flotta ragguardevole, in diretta competizione con quella inglese, che in ogni caso crebbe in misura superiore a quella tedesca, con contemporaneo incremento delle velocità e dei calibri dei cannoni installati. Quanto a qualità si equivalevano, ma le navi da battaglia tedesche avevano una migliore ripartizione dei comparti stagni e questo spiega anche perché, nonostante i colpi subiti, affondassero meno facilmente di quelle inglesi. Comunque fu un epico combattimento e vide contrapposte da parte inglese 28 navi da battaglia, 9 incrociatori da battaglia, 8 incrociatori corazzati, 26 incrociatori leggeri, 78 cacciatorpediniere, e da parte tedesca 16 navi da battaglia, 5 incrociatori da battaglia, 6 pre-dreadnoughts, 11 incrociatori leggeri e 61 torpediniere. In pratica era presente la pressoché totalità del naviglio da guerra dei due paesi, con quello germanico nettamente inferiore come forza e già questo può spiegare come le perdite subite (1 incrociatore da battaglia, 1 pre-dreadnoughts, 4 incrociatori leggeri e 5 torpediniere), benché inferiori in numeri assoluti a quelle inglesi (3 incrociatori da battaglia, 3 incrociatori corazzati e 8 cacciatorpediniere), abbiano avuto un’incidenza ragguardevole sul complesso della loro arma navale di superficie a tal punto da sconsigliare ulteriori iniziative per tutto il seguito della guerra. Appare quindi evidente che dallo scontro la posizione della Gran Bretagna si rafforzò, restando di fatto padrona assoluta del mare, in cui tuttavia riuscirono a operare con brillanti risultati i sommergibili tedeschi. Il libro è interessante, per niente greve e la lettura è quindi indubbiamente piacevole. Sergio Valzania, storico e studioso della comunicazione, autore radiofonico e televisivo, dal 2002 al 2009 ha diretto i programmi radiofonici della Rai. Dal 2001 insegna all'Università di Genova e dal 2010 alla Luiss di Roma. Ha scritto su «La Nazione», «Avvenire», «la Repubblica», «il Giornale», «L'Indipendente», «Liberal».
2 Marzo
Martin Eden di Jack London Edizioni Einaudi Narrativa romanzo
Barriere invalicabili Ecco un romanzo cult della letteratura nordamericana, un’opera fatta di dolore, rabbia, tenerezza e malinconia espresse in modo immediato proprio di chi ha vissuto certe situazioni e non a caso Martin Eden può essere considerato in buona parte autobiografico. La storia del marinaio poco istruito, rozzo, invitato a pranzo in una famiglia dell’alta borghesia, grazie a un occasionale piacere che ha prestato, è una di quelle che, per gli inevitabili contrasti esistenti fra i personaggi, affascina immediatamente. Martin è come un pesce fuor d’acqua che ha persino paura a muoversi; impacciato lo sarà di più conoscendo una ragazza, Ruth, figlia del padrone di casa e che per lui da subito diventa l’inarrivabile oggetto del desiderio. Lei sembra turbata, lui lo intuisce e si rende conto che per avere qualche possibilità di fare una breccia definitiva nel suo cuore deve darsi da fare, con urgenza, per colmare il divario culturale esistente. La sua forza di volontà è spaventosa in un corso accelerato che lo porterà a comprendere progressivamente il significato di libri sempre più complessi, infondendogli una sicurezza tale da pensare da poterne scrivere egli stesso, in modo che con il successo e i diritti d’autore gli sia possibile mantenere Ruth nel tenore di vita della sua classe sociale. Non vado oltre perché il piacere della lettura non sta tanto nella trama pur interessante, ma nella descrizione, superlativa, della progressiva trasformazione del rozzo marinaio. Ciò che mi preme evidenziare è il significato dell’opera, tutta incentrata su un’illusione amorosa che porta a un acceso desiderio di riscatto e di elevazione sociale. Sappiate solo che Martin diventerà un eccellente scrittore, ma la sua è la storia di un successo e insieme di un fallimento, perché l’innalzamento sociale è illusorio, portando invece a una progressiva autodistruttiva regressione. Martin, come si suol dire, diventa né carne né pesce, la velocissima istruzione lo allontanano dal mondo proletario in cui era nato e aveva vissuto la sua giovinezza e i cui valori gli diventano del tutto estranei, ma non può nemmeno accettare il corrosivo conformismo borghese, caratterizzato da una vergognosa ipocrisia. Siamo quel che siamo, ci portiamo dietro le abitudini e i valori dell’ambiente in cui siamo nati e cresciuti, possiamo anche migliorare la nostra condizione, ma perché ciò avvenga, senza che perdiamo la conoscenza delle nostre radici che ci consente di impostare correttamente la nostra vita, il miglioramento deve essere necessariamente lento e progressivo; altrimenti corriamo il rischio di avventurarci in un mare in tempesta senza sapere di un porto sicuro. Con neppure larvati riferimenti alla teoria dell’evoluzione di Darwin e con le indubbie suggestioni del Superuomo di Nietzche, Martin Eden si rivela ben più di un romanzo di assoluto valore, ma è anche una denuncia delle stratificazioni sociali, della divisioni in classi della società, comparti stagni in cui a chi sta in basso è pressoché impossibile salire più in alto. Aggiungo una doverosa annotazione: nel romanzo c’è forse il più bel suicidio della storia della letteratura, un profondo senso di annullamento, una volontà indomita di scomparire senza lasciare traccia. Da leggere questo che ritengo possa essere definito senza alcuna remora un capolavoro. Jack London, pseudonimo di John Griffith London, scrittore statunitense (San Francisco, 12 gennaio 1976 – Glen Ellen, 22 novembre 1916).
27 Febbraio
Il morto in piazza di Ben Pastor Sellerio Editore Palermo Narrativa romanzo giallo
Buona la trama, meno la conclusione Kaputt Mundi finisce con gli alleati che entrano a Roma e con il tenente colonnello von Bora che per ultimo lascia la città per raggiungere il reggimento che comanderà. Se questa era la grande aspirazione dell’ufficiale tedesco viene però subito frustrata dalla necessità impellente e inderogabile di raggiungere uno sperduto paesino abruzzese alla ricerca di un confinato e, soprattutto, di alcune lettere che il Duce gli avrebbe consegnato, relative al carteggio Churchill – Mussolini, dalla portata esplosiva immensa, assai pericolose per diversi alti ufficiali dell’Abwehr, ma soprattutto per l’Italia con le dure norme dell’occupazione nazista che potrebbero inasprirsi a livello tale da provocare un genocidio. Trova l’esiliato politico e ha la certezza che conservi questa pericolosa corrispondenza da qualche parte, anche se sarà difficile convincerlo a metterla a sua disposizione; inoltre c’è un fatto nuovo che giunge a ingarbugliare ancor più una matassa già di per sé difficile da sbrogliare: sulla piazza del paese viene rinvenuto il cadavere di un giovane sconosciuto morto ammazzato. Inizia così Il morto in piazza, quarto volume della serie con protagonista von Bora che ho letto con interesse e con il consueto piacere, anche se questa volta ho un appunto da fare, pur essendo la vicenda in grado di attrarre notevolmente; infatti, se il contrasto fra i caratteri dell’avvocato confinato, più in linea con la sua deontologia morale, e l’ufficiale tedesco, eternamente combattuto fra la sua coscienza e il dovere del soldato, percorre l’intera opera dandole sostanza e se, come al solito, paesaggi e atmosfere sono perfettamente ricreati, tuttavia la soluzione del giallo del morto ammazzato, con l’identificazione del colpevole, reo di altri due precedenti omicidi, non è del tutto convincente, tanto più che nello stringere le indagini, accelerando il ritmo, è facile perdere il filo del discorso, quando invece il lettore dovrebbe essere messo nella condizione di assaporare, goccia a goccia, il piacere della scoperta. Ciò che intendo dire, per farla breve, è che questa volta, a differenza delle precedenti, la trama gialla non è ben congegnata e arrivati all’ultima pagina forse si può convenire con l’autore che il colpevole sia proprio quello, ma che certo la via per arrivare a tale conclusione è talmente aggrovigliata da far sembrare che più il caso che la logica portino alla soluzione. In ogni caso, chi legge non ha molto da lamentarsi, perché permangono l’eccellente stile di una narratrice che sembra aver trovato nel giallo storico il modo per esprimersi al meglio. Ben Pastor, nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha scritto narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico. Della serie di Martin Bora Sellerio ha già pubblicato Il Signore delle cento ossa (2011), Lumen (2012), Il cielo di stagno (2013), Luna bugiarda (2013), La strada per Itaca (2014), Kaputt Mundi(2015), I piccoli fuochi (2016), Il morto in piazza (2017) e La notte delle stelle cadenti (2018).
21 Febbraio
L’ultimo arrivato di Marco Balzano Sellerio Editorte Palermo Narrativa romanzo In cerca di fortuna In un’epoca di grandi migrazioni, dall’Africa alle nostre coste, non poteva mancare un libro che parlasse di un fenomeno analogo, proprio degli anni cinquanta quando masse di mano d’opera si trasferirono dal nostro meridione al nord in cerca di lavoro, e fra questi abbastanza di frequente c’erano dei minori in compagnia di un parente o di un paesano. L’emigrazione infantile pertanto costituisce un’altra caratteristica di questo flusso sud-nord, coinvolgendo migliaia di ragazzini che spinti dalla miseria e sorretti dalla speranza lasciavano i genitori e la piccola realtà in cui fino ad allora avevano vissuto per approdare alle metropoli dell’Italia settentrionale. In questo contesto Marco Balzano ci racconta la storia di Ninetto Giacalone, conosciuto da tutti come “pelleossa” per la notevole magrezza dovuta agli stenti patiti, ma ciò nonostante sostanzialmente sano, a differenza della madre che, vittima di un ictus cerebrale, non è mai riuscita a tornare alla normalità ed è condannata a vivere, anche per decisione del marito, in un ospizio. Di questo incidente di salute vittima indiretta è stato anche Ninetto, costretto ad abbandonare la scuola per lavorare nei campi e infine partito per Milano insieme con il paesano Giuvà, un bonaccione che non si tira mai indietro quando c’è da faticare. A causa della sua minore età gli inizi sono difficili, con lavori precari fino alla grande occasione, cioè l’assunzione all’Alfa Romeo. Ovviamente la storia non si ferma qui, ma prosegue con tanti eventi, fra cui uno che segnerà in modo indelebile la sua esistenza, ma ritengo non siano necessarie altre notizie in merito, lasciando al lettore il piacere di scoprirle. Devo dire che, dopo aver letto Resto qui, mi attendevo di più, soprattutto speravo che l’autore non cadesse in certi stereotipi dell’immigrazione meridionale al nord, ma si vede che è difficile raccontare qualcosa di nuovo in proposito, così che il romanzo, fra l’altro commovente anche oltre misura, si presenta come un prodotto ben confezionato, ma incapace di lasciare una traccia significativa in chi legge. Se la trama appare più gratificante dei contenuti, perché maggiori approfondimenti avrebbero non poco giovato all’opera, di pregevole resta lo stile, snello, immediato, una caratteristica dell’autore che ho riscontrato anche in Resto qui. L’ultimo arrivato è stato premiato con il Campiello e non a caso, perché è un’opera per certi versi furba e accattivante, che tuttavia riesce superiore, come qualità, a quella media, invero modesta, dei libri editi attualmente. Marco Balzano è nato a Milano nel 1978, dove vive e lavora come insegnante di liceo. Ha esordito nel 2007 con la raccolta di poesie Particolari in controsenso (Lieto Colle, Premio Gozzano). Nel 2008 è uscito il saggio I confini del sole. Leopardi e il Nuovo Mondo (Marsilio, Premio Centro Nazionale di Studi Leopardiani). Il suo primo romanzo è Il figlio del figlio (Avagliano 2010, finalista Premio Dessì 2010, menzione speciale della giuria Premio Brancati-Zafferana 2011, Premio Corrado Alvaro Opera prima 2012), tradotto in Germania presso l’editore Kunstmann.
16 Febbraio
La nemica di Brunella Schisa Neri Pozza Editore Narrativa romanzo storico
La grande truffa L’affare della collana è stata una truffa architettata in Francia nella seconda metà degli anni ‘80 del XVIII secolo, crimine organizzato e realizzato dalla contessa Jeanne de Saint-Remy de Valois, o anche de la Motte, dal nome del marito, con il concorso di altri, fra cui il celebre Cagliostro, ai danni della regina Maria Antonietta e del cardinale di Rohan. Il processo, che ne seguì, i suoi esiti, le vicende successive alle sentenze infiammarono l’opinione pubblica francese che prese a detestare la consorte del proprio sovrano. Del fatto non aggiungo altro perché altrimenti sarei costretto a rivelare in anticipo la trama del romanzo “La nemica”, che rappresenta, pur con alcuni spunti di fantasia, quel che fu la vicenda, intricata, ricca di tensione, con risvolti anche erotici che all’epoca appassionò il popolo come francamente ne sarebbe attratto anche oggi. In un fatto che, banalizzandolo, potrebbe sembrare solo una semplice truffa in effetti si innestano altri elementi, soprattutto di carattere politico, viste le notevoli difficoltà economiche della Francia e la crescente disaffezione dei francesi per i loro monarchi, aspetti interdipendenti che porteranno da lì a qualche anno allo scoppio della rivoluzione. Premetto che la vicenda riveste caratteristiche di complessità, perché la personalità stessa dell’imputata non è per niente semplice e quindi come una matassa il filo del racconto tende naturalmente ad aggrovigliarsi ogni tanto, per poi arrivare a una semplificazione che riesce a svelare i retroscena; il compito della Schisa è stato quindi piuttosto arduo, ma l’impegno profuso dall’autore ha dato i suoi frutti e, grazie anche a uno stile sobrio, conciso, a un linguaggio mai ridondante il lettore finisce con l’appassionarsi alla storia, congegnata come un giallo in cui già si sa chi è il colpevole, il quale, se pur condannato al carcere perpetuo, mantiene un atteggiamento più da vittima che da reo, usando sapientemente le sue arti femminili per ottenere la liberazione. Tengo a precisare che quasi tutti i personaggi sono esistiti veramente e al riguardo la Schisa ne fornisce ritratti assai convincenti, la crescente tensione del popolo affamato che accumula odio nei confronti della regina è ben esposta, così come ben delineate sono le contraddizioni di una grande potenza amministrata in modo del tutto inadeguato. Il protagonista di fantasia di maggior spessore è un giovane giornalista, Marcel de la Tache, ben descritto dall’autore ed è per il suo tramite che possiamo conoscere le tragiche e rocambolesche avventure della donna che si fece beffe della corte francese alla vigilia della rivoluzione; il contrasto di caratteri fra i due personaggi, lui timido, ingenuo e irretito dalla donna, lei opportunista, scaltra, mendace che lo utilizza per i suoi scopi costituisce un altro motivo di interesse del romanzo che, nonostante la sua lunghezza, si riesce a leggere velocemente anche perché la vicenda, i suoi contorni e lo sfondo sono narrati in modo tale che non si può non restare avvinti. E da ultimo, quasi una ciliegina sulla torta, l’autore, in forza della professione di giornalista svolta da Marcel de la Tache, professione che gli impone di seguire per la sua Gazzetta gli avvenimenti caotici che iniziano nel 1789, provvede a narrarci le prime vampate della rivoluzione, con una descrizione quasi cinematografica della presa della Bastiglia; i disordini, le violenze, il pathos sono ricreati abilmente in una confusione di avvenimenti, di tripudi, di scoramenti, di rapidi e improvvisi cambi di rotta che furono proprio di quel periodo, con l’affacciarsi alla ribalta di tanti personaggi di cui abbiamo memoria per gli studi scolastici, quali La Fayette, Marat, Mirabeau e Robespierre. Di conseguenza l’opera è senz’altro meritevole di essere letta. Brunella Schisa è nata a Napoli. Dopo aver lavorato come traduttrice, esordisce nella narrativa nel 2006 con il romanzo La donna in nero(Garzanti), che ha vinto numerosi premi tra cui il Premio Letterario Frignano-Opera Prima, il Premio Letterario Città di Bari e il Premio Rapallo. Giornalista di «Repubblica», ha curato per anni la rubrica dei libri sul Venerdì, cui adesso collabora. Tra le sue opere Dopo ogni abbandono (Garzanti, 2009), La scelta di Giulia (Mondadori, 2013) e La nemica (Neri Pozza 2017).
11 Febbraio
10 Febbraio
Il Saladino di Franco Cardini Edizioni Piemme Storia biografia
Il feroce (?) Saladino C’è stato un tempo, all’incirca verso la fine degli anni ‘30, che il Saladino, o meglio il feroce Saladino è stato a lungo ricercato, perché tutti lo volevano per completare la raccolta delle figurine Panini; chissà in quell’occasione se almeno qualcuno dei collezionisti si sia chiesto chi fosse mai questo Saladino e il perché di quell’aggiunta, quel feroce che sembrava farne uno spauracchio. In passato, ma anche in epoche meno lontane, si è sempre teso a demonizzare figure che potevano rappresentare un pericolo per un ordine costituito, per esempio ad Alessandro VI, il papa Rodrigo Borgia, si è sempre accomunata l’immagine di una belva assetata di sangue per il semplice motivo che nei suoi scopi vi erano anche quelli di riunire tutta l’Italia in un unico stato sotto la guida del figlio Cesare; non era un uomo magnanimo, ma quanto a efferatezze non era peggio degli altri potenti dell’epoca che sul suo conto misero in giro voci quasi sempre infondate. Nel caso del Saladino piuttosto il problema fu un altro, perché questo principe dell’aristocrazia militare curda fu quello che riuscì a strappare per sempre il Santo Sepolcro ai cavalieri cristiani e al loro comandante Riccardo Cuor di Leone. Per il resto, Salah al-Din, questo era il suo nome, poi volgarizzato in Saladino, se non era un esempio di bontà, non era però dissimile dai suoi stessi nemici. L’onta però fu tale che i Cristiani che, non dimentichiamolo, strapparono ai mussulmani una Gerusalemme a cui tutti prima potevano accedere, anche per giustificare lo smacco pensarono bene di attribuirgli crudeltà e nefandezze di ogni genere, in larga parte inventate, che lo fecero diventare il feroce Saldino. Tanto per dare un’idea di come un epiteto possa prendere forza, da allora quando le madri dovevano riprendere i figli per qualche marachella li minacciavano di far intervenire il feroce Saladino. Certo, ogni epoca ha le sue violenze e anche nel XII secolo non si scherzava, si era ancora nel medioevo, un periodo però non così buio come i precedenti, visto che cominciò a riprendersi lentamente l’economia e le genti riacquistarono un po’ di quella voglia di vivere che l’ossessivo “memento mori” più volte ripetuto dai monaci negli anni più oscuri aveva quasi cancellato. Franco Cardini, nel parlarci di questo grande personaggio, che perfino Dante stimò al punto da inserirlo nella Divina Commedia nel limbo (non era battezzato) anziché sbatterlo, come si sarebbe potuto ipotizzare, all’inferno, in effetti ci porta a conoscere un’epoca., con le idee dominanti, gli usi, i costumi, cercando anche di evidenziare quelle connessioni sempre esistite fra mondo cristiano e mondo mussulmano. Ne scaturisce un grande affresco in cui la figura del Saladino, pur senza essere sminuita, assume le caratteristiche di un pretesto per parlare dei nostri legami con l’Islam, più che due religioni con non pochi punti di contatto, due culture, non diametralmente opposte come si potrebbe pensare. L’epoca in questione poi vedeva addirittura un predominio intellettuale dei cosiddetti arabi, che già due secoli prima avevano avuto un medico, filosofo e matematico del calibro di Avicenna e che contemporaneo del Saladino e di Riccardo Cuor di Leone potevano presentare una stella di prima grandezza come il medico, filosofo e astronomo Averroè. Quindi, la lettura è senz’altro consigliata. Franco Cardini è professore ordinario di Storia medievale presso l'Università di Firenze, e come giornalista collabora alle pagine culturali di vari quotidiani. Professore Emerito dell'Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa, da mezzo secolo si occupa di crociate, pellegrinaggi, rapporti tra Europa cristiana e Islam, anche trascorrendo lunghi periodi di studio e insegnamento all'estero. Ha fatto parte dei consigli d'amministrazione di Cinecittà e della Rai.
6 Febbraio
La strana guerra. 1939-1940: quando Hitler e Stalin erano alleati e Mussolini stava a guardare di Arrigo Petacco Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia
La stasi del fronte occidentale Venne all’epoca definita, e non a torto, la strana guerra quello stato di ostilità dichiarato fra la Germania e gli alleati anglo-francesi e che cominciò il 1° settembre del 1939 dopo che le forze tedesche si erano impadronite di mezza Polonia (l’altra metà invece fu occupata dall’Unione Sovietica, legata al Terzo Reich da un patto di non aggressione). In effetti, sul fronte occidentale, con i francesi insediati dentro le fortificazioni della linea Maginot, che si sbandierava invalicabile, con gli inglesi acquartierati alla fine di questa lungo una linea che arrivava fino al mare del Nord e un numero assai più ridotto di truppe tedesche a fronteggiarli, era logico pensare, più che a uno stato di guerra, a una tregua armistiziale. In realtà, se lì non si combatteva, in altri luoghi c’erano gli scontri, battaglie, anche furiose, sul mare fra la marina da guerra inglese e le navi corsare naziste. Se questo periodo di pace apparente durò fino al maggio del 1940, allorché le forze corazzate tedesche dilagarono in Francia all’improvviso, su terra e in altri posti si combatté, e non poco, come l’epico scontro fra la piccola Finlandia e il gigante russo che incredibilmente rischiò di soccombere, o come l’occupazione primaverile della Danimarca e della Norvegia, che si risvegliarono ai passi degli scarponi chiodati tedeschi. Perché questa apparente tregua? Quali furono i reali motivi e gli scopi? Arrigo Petacco cerca di rispondere a queste domande, senza tuttavia riuscire a sciogliere il nodo intricato dell’apparenza che ha nascosto chissà quali calcoli, non ultimo quello ipotizzato secondo il quale Hitler intendeva assicurarsi l’alleanza con Francia e Inghilterra per una guerra congiunta contro il comunismo sovietico. Siamo certamente nel campo delle illazioni, non ci sono prove documentali, né testimonianze di rilievo che possano avvalorare questa motivazione, così come si brancola nel buio cercando di dare una spiegazione logica alla decisione del dittatore nazista di fermare la corsa delle sue armate corazzate onde consentire agli inglesi, ristretti nella sacca di Dunkerque, di poter tornare in patria. Voleva dare un segnale di rispetto per un popolo di origine tedesca? Intendeva arrivare a una spartizione dei poteri, con la Gran Bretagna a dominare i mari, e il folle dittatore, terragno per natura, a regnare incontrastato sull’Europa continentale? Come è possibile notare in questo saggio di Petacco ci sono tante domande senza risposte, o al massimo con delle formulazioni di ipotesi; di conseguenza, non c’è da sperare di avere notizie in grado di chiarire atteggiamenti e scopi di un uomo ormai preda del suo delirio di onnipotenza e tanto meno non è possibile avere qualche definitiva delucidazione dai comportamenti del suo alleato Benito Mussolini, ormai irrealisticamente portato a giocare d’azzardo con la pelle degli altri. E’ evidente che Petacco, storico coerente e preciso, non poteva che riferire le ipotesi, magari sostenendo una piuttosto che un’altra e così La strana guerra (così è intitolato il suo saggio storico) finisce con il diventare un’opera di completa e minuziosa descrizione di quello che fu parte del primo anno della seconda guerra mondiale, un lavoro che si fa apprezzare anche perché non risulta mai tedioso, anzi è di facile e gradevole lettura. Arrigo Petacco (Castelnuovo Magra 1929 - Porto Venere 2018), è stato un giornalista e inviato speciale, direttore della «Nazione» e di «Storia illustrata». Scrittore e saggista molto prolifico, ha sceneggiato numerosi film e scritto diverse trasmissioni televisive a tema storico per la Rai. Nel suo lavoro di giornalista, per il quale nel 1983 ha vinto il Premio Saint Vincent, ha avuto modo di intervistare alcuni tra i protagonisti della Seconda guerra mondiale. Tra i suoi libri, in cui affronta tematiche storiche spesso intrise di mistero e ribalta verità giudicate incontestabili, ricordiamo Joe Petrosino (1978, da cui è stato tratto uno sceneggiato Rai), Dear Benito, caro Winston. Verità e misteri del carteggio Churchill-Mussolini (1985), La nostra guerra. 1940-1945 (1997), Regina. La vita e i segreti di Maria Josè di Savoia (1998), L'esodo. La tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia (1975 e 2000), L'armata nel deserto. Il segreto di El Alamein (2002), Il prefetto di ferro. L'uomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia (1977 e 2004, da cui è stato tratto un film), L'uomo della provvidenza. Mussolini, ascesa e caduta di un mito (2006), La strana guerra. 1939-1940: quando Hitler e Stalin erano alleati e Mussolini stava a guardare (2008), Il regno del Nord. 1859: il sogno di Cavour infranto da Garibaldi (2009), La principessa del Nord: la misteriosa vita della dama del Risorgimento: Cristina di Belgioioso (1993 e 2009), L'ultima crociata. Quando gli Ottomani arrivarono alle porte dell'Europa (2009), Quelli che dissero no. 8 settembre 1943: la scelta degli italiani nei campi di prigionia inglesi e americani (2011), Eva e Claretta. Le amanti del diavolo (2012), A Mosca, solo andata. La tragica avventura dei comunisti italiani in Russia (2013), La storia ci ha mentito. Dai misteri della borsa scomparsa di Mussolini alle «armi segrete» di Hitler, le grandi menzogne del Novecento (2014) e Nazisti in fuga. Intrighi spionistici, tesori nascosti, vendette e tradimenti all'ombra dell'Olocausto (2014), tutti editi da Mondadori. Inoltre, ha scritto i monumentali volumi de La seconda Guerra Mondiale (1979), Storia del Fascismo (1982) e Storia d'Italia dall'Unità ad oggi (1987) per Curcio. Nel 1986 gli è stata conferita l'onorificenza di Commendatore, su proposta dell'allora Presidenza del Consiglio.
3 Febbraio
Il cielo di stagno di Ben Pastor Sellerio Editore Palermo Narrativa romanzo giallo
Alta tensione Di ritorno dall’inferno di Stalingrado il maggiore Martin von Bora è inviato nell’Ucraina Nord orientale, dove sta provvedendo a costituire il suo reggimento, con la scelta selettiva degli ufficiali e della truppa, ma nel suo ruolo di appartenente all’Abwehr, il servizio segreto militare, si deve occupare di due ingombranti presenze, due generali dell’Armata Rossa, Platonov catturato quando il suo aereo ha dovuto atterrare oltre le linee, e Tibyetsky, detto Khan, che si è consegnato direttamente al nemico con il suo nuovissimo carro armato T34. Si devono interrogare i due personaggi, ma non sono per niente ciarlieri, anche il Khan, lontano parente di Martin e che almeno in apparenza sembrerebbe dimostrare una certa disponibilità. Il nostro ufficiale investigatore, inoltre, intende occuparsi di feroci omicidi che vengono commessi nella vicina foresta, eventi che sembrano al momento del tutto indipendenti, ma che finiranno per correlarsi quando i due generali prigionieri verranno assassinati. Chi è stato? Perchè? Sono le due domande che si pone von Bora, che all’inizio gira a vuoto senza nemmeno trovare il più piccolo indizio, ma poi, un po’ per fortuna, un po’ per intuito si solleva il velo di nebbia e in un crescendo di tensione (così elevata non l’ho mai riscontrata nei romanzi di Ben Pastor con protagonista l’ufficiale tedesco) si troverà una spiegazione al tutto con la giusta punizione dei colpevoli. Se devo essere sincero questa serie con protagonista von Bora, a cui mi sono accostato con curiosità, mi sta appassionando veramente, perché nella scrittura di Ben Pastor si trovano trame convincenti, uno stile mai greve, atmosfere e ambientazioni ricreate al meglio, senza dimenticare l’incessante e approfondita analisi psicologica dei personaggi. In particolare von Bora si rivela sempre di più un individuo quotidianamente combattuto fra la sua coscienza e il suo dovere di militare, con il secondo che prevale immancabilmente, perché dominante è il senso dell’onore derivante dalla divisa indossata. Non c’è alcuna simpatia per le SS per i crimini che commettono, ma nel maggiore dell’Abwehr prevale sempre il dovere, così che non mancano le rappresaglie nei confronti dei partigiani e delle popolazioni, ma a differenza delle SS tali azioni sono svolte nella convinzione di fare qualcosa di spiacevole, ma necessario, e non per trarne gusto e soddisfazione. Quindi la lettura è senz’altro consigliabile. Ben Pastor, nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha scritto narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico. Della serie di Martin Bora Sellerio ha già pubblicato Il Signore delle cento ossa (2011), Lumen (2012), Il cielo di stagno (2013), Luna bugiarda (2013), La strada per Itaca (2014), Kaputt Mundi(2015), I piccoli fuochi (2016), Il morto in piazza (2017) e La notte delle stelle cadenti (2018).
31 Gennaio
I racconti, le poesie di Giovanni Piubello a cura di Mario Artioli e Vladimiro Bertazzoni Sometti Editoriale Narrativa racconti
Anche poeta I curatori Mario Artioli e Vladimiro Bertazzoni, nel proporre l’opera omnia di Giovanni Piubello, hanno deciso di riunire in un unico volume i racconti e le poesie, scelta a prima vista opinabile, vista l’evidente difformità tipologica, ma che ha un senso ove si tenga presente che i primi sono di gran lunga maggiori di numero delle seconde, non poche, ma comunque nemmeno tante da giustificare una pubblicazione a se stante. Dell’abilità di narratore dell’autore già ho ampiamente riferito in occasione della stesura della nota critica ai suoi due romanzi Matti beati e Gli ubbidienti, e quindi non c’è da meravigliarsi se anche nei racconti si riscontrino i pregi che sono propri di Piubello, come una linearità espositiva, ma comunque non priva di originalità, una struttura sempre sicura, vicende che affondano per lo più nei ricordi dell’infanzia, descrizioni di paesaggi, di ambienti e di atmosfere puntuali, precise, accompagnate ogni tanto da una certa verve poetica e con sullo sfondo sempre una garbata e gradevole ironia. Viene proprio da pensare che lui non abbia avuto in vita i meriti che gli spettavano, insomma il successo che anche per una sua refrattarietà al clamore, all’essere al centro dell’attenzione, aveva lui stesso ostacolato. Forse è il caso di dire che Piubello scriveva pressoché esclusivamente per il piacere di scrivere, per farne oggetto di quelle conversazioni alla bancarella con cui lui trascorreva beatamente la sua giornata. Parte di queste prose, peraltro, non era sconosciuta ai mantovani perché il locale quotidiano La Gazzetta di Mantova aveva pubblicato a puntate i racconti, che alla fine furono riuniti in un volume intitolato Zingara (dal titolo di uno degli stessi, forse il migliore) che incontrò un notevole interesse, tanto da arrivare alla terza ristampa. I Curatori, con felice scelta, nel presente libro hanno suddiviso la narrativa breve in due grandi capitoli, di cui il primo dedicato unicamente alle prose che vennero racchiuse appunto nella pubblicazione intitolata Zingara, mentre le altre sono state tutte riunite con il generico titolo “Altre storie”. Come sempre accade in questi casi ci sono brani che possono più o meno piacere, ma è indubbio come il livello medio sia più che buono. Si tratta di storie semplici, niente di epico, trame che vedono coinvolta, a vario titolo, quasi sempre povera gente, frutto di indubbia creatività che tuttavia – è una mia ipotesi – nascondono un fondo di verità, e d’altra parte stando tutti i giorni sotto i portici si poteva osservare un campionario umano vario e a volte anche di particolare interesse, individui sconosciuti (e che tali spesso rimanevano) che si fermavano a curiosare e magari a conversare con Piubello. Più sorprendente è la parte del volume dedicata alla poesia, sorprendente perché, per quanto nella narrativa sia possibile riscontrare una sua verve poetica, non è detto che poi l’autore possa andar oltre scrivendo addirittura dei versi, e invece si scopre, e con piacere, anche la sua attitudine poetica. Che i titoli dati alle due raccolte qui pubblicate siano I gobbi, questa a suo tempo auto pubblicata, e poi Altri gobbi dimostra in modo chiaro il legame affettivo fra l’autore e la città di Mantova, poiché è notorio che la dinastia dei Gonzaga ebbe di sovente a scontare la tara ereditaria della gobba, frutto del matrimonio con una Malatesta. Ma i protagonisti di queste liriche non sono membri della schiatta gonzaghesca, bensì mantovani, gente colta e osservata nella serali vasche, deambulante per far venire l’ora della cena. E’ l’ironia che prevale, mai feroce, né cattiva, anzi a volte con un sottofondo di pietà, e così si possono cogliere personaggi, protagonisti loro malgrado di versi da trasmettere ai posteri, figure che altrimenti non avrebbero lasciato il segno se non fossero incorse nell’acuto spirito di osservazione di Piubello. Adesso che ne scrivo, mi pare di rivederlo e quando vado a Mantova, che passo di lì, d’istinto guardo, come se ci fosse ancora, come se quest’uomo, tanto umile quanto grande, osservasse il continuo passeggio, pronto a cogliere aspetti, pronto a far nascere idee, non un semplice libraio, ma un artista della penna talmente presente da essere quasi un’istituzione. Piubello era una di quelle persone alla cui presenza ci si abituava, quasi ormai da non notarlo, ma di cui si avvertì immediatamente la mancanza quando venne meno. Da leggere, non c’è dubbio. La sua prima opera, pubblicata in proprio, fu Zingara e poi diede alle stampe numerosi volumetti di racconti, prose, lettere in piazza e A proposito di gobbi, in versi. Nel 1967 l'editore Rizzoli pubblicò il romanzo Matti beati, con il quale vinse il premio nazionale Duomo. Il romanzo è autobiografico e racconta l'infanzia dello scrittore nel paese di San Bonifacio (Sambonifacio), descrivendo un quadro suggestivo della vita contadina e di paese negli anni Venti, in un contesto di sostanziale povertà vissuto tuttavia con allegria. Il successo fu di breve durata e Piubello continuò a stampare in proprio, nelle Edizioni di Bancarella, le sue storie, le sue lettere e i suoi dialoghi con lettori veri o presunti. Fu straordinario osservatore della vita cittadina nella sua patria d'adozione, e fu amato dai mantovani che trovavano nella bancarella sotto i portici Broletto un dimesso ma profondo uomo di cultura.
27 Gennaio
Metello di Vasco Pratolini Edizioni BUR Narrativa romanzo storico
La boje La boje, vale a dire bolle, era parte del motto che i contadini adottarono in occasione della rivolta popolare del periodo 1882 – 1885. Nel caso di Metello, invece, si tratta del primo grande sciopero degli edili avvenuto più tardi, nel 1901, ma in ogni caso si trova pure in questa occasione l’esasperazione di lavoratori quasi alla fame che, prendendo piano piano coscienza dei loro diritti, rivendicano, in uno con un congruo aumento salariale, il riconoscimento della propria dignità di uomini. Protagonista principale di questo grande affresco storico è Metello Salani, nato a Firenze nel 1875 e rimasto nel giro di pochissimo tempo orfano dei propri genitori, tanto che di fatto viene adottato dalla donna che lo teneva a balia. Il romanzo ripercorre la vita di questo bambino che diventerà uomo prima del tempo per la necessità di sopravvivere, un uomo che non ha avuto la guida di un padre, ma che troverà in un compagno di lavoro, l’anarchico Betto, colui che gli insegnerà a leggere e a scrivere e che lo introdurrà alla vita degli adulti. Metello ha un’intelligenza pronta, impara presto, lavora bene come muratore, poco a poco diventa un esempio per gli altri che faticano tutto il giorno, fra mille pericoli, a tirar su muri e a coprire con i tetti. Non è esente da difetti, è sostanzialmente fedele a chi ama, ma è privo di remore quando si tratta di rispondere alle sollecitazioni della carne. Comunque è un uomo in cui matura, senza che lui se ne accorga, il desiderio di rivendicare per la propria categoria tutti quei diritti naturali da tempo negati e senza essere un sindacalista riesce comunque ad assurgere alla figura di capo popolo, una guida per tanti altri che cominciano ad alzar la testa. Si chiedono migliori condizioni di lavoro, un aumento della paga che consenta di vivere, ma è netta la chiusura dei padroni, tanto che, ob torto collo, i muratori sono costretti a indire uno sciopero a oltranza. E’ bellissima la descrizione dell’atmosfera, di questa povera gente che è di fatto obbligata a indebitarsi per tirare avanti, nella speranza che sopraggiunga un accordo. Tutto sembra complottare contro di loro e chi ha il potere ricorre anche alla forza della polizia e dell’esercito, ma alla fine, quando gli animi sono esasperati, quando il fronte degli scioperanti comincia a incrinarsi, quando scoppiano i tafferugli e ci scappa anche il morto, si giunge al tanto agognato accordo, che accoglie solo in parte assai ridotta le richieste economiche, ma che ha un significato che esula dalla materialità del denaro: è sorto uno spirito di categoria, un popolo di cenciosi si è unito per riscattare la propria dignità. Il lavoro può ricominciare, funestato subito da un tragico incidente, in cui periscono un vecchio muratore e un giovane manovale, perché le condizioni di sicurezza sono inadeguate e per di più non esiste un’assicurazione sugli infortuni. Ecco quindi una materia su cui discutere con i padroni, ecco un altro traguardo da raggiungere di quella lunga corsa a tappe che è l’emancipazione di una classe lavoratrice taglieggiata dal padronato. Il romanzo non ha una fine vera e propria, perché Metello esce dal carcere dove è stato tenuto in attesa di giudizio per i fatti di quello sciopero, giudizio che lo assolve pienamente, e ad attenderlo in strada trova la moglie Ersilia con il figlioletto. Si incamminano verso casa, ma prima si fermano in un caffè, dove lei prende un corretto e lui un grappino. Davanti a loro un grande specchio riflette la loro immagine e Metello dice “La Sacra Famiglia”; al che lei lo invita a non bestemmiare e lui replica “Ma d’ora in avanti.”. Gli fa eco lei: “D’ora in avanti cosa?”. Sembrerebbe di capire che Metello da ora in avanti si interesserà solo della famiglia e che non si occuperà più di battaglie politiche, ma entrambi sanno che non è possibile, perché un uomo come lui non può restare sempre a capo chino e la lotta, per quanto lunga e difficile sia, non può essere per lui che pane quotidiano. Scritto splendidamente, coinvolgente, emozionante, a volte anche commovente, Metello è il romanzo che mi sento di definire un capolavoro. Da ultimo, nel 1970 uscì nelle sale cinematografiche una felice trasposizione cinematografica dal titolo Metello, un film diretto da Mauro Bolognini e interpretato da un giovanissimo e convincente Massimo Ranieri e da una brava Ottavia Piccolo che ottenne il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes. Vasco Pratolini (Firenze, 19 ottobre 1913 – Roma, 12 gennaio 1991). Di famiglia operaia, è costretto a interrompere gli studi e svolge mestieri diversi per potersi mantenere. Pratolini comincia a collaborare al periodico «Il Bargello» e diviene redattore con Alfonso Gatto, nel 1938, della rivista «Campo di Marte». Nel 1951 si trasferisce a Roma, città nella quale vivrà da allora in poi. Il registro adottato, sin da quelle prime prove, si pone a mezza via fra il realistico e il lirico. Pratolini svolge con successo, in questi anni, anche un'attività di sceneggiatore e soggettista cinematografico, e intraprenderà in seguito una carriera di autore di testi teatrali ("La domenica della povera gente", 1952; "Lungo viaggio di Natale", 1954). Nel 1955 pubblica Metello (premio Viareggio), primo romanzo di quella che diverrà la trilogia "Una storia italiana", essendo completata da "Lo scialo" (1960) e da "Allegoria e derisione" (1966). Alla città e al mondo dell’adolescenza sono dedicati ancora un romanzo, "La costanza della ragione" (1963), e le poesie raccolte in "La mia città ha trent’anni" (1967). Alcune «cronache in versi e in prosa», scritte dal 1930 al 1980, sono riunite nel volume "Il mannello di Natascia" (1984, premio Viareggio).
23 Gennaio
Mi bolle il cuore di Debora Rienzi Prefazione di Alessandro Barban Postfazione di Alessandro Ramberti Fara Editore Poesia Teopoesia In tutta sincerità, scorrendo il catalogo on line dell’editore, sono stato colpito da questo strano titolo, nonché dall’indicazione di poesia non religiosa, bensì teopoetica, riportata nella quarta di copertina e rappresentate da un breve periodo della prefazione di Alessandro Barban. Strano titolo, certo, forse in apparenza eccessivo per una silloge dai cui versi è lecito attendersi musicalità, dolcezza, pacata esposizione, ma questo non è significativo, perché come un abito non fa il monaco, così un titolo non fa una raccolta; molto più complesso è il discorso in ordine a quel termine, teopoetico di cui non trovi la definizione si Internet nemmeno cercandola con il lanternino e allora è giocoforza affidarsi a quanto precisato dal prefatore che scrive: “ non si tratta di poesia religiosa, ma di teopoetica, cioè di quello spazio interattivo teologico-spirituale di corpo, di intelligenza psichica e di anima spirituale proveniente dalla stessa esistenza dell’autrice, in cui la poesia diventa espressione di Dio e affermazione della propria vita.”. Non è che se ne sappia molto di più e allora è evidente che bisogna andare a leggere le poesie di questa raccolta, lettura che in ogni cosa è da fare se si vuole provvedere a scrivere una nota critica; dunque occorre passare alla lettura, non una lettura semplice e a sé stante, ma volta anche comprendere il significato di teopoesia. E tutto diventa più facile e si chiarisce fin dai primi versi (Spirito segreto / riflesso nel silenzio, / brucia la pula dei nostri pensieri / e prepara l’anima al parto ormai prossimo. / T’inserisci inadatto / nelle fessure del nostro tempo / e parli inascoltato / a vite già fissate… / ma non desisti. E torni / a suggerire levità a cuori appesantiti, / e risciacquare con premura / occhi duri impolverati…). C’è infatti una sorta di colloquio fra la divinità e il soggetto, tanto che mi viene da dire che la dimensione è senz’altro spirituale, mentre l’aspetto religioso, almeno in senso stretto, è appena abbozzato. In fin dei conti in tutti noi, credenti o meno, c’è la possibilità e la necessità di porsi delle domande, perché non siamo solo carne, ma anche e soprattutto spirito. È proprio questa nostra parte immateriale, evanescente a porsi o alla ricerca di Dio o a interagire con Lui, come nel caso di questa raccolta poetica, la cui novità, se così vogliamo definirla, è questa espressività in versi di un dialogo muto e intimo che è più frequente di quanto si possa immaginare, a volte scientemente, altre inconsapevolmente. Proprio per questa tipicità, per il sentire diverso in ogni soggetto e per quell’ancorarsi e disancorarsi, quell’abbracciarsi e quello sciogliersi, quel desiderio di comunicare e nel cercare risposte alle domande, la poesia di Debora Rienzi ha una tale valenza che la rende di non immediata comprensione, richiedendo invece più riletture, onde – elemento indispensabile – entrare in empatia con l’autrice. Poi, tutto diventa più semplice, è come se una luce scendesse dentro a noi a scaldare il cuore e allora anche il titolo appare pertinente. Nata a Padova nel 1974, Debora Rienzi ha studiato Filosofia a Padova e Medicina a Bologna. Dal 2004 al 2017 svolge attività missionarie con l’Ami (Associazione Missionaria Inter-nazionale) facendo servizio in Italia, Africa e India, poi entra nel monastero Camaldolese di Poppi (Arezzo): www.camaldolesidipoppi.it
18 Gennaio
Gli ultimi passi del Sindacone di Andrea Vitali Garzanti Libri Narrativa romanzo
Una Vigilia movimentata Arrivati all’ultima pagina verrebbe da dire “E’ il solito Vitali”, cioè un libro che si lascia leggere senza che resti qualcosa dentro, insomma un puro innocente ed effimero svago, e invece no, perché questa volta il narratore comasco è riuscito a imbastire una storia di piacevole lettura, ma che ha più di un significato, con richiami vari, perfino ai complessi freudiani. Che Attilio Fumagalli, un uomo che soffre di obesità androide, susciti immediata simpatia è senz’altro vero, perché è notorio che gli individui pingui sono le per lo più di indole buona, ma il nostro protagonista, sindaco del paese, soprannominato per le sue caratteristiche, in senso bonario e non spregevole, il sindacone è uno di quei personaggi che lasciano il segno e nel caso specifico per tutto il libro, anche se è presente attivamente solo nella parte iniziale. E’ un uomo ligio ai suoi doveri di amministratore, una brava persona non c’è che dire che ha tuttavia la disavventura di morire nel letto dell’amante la sera della vigilia di Natale. Al fine di evitare uno scandalo, che non avrebbe senz’altro meritato, si avvia una procedura grottesca e che muove anche al riso, coinvolgente una varia umanità, descritta in modo encomiabile e con una punta d’affetto, come se Vitali parlasse dei suoi figli. Così, accanto al rag. Veniero Gattei, vicesindaco e regista dell’intera operazione, si muovono in sincronia il complessato pizzicagnolo Amelio Stoppani, le due giunoniche gemelle Perlina e Luisetta Cesetti, la maestra Pericleta Beregini, zitella per vocazione e bigotta, l’ambiguo geometra Enea Levore, il viveur ormai attempato Emilio Allegretti e tutta una serie di figure azzeccatissime con dei nomi assai indovinati, delle comparse non anonime, ma quasi delle opportune spalle. La vicenda del sindacone un po’ perché di si dipana nella notte della Vigilia, un po’ perché lascia un messaggio di pace e di serenità ha il sapore di una favola, beninteso per adulti e non certo per bambini, a causa di certe situazioni non proprio adatte alla loro età, per quanto molto ben sfumate. Non è che ci sia la possibilità di gridare al capolavoro, ma Gli ultimi passi del Sindacone ci propone un Vitali più maturo, forse anche desideroso di mostrare le sue più recondite capacità, che in quest’opera fanno appena capolino, quasi che ci fosse il timore di interrompere il modesto, ma proficuo tran tran delle produzioni precedenti. E questo è senz’altro un motivo in più per leggere il romanzo. Dopo aver frequentato «il severissimo liceo Manzoni» di Lecco, Andrea Vitali si laurea in medicina all'Università Statale di Milano ed esercita la professione di medico di base nel suo paese natale.
15 Gennaio
Papà Goriot di Honoré de Balzac BUR Biblioteca Universale Rizzoli Narrativa romanzo
Una società malata Se per esprimere un giudizio ci dovessimo basare solo sulla trama, Papà Goriot sarebbe un romanzo anonimo che tratteggia la fine di un padre che ha un amore patologico per le due figlie al punto di cadere in miseria per alimentare la loro sete di ricchezza. L’uomo, anziano, vive in una pensione in cui dapprima lo credono un riccone (e in effetto lo è), avaro e solitario, a cui di tanto in tanto fanno visita due belle signore che lui dice essere le figlie, ma che gli altri, malignamente, definiscono come donne prezzolate da quello che ritengono erroneamente un gran porcone. Insomma, non viene creduto e l’uomo trascina la sua esistenza in una progressiva condizione di indigenza fino al momento del trapasso, dopo che morente nel letto ha atteso invano una visita delle figlie. Una trama quindi modesta, senza particolari colpi di scena, per un’opera che, se ci si basasse solo sullo sviluppo della vicenda, potrebbe apparire modesta, ma che invece è un capolavoro; sono altri infatti gli elementi di giudizio e tutti soggetti a valutazioni ampiamente positive. Balzac già solo nel descrivere la pensione dove alloggia Papà Goriot offre un esempio della sua elevata capacità di proporre al lettore un ambiente, tanto che pagina dopo pagina si ha netta l’impressione di essere lì presenti. Ciò, se pur valido, sarebbe tuttavia poco se non considerassimo anche i vari piani di lettura, che vanno dalle relazioni familiari alla bramosia dell’ascesa sociale, grazie a un’irrefrenabile ambizione; e non poteva mancare il male endemico presente in ogni epoca, in misura maggiore o minore, e al tempo della vicenda maggiore, vale a dire la corruzione. Quello che però stupisce maggiormente è l’approfondita analisi psicologica dei personaggi, perché Papà Goriot, il cui affetto smisurato per le figlie non è adeguatamente corrisposto, anzi è vittima delle stesse, è il ritratto di un uomo fondamentalmente buono e onesto, la cui esistenza viene stravolta dalla sete di denaro di una società in cui le sue discendenti bramano di figurare sempre al massimo livello; la signora Vauquer, che è la proprietaria della pensione, vedova e che aveva messo gli occhi su Papà Goriot agli inizi del suo soggiorno è una persona che vive per il denaro, un tipo dozzinale nonostante professi una incerta patente di nobiltà; Eugene de Rastignac è un giovane universitario, che studia da avvocato, dalle modeste risorse finanziarie, ma che ambisce primeggiare nella bella società parigina, ricorrendo anche a una relazione con una donna più vecchia di lui; Vautrin è il male in persona, un criminale che per raggiungere i suoi scopi ricorre anche al delitto, un uomo inattaccabile dalla corruzione, perché lui è corrotto dalla nascita; e poi ci sono le due figlie di Papà Goriot, la maggiore Anastasie de Restaud, che ha un’amante, accanito giocatore e perennemente indebitato, soccorso di continuo con il denaro del sempre più povero Papà Goriot, e la minore Delphine de Nucingen, che sembrerebbe la migliore, ma che anche lei ha un amante che lascia per il più giovane Eugene de Rastignac. Papà Goriot insomma è un ritratto crudele, indubbiamente realistico della società francese dell’epoca, ma presenta dei personaggi che è possibile trovare in ogni società, spesso individui dal latente carattere che nelle occasioni offerte da un modo vita nazionale finiscono per rivelarsi. Direi che parlare di stile è superfluo, l’opera si presenta da sé per quel che è, vale a dire un capolavoro, un classico, un romanzo sempre e ovunque valido. Honoré de Balzac nacque a Tours il 20 maggio 1799 in una famiglia della media borghesia e solo dal 1830 aggiunse il «de» al suo cognome; suo padre, che era stato segretario del consiglio del re durante l’Ancien Régime, fu poi capo della sussistenza della 22a divisione militare di Tours; la madre proveniva da una famiglia di commercianti. Dal 1807 al 1813 studiò come interno nel Collège de Vendôme. Quando la famiglia si trasferì a Parigi, iniziò gli studi di giurisprudenza e seguì alla Sorbona i corsi di Cousin, Guizot, Villemain.
13 Gennaio
La valle dei Cavalieri di Raffaele Crovi Marsilio Editori Narrativa romanzo storico
Romanzo storico e antropologico La valle dei Cavalieri è una zona di antichi borghi medievali fortificati e si trova sull’Alta Val d’Enza e Val Cedra, fra le odierne province di Parma e di Reggio Emilia. Lì è ambientato l’omonimo romanzo di Raffaele Crovi con cui viene narrata, dal punto di vista di Lino Lodi, la storia di quasi un secolo della nostra nazione, dal disastro di Dogali del 1887, in cui le nostre truppe furono massacrate dagli etiopici, al tragico periodo degli anni di piombo. In questo arco di tempo piuttosto lungo il protagonista, ormai novantenne, rievoca, fa riemergere il ricordo degli eventi salienti della sua lunga vita, indubbiamente personali, ma che si innestano e si intrecciano con vicende nazionali, sì che la piccola storia dell’individuo confluisce nella grande storia di un paese. Nulla di nuovo, si potrebbe dire, perché già diversi narratori hanno inteso raccontare gli avvenimenti di rilievo della nostra nazione parlando della vita di altri, come per esempio Sebastiano Vassalli con i suoi riuscitissimi romanzi Cuore di pietra e Le due chiese; tuttavia, Crovi, che si nasconde dietro l’io narrante Lino Lodi (ma la trama non è autobiografica), ne approfitta per portare avanti un discorso sul senso della vita, sulle immancabili connessioni con la realtà di ogni giorno, che si riflette su di noi, ma che anche è un nostro riflesso. Il personaggio è un uomo che si è fatto da sé, da umile garzone a ricco possidente, da autentico credente a politico che vuole improntare alla religione stessa le sue scelte, un essere umano con diversi pregi, ma non immune da difetti, un Signore lo si potrebbe anche definire, cioè un degno discendente di quei vassalli dei Canossa per conto dei quali amministravano nei borghi della Valle dei Cavalieri. Peraltro è presente una moltitudine di personaggi, quasi tutti locali, ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità, tuttavia accomunati dal fatto di essere nati o di risiedere nella valle dei Cavalieri, una vera e propria comunità che, per quanto comprimaria nell’economia del racconto, ravviva la scena e diviene indispensabile per delineare ancora meglio la figura del protagonista. Lo stile dell’autore è determinante nella qualità dell’opera, di per se stessa non eccelsa, ma comunque piacevole assai da leggere per la narrazione snella, mai greve, accompagnata anche da uno spunto di mistero, giacché si vuole arrivare a sapere chi, con lettere minatorie, minaccia la morte o la rovina di Lodi, un protagonista che desta un’immediata simpatia per la sua semplicità e per la capacità di restare sempre se stesso, costi quel che costi. Le pagine così scorrono veloci, ripassando anche un po’ della nostra storia, un’opportuna rinfrescata per sprofondare ulteriormente le nostre radici e per cercare di gettare le basi del futuro su ciò che è stato e per ciò che siamo ora. Raffaele Crovi (Paderno Dugnano, Milano, 1934 - Milano 2007) scrittore italiano. Le sue opere, ispirate da un cristianesimo anticonformista, esprimono una costante polemica contro ogni omologazione - politica, culturale, ideologica - del nostro tempo. È autore di romanzi (da La valle dei cavalieri, 1993, premio Campiello, a Cameo, 2006) che indagano il cambiamento del Paese Italia; parabole narrative (da Il franco tiratore, 1968, a Nerofumo, 2007), in cui esplora la violenza del potere, e storie milanesi (tra cui L’indagine di via Rapallo, 1996). Nelle raccolte poetiche (da La casa dell’infanzia, 1959, a La vita sopravvissuta, 2007), vicende etiche individuali si trasformano in metafore della vita sociale.
10 Gennaio
Lumen di Ben Pastor Hobby & Work Publishing Narrativa romanzo giallo Delitto al convento A Cracovia, nel 1939, nella Polonia da poco invasa dall’esercito tedesco viene uccisa Madre Kazimierza, badessa del convento di Nostra Signora delle Sette Pene, religiosa in odore di santità, a cui vengono attribuite profezie e miracoli. Le indagini sull’omicidio vengono svolte dal capitano Martin von Bora dei Servizi Segreti dell’esercito di occupazione e dal sacerdote americano di origine polacca padre John Malecki, che da tempo, su incarico del Vaticano, cerca di appurare se le straordinarie proprietà della suora siano o meno vere. Fra mille difficoltà, con la presenza opprimente delle famigerate SS che già stanno dando corso ai massacri per cui diventeranno tristemente famose, riusciranno alla fine a scoprire il colpevole. Per sommi capi è questa la trama di Lumen, termine latino che tradotto in italiano significa luce, e che è il primo romanzo scritto da Ben Pastor della fortunata serie che vede come protagonista l’ufficiale tedesco Martin von Bora, personaggio complesso, ma affascinante, eternamente combattuto fra il senso del dovere e la sua coscienza. Benché si sia di fronte a un giallo storico, l’aspetto investigativo non è prioritario, anzi costituisce semplicemente il fil rouge per narrare le vicende di una certa epoca (quelle della seconda guerra mondiale) e le atmosfere che hanno caratterizzato questo periodo bellico, con l’aggiunta di riflessioni per nulla scontate e spesso assai profonde che sono proprie del protagonista e non di rado di personaggi utili alla trama, sovente esistiti veramente. In questa prima opera è già possibile apprezzare lo stile preciso, ma snello, dell’autore e la sua non indifferente capacità di attrarre progressivamente il lettore, la cui attenzione non è volta solo a conoscere l’esito dell’indagine, ma a svelare anche e soprattutto il carattere del protagonista. La lettura, quindi, è particolarmente piacevole, ma non è solo svago, perché il coinvolgimento comporta frequenti considerazioni su temi primari, in primis su ciò che ci viene imposto di fare e su quello che invece è dettato dalla nostra coscienza. Ben Pastor, scrittrice italo americana, all'anagrafe Maria Verbena Volpi, nata a Roma ma trasferitasi ben presto negli Stati Uniti, ha insegnato Scienze sociali presso le università dell'Ohio, dell'Illinois e del Vermont. Oltre a Lumen, Luna bugiarda, Kaputt Mundi, La canzone del cavaliere, Il morto in piazza, La Venere di Salò, Il cielo di stagno, - ovvero il ciclo del soldato-detective Martin Bora (pubblicati da Hobby&Work a partire dal 2001 e poi da Sellerio) - è autrice di I misteri di Praga (2002), La camera dello scirocco, omaggi in giallo alla cultura mitteleuropea di Kafka e Roth (Hobby &Work), nonché de Il ladro d'acqua (Frassinelli 2007), La voce del fuoco (Frassinelli 2008), Le vergini di pietra e La traccia del vento (Hobby & Work 2012), una serie di quattro thriller ambientata nel IV secolo dopo Cristo.
7 Gennaio
La più grande vittoria di Napoleone di Sergio Valzania Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Storia Il sole splendette ad Austerlitz Austerlitz è stata senza dubbio la più grande vittoria di Napoleone, irripetibile perché unica nel suo svolgimento e nelle conseguenze del suo esito. Detta anche la battaglia dei tre imperatori, per l’appunto Napoleone Bonaparte, Alessandro I di Russia e Francesco II d’Asburgo – Lorena, fu combattuta il 2 dicembre 1805 nelle vicinanze della cittadina di Austerlitz in quella che è l’attuale Repubblica Ceca fra l’esercito francese, forte di 73.000 uomini con 139 cannoni e la coalizione Russa – Sacro Romano Impero con circa 86.000 effettivi e 278 cannoni. Le perdite furono particolarmente rilevanti (25.000 fra morti e feriti e 12.000 prigionieri) per gli avversari di Napoleone, ma le conseguenze maggiori furono politiche e territoriali, con la potenza asburgica ampiamente ridimensionata e l’orso russo praticamente ammansito. Di questo epico scontro parla Sergio Valzania nel suo interessante saggio intitolato appunto Austerlitz La più grande vittoria di Napoleone proponendo ai lettori i prodromi, i preparativi, lo svolgimento della battaglia e le conseguenze. L’autore se pone giustamente l’accento sul piano militare non trascura però l’importanza del risultato dal punto di vista dell’effetto nel territorio europeo, poiché grazie al successo Napoleone si presentò definitivamente come colui la cui potenza risiedeva nell’invincibilità e se poi questa pregiudiziale così importante per gli avversari venne meno fu solo per la disastrosa campagna di Russia, voluta da Napoleone stesso più che convinto, sbagliando, della sua impossibilità di essere sconfitto. Del resto all’aspetto psicologico il Bonaparte dava somma importanza, visto che la vera chiave del successo di Austerlitz era consistita nel far presupporre agli avversari di essere impreparato, cioè in difficoltà sia tattica che strategica; incautamente abboccarono e quasi certi della loro vittoria commisero errori tattici che determinarono la loro sconfitta. Come è possibile immaginare ampio risalto viene dato allo svolgimento della battaglia, offrendo così un magistrale esempio di storia militare, un risultato che potrà risultare gradito anche ai profani per lo stile snello e per nulla pedante dell’opera. Da leggere. Sergio Valzania, storico e studioso della comunicazione, autore radiofonico e televisivo, dal 2002 al 2009 ha diretto i programmi radiofonici della Rai. Dal 2001 insegna all'Università di Genova e dal 2010 alla Luiss di Roma. Ha scritto su «La Nazione», «Avvenire», «la Repubblica», «il Giornale», «L'Indipendente», «Liberal».
5 Gennaio
Il cavaliere dei Rossomori. Vita di Emilio Lussu di Giuseppe Fiori Edizioni Il Maestrale Storia biografia
Un uomo perbene Se avete l’ardire di chiedere a un gruppo di studenti chi sia Emilio Lussu, non meravigliatevi se vedrete dei volti con espressioni stupite, o peggio ancora sfuggenti, tipiche di chi non è in grado di dare una risposta. Al più, se si è particolarmente fortunati, può darsi che qualcuno, pescando nella memoria, risponda che si tratta dell’autore di Un anno sull’altopiano, un libro contro la guerra, ma anche in questo caso non potrete mai avere un ritratto, almeno abbozzato, di quest’uomo. Sì, è certamente l’autore di Un anno sull’altopiano, romanzo assai riuscito tanto da poter essere accostato a Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque, opere entrambe che si pongono in un atteggiamento critico e costruttivo del fenomeno della guerra in generale, pur partendo dalle diverse esperienze degli autori. A differenza del narratore tedesco Lussu è un protagonista di un secolo, quello trascorso, in cui ha potuto manifestare tutte le sue indubbie qualità di uomo e di politico, sempre in prima persona, sia quando da acceso interventista partecipa alla Grande Guerra, chiaro esempio per i soldati a lui sottoposti, sempre primo nell’affrontare il nemico, sempre ultimo nel retrocedere, tanto da meritarsi, oltre a promozioni sul campo, anche ben quattro medaglie al valore. La guerra, gli scontri, le carneficine forgiano l’uomo Lussu, gli fanno comprendere il senso immane di quella tragedia, indirizzano la sua vita alla difesa delle classi più deboli ed è ciò che farà nel ritorno alla sua Sardegna, organizzando i contadini e i pastori nel Partito Sardo d’Azione, che aveva per emblema i quattro mori. Sono gli anni in cui sorge e impera il fascismo, che trova nello scrittore sardo un fiero e valido oppositore. Lui non si tira mai indietro, affronta di petto i facinorosi e, per legittima difesa, ne uccide uno. Viene prosciolto dal Tribunale, ma i fascisti non sono d’accordo e lo mandano cinque anni al confino, a Lipari, da cui riesce a fuggire rocambolescamente con Rosselli e Nitti. Inizia così il lungo pellegrinaggio da esule all’estero, tanto che rientrerà in Italia solo dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e si dedicherà anima e corpo alla nuova Italia, a quella che nascerà con la Repubblica e la costituzione, diventando anche ministro, per il Partito Socialista, nei primi governi; uomo di sinistra, ma autonomo da ogni condizionamento esterno uscirà poi dal partito nel 1964, aderendo al Psiup, per ritirarsi definitivamente dalla vita politica nel 1968. Coerente, mai estremizzante, libertario, Lussu è uno di quei rari uomini che si possono definire “perbene”, ma è anche un acuto osservatore del suo tempo, con quella sua particolare capacità di analizzare fenomeni di grande ampiezza, pur dal suo punto di vista particolare. E allora non è un caso se ha scritto Un anno sull’altopiano, e poi Marcia su Roma e dintorni, sull’avvento del fascismo, e infine La catena, sul consolidamento del regime. A leggere questi libri si apprende parecchio su uno dei periodi più bui della nostra storia e una sua biografia appare quindi, oltre che opportuna, soprattutto doverosa; a ciò ha provveduto, con un’opera di notevole pregio, Giuseppe Fiori, sardo pure lui e ideologicamente vicino a Lussu. L’ambiente, la giovinezza, gli studi, la guerra, il fascismo, la resistenza, la nascita della repubblica, il dopo sono gli argomenti di queste pagine che, nel fornirci un quadro puntuale della storia del nostro paese, tratteggiano in modo esemplare la figura di un uomo che seppe essere tale in ogni frangente, nei momenti di fortuna e in quelli più neri, sempre coerente, mai domo, con lo sguardo proteso oltre gli avvenimenti contingenti, capace di vedere quella nuova Italia che sulle alture dell’altopiano di Asiago, fra scontri e carneficine, aveva cominciato ad abbozzare. Da leggere, mi sembra ovvio. Giuseppe Fiori (Silanus, Nuoro, 1923 - Roma 2003) giornalista e biografo italiano. A un’intensa attività giornalistica in televisione (e di televisione si è occupato anche in sede parlamentare) ha affiancato una nutrita produzione di inchieste e biografie. Tra queste ultime si ricordano quelle di A. Gramsci (1966), dell’anarchico Michele Schirru (1983), di E. Lussu (1985), di E. Berlinguer (1989), di S. Berlusconi (Il venditore, 1995), di Ernesto Rossi (1997). Del 1993 è Uomini ex, romanzo-inchiesta su un gruppo di partigiani rifugiatisi a Praga dopo la guerra per sfuggire alla giustizia italiana.
|
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Poetare.it © 2002